 Marina Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, DeriveApprodi, Roma, 2016, pp. 136, € 15,00
Marina Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, DeriveApprodi, Roma, 2016, pp. 136, € 15,00
Tra pochi giorni, a fine giugno, la legge sull’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento penale italiano arriverà a Montecitorio, per concludere, forse, l’iter di approvazione parlamentare. Si potrebbe pensare che stia per essere scritta una pagina positiva della storia legislativa e politica del nostro paese, ma la realtà delle cose è ben diversa e per almeno due grandi ordini di ragioni: innanzi tutto perché il ritardo con cui il codice penale italiano riconosce la fattispecie del reato di tortura è [...]]]>
 Marina Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, DeriveApprodi, Roma, 2016, pp. 136, € 15,00
Marina Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, DeriveApprodi, Roma, 2016, pp. 136, € 15,00
Tra pochi giorni, a fine giugno, la legge sull’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento penale italiano arriverà a Montecitorio, per concludere, forse, l’iter di approvazione parlamentare. Si potrebbe pensare che stia per essere scritta una pagina positiva della storia legislativa e politica del nostro paese, ma la realtà delle cose è ben diversa e per almeno due grandi ordini di ragioni: innanzi tutto perché il ritardo con cui il codice penale italiano riconosce la fattispecie del reato di tortura è a dir poco epocale, visto che la stessa Italia ratificò la Convenzione internazionale contro la tortura (Onu, 1984) nel gennaio 1988, insomma una trentina di anni fa; in secondo luogo perché il testo approvato al Senato il 17 maggio scorso è talmente rabberciato e contraddittorio da tradire lo spirito stesso di una legge che dovrebbe in modo netto e senza equivoci riconoscere la tortura come fattispecie di reato e delle peggiori. Un “tradimento” che lo stesso Luigi Manconi, che nel maggio del 2013 aveva presentato il progetto di legge in qualità di presidente della commissione parlamentare sui diritti umani, non ha esitato a definire inaccettabile, avanzando le stesse critiche e perplessità espresse da associazioni quali Amnesty International ed Antigone o dalle vittime della tortura di Stato italiana e dai parenti delle stesse. Vittime, che nel paese dei fatti di Genova 2001, di Cucchi e di Aldrovandi tra gli altri, sono numerose e ancora in attesa (vana) che venga fatto un minimo di giustizia e venga loro restituita quella dignità di uomini e cittadini che è stata a loro negata dai violenti abusi di potere di uomini dello Stato, dell’arbitrio dei quali sono caduti in balia.
Il testo della legge, se verrà approvato in via definitiva, sembra fatto apposta per restringere il campo dell’applicabilità della medesima e per mantenere ampio invece quello dell’impunità delle forze dell’ordine, per introdurre attenuanti, nonché elementi di discrezionalità ed ostacoli di vario genere all’applicazione della fattispecie penale. Ne conseguirà che in Italia, come ha fatto notare Manconi in alcune dichiarazioni riportate da numerosi organi di stampa, la tortura non verrà rubricata come un reato specifico di pubblici ufficiali, che abusano violentemente del loro potere di tenere sotto custodia un individuo, ma sarà equiparata a forme di violenza tra semplici cittadini; ne discenderà inoltre che, a fronte di processi che potrebbero svolgersi a distanza di molti anni dai fatti, il trauma psichico subito dalla vittima di presunta tortura dovrà essere “verificabile” di molto a posteriori ed infine vi dovrà essere la reiterazione del crimine (il testo parla di “più condotte” della stesso genere) affinché possa essere riconosciuto il reato di tortura.
Insomma una legge “truffa”, una legge pasticciata che poco o nulla cambierà nella sostanza in un paese che sembra non avere problemi a convivere con il ricorso delle proprie forze dell’ordine a pratiche di tortura, forse perché lo ritiene il male minore o un male necessario, un’arma estrema che deve essere lasciata alla disponibilità delle forze dell’«ordine» nella lotta contro un male considerato peggiore, come gli odierni teorici e sostenitori della legittimità della tortura argomentano con la cosiddetta teoria, di sicuro impatto in tempi di “ossessione e paura terroristiche”, della “bomba ad orologeria”, secondo cui anche una pratica brutale e ripugnante come la tortura può risultare giustificata se serve a disinnescare una minaccia giudicata maggiore.
Il libro di Marina Lalatta Costerbosa, che – uscito per DeriveApprodi nell’aprile del 2016 – intendeva dare un contributo proprio al dibattito intellettuale a supporto dell’introduzione del reato di tortura nel nostro codice, a più di un anno di distanza risulta quanto mai attuale e di certo interesse, proprio alla luce di ciò che si è detto sopra e delle difficoltà che si incontrano nel nostro paese nell’affrontare la questione, sia dal punto di vista giuridico-legislativo sia da quello della discussione pubblica sull’argomento, che, fatta eccezione per i momenti in cui il problema si presenta con tutta la sua cruda violenza all’attenzione collettiva e a quella di media e stampa, presto si tacita e lascia il posto ad un disinteressato silenzio. Il “silenzio della tortura”, per l’appunto, quello di cui parla anche il titolo del bel saggio della docente di filosofia del diritto dell’Università di Bologna.
Spiega l’autrice nelle prime pagine del libro che la scelta del sintagma “il silenzio della tortura” è motivata soprattutto dai tanti significati che esso può assumere, che mettono efficacemente in luce aspetti diversi della pratica della tortura: i suoi effetti sulle vittime, sul loro corpo e sulla loro psiche; le conseguenze sociali di essa, sia per chi la tortura la subisce sia per chi la pratica, ma anche per chi di fatto con essa convive, poiché cittadino di uno Stato che, esplicitamente o surrettiziamente ne fa uso, e così via. Infatti c’è il silenzio di governi, apparati di polizia e Stati che nascondono o minimizzano i supplizi che infliggono, ma c’è anche il silenzio indifferente dell’opinione pubblica che non crede (o non vuole credere, per falsa coscienza) che in pieno XXI secolo e in paesi sedicenti democratici una cosa “barbara” e “medievale” quale è la tortura venga praticata come strumento di potere o che con disarmante velocità presto dimentica e archivia anche i casi peggiori e più evidenti di ricorso alla tortura, che per qualche tempo hanno risvegliato l’attenzione collettiva. Da questo punto di vista le vicende italiane successive ai fatti di Genova 2001 sono davvero paradigmatiche. Ed anche più recentemente, in occasione della approvazione della legge in Senato, ad una “impennata” di attenzione per l’argomento su media e giornali, hanno poi fatto seguito, di nuovo, indifferenza e non curanza, quasi che la questione sia per il nostro paese così irrilevante e così lontana da non meritare se non la fugace considerazione di qualche titolo di prima pagina per non più di un paio di giorni.
L’Italia con il suo reiterato diniego a legiferare in materia e a definire la tortura come fattispecie penale appare di tale silenzio un paradigma. […] Ebbene, che nel nostro paese si torturi e che per di più la colpevole lacuna del nostro ordinamento giuridico, che non prevede nel Codice penale la fattispecie del reato di tortura, persista, rappresentano un punto di depressione morale e di deficit democratico non scusabile (pp. 7-8)
La tortura – osserva Lalatta Costerbosa – è un sistema eccezionale di produzione di violenza pubblica (p. 5) e la sua intenzionalità è l’annientamento psichico, attraverso l’inflizione di atti di estrema violenza fisica e psichica, di colui su cui si accanisce. Le finalità sono la disumanizzazione, l’animalizzazione della vittima, la distruzione della sua personalità e della sua dignità di uomo e spesso la brutalità incommensurabilmente eccessiva della tortura va anche al di là della sola violenza fisica. È l’Altro – in quanto uomo su cui viene esercitato un potere assoluto, totale e a cui non si può sottrarre – che viene annientato, cioè privato della sua umanità; ma – spiega l’autrice – la brutalizzazione dell’Altro necessita come conditio sine qua non della disumanizzazione del Medesimo, cioè dell’imbarbarimento innanzi tutto del carnefice stesso.
Nel primo capitolo il concetto del “silenzio della tortura” viene declinato/articolato secondo alcuni significati fondamentali: il silenzio come occultamento, come menzogna, come deserto interiore, il silenzio dell’aguzzino e nella società. Nonostante la convinzione dei sostenitori della tortura – soprattutto nel clima securitario ormai inarginabile e parossistico post 11 settembre – che essa serva a “far parlare”, in realtà, sostiene con fermezza l’autrice, essa produce solo silenzio o, in alternativa, “menzogna”.
Dal punto di vista politico è dall’età moderna in poi che la menzogna comincia ad assumere un significato diverso ed ulteriore rispetto a quello tradizionale di arcana imperii, di segreto di Stato, cioè di una verità occultata, celata per tornaconto del potere; la menzogna si fa “azione”, diviene performativa, in quanto incide sulla realtà, di fatto creandone una nuova, costruendo una verità. La menzogna in questo modo pone in essere una “verità falsa”, che però vale come vera; si tratta di una “verità predisposta di fatto”, cioè di una falsificazione pubblicamente esibita, che inoltre capovolge il paradigma tradizionale della menzogna, che non è più sinonimo di segretezza ed occultamento, ma di esibizione. Si tratta di menzogne che per poter essere efficaci devono essere conosciute da tutti o dalla maggioranza. La menzogna come arcana imperii era una strategia politica che, secondo Machiavelli, il principe doveva padroneggiare, ma
ben diversa è la menzogna chiamata in causa dalla prassi della tortura, il mentire come invenzione programmatica di concetti, ideologie, fatti, documenti allo scopo di affermare o consolidare un regime politico: di creare una nuova realtà, funzionale al proprio interesse o potere. […] Come viene dimostrato tragicamente dal sistema del lager novecentesco, ove le menzogne alimentate ed escogitate tramite la tortura si resero determinanti per il suo funzionamento e per la sua sopravvivenza (pp. 13-14).
La menzogna politica intesa come creazione/imposizione di una realtà falsa diventa consustanziale al processo di legittimazione dell’ordine politico e va a colmare «il deficit di legittimazione del potere che inaugura la modernità» (p. 16); carenza dovuta al venir meno di altri elementi fondanti la legittimità del potere di ordine teologico, teocratico, feudale e che impone all’ordine politico la necessità di autogiustificarsi, di autofondarsi, producendo rappresentazioni della realtà. Pertanto, la menzogna – anche la tortura in quanto «sorgente di menzogne» (p. 15) –
corrisponde a tale esigenza a due livelli. Da un lato, si presenta una potenza immaginativa che prospetta nuove realtà dotate di senso ed espressione di un nuovo ordine. Dall’altro lato, si profila una potenza immaginativa asservita all’invenzione di nemici esterni e interni, funzionale a inculcare nella massa delle persone l’idea della cogenza di un potere forte che sappia restituire la perduta sicurezza, garantire la tranquillità, superare l’endogena incertezza, fonte di paura diffusa e pervasiva nella società intera (p. 17).
La caccia alle streghe dal Trecento al Seicento perfettamente risponde a queste esigenze e corrisponde a queste dinamiche.
 Se l’attenzione poi si sposta dalla vittima al persecutore (“Il silenzio nell’aguzzino”), allora occorre innanzi tutto comprendere come la tortura interrompa «ogni canale comunicativo sensoriale, intellettuale ed emotivo, creando il deserto attorno alla vittima e pietrificando anche il torturatore che per divenire tale ha attraversato […] un processo di estraneazione e riconversione della propria morale e della propria personalità» (p. 23). Insomma, affinché il persecutore possa portare a termine il proprio lavoro di annientamento fisico e psichico della vittima occorre che lui stesso annienti in sé la propria umanità per poi umiliare ed annichilire quella altrui, con l’essenziale differenza – osserva più che opportunamente l’autrice – che nel caso dell’aguzzino si tratta di un processo di disumanizzazione consapevole, o quanto meno dell’assunzione cosciente di un ruolo che per essere svolto comporta la riduzione a zero della propria umanità, l’annullamento di ogni forma di empatia e compassione per l’altro, cioè una assoluta “ottusità emotiva” – argomenta Lalatta Costerbosa sulla scorta delle riflessioni di Hanna Arendt sulla “banalità del male” dei tanti Eichmann della storia – che consiste nella «carenza di discernimento e di disponibilità al giudizio e alla ponderazione [che rendono il torturatore ] – appaesatosi nel meccanismo burocratico e gerarchico che gli conferisce un ruolo e un movente – capace di infliggere supplizi disumani» (p. 25).
Se l’attenzione poi si sposta dalla vittima al persecutore (“Il silenzio nell’aguzzino”), allora occorre innanzi tutto comprendere come la tortura interrompa «ogni canale comunicativo sensoriale, intellettuale ed emotivo, creando il deserto attorno alla vittima e pietrificando anche il torturatore che per divenire tale ha attraversato […] un processo di estraneazione e riconversione della propria morale e della propria personalità» (p. 23). Insomma, affinché il persecutore possa portare a termine il proprio lavoro di annientamento fisico e psichico della vittima occorre che lui stesso annienti in sé la propria umanità per poi umiliare ed annichilire quella altrui, con l’essenziale differenza – osserva più che opportunamente l’autrice – che nel caso dell’aguzzino si tratta di un processo di disumanizzazione consapevole, o quanto meno dell’assunzione cosciente di un ruolo che per essere svolto comporta la riduzione a zero della propria umanità, l’annullamento di ogni forma di empatia e compassione per l’altro, cioè una assoluta “ottusità emotiva” – argomenta Lalatta Costerbosa sulla scorta delle riflessioni di Hanna Arendt sulla “banalità del male” dei tanti Eichmann della storia – che consiste nella «carenza di discernimento e di disponibilità al giudizio e alla ponderazione [che rendono il torturatore ] – appaesatosi nel meccanismo burocratico e gerarchico che gli conferisce un ruolo e un movente – capace di infliggere supplizi disumani» (p. 25).
Di fronte alla tortura» – riflette l’autrice, in conclusione della sua analisi dei principali significati del “silenzio della tortura” e considerando in particolare l’ultimo, il “silenzio nella società”, ovvero l’interruzione delle condizioni di possibilità della relazione sociale che isola il torturato, privato della sua integrità e dignità umane – «in definitiva perdono tutti, individualmente e collettivamente. Perde il torturatore; perde il torturato, comunque riesca, scelga o non scelga di comportarsi; perde la società che ha accolto e non ha offerto adeguata resistenza a un germe maligno che costituisce il principio certo della propria disintegrazione (p. 27).
Di grande interesse è l’excursus storico che Lalatta Costerbosa compie nel secondo capitolo, il più lungo dei sei che compongono il libro, riguardo alla riflessione intellettuale sulla pratica della tortura, sulla sua giustificazione o sulla sua condanna. Per quel che riguarda il primo caso, sono Machiavelli, Bodin e i domenicani Kramer e Sprenger, autori del quattrocentesco manuale inquisitoriale contro le streghe, il Malleus maleficarum, i riferimenti proposti al fine di mostrare come la tortura, nel corso della sua lunga storia, abbia visto via via prevalere la sua funzione di “strumento politico” per il rafforzamento dell’autorità del potere su quella di “strumento giudiziario” per ottenere ed estorcere in fase processuale confessioni da testimoni o sospetti. Ma a partire dallo stesso Cinquecento prende il via una letteratura che della tortura denuncia la disumanità, l’irrazionalità nonché l’inaccettabilità morale e l’inefficacia giudiziaria; tutti temi questi che la riflessione illuministica settecentesca svilupperà per approdare finalmente ad una condanna senza appello della pratica del supplizio.
In questo caso l’autrice considera il filosofo spagnolo di inizio XVI secolo Juan Luis Vives, che denuncia l’irrazionalità della tortura in quanto disumana ed inutile, e altri grandi pensatori del secolo come Michel de Montaigne, Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro, che propongono considerazioni analoghe, per poi affrontare più dettagliatamente il testo del 1631 contro i processi alle streghe e contro la tortura del gesuita tedesco Friedrich von Spee – Cautio criminalis – che può essere considerato «uno dei testi più generosi sotto il profilo argomentativo, sebbene uno dei meno noti e frequentati sul tema» (p. 34). Sulla base di un impianto teorico giusnaturalistico e del principio morale della compassione, il religioso tedesco enuclea numerosi argomenti contrari alla tortura quali l’ingiustificabilità della discrezionalità nella sanzione della pena; la violazione del diritto ad una difesa adeguata; l’infondatezza della teoria del doppio effetto per cui «il movente dell’azione ne qualifica la moralità o meno», dal momento che «non si possono commettere cattive azioni per conseguire il bene» (p. 36); la perdita della dignità e l’infamia causate dal supplizio; l’inutilità della tortura al punto da risultare controproducente al fine dell’accertamento della verità, poiché facilmente induce a confessioni false mosse solamente dal disperato tentativo di far cessare i tormenti; l’eccesso, la gratuità e di conseguenza l’immoralità delle sofferenze inflitte. Anticipatrici di riflessioni successive sono anche le osservazioni che von Spee propone circa le ragioni dell’impiego della tortura, da cui emerge «con nettezza anche la motivazione politica, la strategia di affermazione e di consolidamento del potere attraverso l’esibizione dell’arbitrio» (p. 38).
Col passaggio al secolo dei Lumi le voci che si sollevano contro l’abominio della tortura si moltiplicano e quelle considerate da Lalatta Costerbosa vanno da Christian Thomasius a Ludovico Antonio Muratori, da Cesare Beccaria e Pietro Verri, da Wilhelm von Humboldt a Voltaire, da Gaetano Filangieri a Immanuel Kant e le argomentazioni a supporto della comune tesi di fondo riguardano l’opposizione al diritto di natura ovvero alla retta ragione; la violazione del principio della presunzione di innocenza; l’eccesso e la sproporzione della violenza della pena; l’arbitrarietà della stessa e l’abuso di potere che la sottende; l’assoluta l’inutilità, soprattutto dal punto di vista giudiziario, del supplizio, che – sono le note parole di Beccaria in Dei delitti e delle pene – “è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e condannare i deboli innocenti”; l’intrinseca ingiustizia di una pratica che equipara in modo del tutto immotivato il reo e l’innocente, che sono sottoposti al medesimo trattamento, con la conseguenza che – ancora una volta sono parole del Beccaria – “l’innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare”.
E in conclusione dell’esauriente excursus storico e dottrinale, così osserva acutamente e puntualmente sintetizza la studiosa:
Questo sul finire del Settecento, questo tre secoli fa. Ciononostante, dopo questo tuffo nel passato dei tormenti, lampante ci sembra l’odierno ricorrere di vecchi pretesti e cattivi argomenti, magari frettolosamente rinnovati […]. La tortura – per sintetizzare – ha una doppia natura: è giudiziaria e politica. La tortura è inutile per l’interesse pubblico e produce effetti paradossali per il caso giudiziario e per la stabilità dell’ordine politico. La tortura è ingiusta per almeno quattro ragioni: viola il principio di presunzione di innocenza; implica il misconoscimento dei diritti fondamentali, in particolare e innanzitutto del diritto alla vita; è essenzialmente eccessiva e non può essere moderata da norme giuridiche; non può essere giustificata dalla tradizione; porta con sé l’infamia (o l’autopercezione di essa). […] Eppure, queste idee non sembrano oggi così unanimemente condivise; e vengono nuovamente messe in discussione (pp. 54-55).
E non si può che condividere anche questa ulteriore osservazione di Marina Lalatta Costerbosa: «La nostra impressione è, in definitiva, che anche queste circostanze […] mostrino il carattere regressivo del momento presente, un momento nel quale sotto questo specifico profilo legato alla tortura, i diritti soggettivi sembrano “avere un prezzo”: il prezzo della cosiddetta sicurezza pubblica» (p. 55).
La storia recente della “democrazia” occidentale, almeno dalla fondamentale svolta dell’11 settembre 2001 in poi, è prova provata di una deriva autoritaria e repressiva, intollerante e profondamente antidemocratica, di cui è al momento impossibile intravedere la conclusione e che ha riportato in auge, nella pratica e nella teoria, nella predisposizione e nell’utilizzo di violenti strumenti coercitivi di esercizio del potere e nella riflessione giustificazionista di un’intellighenzia prezzolata che si presenta con l’abito del crudo pragmatismo securitario, quanto secoli di riflessione e di progresso giuridico e civile avevano relegato nella categoria dell’esecrabile (per quanto il suo utilizzo, in realtà, non fosse mai stato abbandonato).
Tra gli argomenti attualmente più diffusi a sostegno della legittimità del ricorso alla tortura troviamo – osserva l’autrice – quello del “caso di emergenza”, secondo il quale dinanzi a circostanze eccezionali la sospensione del diritto sarebbe non solo possibile, ma addirittura necessaria e, in secondo luogo, quello della “sicurezza pubblica”, intesa come finalità primaria ed assoluta del potere sovrano, rispetto alla quale anche i diritti fondamentali vanno in subordine. Oppure quello – che sfiorerebbe la comicità, se non fosse tragico – che presume che sia possibile infliggere un supplizio “temperato” da limiti e principi morali accettabili: è la teoria – spiega Lalatta Costerbosa – del «torture warrant, l’autorizzazione giudiziale alla tortura da lasciare al libero convincimento del giudice» (p. 60), che, pertanto, in maniera pubblica e “responsabile”, valuterebbe circa la necessità della tortura.
Ma il ragionamento che in un certo senso fa e da sintesi e da fondamento di tutti gli altri è «quello dal tratto demagogico più spiccato, l’argomento di chiara matrice utilitaristica, declinato in una direzione specifica negli anni Novanta dall’autorevole sociologo Niklas Luhmann e divulgato in innumerevoli circostanze e sedi come argomento della “bomba a orologeria”, della ticking-bomb» (p. 61), che – come già osservato in precedenza – conduce alla relativizzazione di qualsiasi principio, norma o diritto in relazione a situazioni pericolose ritenute gravemente lesive della sicurezza della società: in buona sostanza, oggi non esisterebbero norme irrinunciabili nelle nostre società dinanzi, poniamo, al pericolo terroristico costituito dalla presenza di ordigni innescati e predisposti all’esplosione o di criminali pronti all’azione.
Una simile meschinità di pensiero lascia facilmente intravedere dietro l’apparenza del fine giudiziario – comunque ingiustificabile – quale sia la vera finalità della tortura, anche quando teorizzata e sostenuta attraverso la teoria della ticking-bomb, cioè quella politica; pertanto non si tratta tanto di operare in modo “estremo” ed “eccezionale” per sventare un pericolo assoluto, ottenendo confessioni e informazioni utili, ma si tratta, in realtà, di esibire in maniera indubitabile la forza e la capacità di produzione di violenza del potere politico dello Stato.
È in un contesto complessivo di questo genere che, dopo decenni di inaccettabile e colpevole silenzio, le istituzioni legislative italiane hanno affrontato il doveroso compito del riconoscimento della tortura come fattispecie di reato; circostanze non certo favorevoli per la stesura di una legge chiara, inflessibile ed inequivocabile quale un crimine esecrando come questo esigerebbe, caratteristiche che, infatti, il testo della norma recentemente licenziata dal Senato – lo si è detto in precedenza – fin troppo evidentemente non possiede.
]]>
Oggi nel liceo “Claudio Cavalleri” di Parabiago il suono della prima campanella sarà più triste del solito. Mancherà a quel liceo e ai suoi studenti un bravo insegnante e un uomo sincero, Valter Binaghi. Per ricordarlo, a due mesi dalla sua dipartita, pubblico il testo di un mio intervento a un seminario sulla didattica dello scorso novembre.
In prima battuta vorrei spiegare il senso del titolo che ho dato a questo mio intervento. Sono convinto – e cercherò di dimostrarlo – che il sistema scolastico, e più in generale quello degli apprendimenti, non abbia [...]]]>

Oggi nel liceo “Claudio Cavalleri” di Parabiago il suono della prima campanella sarà più triste del solito. Mancherà a quel liceo e ai suoi studenti un bravo insegnante e un uomo sincero, Valter Binaghi. Per ricordarlo, a due mesi dalla sua dipartita, pubblico il testo di un mio intervento a un seminario sulla didattica dello scorso novembre.
In prima battuta vorrei spiegare il senso del titolo che ho dato a questo mio intervento. Sono convinto – e cercherò di dimostrarlo – che il sistema scolastico, e più in generale quello degli apprendimenti, non abbia bisogno tanto di un elenco di materie e argomenti, quanto di una riflessione sugli strumenti con cui si agisce e si interagisce nel capo dell’apprendimento. È chiaro che parlare di strumenti cognitivi, piuttosto che di argomenti o materie, significa focalizzare l’attenzione non sui “contenuti”, ma su quelli che l’idioletto burocratico-scolastico chiama “competenze” e “capacità”, e che io preferisco chiamare strutture logico-cognitive. Cerco di chiarire subito questo concetto con un esempio che viene da un autore – Raoul Vaneigem – che assieme a Bateson costituisce per me la stella polare di una didattica libertaria. Scrive Vaneigem, nel suo Avviso agli studenti [ qui una sintesi,
qui una sintesi,  qui il testo integrale], che «una scuola in cui la vita si annoia educa solo alla barbarie». Cosa c’è un questa affermazione? In primo luogo, la centralità della vita, del bios: non questa o quella vita, tantomeno quel fumoso concetto di vita che viene agitato in modo apodittico e selettivo dai difensori del cosiddetto “diritto alla vita sin dal concepimento”. La vita di cui qui si tratta è quella concreta, materiale, di tutti i partecipanti all’interazione educativa, quella vita che ci attraversa tutti senza essere specificamente “posseduta” da alcuno, perché di essa non si può fare oggetto di possesso. Una vita che ha dei diritti, radicati nella potenza di essere e di metamorfosi che costituisce la sua stessa essenza. Di quale barbarie parla Vaneigem? Dell’educazione all’ordine gerarchico, all’apprendimento passivo, all’obbedienza. All’accettazione dei rapporti umani fondati sulla riduzione dell’essere umano a merce, all’interno di «un angusto orizzonte giuridico che costringe a calcolare con la durezza di uno Shylock: non avrò per caso lavorato mezz’ora più di un altro, non avrò guadagnato un salario inferiore a un altro?» Di cosa ha bisogno, per contro, una vita per non cadere nella noia, e con essa nell’acritica accettazione della barbarie? In un paese civile non ci dovrebbe essere bisogno di un magistrato anti-mafia per ricordare che le scuole dovrebbero essere ampie, belle e colorate: ma se il paese ha perso il senso della civiltà che dimora nel giusto valore che pretendono la scuola, gli insegnanti e i discenti, ben venga la parola di Nicola Gratteri a ricordarcelo. Perché la dimensione, il colore e il valore estetico dell’ambiente non sono orpelli o accessori: sono parte integrante di uno scambio educativo all’interno del quale ciò che è in questione è la ricchezza, ovvero la miseria, degli stimoli cognitivi, e con essi dell’arricchimento della mente, della maturazione di una coscienza critica, di una mente educata alla pluralità delle logiche e delle strategie operative nella ricostruzione dei rapporti di causa ed effetto. Sono temi che un tempo erano relegati nelle utopie educative dei don Milani o degli Ivan Ilic, e che oggi sono al centro di quella rivoluzione epistemologica che ruota attorno alla scoperta delle intelligenze multiple, e del funzionamento dei neuroni a specchio: scoperte che non vanno mitizzate – reitrodurremmo altrimenti un oggettivismo scientifico di sapore ottocentesco –, ma che ci rafforzano nel convincimento che l’ambiente e l’interazione sono parte integrante del processo cognitivo.
qui il testo integrale], che «una scuola in cui la vita si annoia educa solo alla barbarie». Cosa c’è un questa affermazione? In primo luogo, la centralità della vita, del bios: non questa o quella vita, tantomeno quel fumoso concetto di vita che viene agitato in modo apodittico e selettivo dai difensori del cosiddetto “diritto alla vita sin dal concepimento”. La vita di cui qui si tratta è quella concreta, materiale, di tutti i partecipanti all’interazione educativa, quella vita che ci attraversa tutti senza essere specificamente “posseduta” da alcuno, perché di essa non si può fare oggetto di possesso. Una vita che ha dei diritti, radicati nella potenza di essere e di metamorfosi che costituisce la sua stessa essenza. Di quale barbarie parla Vaneigem? Dell’educazione all’ordine gerarchico, all’apprendimento passivo, all’obbedienza. All’accettazione dei rapporti umani fondati sulla riduzione dell’essere umano a merce, all’interno di «un angusto orizzonte giuridico che costringe a calcolare con la durezza di uno Shylock: non avrò per caso lavorato mezz’ora più di un altro, non avrò guadagnato un salario inferiore a un altro?» Di cosa ha bisogno, per contro, una vita per non cadere nella noia, e con essa nell’acritica accettazione della barbarie? In un paese civile non ci dovrebbe essere bisogno di un magistrato anti-mafia per ricordare che le scuole dovrebbero essere ampie, belle e colorate: ma se il paese ha perso il senso della civiltà che dimora nel giusto valore che pretendono la scuola, gli insegnanti e i discenti, ben venga la parola di Nicola Gratteri a ricordarcelo. Perché la dimensione, il colore e il valore estetico dell’ambiente non sono orpelli o accessori: sono parte integrante di uno scambio educativo all’interno del quale ciò che è in questione è la ricchezza, ovvero la miseria, degli stimoli cognitivi, e con essi dell’arricchimento della mente, della maturazione di una coscienza critica, di una mente educata alla pluralità delle logiche e delle strategie operative nella ricostruzione dei rapporti di causa ed effetto. Sono temi che un tempo erano relegati nelle utopie educative dei don Milani o degli Ivan Ilic, e che oggi sono al centro di quella rivoluzione epistemologica che ruota attorno alla scoperta delle intelligenze multiple, e del funzionamento dei neuroni a specchio: scoperte che non vanno mitizzate – reitrodurremmo altrimenti un oggettivismo scientifico di sapore ottocentesco –, ma che ci rafforzano nel convincimento che l’ambiente e l’interazione sono parte integrante del processo cognitivo.
Mi sto muovendo (credo lo si sia capito) all’interno di quell’orizzonte delineato cinque secoli or sono da Michel Eyquem, signore di Montaigne (ma potrei citare con pari dignità la mente poetica e gli universali fantastici di Giambattista Vico): «per un figlio di buona famiglia che si volga alle lettere, non per guadagno (perché uno scopo tanto abietto è indegno della grazia e del favore delle Muse, e poi riguarda gli altri e dipende dagli altri), e non tanto per i vantaggi esteriori quanto per i suoi personali, e per arricchirsene e ornarsene nell’intimo, se si desidera farne un uomo avveduto piuttosto che un dotto, vorrei che si avesse cura di scegliergli un precettore che avesse la testa ben fatta piuttosto che ben piena, e che si richiedessero in lui ambedue le cose, ma più i costumi e l’intelligenza che la scienza» (Saggi, I, 26). Questo precettore, prosegue Montaigne, dovrebbe far sì che il discepolo gusti, scelga e discerna le cose da sé; dovrebbe saper ascoltare il discepolo, e non parlare lui solo; dovrebbe sapersi adattare alle possibilità dell’allievo con giusta proporzione, piuttosto che cercare di governare una molteplicità di spiriti col una sola e medesima lezione per tutti; che sappia giudicare il profitto che l’allievo avrà tratto non dalle prove della memoria, ma da quelle della vita; che faccia esporre ciò che l’allievo ha appreso in cento guise e adattamenti diversi; che gli faccia vagliare ogni cosa e non gli metta in testa nulla con la sua sola autorità. L’insegnamento di cui scrive Montaigne necessita della libertà che è negata tanto al cortigiano, e ha luogo nel commercio con gli uomini, nell’osservazione e nella conoscenza attiva di uomini, linguaggi e contesti diversi da quello di appartenenza – compreso quello familiare: «Dal frequentare la gente si ricava una meravigliosa chiarezza per giudicare gli uomini. […] Questo gran mondo, che alcuni moltiplicano ancora come specie sotto un genere, è lo specchio in cui dobbiamo guardare per conoscerci per il verso giusto. Insomma, voglio che questo sia il libro del mio scolaro».
Ciò che Montaigne ha compreso in modo mirabile è che il perimetro dell’orizzonte educativo è la linea di un’ellisse, perché l’apprendimento è un processo che ruota attorno a non uno, ma due fuochi: il docente e il discente. E che ciascuno dei due fuochi può scambiare il proprio posto con l’altro.
La testa ben fatta di cui parla Montaigne è una testa che apprende ciò che serve a renderla più saggia e migliore, e che con questi mezzi affronta le diverse discipline e i loro contenuti, per venire a capo della scienza che tale testa sceglierà. Se teniamo ben salda come stella polare questa riflessione, dobbiamo chiederci come e cosa deve insegnare la testa ben fatta del precettore del terzo millennio, a fronte di una crisi e di un mutamento di paradigma globale la cui radicalità non è minore della crisi e dei nuovi paradigmi che Montaigne intuì sul crinale del Rinascimento.
Ma lasciamo, prima di affrontare questo passaggio, un’ultima volta la parola al 26° capitolo del primo libro dei Saggi: «Come Anassimene scriveva a Pitagora: “con che coraggio posso perdere il mio tempo a conoscere il segreto delle stelle, quando davanti agli occhi ho sempre presente o la morte o la schiavitù?”, ognuno deve dire così: “Agitato dall’ambizione, dalla cupidigia, dalla temerarietà, dalla superstizione, e avendo dentro di me altri simili nemici della vita, mi metterò a pensare al moto del mondo?”».
La metafora di un nemico alle porte è, nel testo di Montaigne, il significante per alludere a quelle che Spinoza avrebbe poi chiamato “passioni tristi”, nemiche della vita perché asservitrici e disciplinatrici della mente. Nell’epoca presente, io credo che si possa rafforzare l’immagine dei persiani per indicare dei nemici reali della vita e della mente, attraverso i quali comprendere meglio cos’è la scuola del terzo millennio, e come al suo interno si debba agire.
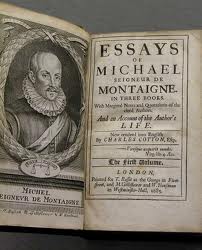 Perché abbia senso la questione di cosa insegnare a scuola, è necessario che vi sia una scuola, e che tale scuola sia, in senso ampio, “pubblica”. Quando si parla di “scuola pubblica”, si intende non solo e non tanto il suo gestore o amministratore, quanto l’insieme di valori pubblici e diritti (e correlati doveri) cui l’attributo “pubblico” allude: e cioè a quella capacità, sancita dalla Costituzione di essere cittadini attivi, ossia di esercitare in maniera autonoma e critica i correlati diritti costituzionali. Si allude, per chi parla con cognizione di causa, a una “scuola costituzionale” che non si riduce al solo articolo 3 della Costituzione. Qui possiamo solo nominare un problema che resta sullo sfondo, ma che va comunque tenuto presente: e cioè l’incapacità dello Stato di garantire, attraverso lo strumento del lavoro, la rimozione di quegli ostacoli e disuguaglianze che impediscono il pieno accesso ai diritti costituzionali e alla piena espressione della persona. Nondimeno questo tema va richiamato, perché sono proprio le trasformazioni avvenute nel campo del lavoro a rendere il lavoro non più strumento di riduzione delle disuguaglianze (posto che questa intenzione abbia avuto effettiva attuazione negli anni ormai etichettati come quelli della prima repubblica). Una scuola pubblica, in definitiva, rimanda non solo all’esistenza di beni pubblici, possibilmente gratuiti o comunque accessibili a tutti, come edifici, testi scolastici e qualsivoglia supporto materiale; e all’esistenza di un congruo numero di dipendenti retribuiti dallo Stato (o dagli enti locali), la cui esistenza, come la costruzione, gestione e manutenzione degli edifici, trae linfa dalla ricchezza prodotta con la cooperazione sociale. Una scuola pubblica ha a che fare, sia in entrata (e cioè come ciò che riceve dalla società nella quale è radicata), sia in uscita (e cioè come soggetto attraversato dalle pratiche educative in senso lato, e restituito alla società in quanto trasformato dalle pratiche di soggettivazione), con l’interazione sociale, «le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via»: ossia con la capacità di produrre e criticare questi aspetti dei processi di soggettivazione, che nel burocratese invalso nella pratica didattica (dai documenti della Commissione Europea giù giù fino ai Piani di Offerta Formativa delle singole scuole) si riassume in indeterminati elenchi di “competenze” e “capacità”. E questo diventa ancor più vero con l’ingresso nella società dell’informazione, del capitalismo cognitivo e della produzione di merci immateriali. E dunque, piuttosto che difendere una parola ormai screditata (e ormai inadeguata) come “pubblico”, sembra più utile ricorrere al concetto di “comune”, quel common del commonwealth nel quale risuona l’accezione originaria del Comune virtuoso esaltato dal Machiavelli dei Discorsi: con le parole di Negri e Hardt (Comune. Oltre il pubblico e il privato), «il comune di cui si sta parlando non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti». Un’accezione che risalta ancor di più se prendiamo come riferimento il termine antitetico, e cioè “privato”, nella sua accezione più autentica: e cioè quella di privatus. Il privatus, nel diritto romano, è colui al quale manca qualcosa, perché si priva della relazione pubblica, cioè del pubblico interesse: di quel inter hominem esse in cui, secondo Cicerone, consiste il vero significato di “interesse”.
Perché abbia senso la questione di cosa insegnare a scuola, è necessario che vi sia una scuola, e che tale scuola sia, in senso ampio, “pubblica”. Quando si parla di “scuola pubblica”, si intende non solo e non tanto il suo gestore o amministratore, quanto l’insieme di valori pubblici e diritti (e correlati doveri) cui l’attributo “pubblico” allude: e cioè a quella capacità, sancita dalla Costituzione di essere cittadini attivi, ossia di esercitare in maniera autonoma e critica i correlati diritti costituzionali. Si allude, per chi parla con cognizione di causa, a una “scuola costituzionale” che non si riduce al solo articolo 3 della Costituzione. Qui possiamo solo nominare un problema che resta sullo sfondo, ma che va comunque tenuto presente: e cioè l’incapacità dello Stato di garantire, attraverso lo strumento del lavoro, la rimozione di quegli ostacoli e disuguaglianze che impediscono il pieno accesso ai diritti costituzionali e alla piena espressione della persona. Nondimeno questo tema va richiamato, perché sono proprio le trasformazioni avvenute nel campo del lavoro a rendere il lavoro non più strumento di riduzione delle disuguaglianze (posto che questa intenzione abbia avuto effettiva attuazione negli anni ormai etichettati come quelli della prima repubblica). Una scuola pubblica, in definitiva, rimanda non solo all’esistenza di beni pubblici, possibilmente gratuiti o comunque accessibili a tutti, come edifici, testi scolastici e qualsivoglia supporto materiale; e all’esistenza di un congruo numero di dipendenti retribuiti dallo Stato (o dagli enti locali), la cui esistenza, come la costruzione, gestione e manutenzione degli edifici, trae linfa dalla ricchezza prodotta con la cooperazione sociale. Una scuola pubblica ha a che fare, sia in entrata (e cioè come ciò che riceve dalla società nella quale è radicata), sia in uscita (e cioè come soggetto attraversato dalle pratiche educative in senso lato, e restituito alla società in quanto trasformato dalle pratiche di soggettivazione), con l’interazione sociale, «le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via»: ossia con la capacità di produrre e criticare questi aspetti dei processi di soggettivazione, che nel burocratese invalso nella pratica didattica (dai documenti della Commissione Europea giù giù fino ai Piani di Offerta Formativa delle singole scuole) si riassume in indeterminati elenchi di “competenze” e “capacità”. E questo diventa ancor più vero con l’ingresso nella società dell’informazione, del capitalismo cognitivo e della produzione di merci immateriali. E dunque, piuttosto che difendere una parola ormai screditata (e ormai inadeguata) come “pubblico”, sembra più utile ricorrere al concetto di “comune”, quel common del commonwealth nel quale risuona l’accezione originaria del Comune virtuoso esaltato dal Machiavelli dei Discorsi: con le parole di Negri e Hardt (Comune. Oltre il pubblico e il privato), «il comune di cui si sta parlando non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti». Un’accezione che risalta ancor di più se prendiamo come riferimento il termine antitetico, e cioè “privato”, nella sua accezione più autentica: e cioè quella di privatus. Il privatus, nel diritto romano, è colui al quale manca qualcosa, perché si priva della relazione pubblica, cioè del pubblico interesse: di quel inter hominem esse in cui, secondo Cicerone, consiste il vero significato di “interesse”.
In questa accezione risuona il sempre attuale argomento di Thomas Paine in favore dell’egualitarismo, che nella riformulazione di Guy Standing suona così:
«Tutti noi dobbiamo il nostro benessere sociale ed economico agli sforzi delle innumerevoli generazioni dei nostri antenati. È palesemente disonesto predicare che il reddito rifletta una distribuzione meritocratica, che coloro che diventano ricchi lo fanno grazie al loro merito e impegno. In una certa misura, qualcuno fa meglio di altri col duro lavoro e la vivacità d’ingegno. Ma l’eredità collettiva è qualcosa che nessuno di noi, individualmente, ha donato alla società. È la ricchezza che essa rappresenta a dover essere condivisa».
Ciò che vale per la ricchezza materiale, vale a più forte ragione per la ricchezza della mente, e cioè per il sapere che non è di nessuno perché è di tutti. A questa riflessione vorrei collegare le parole di un testo sugli ambienti di apprendimento alla luce delle neuroscienze: «Il cervello umano è costantemente alla ricerca di schemi e collegamenti tra aspetti diversi della realtà esterna e tutto questo viene archiviato nella propria rete neuronale che così cresce e si sviluppa. Quando si sviluppano apprendimenti totalmente nuovi, il cervello crea nuove ramificazioni e connessioni tra i neuroni; quando invece si rafforzano apprendimenti precedenti, si ritiene che le connessioni esistenti si rafforzino per mezzo della mielinizzazione dei dendriti, e questo sembra avere effetti sulla memoria e sulla velocità con cui il cervello è in grado di gestire quel dato compito o azione. Il curricolo scolastico viene sempre presentato come un insieme di discipline diverse e separate e raramente le nuove informazioni e conoscenze vengono proposte come parti di una rete di saperi e culture precedenti. In questo modo non si favorisce la crescita di connessioni cerebrali perché le connessioni del mondo esterno vengono nascoste o frammentate. Al contrario, il modo più efficace di apprendere è quello che lega l’apprendimento a reali eventi della vita scolastica e del mondo esterno, dove nuove informazioni vanno ad aggiungersi e connettersi alle esperienze e conoscenze precedenti» (Michele Capurso, Ambienti di apprendimento per lo sviluppo umano,  qui). Come si vede, non c’è nulla di veramente nuovo per chi ha praticato la sperimentazione didattica: ma adesso abbiamo ragioni più forti per fondare le nostre buone pratiche scolastiche in direzione di una didattica trasversale e modulare.
qui). Come si vede, non c’è nulla di veramente nuovo per chi ha praticato la sperimentazione didattica: ma adesso abbiamo ragioni più forti per fondare le nostre buone pratiche scolastiche in direzione di una didattica trasversale e modulare.
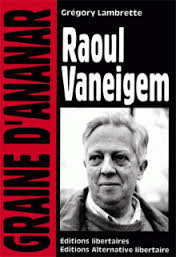 Quando, come sto facendo qui, usiamo la metafora della «testa ben fatta», non sottolineiamo a sufficienza che questa testa ben fatta è un cervello collettivo, la cui essenza è la cooperazione sia orizzontale tra soggetti docenti o discenti, sia verticale tra docenti e discenti. Non c’è forse attività umana che esprima meglio la realtà del comune che i processi di apprendimento: soprattutto nell’epoca del capitalismo cognitivo, nella quale la produzione sociale di sapere è im-mediatamente produzione di valore. Ma questa produzione biopolitica di sapere/valore è regolamentata in forma privatistica, in primo luogo dal punto di vista amministrativo: l’abolizione dell’organico funzionale (il criterio in base al quale alle scuole sarebbe stato assegnato tanto personale, quante erano le funzioni da svolgere), l’aumento dei carichi di lavoro individuali a scapito del tempo della progettazione e della condivisione, e la progressiva precarizzazione del corpo docente sono conseguenze logiche di quella privatizzazione del rapporto di lavoro che trasforma l’attività del docente in un sinallagma contrattuale, ossia in uno scambio paritario tra prestazione e salario che mette al centro la quantità di tempo lavorativo ceduto, e non il valore in sé della prestazione.
Quando, come sto facendo qui, usiamo la metafora della «testa ben fatta», non sottolineiamo a sufficienza che questa testa ben fatta è un cervello collettivo, la cui essenza è la cooperazione sia orizzontale tra soggetti docenti o discenti, sia verticale tra docenti e discenti. Non c’è forse attività umana che esprima meglio la realtà del comune che i processi di apprendimento: soprattutto nell’epoca del capitalismo cognitivo, nella quale la produzione sociale di sapere è im-mediatamente produzione di valore. Ma questa produzione biopolitica di sapere/valore è regolamentata in forma privatistica, in primo luogo dal punto di vista amministrativo: l’abolizione dell’organico funzionale (il criterio in base al quale alle scuole sarebbe stato assegnato tanto personale, quante erano le funzioni da svolgere), l’aumento dei carichi di lavoro individuali a scapito del tempo della progettazione e della condivisione, e la progressiva precarizzazione del corpo docente sono conseguenze logiche di quella privatizzazione del rapporto di lavoro che trasforma l’attività del docente in un sinallagma contrattuale, ossia in uno scambio paritario tra prestazione e salario che mette al centro la quantità di tempo lavorativo ceduto, e non il valore in sé della prestazione.
In altri termini, cospicui settori dell’istruzione “pubblica” sono oggi di fatto privatizzati. L’opposizione pubblico/privato non consente di cogliere appieno i processi di segmentazione del sistema istruzione che, frammentando e suddividendo la comunità scolastica, mirano a selezionare un’élite di cittadini in possesso di quei livelli di capacità e competenze che rendono possibili operazioni mentali complesse. Al contrario, l’opposizione di una scuola del comune alla scuola del privatus ha quindi, per noi, non una mera valenza terminologica, ma un significato politico radicale, nel quale risuona il potenziale di ricchezza umana e sociale – in una parola: la ricchezza generica, intesa come essenza costitutiva del genere umano – degli esseri umani.
Il comune, dicevo poc’anzi, è costituito dagli esseri umani, dalle relazioni che si intrecciano fra loro, dall’ambiente entro cui questi scambi avvengono. Una scuola intesa non solo come “bene comune”, ma come “bene del comune” – cioè di tutti, e perciò stesso di nessuno, non mercificabile né privatizzabile – è una scuola che mette al proprio centro quelle relazioni immateriali, ma nondimeno concretissime, che definiscono l’individuo all’interno dell’insieme, così come l’insieme a partire dalle relazioni tra individui. È qui che la riflessione si incontra con i contributi delle neuroscienze: la predisposizione all’interazione, il valore cognitivo dell’osservazione, la costruzione dello spazio esterno a partire dalla proiezione del proprio spazio interno sono processi mentali che, radicandosi nella dimensione neuronale, antecedono il soggetto, ne costituiscono le condizioni del suo manifestarsi, del suo agire, del suo inter hominem esse. Queste – chiamiamole così – “competenze” sono, in tutta evidenza, trasversali rispetto allo statuto dei saperi e delle discipline: non si tratta quindi di insegnarle attraverso nuove materie che dovrebbero soppiantare le vecchie, quanto di riformulare – o, nei casi migliori, di approfondire un processo di rinnovamento della didattica che è stato già intrapreso nelle buone pratiche scolastiche – le modalità di insegnamento di questa o quella disciplina, mettendone al centro non i contenuti, ma ciò a cui i contenuti alludono. Si insegna l’interazione attraverso una didattica orizzontale, dialogante, interattiva; si insegna ad imparare osservando, secondo quel processo di deutero-apprendimento che Bateson considerava, a giusta ragione, una risposta alla crisi ecologica della nostra epoca, in ambienti (classi, laboratori, spazi comuni) predisposti per metratura, arredo e numero degli abitanti all’osservazione reciproca tra docente e allievi. Si insegna l’interazione – e con essa si stimola lo sviluppo psico-fisico della mente – attraverso l’interazione dei docenti nei moduli scolastici, che invece di essere rimossi dalla scuola di base dovrebbero essere estesi alla scuola secondaria tutta; e attraverso le compresenze, che invece di essere considerate un costo da tagliare dovrebbero essere valutate in ragione del prezioso contributo che esse danno allo sviluppo mentale degli allievi.
Vorrei fare qui un esempio concreto, che riguarda le competenze più strettamente logiche. A lungo ho pensato che la logica, quantomeno quella di base, e cioè quella aristotelica, dovesse assumere dignità di materia a sé stante, e tutt’ora non mi spiacerebbe insegnare questa materia, come mi è capitato di fare per alcuni anni alle matricole di giurisprudenza, a Ferrara. Ma, più ancora che i contenuti della logica, credo che sia importante favorire lo sviluppo di una mente predisposta ad operare giudizi logicamente coerenti tanto nei processi quanto nella motivazione dei giudizi, mettendo in rete, attraverso una didattica interdisciplinare, quelle discipline che sono strutturalmente predisposte a sviluppare queste competenze: e parlo non solo, com’è ovvio, della matematica e della filosofia, ma anche delle lingue (col loro correlato strumento dell’analisi logica), e tra queste in primo luogo di quel latino tanto bistrattato, e che oggi non sappiamo, e spesso non vogliamo più insegnare, perché non ne capiamo il valore. Dimenticando che nella storia, recente e lontana, non c’è popolo che non abbia attinto ai classici latini per trovare esempi atti a rafforzare la volontà di ribellione contro la tirannide.
Un secondo esempio è la cosiddetta “Cittadinanza e Costituzione”, un aborto di materia nato a partire da un’idea errata e retrograda della didattica – occorre dirlo, a dispetto del fatto che tra i suoi sostenitori ci sia stato il presidente Napolitano: che la cosiddetta “educazione civica”, definizione peraltro nobilissima, dovesse essere insegnata all’interno di uno specifico curricolo, invece di scaturire dall’interazione collegiale. Chiedo, provocatoriamente: insegna ad essere un buon cittadino l’insegnante di storia che fa la storia della Costituzione, l’insegnante di lingue straniere che fornisce gli strumenti per praticare una reale interazione, pratica e osservativa, delle vite e dei costumi altrui, o l’insegnante di educazione motoria che insegna a praticare il rispetto dell’altro all’interno di regole condivise e accettate? La risposta è, com’è naturale: tutti e tre, se ciò che fanno lo fanno di concerto. Non certo il primo, se ciò che fa lo fa da solo, e magari attraverso un apprendimento mnemonico.
 Avevo citato, accanto alle neuroscienze, il contributo della teoria delle intelligenze multiple, a partire dalle ricerche di Howard Gardner. L’individuazione di almeno nove diverse intelligenze (il cui numero potrebbe estendersi se venisse confermata l’intuizione che anche alcune emozioni hanno dignità di intelligenza) – Linguistica, Logico-Matematica, Spaziale, Corporeo-Cinestesica, Musicale, Interpersonale, Intrapersonale, Naturalistica, Esistenziale – è rilevante non solo per lo specifico di ciascun ambito, ma soprattutto per la scoperta che le diverse intelligenze si sostengono l’un l’altra come un pacchetto di mischia nel rugby: la necessità di una pluralità di discipline – e qui sottolineo l’educazione musicale, particolarmente penalizzata dalla riforma Gelmini –, e della loro reciproca interazione, trova qui un ulteriore fondamento.
Avevo citato, accanto alle neuroscienze, il contributo della teoria delle intelligenze multiple, a partire dalle ricerche di Howard Gardner. L’individuazione di almeno nove diverse intelligenze (il cui numero potrebbe estendersi se venisse confermata l’intuizione che anche alcune emozioni hanno dignità di intelligenza) – Linguistica, Logico-Matematica, Spaziale, Corporeo-Cinestesica, Musicale, Interpersonale, Intrapersonale, Naturalistica, Esistenziale – è rilevante non solo per lo specifico di ciascun ambito, ma soprattutto per la scoperta che le diverse intelligenze si sostengono l’un l’altra come un pacchetto di mischia nel rugby: la necessità di una pluralità di discipline – e qui sottolineo l’educazione musicale, particolarmente penalizzata dalla riforma Gelmini –, e della loro reciproca interazione, trova qui un ulteriore fondamento.
È altresì evidente quale negativo quadro emerge da una scuola che diriga – come sta facendo quella attuale – la propria rotta in tutt’altra direzione: quale mente, quali servitù, quali deficit cognitivi, esistenziali, quali mutilazioni nella capacità di esercizio attivo della cittadinanza sono in corso d’opera.
Torniamo al titolo di questo incontro: cosa insegnare a scuola? La risposta è: la vita, in quanto vita. Una scuola in cui la vita non si annoia è, per citare un bravo collega, Valter Binaghi, una scuola che è luogo vitale «quando i ragazzi hanno la percezione non di affettarsi giorno per giorno un diploma, ma che lì dentro si forgiano un carattere, un patrimonio irrinunciabile e un destino. Se no meglio chiuderla».
Nota al testo
Il seminario in cui fu pronunciato questo intervento si è tenuto a Candriai (TN) il 17 e 18 novembre 2012. Gli atti sono stati raccolti nel volume Cosa insegnare a scuola. Qualche idea sulle discipline umanistiche, a cura di Amedeo Savoia e Claudio Giunta, Editore Provincia Autonoma di Trento IPRASE, Trento 2013, che è disponibile all’indirizzo  http://www.iprase.eu/librocosainsegnareascuola. La citazione di Valter Binaghi era tratta del suo testo Cosa insegnare a scuola, pubblicato sul suo blog il 6 novembre 2012.
http://www.iprase.eu/librocosainsegnareascuola. La citazione di Valter Binaghi era tratta del suo testo Cosa insegnare a scuola, pubblicato sul suo blog il 6 novembre 2012.