 S. Chemotti, M. Coglitore, Il giogo dei ruoli, Il Poligrafo, Padova, 2021, pp. 201, euro 23,00.
S. Chemotti, M. Coglitore, Il giogo dei ruoli, Il Poligrafo, Padova, 2021, pp. 201, euro 23,00.
È difficile liberarsi dei “ruoli”, delle identità cristallizzate e incancrenite da dinamiche di tipo sociale, politico, economico e, perché no, anche letterario. È difficile perché il ruolo può presto trasformarsi in “giogo”, in una sorta di prigionia identitaria che cresce intorno ai singoli individui. E, probabilmente, risulta ancora più difficile quando i ruoli assumono le loro forme all’interno di una coppia, una struttura sociale appesantita da rigidità imposte dall’alto, dalle convenzioni di matrice borghese [...]]]>
 S. Chemotti, M. Coglitore, Il giogo dei ruoli, Il Poligrafo, Padova, 2021, pp. 201, euro 23,00.
S. Chemotti, M. Coglitore, Il giogo dei ruoli, Il Poligrafo, Padova, 2021, pp. 201, euro 23,00.
È difficile liberarsi dei “ruoli”, delle identità cristallizzate e incancrenite da dinamiche di tipo sociale, politico, economico e, perché no, anche letterario. È difficile perché il ruolo può presto trasformarsi in “giogo”, in una sorta di prigionia identitaria che cresce intorno ai singoli individui. E, probabilmente, risulta ancora più difficile quando i ruoli assumono le loro forme all’interno di una coppia, una struttura sociale appesantita da rigidità imposte dall’alto, dalle convenzioni di matrice borghese e cattolica ancora dure a morire nell’Italia di oggi, dove è stato creato addirittura un ministero “della famiglia, della natalità e delle pari opportunità”. Ma il “giogo dei ruoli” può trasformarsi anche in un vero e proprio gioco nel quale, per mezzo di una sottile ironia, si cerca di prendere a staffilate quelle antiquate e rigide convenzioni imposte dal potere. È ciò che si propongono di fare Saveria Chemotti e Mario Coglitore nel loro bel libro intitolato, appunto, “Il giogo dei ruoli”, in cui i due autori mettono in scena dei dialoghi fra personaggi letterari o reali che appartengono a coppie famose di innamorati o di amanti, cristallizzati dal tempo e dall’immaginario comune. All’interno di una struttura articolata in tre tempi, incontriamo, fra gli altri, Paolo e Francesca, Dulcinea e Don Chisciotte, Orfeo ed Euridice, Marianna e Sandokan ma anche Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, Mileva Marić e Albert Einstein, Sibilla Aleramo e Dino Campana. La scrittura si trasforma quindi anche in un gioco in cui la rigidità del giogo si rompe perché, come affermano gli stessi autori in una nota finale, “i momenti più divertenti di questa scrittura senza affanni sono consistiti nella stesura di quelli che abbiamo chiamato «ordini inversi», quando cioè ci siamo scambiati i ruoli, affidando al maschio di questa inusuale coppia di sorella e fratello per «elezione» il personaggio femminile e viceversa alla femmina il personaggio maschile. Un rovesciamento del «gioco delle parti» che ci è piaciuto particolarmente”.
I personaggi messi in gioco non dialogano soltanto fra di loro ma anche, metaletterariamente, con il lettore e con la sua epoca, con avvenimenti storici ancora di là da venire. Il “giogo” viene rotto anche in questo modo: le figure reali e letterarie messe in scena da Chemotti e Coglitore escono dal loro imprigionante contesto e si inseriscono all’interno di un immaginario comune non statico ma avvolto da un movimento continuo. Altre volte, come nel caso di Paolo e Francesca o di Alphonsine Plessis e Alexandre Dumas figlio non si instaura un vero e proprio dialogo ma una narrazione commentata attraverso la quale gli autori discutono sui personaggi, sul loro tempo e sul loro ambiente sociale, intervallando la narrazione con un andamento più riflessivo e saggistico. Ad esempio, come scrive Saveria Chemotti giocando sul significato del verbo “scambiare” e “scambiarsi”, “la colpa di Paolo e Francesca non è stata solo quella di scambiarsi di nascosto un tenero bacio, ma quella di aver scambiato la letteratura con la vita, cadendo nel più pacchiano degli errori”. Perché la stessa letteratura può trasformarsi in gabbia, in schema, in rigido meccanismo che consegna all’immaginario comune figure stereotipate. Gli stessi personaggi letterari (e mitici, come in questo caso) lottano per scrollarsi di dosso quegli stereotipi, quei gioghi arbitrariamente imposti, come Euridice (la cui voce è mediata da Chemotti) che, dopo essersi dichiarata una “preda del destino a cui mi hanno assoggettata gli dei”, afferma perentoria: “A nessuno viene in mente che io ero in grado di resuscitarmi da sola? Che potevo fare affidamento sulla mia sensibilità, sulla mia stessa natura per vincere le ombre e risalire al sole? Che potevo liberare la mia anima prigioniera dei gioghi di un potere che mi avrebbe incatenata a una ventura tragica e senza soluzione di continuità, secolo dopo secolo? Un giorno, nella primavera di molte ragazze io avrò finalmente consolazione e riscatto. Sarò una di loro e non mi volterò mai indietro”. Euridice, esprimendo la sua autoaffermazione di donna contro un potere invisibile che la vorrebbe sempre assoggettata, viaggia, se così si può dire, nel tempo fino a prefigurare le lotte femministe che verranno.
Bisogna infatti notare che tutti i personaggi femminili del libro possiedono in sé una forte carica di ribellione dalle connotazioni di genere, in quanto si oppongono costantemente al potere patriarcale rivestito e simboleggiato dalla controparte maschile della coppia. Penelope, sempre con le parole di Chemotti (che non a caso è una studiosa di letteratura di genere e delle donne), rivendica il suo diritto a raccontare la sua versione dei fatti perché ormai “stanca di essere additata a eroina del matrimonio consacrato”. Ebbene, secondo Penelope, Odisseo è tornato “per attuare la sua vendetta, non per raggiungere me”. E, sicuramente, nella rivisitazione del Giogo dei ruoli, l’eroina omerica avrebbe ceduto alla corte serrata dei pretendenti se avesse capito che l’intenzione di Odisseo era quella “di restare per una toccata e fuga capace di mettermi di nuovo incinta, cioè di imprimermi le stimmate del padrone”. L’eroe se n’è andato senza neanche salutarla: “egocentrico e avido di conoscenza se n’è andato alla ricerca dei confini del mondo”. Naturalmente, adesso non si tratta più del personaggio omerico ma di quello dantesco e, infatti, con spirito metaletterario, Penelope conclude che “si merita di finire all’inferno”. Ma non sono soltanto i personaggi femminili a rimproverare e, quasi, a maledire i propri uomini, in una sorta di libera rivisitazione delle Heroides di Ovidio; anche alcuni personaggi maschili sottolineano la condizione subalterna delle donne nella loro epoca. È il caso, ad esempio, di Alexandre Dumas figlio (non un personaggio letterario, quindi, ma uno reale, anche se legato all’immaginario della letteratura), a cui presta la voce Mario Coglitore. Quest’ultimo, attingendo alla sua vocazione di storico e studioso di dinamiche storico-sociali, dopo una digressione in cui descrive gli effetti nefasti della rivoluzione industriale (“L’età delle ciminiere. Che da giovane ho visto spuntare a una a una, sentinelle implacabili dell’economia di mercato e per converso dello sfruttamento indecente di uomini, donne e persino bambini”), pone l’accento su alcune dinamiche della “sessualità «vittoriana»”, in un periodo in cui le donne dovevano rivestire il ruolo di procreatrici “meglio se di maschi e non di femmine, naturalmente, specie nel caso dei primogeniti cui verrà affidato il patrimonio familiare”. Parlando di Alphonsine Plessis, la cortigiana divenuta amante dello scrittore al quale ha ispirato il personaggio di Marguerite Gautier per il suo romanzo La signora delle camelie, così Coglitore-Dumas figlio si esprime: “Lei, considerata né più né meno che una prostituta, ha preso tutto ciò che ha potuto dalla vita senza risparmiarsi, assaggiandone i frutti più dolci e soprattutto quelli più amari. Fino a che la malattia non ha spezzato l’insopportabile giogo che la teneva prigioniera di questi uomini dall’animo violento e dalla insaziabile bramosia. Gli stessi che la domenica frequentano la chiesa del quartiere o le grandi cattedrali, inginocchiandosi davanti agli altari e prendendo la comunione”.
Un altro personaggio letterario inchiodato al suo ruolo dalla tradizione è l’Angelica dell’Orlando furioso (la cui voce è quella di Chemotti) che giustifica la sua fuga continua dalla guerra (“Io scappo. Anche da questo scempio, ma lo tengo per me”) e da Orlando con il suo diritto ad innamorarsi: il cavaliere “non contempla neppure l’ipotesi che io mi sia finalmente innamorata, che in me sia sorto un sentimento sconosciuto e raro che mi spinge ad abbandonarmi senza l’aiuto di sortilegi”. Ciò che rifugge è, ancora una volta, il ruolo stereotipato: “Certo: alcuni dicono che io non ho davvero una vita mia propria, che sono un «sorridente fantasma» perché configuro un modello che è fin troppo facile convertire in stereotipo e destabilizzarlo”. Perché una donna non può essere un “soggetto del desiderio”. D’altra parte, Angelica conclude la sua ‘tirata’ appassionata con un appello alle donne musulmane, parole che valicano i confini del tempo per giungere fino ai giorni nostri, dense di significato politico e sociale se pensiamo ai tragici fatti che avvengono in Iran: “Perché allora noi, cristiane e mussulmane, non stringiamo un patto che ci sveli nella nostra essenza, con la pretesa di esser guardate oltre la pelle liscia o a rughe, i capelli al vento o sotto un velo, comunque sia?”. Una rivendicazione di sé e dei propri diritti che suona anche come una contestazione alla società tout court è anche quella che Mario Coglitore, dando la voce a Jane (nel ‘dialogo’, costruito dagli autori in un “ordine inverso”, dedicato a Tarzan e Jane, i personaggi inventati da Edgar Rice Burroughs nel suo romanzo Tarzan delle scimmie del 1914), fa risuonare con echi politici e sociali. La giovane, infatti, afferma che la società europea e occidentale ha da sempre avuto pregiudizi non solo nei confronti degli africani ma dell’Africa intera, vista come “il Continente Nero pieno di misteri, giungle soffocanti e umidità insopportabile, screpolata in alcune latitudini da un sole impietoso e da sabbie smosse dal Ghibli tormentoso”. E allora, l’inglese Jane, innamorandosi del misterioso “Tarzan delle scimmie”, riesce a spezzare “i vincoli opprimenti della società del mio tempo, ben poco seducente” e, finalmente, non sarà più costretta a “respirare i miasmi del carbone delle industrie della capitale che sbuffavano a pieno ritmo, nebbia puzzolente dentro alla nebbia che già saliva dal Tamigi”.
E i personaggi maschili? Anche loro, nonostante siano in alcuni casi staffilati ben bene dalla loro controparte femminile, riescono a liberarsi dal giogo che li vorrebbe imprigionati nel loro ruolo. Se, come abbiamo visto, Dumas figlio sottolinea la subalternità della condizione femminile, Tarzan, da parte sua, nelle parole di Saveria Chemotti, afferma che anche lui si sente un ‘diverso’ nella giungla e, alcune volte, è stato costretto a nascondersi perché cosciente della propria diversità rispetto alle scimmie. Forse, però, la figura maschile che viene presentata più slegata dal proprio ruolo è quella di Giacomo Casanova, irrigidito nello stereotipo del seduttore fino all’antonomasia. Mario Coglitore, da buon veneziano, ci presenta un Casanova vecchio e triste in una lontana Boemia, profondamente immalinconito dal ricordo della sua ormai irraggiungibile Venezia: “Venezia mi manca. Mi manca l’odore dell’acqua che ristagna, i rumori del remo che sciaborda, lo spettacolo della laguna in qualunque stagione”. In quest’immagine malinconica (che può ricordare il poetico finale del Casanova di Federico Fellini, in cui il personaggio sogna di danzare sulla laguna ghiacciata con una dama meccanica), Casanova si libera del suo ruolo, concedendosi finalmente un immaginario libero dagli stereotipi. Ed è lo stesso immaginario che ci regala Il giogo dei ruoli: un tentativo di resistenza – attuato per mezzo di una scrittura che valica i confini fra realtà e letteratura – ai gioghi imposti da qualsiasi potere.
]]>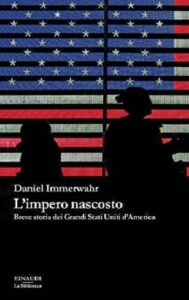 Daniel Immerwahr, L’impero nascosto. Breve storia dei Grandi Stati Uniti d’America, Einaudi, 2020, pp. 603, euro 34.
Daniel Immerwahr, L’impero nascosto. Breve storia dei Grandi Stati Uniti d’America, Einaudi, 2020, pp. 603, euro 34.
Ha scritto molto tempo fa Alfred Korzybski, ingegnere e matematico – a lui si deve la fondazione della cosiddetta Semantica generale –, che “la mappa non è il territorio”. Di più, sosteneva ancora Korzybski, anticipando di alcuni decenni le riflessioni dello stesso Foucault, “la parola non è la cosa” (Molto brevemente, per comprendere i fondamenti della General Semantics: secondo Korzybski gli esseri umani hanno dei limiti piuttosto consistenti nell’atto del conoscere il mondo [...]]]>
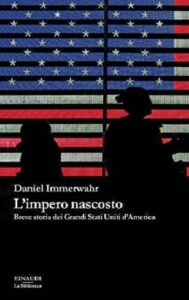 Daniel Immerwahr, L’impero nascosto. Breve storia dei Grandi Stati Uniti d’America, Einaudi, 2020, pp. 603, euro 34.
Daniel Immerwahr, L’impero nascosto. Breve storia dei Grandi Stati Uniti d’America, Einaudi, 2020, pp. 603, euro 34.
Ha scritto molto tempo fa Alfred Korzybski, ingegnere e matematico – a lui si deve la fondazione della cosiddetta Semantica generale –, che “la mappa non è il territorio”. Di più, sosteneva ancora Korzybski, anticipando di alcuni decenni le riflessioni dello stesso Foucault, “la parola non è la cosa” (Molto brevemente, per comprendere i fondamenti della General Semantics: secondo Korzybski gli esseri umani hanno dei limiti piuttosto consistenti nell’atto del conoscere il mondo a causa della struttura del loro sistema nervoso e dei loro linguaggi. La realtà viene essenzialmente sperimentata attraverso “astrazioni”, impressioni non verbali che provengono appunto dal sistema nervoso e che vengono poi portate alla coscienza e verbalizzate per mezzo della lingua che ciascuno di noi utilizza).
Questi due concetti si attagliano perfettamente all’analisi che Daniel Immerwahr ci propone nel suo corposo e vibrante saggio, interpolando i lemmi della storia, dell’economia, della politica e, buona ultima ma essenziale, della geografia, in un’opera di ampio respiro che a tratti è capace di sorprendere per la ricchezza delle informazioni e degli aneddoti forniti, tutti egualmente importanti per ricomporre le tessere del complicato puzzle che ci ritroviamo davanti a fine lettura.
Siamo abituati, nella nostra proiezione immaginativa, a far coincidere gli Stati Uniti con la mappa-logo, così la definisce l’autore, costituita dall’insieme degli Stati federati che confina a nord con il Canada, al sud con il Messico e a Ovest ed Est rispettivamente con l’oceano Atlantico e l’oceano Pacifico; dimenticando quasi sempre, sia detto en passant, l’Alaska che, troppo in alto forse per il nostro sguardo accidentato, sfugge nove volte su dieci alla corretta evidenza che pure lo rende una formale porzione degli States. La mappa rimanda visioni del territorio imperfette durante le quali si manifesta davvero l’assoluta distanza tra le parole e le cose, anche a causa, se vogliamo, della scarsa importanza che viene tradizionalmente attribuita alla geografia nella nostra cultura, e nell’apprendimento scolastico di ogni ordine e grado fino agli studi universitari.
Il significato complessivo che si ricava dal perspicuo studio di Immerwahr, a cui egli ha dedicato quasi una decina d’anni, emerge, pagina dopo pagina, sempre più evidente: la storia degli Stati Uniti, esemplare sotto molti punti vista tanto l’intero pianeta ne è stato condizionato e trasformato, da Oriente a Occidente senza soluzione di continuità, è storia di un impero mai formalmente riconosciuto e abilmente non caratterizzato dalle conquiste e annessioni colonialiste che vedono la luce con le prime avventure dei portoghesi, e poi degli olandesi e degli spagnoli, in terre d’oltremare invase e depredate senza tanti complimenti, sino alla fase coloniale tecnologico-economica otto e novecentesca così ben incarnata dalla spietata Gran Bretagna e dall’altrettanto intrusiva Francia, passando per Belgio, Germania e persino, in formato ridotto ma non per questo meno letale, Italia. È storia quella americana di un imperialismo diffuso e reticolare del quale, a tratti, si è cercato di delineare i contorni, tentando di far riemergere dalla secche della ricostruzione storica un “paesaggio” sottratto ai più e lasciando che il flusso degli eventi della storia mondiale percorresse i consueti, tradizionali percorsi; anche qui utilizzando l’aggettivo “americana” per identificare la mappa-logo di cui si diceva e prendendo una parte per il tutto, dato che il termine America dal punto di vista geografico non è assimilabile ai soli Stati Uniti. L’Impero statunitense rappresenta, in sostanza, un rimosso. Ma, secondo quanto ci ha insegnato Sigmund Freud, il rimosso tende a ritornare spesso come sintomo. Negare l’esistenza di questa “conformazione imperiale” ci impedisce di apprezzare alcune sensibili variazioni nelle vicende che sono occorse al pianeta negli ultimi duecento anni circa, determinando la nascita e lo sviluppo di pratiche economiche, militari, sociali e culturali capaci di cambiare il corso degli eventi, e di segnarne possibilità e tipicità.
Ritorniamo alla geografia e al fascino che esercitano le mappe. Sapremmo dire, senza pensarci su troppo, dov’è l’isola di Guam? O dove sono collocate esattamente le Hawai’i? Sapremmo indicare in un attimo, senza smarrirci nell’imprecisabile, dove si trovano Puerto Rico o le Isole Marianne settentrionali? Forse no. La mappa-logo ci costringe a puntare gli occhi soltanto lì dove la potenza territoriale degli Stati Uniti ha fatto bella mostra di sé in una mitopoiesi carica di genealogie addomesticate: lungo le carovane dei coloni che si spostavano verso il “favoloso” Far West, a totale detrimento della popolazione pellerossa gradualmente e implacabilmente messa in condizione di non nuocere e sterminata poco a poco, oppure lungo i binari della ferrovia – oggetto di altrettanta mitizzazione cui la cinematografia hollywoodiana contribuì esportandone l’immaginario simbolico ovunque – che congiunse i due oceani poc’anzi nominati. Praterie sterminate e branchi di cavalli selvaggi, mandrie di bisonti alla cui caccia spietata Buffalo Bill, prima di girare per l’Europa con il suo improbabile Circo, non si sottrasse, canyon sontuosi e imponenti, fiumi dal corso impetuoso e dalla straordinaria lunghezza e portata, e mille altre suggestioni colmano la nostra fantasia di incalliti occidentali.
La carta geografica declina la sostanza di un mezzo continente che già nelle premesse sembra contenere il futuro destino della grandezza delle sue genti di importazione, giunte dalla Vecchia Europa, incredibilmente più piccola e insignificante, e della missione cui la storia ha chiamato quel nuovo costrutto politico e culturale che, a tutt’oggi, per gli statunitensi è la “nazione” con la sua robusta e immarcescibile identità. Secondo Immerwahr è questo insieme di sollecitazioni socio-antropologiche che va messo in discussione. Ridisegnando la mappa, per l’appunto.
Per farlo, si tratterà di dare un’occhiata oltre i confini di terra e stabilire, se mai sarà possibile, quelli di mare. L’oceano Atlantico è stato oggetto di decine di opere letterarie, dai romanzi ai saggi, che ne hanno dipanato l’epica narrativa e le stagioni. Decisamente meno si parla del Pacifico, non fosse altro perché, probabilmente, non è identificato tout court con la storia dell’Occidente. Eppure è in quelle acque e tra quelle correnti, dentro alle quali si mosse la Pequod di Melville all’inseguimento di Moby Dick, che gli Stati Uniti hanno trovato la ragion d’essere del proprio affrancamento continentale verso una strategia insulare di tutto rispetto, agendo in una rete di isole grandi e piccole con conseguenze nella maggioranza dei casi tragiche, all’insegna del conflitto permanente e del sangue, sparso dappertutto.
Ci racconta, così, l’autore, delle guerre che hanno lacerato le Filippine, territorio dalla densità politica e militare rilevante e dallo sconcertante tasso di mortalità tra gli abitanti sottoposti prima al dominio spagnolo, di seguito a quello americano e giapponese, e infine di nuovo a quello americano; e ancora, costretti a feroci contrapposizioni tra gruppi di isolani accerchiati dal dominio di nazioni che si contendevano un territorio strategico, adagiato nel Sud-est asiatico da decenni teatro di aspre contese. Ma sono le isole minori del Pacifico a destare la maggior curiosità nel momento in cui esse diventano punti di torsione di una cartografia militare che dà sostanza al potere statunitense ben prima che il governo di Washington decidesse di partecipare alla Seconda guerra mondiale. Segnando il tempo della onnivora conquista di geografie e mercati, delle migliaia di morti in un esercito mandato a combattere su più fronti nel pianeta e di una spettacolarizzazione della violenza, culminata con i due tremendi ordigni nucleari sganciati sul Giappone ai primi d’agosto del 1945.
A tutto ciò fece seguito l’approntamento di un efficiente e compulsivo sistema tecnico-economico, le cui premesse datavano già dall’intervento durante la Prima guerra mondiale, che ha fatto del Novecento il “secolo americano”, come ha ben argomentato parecchi anni fa con grande dovizia di particolari Geminello Alvi1.
Spartiacque tra un prima e un dopo durante i quali idealmente si ricongiunsero meditati approcci a politica ed economia, esaltando una pervasiva logica del dominio – di altro non si può parlare in questo atlante del potere in cui sono state fatte scorrere al meglio le risorse, codificandole e ottimizzandole in funzione degli obiettivi prefissati –. la Seconda guerra mondiale ha contribuito ad espandere al massimo l’impero americano con una popolazione dei territori d’oltremare che in termini numerici superava di gran lunga, negli anni successivi alla fine delle ostilità, quella del continente. In questo raffinato dispositivo strategico l’influenza esercitata prescindeva dall’esistenza o meno di colonie e, anzi, un classico impianto coloniale avrebbe impedito lo sviluppo del complessivo assetto di controllo.
Furono alcune innovazioni introdotte a partire dalle esigenze belliche a fare la differenza. La prima, e più importante, fu lo sviluppo della tecnologia aerea; la seconda, certamente l’approntamento di basi militari. Il sistema di comunicazione che gli aerei garantiscono in termini di duttilità, efficacia, velocità e sicurezza – non dimentichiamo il radar la cui tecnologia fu sviluppata proprio in quello scenario bellico dagli stessi americani a sostegno delle flotte dei cieli – non ha paragoni con il trasporto via nave che ugualmente aveva reso possibile lo spostamento di persone e merci tra Ottocento e Novecento. Oltre al ruolo determinante che l’aereo ebbe sul piano militare per dar voce tonante a quella che potremmo chiamare la “filosofia” del bombardamento negli anni dal 1940 in poi, non dobbiamo trascurare il fatto che, al pari di ciò che è stato il treno per tutto il XIX secolo e oltre, l’aereonautica sarebbe diventata settore di punta dell’industria mondiale; in aggiunta, gli studi sulla tecnologia del volo avrebbero presto condotto alla realizzazione di vettori da spedire nello spazio o, molto prosaicamente, di testate missilistiche da lanciare contro il nemico, chiunque esso fosse, evitando di compromettere, o compromettendo molto meno, la sicurezza e l’incolumità degli esseri umani che si occupavano di quell’operazione.
Quanto alle “basi”, esse possono diventare totalmente indipendenti da rifornimenti via terra, costosi e molto spesso soggetti ai pericoli legati alla natura del terreno e alle sue insidie, e possono essere dislocate lontano dalla madrepatria, pur servendone gli scopi. L’aereo, d’altronde, garantisce proprio questo elemento fondamentale per la collocazione di una “base”, vale a dire il fatto che è in grado di coprire distanze molto ampie. E su questo giocarono, e giocano ancora, gli Stati Uniti istituendo quello che Immerwahr chiama l’Impero “puntillista”, soltanto in apparenza caratterizzato da un forte radicamento territoriale nel continente. Di puntino in puntino, grande e meno grande, la “disposizione imperiale” di piste d’atterraggio intorno alle quali fioriscono strutture logistiche interconnesse che diventano presto ampie come città alimenta la catena di controllo planetaria riverberando i suoi effetti perfino nel territorio che circonda la “base”, quando esso appartiene ad altra sovranità. Una buona parte delle attuali 800 installazioni militari statunitensi sparse nel globo lo dimostrano con relativa facilità, se appena pensiamo all’Italia di Aviano e alla micro-economia sorta attorno alla “base” laggiù attiva che prospera in virtù della presenza del personale americano in quell’area.
Non esclusivamente aerei, ci ricorda Immerwahr: ma anche elettronica, medicina, e persino cultura popolare; il “puntillismo” a stelle e strisce ha promosso opportunità scientifiche sostenute da solidi enti di ricerca e creato ex novo, o semplicemente modificato con la sua invasiva permanenza, interi ambienti sociali, inducendo evoluzioni e conseguenze del tutto particolari.
Dahran, Arabia Saudita; un posto dimenticato da Dio e dagli uomini. Negli anni Trenta del Novecento l’Aramco (conglomerata statunitense che comprende all’epoca Standard Oil, Texaco, Exxon e Mobil) si stabilisce tra quelle sabbie inospitali per estrarre petrolio con il permesso del governo locale. Vanno costruiti degli insediamenti per ospitare operai e personale tecnico e l’azienda americana se ne assume l’onere. Tra i manovali ce n’è uno particolarmente esperto e energico che non tarda a fiutare l’affare e a mettersi in proprio con il consenso del suo Paese e il gradimento dell’Aramco, fondando una piccola impresa di costruzioni. Muhammad Bin Laden entra nella lobby imprenditoriale giusta: molto petrolio, molti affari, molta espansione. Gli Stati Uniti premono affinché i Sauditi collaborino fattivamente, tenuto conto che considerano l’Arabia uno snodo centrale delle linee intercontinentali di trasporto. Dal 1945 al 1962 ottengono in affitto una grande base aerea a Dahran per la quale c’è bisogno di ulteriori lavori di costruzione, in piccola percentuale affidati al rampante Muhammad che inizia così una proficua collaborazione anche con gli americani a suon di lauti contratti più o meno ufficiali per non destare sospetti nel suo Re. Quando i rapporti con coloro che il popolo saudita considera di fatto “invasori” e per di più “infedeli” si fanno tesi e la concessione del terreno viene sospesa, l’esercito USA abbandona il luogo nel 1962. Ma Muhammad vola già alto e qualcuno dei suoi 54 figli se ne va a studiare direttamente negli Stati Uniti.
Alla sua morte nel 1967, alcuni dei rampolli si dedicano agli affari di famiglia per potenziare un’azienda che valeva già svariate centinaia di milioni di dollari. Tra loro spicca per impegno e dedizione il giovane Osama, che di questioni tecniche sembra capirci parecchio. Quando all’ingegneria dei materiali l’erede Bin Laden affianca anche la politica, la strada appare segnata. Contro l’imperialismo occidentale Osama si schiera fin da subito e non può sottrarsi all’appello che nel 1978 i Mujahidin lanciano a tutti i veri credenti dopo che l’Unione sovietica ha invaso l’Afghanistan. Arriva a Peshàwar vicino al confine afghano dove mette subito a frutto la sua perizia nello scavare tunnel e costruire strade; non gli mancano certo i mezzi, che fa affluire abbondanti in Pakistan, e la competenza. La jihad prende piede e chiama a raccolta i suoi devoti apostoli. Nel 1988 Osama fonda una piccola organizzazione per dirigere la sua guerra santa; la chiamerà al-Qaida al-Askariya che in arabo significa “la base militare” e più tardi sarà conosciuta semplicemente come al-Qaida, “la base”. Il resto della vicenda è abbastanza noto alle cronache. Quel che preme sottolineare qui, e che certo lascia interdetti, è la concatenazione di eventi che porta dal misconosciuto muratore analfabeta Muhammad, cresciuto professionalmente nel brodo di coltura promosso dagli Stati Uniti in quello specifico frangente della loro espansione “puntillista”, alla lotta di resistenza benedetta da Allah che il figlio Osama intraprende contro Mosca all’inizio della sua carriera di condottiero. In qualche modo, l’“Impero nascosto” ha colpito ancora.
Si veda Geminello Alvi, Il secolo americano, Milano, Adelphi, 1994. ↩
 Mario Coglitore, Viaggi coloniali. Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra Ottocento e Novecento, prefazione di Barbara Henry, Il Poligrafo, Padova, 2020, pp. 159, euro 24,00.
Mario Coglitore, Viaggi coloniali. Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra Ottocento e Novecento, prefazione di Barbara Henry, Il Poligrafo, Padova, 2020, pp. 159, euro 24,00.
I viaggi coloniali avvenivano soprattutto a bordo di una nave; come scrive Michel Foucault, «la nave è un frammento galleggiante di spazio, un luogo senza luogo, che vive per se stesso, che si autodelinea e che è abbandonato, nello stesso tempo, all’infinito del mare e che, di porto in porto, di costa in costa, da case chiuse a case chiuse, si spinge fino alle [...]]]>
 Mario Coglitore, Viaggi coloniali. Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra Ottocento e Novecento, prefazione di Barbara Henry, Il Poligrafo, Padova, 2020, pp. 159, euro 24,00.
Mario Coglitore, Viaggi coloniali. Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra Ottocento e Novecento, prefazione di Barbara Henry, Il Poligrafo, Padova, 2020, pp. 159, euro 24,00.
I viaggi coloniali avvenivano soprattutto a bordo di una nave; come scrive Michel Foucault, «la nave è un frammento galleggiante di spazio, un luogo senza luogo, che vive per se stesso, che si autodelinea e che è abbandonato, nello stesso tempo, all’infinito del mare e che, di porto in porto, di costa in costa, da case chiuse a case chiuse, si spinge fino alle colonie per cercare ciò che esse nascondono di più prezioso nel loro giardino»1. Lo studioso continua affermando che «la nave è stata per la nostra civiltà, dal XVI secolo fino ai nostri giorni, non solo il più grande strumento di sviluppo economico (non è di questo che voglio occuparmi adesso), ma anche il più grande serbatoio di immaginazione»2. Per Foucault, la nave è uno strumento di sviluppo economico ma anche una vera e propria eterotopia, cioè uno spazio separato da tutti gli altri spazi, saturo di immaginazione e di fantasia liberata.
Certo, non si può negare che grandi «serbatoi di immaginazioni» siano anche le navi che, emblemi dell’imperialismo marittimo vittoriano, si dirigono verso mari orientali e sconosciuti nei romanzi di Joseph Conrad. Però, Conrad riveste le sue navi e i suoi equipaggi di connotazioni quasi ‘infernali’ e ‘malate’, segno di un’avventura coloniale che si dirige verso una lenta decadenza. Ad esempio, la nave de Il compagno segreto (The Secret Sharer, 1909), avvolta da isole sconosciute e scogli affioranti pericolosi per la navigazione, viene definita come un «battello di morti» che si dirige verso «l’ingresso stesso dell’Erebo»3 (l’oscura e misteriosa isola di Koh-Ring, nel Golfo del Siam). Ma già in un romanzo precedente come Il negro del «Narciso» (The Nigger of the «Narcissus», 1897), gli stessi personaggi sono caratterizzati da volti grotteschi e mostruosi mentre la malattia e il disfacimento sembrano dominare visibilmente i loro corpi. Per non parlare, poi, dei funzionari coloniali europei che si recano in Africa dipinti da Céline nel suo Viaggio al termine della notte (Voyage au bout de la nuit, 1933) come «satolli», «stravaccati», «pustolosi», «panciuti», «olivastri»: «Satolli, stravaccati, si rassomigliavano tutti adesso, ufficiali, funzionari, ingegneri e appaltatori d’imposte, pustolosi, panciuti, olivastri, mescolati, pressappoco identici. I cani assomigliano ai lupi quando dormono»4. I viaggiatori coloniali imbarcati sulle navi di Conrad e di Céline, benché esponenti di un mondo ormai alla deriva, continuano a vedere, negli “altri da sé”, siano essi orientali o africani, come scrive Mario Coglitore nel suo interessante saggio Viaggi coloniali. Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra Ottocento e Novecento, «l’emblematica raffigurazione di un selvaggio paragonabile al massimo a una scimmia urlante che salta tra gli alberi».
Del resto, come nota ancora Coglitore, «la conoscenza dell’Oriente che circolava in Europa era funzionale della messa a punto del congegno coloniale; era stata formalizzata in un “discorso” che utilizzava le rappresentazioni culturali di stampo schiettamente occidentale del “Vicino Oriente”, oggi indicato come Medio Oriente, per sostenere la creazione e il funzionamento stessi delle società coloniali». Si tratta, in sostanza, di quell’«orientalismo» del quale Edward W. Said ci ha offerto una lucida analisi. Come ha dimostrato quest’ultimo, lo studio dell’Oriente, realizzato anche per mezzo di testi letterari, ha consolidato modi di pensare che hanno costituito l’ossatura fondamentale del potere coloniale. Un certo «orientalismo» di fondo lo si può riscontrare anche nell’atteggiamento razionalista di Jonathan Harker che, in Dracula (1897) di Bram Stoker, viaggia verso la Transilvania per incontrare l’Altro al grado più alto, il vampiro: si tratta pur sempre di un inglese del periodo vittoriano che, dalla metropoli imperialista si sposta in treno verso le misteriose periferie del continente europeo. Harker, prima di partire, si era recato alla biblioteca del British Museum e aveva raccolto informazioni sugli usi e costumi della Transilvania, i cui abitanti vengono guardati con distacco e superiorità. Non a caso, il giovane e razionale inglese si prenderà gioco delle truci leggende e delle superstizioni di quel popolo, non ascoltando gli ammonimenti degli indigeni. Gli abitanti della Slovacchia e della Transilvania sono poi allontanati in una dimensione fantastica e ‘teatrale’, descritti da Harker come dall’«aspetto assai pittoresco, ma poco rassicurante. Sul palcoscenico potrebbero assai bene rappresentare qualche antica banda orientale di briganti. Sono però, mi si dice, del tutto innocui e mancano di qualunque autorità»5.
Il saggio di Mario Coglitore, da un punto di vista della forma, rifiuta, in modo originale, le tradizionali suddivisioni in «prologo, primo, secondo, terzo capitolo e conclusioni» sostituendo ad esse delle partizioni derivate dalla musica: abbiamo quindi una «Ouverture», tre «movimenti» e un «Finale». Dopo una lucida disamina introduttiva del concetto di «viaggio coloniale» da un punto di vista sociale, letterario, politico ed economico («Ouverture»), l’analisi si focalizza sulla figura di un funzionario coloniale, Roger Casement («Primo movimento (adagio)»), sulla figura di uno scrittore, Emilio Salgari («Secondo movimento (allegro)») e, infine, sull’importanza che la ferrovia (oltre che la nave) ha giocato nel viaggio coloniale («Terzo movimento (presto)»). Funzionario coloniale britannico e esploratore di origine irlandese, Casement partecipò a diversi viaggi in Africa, soprattutto in Congo. Dapprima fedele all’ideologia colonialista, successivamente, deciderà di prendere le parti degli indigeni difendendone i diritti e pagando con la vita questa sua scelta. Verrà infatti condannato all’impiccagione nel 1916 per alto tradimento, dopo aver cercato il sostegno della Germania contro la Gran Bretagna in favore dell’indipendentismo irlandese. Casement è l’autore del Congo Report, «un vivido documento di denuncia delle atrocità commesse dai belgi nei confronti degli indigeni con la complicità di altre nazioni europee: massacri, mutilazioni, criminale sottrazione di risorse per salvaguardare il commercio della gomma e promuoverne l’espansione nel mercato mondiale». Nel saggio di Coglitore non mancano certo puntuali rimandi alla letteratura: in uno di essi lo studioso ricorda che «l’anno precedente al viaggio di Casement, Joseph Conrad aveva pubblicato in volume Heart of Darkness, ambientato nel Congo belga, dove lo scrittore inglese era rimasto per sei mesi nel 1890; destinato a diventare un classico della letteratura, il romanzo di Conrad aveva denunciato i crimini perpetrati ai danni delle popolazioni locali più di un decennio prima. Nel 1904 il Rapporto sul Congo venne reso pubblico». Nonostante Casement si sia battuto senza tregua per difendere i diritti delle popolazioni indigene, «sarebbe rimasto per l’intera esistenza fermamente convinto della superiorità europea», segno che è veramente difficile, per un europeo, liberarsi della sua mentalità di carattere «orientalista».
Di una mentalità di questo tipo sono imbevuti anche i romanzi di Emilio Salgari (affrontati nel «secondo movimento» del volume), nati non da esperienze dirette dell’autore ma forgiati dall’immaginazione «sfogliando atlanti ed enciclopedie». Come osserva Coglitore, «le fonti di cui si serve Salgari sono già di per se stesse vettore di “orientalismo”, appartengono all’universo culturale degli occidentali e possiedono, in una densità linguistica strutturalmente “bianca”, le locuzioni della subalternità degli “altri da sé” che popolano le colonie, mondi totalmente inconoscibili se non a partire dalla necessità della conquista e, nel migliore dei casi, del riscatto che, quasi fosse un dono, viene offerto al non europeo dalle mille sfumature di nero». Le stesse stanze in cui vive Sandokan in Le tigri di Mompracem sono «colme di ogni specie di suppellettili e ornamenti, le “cineserie” per le quali impazzivano gli europei, che lo avvicinano più a un ricco possidente della metropoli che a un reietto». Le opere di Salgari sono il frutto di una fantasia liberata capace di creare un immaginario strettamente legato alla dimensione del viaggio in terre lontane e sconosciute. Se l’Oriente dello scrittore veronese è intriso della visione occidentale, è anche vero che la sua penna è stata capace di creare personaggi che resistono e si ribellano all’ingordigia dell’imperialismo: «Considerato autore di puro intrattenimento e sostanzialmente ignorato dalla critica, Salgari descrisse, forse inconsapevole, il colonialismo nei suoi vari aspetti, modellando figure a tutto tondo di veri e propri rivoluzionari: partigiani e guerriglieri che resistevano all’ingordigia dell’imperialismo (il cosiddetto ciclo de I pirati della Malesia ne è l’esempio più classico)».
Parlando di viaggi verso territori orientali, saturi di immaginazione e di mistero, non si può non ricordare che molti di essi avvenivano per mezzo del treno e della ferrovia. Come sottolinea l’autore del saggio, lo stesso Phileas Fogg, protagonista del Giro del mondo in 80 giorni (1873) di Jules Verne, per attraversare il territorio indiano da Ovest a Est, si sarebbe servito di una linea ferroviaria all’epoca famosa, la Great India Peninsular Railway, costruita tra il 1852 e il 1870. Il «terzo movimento» del volume è dedicato appunto alla «ferrovia nel viaggio coloniale». Gli europei, dopo aver colonizzato e assoggettato i paesi africani o orientali, costruivano la strada ferrata (molto più antica della locomotiva) per agevolare i trasporti e le comunicazioni in territori che, in alcuni casi, si presentavano estremamente vasti. Anche la costruzione della ferrovia rientrava quindi in una ‘europeizzazione’ dei paesi conquistati: essa, infatti, appartiene interamente al paesaggio europeo, sia reale che mentale. Fin dal 1855 le ferrovie erano attive in tutti e cinque i continenti: come, in modo suggestivo, scrive l’autore, «un pianeta in movimento venne intessuto di ragnatele di metallo che inventarono nuove geografie economiche, promossero scambi culturali e politici, favorirono commistioni tra abitudini, costumi, mentalità». La ferrovia e il treno a vapore divengono gli emblemi della modernità e della Rivoluzione Industriale; non si dimentichi, del resto, che il ‘razionalista’ inglese Jonathan Harker, per recarsi dal conte Dracula, viaggia in treno, utilizzando, così, il mezzo moderno per eccellenza. Non è un caso che il vampiro, esponente invece di un’arcaica alterità, per muovere il suo attacco a Londra, cuore economico dell’imperialismo, si imbarchi di nascosto su un mezzo più antico come la nave a vela, molto più lenta delle navi a vapore che pure in quello stesso periodo solcavano i mari.
Discutendo di ferrovia nel viaggio coloniale, l’analisi di Coglitore si concentra principalmente sulla costruzione della linea Congo-Oceano, realizzata fra il 1921 e il 1934, definita come «una delle opere d’ingegneria più letali della storia coloniale». I lavoratori vennero reclutati fra le tribù indigene, costretti a turni di lavoro massacranti e senza le più elementari condizioni igieniche (nei cantieri, la mortalità raggiunse molto probabilmente il tasso del 57 %). In questo genere di imprese, infatti, «si assiste a una reificazione degli indigeni, ridotti a puri e semplici automi, oggetto di brutalità indescrivibili». Essi venivano trattati come esseri viventi di infima categoria e – si potrebbe aggiungere – soggetti a un vero e proprio processo di “zombificazione”.
L’analisi portata avanti da Coglitore in modo lucido e disincantato appare intrisa di un habitus narrativo che tiene avvinghiato il lettore al racconto di viaggi che mettono in contatto culture diverse, le amalgamano, le apparentano, le incrociano, le contaminano. I viaggi “riterritorializzano”, quando il viaggiatore si stabilisce nella nuova terra. E allora, «in quelle comunità turbate da arrivi improvvisi, e indesiderati, ritroviamo spesso i nuclei di transizioni e di mutamenti storici». Ma si tratta pur sempre di viaggi coloniali e le riflessioni conclusive, in fin dei conti, sono amare perché «perfino quando gli eserciti si ritirano il colonialismo resta un destino», «una condizione esistenziale così profondamente imposta da essere ritenuta imprescindibile». Come scrive lo studioso, «l’Occhio dell’Impero sembra immortale». E, si potrebbe aggiungere, sembra continuare a sussistere ancora oggi, nelle stragi di migranti nel Mediterraneo che avvengono sotto gli occhi indifferenti dei paesi ricchi, nelle delocalizzazioni del capitalismo occidentale nei paesi più poveri, nel lavoro che spesso diventa schiavitù, nelle mille prevaricazioni quotidiane nei confronti dell'”altro da sé”. Nessun Sandokan e nessun pirata della Malesia riuscirà a scalfire tale «condizione esistenziale» che sembra non finire; ci riuscirà, forse, un nuovo immaginario libero e liberato che faccia a pezzi queste strutture di pensiero surrettiziamente sopravvissute fino ad oggi.
M. Foucault, Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, a cura di S. Vaccaro, Mimesis, Milano, 2002, p. 32. ↩
Ibid. ↩
J. Conrad, I grandi romanzi e i racconti, Newton Compton, Roma, 2013, p. 1615. ↩
L.-F. Céline, Viaggio al termine della notte, trad. it. Corbaccio, Milano, 2010, p. 141. ↩
B. Stoker, Dracula, in B. Stoker, J. S. Le Fanu, J. W. Polidori, Vampiri. Dracula, Carmilla, Il vampiro, Skira, Milano, 2018, p. 11. ↩