Zitto! La smetta con quel mandolino altrimenti ci cacciano, sssh! (Filini a Fantozzi)
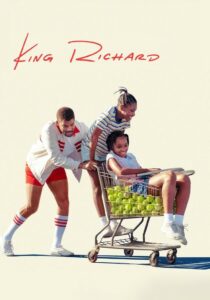 1936 – Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green, USA 2021 Filmone agiografico che racconta la storia del papà delle ubertenniste sorelle Williams, della sua caparbietà e infine del suo successo. Tutto sommato ben costruito e ritmato, è per forza di cose prevedibile, un po’ perché la realtà la conosciamo tutti, un po’ perché gli snodi sono quelli classici di ogni narrazione di questo tipo con i temi di caparbietà e successo che [...]]]>
1936 – Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green, USA 2021 Filmone agiografico che racconta la storia del papà delle ubertenniste sorelle Williams, della sua caparbietà e infine del suo successo. Tutto sommato ben costruito e ritmato, è per forza di cose prevedibile, un po’ perché la realtà la conosciamo tutti, un po’ perché gli snodi sono quelli classici di ogni narrazione di questo tipo con i temi di caparbietà e successo che [...]]]>
Zitto! La smetta con quel mandolino altrimenti ci cacciano, sssh! (Filini a Fantozzi)
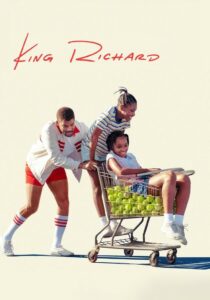 1936 – Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green, USA 2021
1936 – Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green, USA 2021
Filmone agiografico che racconta la storia del papà delle ubertenniste sorelle Williams, della sua caparbietà e infine del suo successo. Tutto sommato ben costruito e ritmato, è per forza di cose prevedibile, un po’ perché la realtà la conosciamo tutti, un po’ perché gli snodi sono quelli classici di ogni narrazione di questo tipo con i temi di caparbietà e successo che tanto piacciono agli americani: la determinazione e il rigare dritto portano indubitabilmente all’affermazione del talento. Venus e Serena Williams sono state produttrici esecutive e sebbene non si tratti di un documentario la sensazione talvolta è quella. Alla fin fine non mi pare un gran film ma il pubblico, più della critica, ha apprezzato (io ovviamente mi metto nella categoria dei guitti). Salto in avanti di due settimane dalla mia visione in sala e Will Smith vince il premio Oscar come migliore attore per questa sua prestazione edificante, condendola con un ceffone – un dritto in top spin, per rimanere in ambito tennistico – al comico Chris Rock in risposta primordiale a una battuta infelice su sua moglie Jada Pinkett. Che dire? Ma niente, dài. (Cinema Orizzonte, Milano, 12/3/22)
 1938 – I fichissimi di Carlo Vanzina, Italia 1981
1938 – I fichissimi di Carlo Vanzina, Italia 1981
Mi tolgo uno sfizio. Ci son critici che non han mai visto un film di Murnau e c’è il Cacace che mai ha visto I fichissimi, lo ammetto dolorosamente. E com’è? Una bella cacatina che però ha un sapore casereccio, di tempi semplici e si fa vedere con sapore archeologico. La storia è poco più di un canovaccio basato su Romeo e Giulietta, con la rivalità metropolitana tra milanesi e immigrati e di mezzo una ragazza, Giulietta, appunto, che s’innamora di Romeo, Jerry Calà, ed è sorella di Felice, Diego Abatantuono. Definire la comicità di grana grossa è quasi riduttivo: Calà si affida a iperboli linguistiche che forse per l’epoca erano innovative ma che non stupiscono mai granché. Abatantuono invece dà il meglio con la sua parlata da terrunciello che qualche risata la strappa, un delirio linguistico dove si mescolano alto e basso, citazioni colte e strafalcioni inimmaginabili che avrebbero trovato la consacrazione definitiva col successivo (quello sì un masterpiece) Eccezzziunale… veramente. Milano era un’altra città e questo è forse uno dei motivi più interessanti del film, come la rappresentazione di un’Italia scalcagnata prima della sbornia degli anni Ottanta, ancora povera, divisa esplicitamente in classi. Non che oggi ci sia una stratificazione diversa, ma è dissimulata da tutti mentre allora era esplicita e condivisa, dal basso quasi con orgoglio. Nella vicenda ci sono naturalmente i froci (il fratello di Abatantuono, definito “ibrido”), l’avvocato paralitico e strabico e le donne sono intese come prede (“gallinelle”) ma processare tempi e linguaggi diversi mi sembra un esercizio un po’ carognesco e molto ipocrita. E vabbeh. In un finale caotico si riesce a far decidere a Calà di disonorare Giulietta pur di poterla sposare: d’accordo che siamo nella farsaccia, ma nel 1981 si faceva ancora ricorso a questi escamotage pensando che fossero credibili? Mah! I fichissimi fa quasi tenerezza, con protagonisti che non sono comunque ricchi, belli o eroici ma che lottano contro una società di gente attempata, rivendicando il loro diritto alla felicità. Detta così sembra che si stia parlando di un’opera con un senso altissimo, ma poi l’impressione è che il film sia stato scritto e girato in due settimane e che certo cinema d’epoca anticipasse quella che poi sarebbe diventata la tivù (solo 2 anni dopo, il Drive In). Una comicità veloce e ricca di tormentoni, in qualche maniera antagonista di quella dei padri, più pomposa e, seppure tecnicamente inappuntabile, antica. Spulciando su Internet scopro che il film costò una miseria per arrivare poi a incassare una decina di miliardi di lire, preceduto nella classifica dei film della stagione da titoli come Innamorato pazzo, Il marchese del Grillo, Il tempo delle mele, Culo e camicia, I predatori dell’Arca perduta, Nessuno è perfetto, Eccezzziunale… veramente, Excalibur, Fracchia la belva umana. (Dvd, 16/3/22)
 1939 – Succession Season 2 & 3 di Jesse Armstrong, USA 2019
1939 – Succession Season 2 & 3 di Jesse Armstrong, USA 2019
A solo poco più di un mese dalla visione della prima stagione ci metto un po’ a ingranare perché c’è un intrico di nomi e mosse finanziarie e politiche che, in inglese stretto e stante il mio ottundimento, rende tutto difficoltoso. Ma Succession decolla ancora, talvolta sfiora il ridicolo quando scade nel grottesco, eppure regge e inanella scene eccezionali. Come quella del primogenito dei Roy, Connor, il megalomane che vuole diventare presidente degli Stati Uniti, che al funerale di uno zio molestatore legge un’eulologia imbarazzante scritta dalla fidanzata aspirante commediografa (ed ex escort). Poi c’è il più piccolo degli eredi, Roman, impotente, onanista e bipolare che rivela insospettabili capacità professionali dopo diversi disastri. E c’è anche la sorella Shiv, strategista politica rosa da gelosie e ambizioni, accompagnata al marito imbecille Tom, dall’eloquio ricercatissimo e succube di un rapporto insensato col cugino idiota Greg. Uno spasso dove emergono la figura gigantesca del capofamiglia Roy e del tormentatissimo figliol prodigo Kendall, schiavo di polveri e sensi di colpa. Insomma un bazar familiare impressionate e gustosissimo che prospera grazie ad attori eccezionali con in bocca dialoghi superbi, curati al dettaglio infinitesimale, tra interiezioni umorali e battute laceranti. Nell’ultima serie il gioco di alleanze e ricatti assume proporzioni inimmaginabili e si consuma l’ennesimo impensabile tradimento. Ma c’è ancora una quarta serie in arrivo e chissà chi la spunterà. (Sky, marzo 2022)
 1940 – One Day One Day di Olmo Parenti & co., Italia 2021
1940 – One Day One Day di Olmo Parenti & co., Italia 2021
Olmo Parenti e i suoi soci (Marco Zannoni, Matteo Keffer e Giacomo Ostini) non hanno neanche trent’anni e arrivano da studi diversi; hanno l’energia dell’età e le idee chiare su cosa raccontare e seguono uno dei principi cardine di Werner Herzog: prendi e vai, un film non è questione di tecnica o di attrezzature, ma di idee e volontà. E così, vivendo per un anno fianco a fianco dei braccianti extracomunitari di Borgo Mezzanone vicino a Foggia ci viene raccontata l’esistenza coraggiosa di chi ci porta in tavola la frutta e la verdura lavorando a salari da schiavitù. Una vita lontana dalla famiglia, col conforto delle telefonate a casa, della musica, della cura personale, ma dimenticati dallo Stato, senza documenti e diritti, abbandonati in una shanty town che fa notizia solo se scoppia un incendio o ci scappa il morto. Detta così – da me, male – potrebbe essere il consueto atto d’accusa, un film frignone e in qualche maniera deresponsabilizzante. Ma invece si vola alto perché il ritratto intimo dei protagonisti e la cinematografia, che sa essere lirica senza indugiare in un’estetica del disagio, rendono One Day One Day un documentario unico, entusiasmante, senza alcuna menata ideologica o dito puntato, senza strillate o piagnistei: vedi la vita di questa gente così com’è e ti rendi conto anche di tanta ipocrisia cinematografica che trasforma le disgrazie altrui in una sorta di giustificazione propria, come se potesse bastare la denuncia bella infiocchettata. Olmo & company – dopo essersi prodotti il film con pochissimi soldi e tanto lavoro – hanno cercato invano una distribuzione ma in questo paese a nessuno piace non lasciare il proprio timbro e con poco da guadagnarci: un film così è la dimostrazione plastica di come ci sia un blocco culturale e produttivo nei confronti di giovani pieni di energia che vogliono uscire dai percorsi soliti, dalle terrazze degli aperitivi, dalle cordate amicali che escludono tutti gli altri. E ci sono riusciti: visto che non si trovavano sbocchi hanno portato il film nelle scuole conoscendo un successo immediato (e non è un film facile all’inizio, per quanto alla fine immensamente soddisfacente) tanto che poi un distributore coraggioso s’è trovato e presto – si spera – One Day One Day lo vedrete su qualche piattaforma. Ma questi ragazzi hanno fatto tutto senza rivendicazioni, rimpianti o accuse: hanno semplicemente usato i social come sa fare chi ha la loro età e annunciato che il documentario era vietato ai maggiori di 18 anni, visto che i “grandi” non gli permettevano di avere una vita distributiva propria regolare. E io sono felice e son sicuro che arriveranno altri film perché qui, in One Day One Day, c’è la vita, magari misera ma dignitosa, e di opere così ne abbiamo tutti un gran bisogno. (Marzo 2022)
P.s.: Not everything is Black, primo documentario di Parenti, è su Amazon Prime: date un senso a quell’abbonamento e vedete come dalle semplici idee possano scaturire grandi film.
 1941 – La persona peggiore del mondo di Joachim Trier, Norvegia 2021
1941 – La persona peggiore del mondo di Joachim Trier, Norvegia 2021
A me per godere di un film certe volte basta un sorriso, un tocco delicato, una canzone che irrompe dalla colonna sonora. Questo film ha tante qualità, forse anche dei difetti, ma mi ha talmente conquistato il ritratto di Julie che non starò a sindacare. Julie (Renata Reinsve) è una magnifica ragazza irrisolta che – divisa tra due uomini – prova a capire cosa le riserverà la vita. Quale lavoro? Quale ruolo? Madre, compagna, amica? Una boccata d’aria per uscire dagli schemi americani o italiani: bello, coi tempi giusti, vitale, con idee di montaggio ed evasione fantastica inaspettate. E poi una buona fattura generale, con attori azzeccati e partecipi. Candidato agli Oscar stranieri 2022 (premio poi vinto da Drive My Car), mi è piaciuto, mi ha intenerito. (Sky, 2/4/22)
 1942 – Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Usa 2022
1942 – Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Usa 2022
Dopo la pandemia e il blackout seguente non era ancora capitata l’occasione. Colgo la palla al balzo e costringo la famiglia tutta a un film assieme, finalmente in sala, senza considerare che le figlie sono cresciute, hanno sviluppato un gusto loro e andare al cinema col papà è un supplizio e non più il piacere d’una volta. Infatti si annoiano, abituati ad altri tempi e ritmi. Io invece il film l’ho trovato bello, affettuoso e positivo ma ammetto che avrei apprezzato ancora di più se Anderson avesse lavorato di forbici e sintesi, perché anche a me, alla fin fine, l’accumulo ha un po’ stancato. Ma detto questo ci sta pure che questo ritratto dell’adolescenza (o perlomeno della gioventù) sia così: una vita esagerata, senza rete, senza particolare razionalità ma anzi con un po’ di stupidera collettiva, però con entusiasmo, generosità e ingenuità e soprattutto senza paura, con nulla che possa fermare la corsa dei protagonisti, una corsa che alla fine, finalmente, li porterà a collidere. Negli USA di inizio anni Settanta, tra nuove mode e crisi del petrolio, il liceale Gary si innamora della venticinquenne Alana, senza preoccuparsi della differenza d’età. Gli attori sono bravi e con facce interessanti e tutta la ricostruzione d’epoca, la musica e la fotografia sono eccellenti e alcune scene rimangono impresse, magari quelle minimali dove c’è un’intuizione che – sbam! – ti restituisce quelle emozioni perse crescendo. Come quando Gary e Alana si sfiorano le dita distesi su un materasso ad acqua, galleggiando in una sorta di liquido amniotico. Nel film c’è un mondo di giovani, praticamente una banda, che è in perenne movimento, lavorativo, affettivo, economico, senza freni e senza paure. Ogni occasione va presa, divincolandosi e oltrepassando le convenzioni della generazione dei vecchi, con ritmi antichi, grotteschi o semplicemente passati. C’è qualcosa che ricorda il free cinema o Hal Ashby, quella magnifica onestà dell’essere ragazzi e di vivere in libertà e di questi tempi non è assolutamente poco. Sofia ed Elena sono uscite dal cinema abbastanza incazzate perché si fermano su particolari inessenziali ma mancano la big picture. Vabbeh, cresceranno. (Cinema Ducale, Milano, 3/4/22)
 1945 – Anna di Niccolò Ammaniti, Italia 2021
1945 – Anna di Niccolò Ammaniti, Italia 2021
Dopo un’epidemia globale che ha colpito solo gli adulti è rimasto un mondo di bambini abbandonati a loro stessi: Ammaniti coglie nel segno di nuovo, dopo Il miracolo, e costruisce un universo folle credibile, crudele, spietato, disturbante, coloratissimo e spesso poetico, convincente fin dai titoli di testa. E tutto in anticipo sulla pandemia reale scoppiata mentre si girava la serie. Riaffiorano certi temi e manie dello scrittore: gli animali, i rapporti di forza, il cibo confezionato, ma ha tutto un lirismo coerente e un impatto visivo clamoroso. Location siciliana inedita, lontana dal cartolinismo televisivo delle fiction italiane abituali, e cast azzeccato con bambini e adolescenti diretti benissimo. Che bello. (Sky, aprile 2022)
 1946 – Jimmy Savile: A British Horror Story di Rowan Deacon, Gran Bretagna 2022
1946 – Jimmy Savile: A British Horror Story di Rowan Deacon, Gran Bretagna 2022
Jimmy Savile, personaggio onnipresente per oltre 40 anni sulla televisione britannica, era una star incontrastata e grottesca dedita alla beneficenza e anche a diversi vizi innominabili. Molti sospettavano, molti sapevano, moltissimi vivevano in trance seguendo le gesta di questo pagliaccio orrendo, pedofilo e stupratore e impunito fino alla morte. Confezione documentaria ricchissima e impeccabile, costruzione intrigante, forse finale un po’ troppo veloce, come se si avesse ancora pudore a far vedere l’inganno in cui è cascata una nazione intera che fa ancora fatica a riconoscere l’errore. Comunque bello e terrificante, montato bene e narrato con onestà, sbattendoci in faccia l’equivoco televisivo tra persona e personaggio. (Netflix, aprile 2022)
 1397 – Ozark Season 4, part 2 di Bill Dubuque e Mark Williams, USA 2022
1397 – Ozark Season 4, part 2 di Bill Dubuque e Mark Williams, USA 2022
Poco da aggiungere rispetto a quanto scritto in precedenza (qui). Ozark è (stata) una serie con tutti i difetti e pregi (effimeri) della nuova serialità. L’ho subita e ora, all’ultima stagione, la vivo con sentimenti altalenanti. Se penso a Breaking Bad, là c’era una coralità coerente, un universo risolto, dove tutto quello che veniva toccato narrativamente aveva un suo senso nell’affresco generale. Sapevamo perché era lì, da dove arrivava, come sarebbe finita (c’era una finalità). Qui in Ozark invece sembra tutto casuale e in molti casi lo è: entrano ed escono personaggi secondo convenienza effettistica. Tutte le attività della famiglia Byrde (economiche, politiche, diplomatiche, affettive etc.) durano lo spazio di una breve costruzione fino al colpo di scena e al prossimo giro, dimenticando conseguenze e destini. Ogni serie insomma pare ripartire da capo, senza uno svolgimento complessivo coerente. Poi ovviamente lo svolgimento è divertente (diverte proprio, nel senso che ti fa spostare lo sguardo, ti inganna facendoti distrarre), gli attori sono molto bravi, la fotografia è interessante (luci fredde fino all’acidità, senza colori caldi). Ma io rimpiango – per dire – tutto l’affresco delle prime due stagioni del mondo southern, pian piano perso per quanto il sud sia ancora il luogo dove tutto si svolge. Quei riti, quella signorilità antica mescolata a una certa rozzezza, la fede, il white thrash, l’etica redneck… tutto smarrito nella virata verso Narcos. Tant’è la serie ha tenuto comunque bene ma, ripeto, l’impressione è che si sia alzata l’asticella sempre, sfiorando il ridicolo e giocando apertamente con l’implausibile, purché lo spettacolo reggesse. Così si fanno gli ascolti, certo, ma non la storia, eh no. Il rush finale è abbastanza emblematico e tutto sommato ben concertato seppure nella consueta economia che quando conviene fa saltare passaggi e sviluppi, rendendo all’improvviso semplice e immediato quello che pareva insormontabile (del resto basta dire: “risolto!” e nella finzione è… risolto!). Rimane aperta una possibilità di riapertura delle vicende future dei Byrde e in qualche maniera si chiude esplicitando quello che era intuibile sottotraccia fin dall’inizio ma si faceva fatica a dire: tutti i personaggi con una coscienza e una dirittura morale vengono fatti secchi e trionfano il male, il familismo amorale e le connivenze. Un sussulto finale che che non illumina retrospettivamente quanto visto finora ma dà un minimo di nobiltà a una serie che del cinismo era interprete in tutti i sensi. (Netflix, maggio 2022)
 1398 – Tromperie – Inganno di Arnaud Desplechin, Francia 2021
1398 – Tromperie – Inganno di Arnaud Desplechin, Francia 2021
Il film ce lo hanno caldamente consigliato i miei genitori e io mi fido di una presentazione di MyMovies che parla di “film che dovremmo pregare di vedere. Luminoso e galvanizzante”. E non mi sfiora l’idea di dare un’occhiatina, chessò, a Rotten Tomatoes dove un 40% di consenso avrebbe dovuto farmi venire qualche dubbio (non che il sito sia le Tavole della Legge, però un’ideuzza te la fai). Vedendo il film ho poi pensato a quando si diceva “tua suora” o “tua Prinz verde”, passandosi la sfiga. Chi vede ‘sto film si fa passare la scalogna consigliandolo a qualcuno, se no non si spiega, perché Tromperie è una fetecchia delle peggiori, le fetecchie presuntuose, supponenti, compiaciute, che puntano altissimo e crollano miseramente. E che ovviamente convogliano l’apprezzamento di tutto il carrozzone critico che – non bastassero i cineasti cani – sfoga la propria frustrazione sugli spettatori mettendoli in soggezione e mandandoli poi a vedere film come questi, supposte pellicole d’autore, in realtà solo dolorosissime supposte. Tromperie o Inganno tiene fede al suo titolo e trascina lo spettatore in un tour de force dialogico sfiancante e poco riuscito, senza fascino, senza particolari intuizioni. Inganna perché è come una raffica di sberle e tu rimani frastornato. La base drammaturgica è fornita da Philip Roth, dal suo romanzo Deception (che mi mancava e che da adesso mi mancherà per sempre), di cui l’autore è anche protagonista. Si racconta del suo rapporto con una amante inglese, relazione alla base a sua volta per il romanzo nel romanzo (o nel film), in una masturbazione intellettualoide esasperante, di quelle che ti esulcerano e ti spossano. Io ho capito che avevamo preso il pacco dopo neanche 30 secondi. E pacco di quelli super. Per cominciare Roth ha la faccia di Denis Podalydès, già protagonista del funesto Imprevisti digitali. Veste i panni di Roth (vero o finto non mi importa, diciamo i panni di uno scrittore intelligente e affascinante) ed è credibile nella parte quanto un Lino Banfi. Inoltre ha le mani più brutte del creato, con le dita tozze e le unghie da bambino, e visto in questi due ultimi film francesi per me adesso ha il rating più scarso di sempre. La donna inglese con cui si trastulla con arzigogoli mentali è Léa Seydoux, pure lei credibile come inglese quanto una ugandese a interpretare una lappone. E non aiutano a dar retta al rapporto tra i due i dialoghi spezzettati, con ciance che si vogliono filosofiche e cazzeggi con pretese di poesia e profondità, sicuramente sensati su carta ma qui disidratati e coreografati in una messa in scena che vorrebbe essere ardita ma risulta solo vuota, neanche fotografata particolarmente bene, e piagata o da montaggi in asse che fanno moderno o, quando si vuole andare sul classico, da campi e controcampi con spesso palesi deficit di continuità. Ora: il regista, con una decina di film all’attivo, sarà mica un cretino, no? Boh: io volevo scappare e in quasi 50 anni di cinema m’è successo forse due tre volte. Perché era evidente subito che non si sarebbe andato a parare da nessuna parte (e sì che la confusione tra autore e protagonista era un bel tema – e lo si affronta veramente negli ultimi 10 minuti – così come il tema dell’ebraismo, sfiorato neanche male, ma solo sfiorato. Come in generale tutto il dualismo pubblico/privato, reale/romanzesco). Per il resto si cincischia, invece, si fa della poesia da strapazzo, si giochicchia con i temi cari a Roth (ma Roth lo può fare, non tu che adatti Roth!) e il risultato è una ciofeca sciagurata anche perché pretenziosa oltre ogni dire, col regista che ti dà di gomito facendo dire alla Seydoux che anni prima aveva i capelli blu. Capito? Ti faccio l’occhiolino, ti compiaccio dicendoti che era lei ne La vie d’Adele. Unico sussulto quando sullo schermo irrompe Rebecca Marder che è Valentina Cervi 20 anni fa, incredibile, veramente identica. Però, ecco: è il sussulto che può avere un rimbambito come me ed evidentemente mio padre che sarà stato conquistato anche dalla generosa e inutile capezzolata della Seydoux a inizio film. Quanto sarà costato un film così? Qualche milioncino di sicuro e io mi chiedo: ma chi sgancia i soldi – produttori, consorzi, commissioni etc. – quando vede poi questa roba, rimane allo stesso posto? Non viene giubilato con peci e piume e magari anche nerbate con bambù fresco? Io mi chiedo come si faccia, veramente. Son troppo vecchio per tollerare ancora il cinema cagone da festival, compiaciuto e compiacente con i criticonzi che poi scrivono recensioni imbellettate. E mio padre me la pagherà cara. (Cinema Ariosto, Milano, 8/5/22)
 1400 – La svolta di Riccardo Antonaroli, Italia 2002
1400 – La svolta di Riccardo Antonaroli, Italia 2002
Veloce, pulito, ben fotografato, ben recitato, con diverse ideuzze e una trama ben gestita. Un piccolo film con pochi difetti (il sonoro, forse… tra romanesco rubato e raccolta bassissima dopo un po’ abbiamo messo i sottotitoli) che ci ha fatto subito simpatia. Ludovico è un ragazzo irrisolto, solitario, inconcludente. Nella sua routine irrompe il criminale Jack, pieno di forza di vivere e in fuga: l’incontro porterà conseguenze imprevedibili (belle queste note di trama da quotidiano pigro). Thriller meticciato con la commedia all’italiana, ha un finale non consolatorio e tanti rimandi al cinema nostrano che fu (anche la commedia sexy!) ma in modo funzionale e ammiccante, senza compiacimenti e citazionismo autoreferenziale. Carino e riuscito. (Netflix, 21/5/22)
(Continua – 84)
Altre Divine Divane Visioni su Twitter e Facebook
Oppure binge reading qui, su Carmilla.
]]>Un regista oggi deve accettare l’idea che il suo lavoro potrà essere giudicato anche da qualcuno che magari non avrà mai visto un film di Murnau. (François Truffaut, 1975)
 1920 – Succession di Jesse Armstrong, USA 2018 Ci siamo trastullati per un po’ con la serie New Amsterdam, sostanzialmente un E.R. aggiornato ai tempi di Donald Trump e del politicamente corretto statunitense, con un dosaggio millimetrico di facce, situazioni e colpe che Cencelli a confronto era un dilettante. Poi però ci serviva qualcosa di meno [...]]]>
1920 – Succession di Jesse Armstrong, USA 2018 Ci siamo trastullati per un po’ con la serie New Amsterdam, sostanzialmente un E.R. aggiornato ai tempi di Donald Trump e del politicamente corretto statunitense, con un dosaggio millimetrico di facce, situazioni e colpe che Cencelli a confronto era un dilettante. Poi però ci serviva qualcosa di meno [...]]]>
Un regista oggi deve accettare l’idea che il suo lavoro potrà essere giudicato anche da qualcuno che magari non avrà mai visto un film di Murnau. (François Truffaut, 1975)
 1920 – Succession di Jesse Armstrong, USA 2018
1920 – Succession di Jesse Armstrong, USA 2018
Ci siamo trastullati per un po’ con la serie New Amsterdam, sostanzialmente un E.R. aggiornato ai tempi di Donald Trump e del politicamente corretto statunitense, con un dosaggio millimetrico di facce, situazioni e colpe che Cencelli a confronto era un dilettante. Poi però ci serviva qualcosa di meno democristiano, un po’ più cattivello, ecco, e la scelta è caduta su questa serie premiatissima. E se in New Amsterdam sono tutti buoni, qui, in Succession, non si salva nessuno, ma proprio nessuno. Come da titolo, il problema della famiglia Roy è la successione al vecchio patriarca per prendere le redini della Waystar RoyCo, il più potente gruppo editoriale americano, che produce televisione, gestisce parchi di divertimento e crociere e in definitiva costruisce e gestisce consenso politico. I riferimenti alla famiglia Murdoch o a concentrazioni editoriali come quelle di Trump, Turner o Bezos sono lampanti e sfumati allo stesso tempo: assistiamo a una vicenda edipica dove i quattro figli del tycoon si scannano per ereditare il potere e per esercitarlo poi sui familiari, in un gioco al massacro senza esclusione di colpi. Il capitalismo ha molte facce, tutte orrende e variamente amalgamate a stupidità, egoismo, sociopatia, deviazioni e prepotenza e seguendo le vicissitudini della famiglia Roy abbiamo il catalogo più aggiornato di sempre. Un tempo una serie così avrebbe potuto produrla solo chi avesse voluto dimostrare l’inequivocabile vocazione al cannibalismo e all’autodistruzione del Capitale. In tempi di guerra fredda, se ci fosse stato il budget, avrebbe potuto essere la prima serie sovietica, altroché, prodotta proprio per farci vedere dove porti l’amore sfrenato per denaro e potere nella società occidentale. Ovviamente negli USA il successo è stato immenso: mentre la realtà sembra copiare la fantasia, la narrativa televisiva americana riesce pure a trarne un prodotto culturale dove sulla critica e sull’analisi politica prevale l’intrattenimento. Diventa tutto spettacolo, insomma. Però va ammesso: uno spettacolo eccezionale, che trascende la tragedia shakespeariana familiare in uno humour nero irresistibile in cui, volta per volta, ti trovi a fare il tifo per il meno peggio del cast. In questo caso Kendall Roy, il secondogenito ormai vicino a succedere al padre e a svecchiare il colosso multimediale. È un personaggio ambiguo, con un passato di dipendenze e una separazione dolorosa, ed è stretto tra obblighi e ambizioni in mezzo a una famiglia di squali stronzi. Suo padre (l’eccellente Brian Cox nel ruolo di Logan Roy: sembra Maradona fra 10 anni se non fosse morto nel frattempo) è una carogna fatta e finita ma, come Kendall, non è un coglione, anzi. Ma è un’intelligenza votata al Male e alla manipolazione di cui sono vittime, a tratti consapevoli in vista di un vantaggio, più spesso inconsapevoli, gli altri tre figli. Un inferno di famiglia, insomma. La serie è scritta con astuzia luciferina: qualche volta si fa più fatica nella reiterazione di tradimenti, alleanze e rappacificazioni ma i dialoghi strepitosi (in un mix ritmatissimo tra tecnicismi finanziari, eloquio Ivy League e volgarità da trivio) e le prestazioni attoriali magistrali vi trascineranno inesorabilmente. Nota di merito anche alla musica neobarocca di Nicholas Britell. Producono Will Ferrell e Adam McKay che ha girato la puntata pilota con stile nervoso, molto godibile. Siamo senza dubbio tra le migliori serie di sempre. Vediamo come cresce. (Sky, gennaio 2022)
 1923 – America Latina dei Fratelli D’Innocenzo, Italia 2021
1923 – America Latina dei Fratelli D’Innocenzo, Italia 2021
Non conosco il cinema dei fratelli D’Innocenzo, sono sempre rimasto lì lì per provare combattuto dall’accusa di estetizzazione del marginale, con situazioni al limite etc. Ma sto parlando, appunto, di qualcosa che non conosco e dei miei pregiudizi duri a morire, pregiudizi che poi scompaiono di fronte a un film ben fatto e riuscito. È il caso di ieri sera quando su insistente richiesta della secondogenita che si vuol dare un’istruzione ho rivisto dopo un quarto di secolo L’odio, film che all’epoca era stato (anche) accusato di lettura borghese di problemi lontani dal mondo del regista, un Kassovitz che aveva reso “bello” il mondo delle periferie. Beh, posso dire? Ma che stracazzo di capolavoro, L’odio. Fotografia, ritmo, dialoghi, attori, storia ed episodi. Tutto che funzionava alla perfezione. Gli si perdonava anche il doppiaggio che spesso e volentieri tradiva l’origine romana dei doppiatori (ammerda, ar culo, astronzo… nelle banlieue, io boh). Ed è con queste premesse che non c’entrano nulla – a ragion veduta – che ho affrontato America latina in sala. E l’ho trovato interessante, non so in fondo quanto riuscito, ma coraggioso e spiazzante. Tanto per cominciare non era estetizzante o fighetto come avevo letto. Cioè, la bravura della messa in scena non l’ho vista così esibita o compiaciuta. È linguaggio e mi sono anche rotto di film girati coi piedi o con pigrizia in nome del famigerato “messaggio”. Poi ho apprezzato la direzione di Elio Germano, bravissimo in un ruolo ambiguo: un dentista di provincia, affermato ma con una sua interiorità contorta e con una famiglia dove si sommano consueti casini dell’adolescenza, rapporti di coppia e l’essere adulti in un mondo che va veloce. Il punto di svolta si ha quando il protagonista trova una ragazza prigioniera nella propria cantina. Che si fa? Non ho granché capito il punto del film, cosa ci voglia dire effettivamente, se il centro della narrazione sia sentirsi un incel o cosa. O se sia pura messa in scena. Però, ecco: avercene di registi che sanno organizzare così il materiale narrativo e visivo, che non hanno paura di uscire dai percorsi ormai veramente antichi del cinema italiano. C’è un’estetica del disagio? Sì, ma stavolta mi pare ben inserita nel racconto, non fuorviante. Semmai contesto l’endemico problema dell’audio nei film italiani che io, boh, proprio non capisco. Ma forse è colpa della mia sordità. Comunque bel film, dài, non consolatorio e né pacificatore. (Cinema Ducale, Milano 22/1/22)
 1924 – Ozark Season 4 Part I di Bill Dubuque e Mark Williams, USA 2022
1924 – Ozark Season 4 Part I di Bill Dubuque e Mark Williams, USA 2022
A un certo punto ho realizzato perché, tra tanti altri motivi, c’è qualcosa che veramente mi irrita in Ozark e allo stesso tempo mi fa andare avanti inesorabilmente. La vicenda potreste non saperla: Marty Byrde è un insipido consulente finanziario di Chicago che da finto tonto fa da ragioniere anche per un cartello della droga messicano. Nella prima puntata della serie è costretto a scappare con la famiglia (la moglie fedifraga Wendy e gli adolescenti Jonah e Charlotte) e rifugiarsi nei monti Ozark, in Missouri, in mezzo a dei burini, dove si rifà una vita rimettendo subito in piedi un meccanismo per lavare il denaro sporco. Ma alla sopravvivenza subentra anche l’ambizione, la sete di potere, l’affermazione personale, mascherando tutto sempre ipocritamente come passo ulteriore per salvarsi la vita. Già visto ma non male. Una sorta di rivisitazione di Breaking Bad con temi e ambientazioni diverse. E la gente per bene di Chicago si innesta sul marcio di Ozark, trascinando anche chi viveva inconsapevole una sua vita tranquilla. Ecco, mi son reso conto quasi subito che io non faccio il tifo per i protagonisti principali. Li detesto. Sono falsi, ipocriti, arrivisti. E altrettanto naturalmente mi son reso conto che il vero motivo per cui vado avanti è una delle loro vittime, una redneck che – anche lei per sopravvivenza – deve stare al gioco, ma mostrando qualità umane e professionali molto più ammirevoli. Nella serie lei è Ruth Langmore ed è interpretata dalla straordinaria Julia Garner, attrice di una bravura inarrivabile, semplicemente pazzesca. Io tengo per lei, ecco. La serie è ormai arrivata alla quarta stagione e prosegue con un proliferare di linee narrative che rendono tutto molto difficoltoso. Inoltre sono tutti contro tutti, anche all’interno della famiglia Byrde, con repentini cambi di fronte, tradendo la rispettiva fiducia. Il capofamiglia Marty è il consueto cucciolone, all’apparenza innocente, e invece ipocrita e calcolatore, sempre imperturbabile sia che venga picchiato (mai abbastanza) sia che prenda decisioni drammatiche che portano a conseguenze mortali, tutto con una flemma irritante e poco credibile. La moglie Wendy, viceversa, è una decisionista, ansiosa di potere, stronza come poche. L’abbraccio mortale con la famiglia di narcotrafficanti Navarro è sempre più soffocante e si va avanti con colpi di scena e colpi bassi e non si può negare che ci sia il divertimento (quando non si eccede con le durate: si è sempre intorno all’ora di racconto e proprio non ne vale la pena). Ma c’è anche la sensazione di un gelato Tutti frutti a cui si aggiungono senza criterio caramello, granella, pistacchi, panna montata, zucchero a velo, dressing di mirtilli e scaglie di cioccolata. Non c’è continenza, insomma, né una morale se non farti vedere quanto siamo corrotti noi americani e quanto godiamo a raccontarcelo. Gli archi narrativi sono sballati e i colpi di scena sono shock improvvisi e imprevedibili perché non verosimili. Però, e ritorno da dove son partito, c’è Julia Garner. E io tengo per lei e spero che, nell’ultima parte della serie in arrivo, li ammazzi tutti, dal primo all’ultimo. TUTTI. (Netflix, febbraio 2022)
 1925 – Crash Landing on You di Lee Jeong-hyo, Corea del Sud 2019
1925 – Crash Landing on You di Lee Jeong-hyo, Corea del Sud 2019
Il classico dubbio che assale chi scandaglia l’enorme catalogo di Netflix: leninisticamente che fare? E allora io mi scoppio una serie sudcoreana, ecco cosa, che matto! Dunque: una giovane imprenditrice sudcoreana che ha voltato le spalle al padre e ora ereditiera di un impero economico viene travolta da un tornado mentre prova un nuovo parapendio e, per beffarda capacità sceneggiatoria e meteorologica, finisce in Corea del Nord, appesa a un albero da cui cade tra le braccia di un ufficiale rigoroso ma ovviamente sensibile al fascino della tizia. Basta uno sguardo e capisci già come finirà, con la consueta lotta tra dovere, libertà e amore. Beh, abbastanza farsesco, con toni da commedia molto infantili. Però interessante nella rappresentazione della Corea del Nord (militari ottusi e contadinotti simpatici) e come prodotto di largo consumo che in Corea del Sud ha conosciuto un successo clamoroso. Poi: faccio il mattocchio, va bene, ma di questo Crash Landing on You ne vedo solo qualche puntata e infine desisto perché il livello è proprio basso. Ma non nascondo che nella puntata pilota mi sono divertito: anche i coreani hanno i loro Don Matteo, che credete, eh. (Netflix, 29/1/22)
 1926 – Landscapers di Ed Sinclair, Gran Bretagna/USA 2021
1926 – Landscapers di Ed Sinclair, Gran Bretagna/USA 2021
David Thewlis e Olivia Colman interpretano una coppia omicida di disadattati inglesi non granché intelligenti, una sorta di Rosa e Olindo britannici: hanno fatto secchi i genitori di lei e poi hanno vissuto incredibilmente senza destare sospetti per dieci anni finché – scappati in Francia – non hanno esaurito tutti i soldi. Non avendo ulteriori vie di fuga, tornano in patria e si lasciano arrestare, convinti di farla franca: si proclamano innocenti con un ingenuo piano di difesa che crollerà prestissimo. Interessante la regia, straniante, con la realtà che si mescola al racconto, usando il set della serie come nuovo piano narrativo o, come nello splendido ultimo episodio, ambientando tutto su un piano fantastico (in questo caso western), a ulteriore riprova del distacco dalla realtà dei due protagonisti. Produzione eccellente, attori bravissimi, dura circa 3 ore ed è spezzato in 4 parti, con sapori differenti e senza particolari cliffhanger. (Sky, febbraio 2022)
 1927 – After Life Season 3 di Ricky Gervais, Gran Bretagna 2022
1927 – After Life Season 3 di Ricky Gervais, Gran Bretagna 2022
La seconda serie di After Life mi era già sembrata di troppo, quasi che sporcasse l’esito notevolissimo della prima e adesso ho tantissimi dubbi su questa ennesima riproposizione. Tony (Ricky Gervais) sta ancora elaborando con il suo cinismo disincantato il lutto per la scomparsa della moglie e non ha più nulla da chiedere alla vita, tanto per cambiare. Ha tutto il sapore di un déjà vu, senza veramente alcun avanzamento, come se il tempo si fosse congelato, con tutte le intuizioni fantastiche della prima serie ripetute per la terza volta. Certo, c’è sempre il piacere per la battuta feroce e per la programmatica sgradevolezza, per gli imbarazzi, per la scorrettezza politica pure un po’ prevedibile ma liberatoria. La seconda serie terminava con l’infermiera – che seguiva il padre di Tony – che si accontentava di avere con lui una relazione aperta: una continua ripartenza ogni volta. E la sensazione è che sia successo anche alla terza serie di avere adottato questa modalità: lo stralunato mondo del paesino di Tambury va avanti e Tony, nella sua casa da riccone continua a non venire a capo del suo immenso dolore. That’s it. O perlomeno, c’è un’accettazione più serena della vita per impercettibili tocchi e avanzamenti, ma è tutto molto impalpabile e si arriva a un finale melassoso dove la cosa paradossale è che non è Tony a imparare delle lezioni (se non quella molto prevedibile da parte di un bimbo leucemico) ma semmai è lui a impartirle e a risolvere i guai degli amici. Una glassa di buoni sentimenti che stona con quanto abbiamo visto finora. Non che volessi l’irriducibile cinismo a tutti i costi ma che ci fosse una mediazione sì. Poi, a Gervais vuoi bene, è tutto di buon livello (ma meno del solito) e perdoni anche i momenti che girano a vuoto (e ce ne sono diversi, dove attendi la chiusa finale, una battuta, un punto. E non c’è). Però non lo trovo un finale all’altezza di cosa lo ha preceduto. Peccato. (Netflix, febbraio 2022)
 1928 – Il potere del cane di Jane Campion, Gran Bretagna/ Australia/ Nuova Zelanda/ Canada 2021
1928 – Il potere del cane di Jane Campion, Gran Bretagna/ Australia/ Nuova Zelanda/ Canada 2021
Ubriacato da troppe serie azzardo il grande passo col film Netflix da festival, già vincitore del Leone d’Argento a Venezia 2021 e firmato da quella Jane Campion che in passato mi ha regalato film intensi ma anche qualche vaccata. Il potere del cane è immediatamente un film insinuante, intrigante, velato di sensualità e con un passo autoriale molto meditato e lontanissimo dalle abitudini indotte dal consumo televisivo col diktat pavloviano del colpo di scena continuo. No, qui c’è una calma quasi olimpica, accompagnata dalla fotografia dei maestosi paesaggi neozelandesi non ancora antropizzati che recitano da dio. La vicenda è ambientata nel Montana del 1925, praticamente ancora il Far West: tra due fratelli rancheros scoppia la rivalità quando il posato amministratore George si innamora della vedova Rose, scatenando la gelosia del machissimo cowboy Phil. Apparentemente il problema sono i soldi ma anche l’omosessualità considerata una devianza da beffeggiare o il ruolo della donna in una società rurale ancora arcaica. Bravissimi gli attori, su tutti lo spigoloso Benedict Cumberbatch (Phil), un viso espressionista che sembra dipinto da Francis Bacon, e Kirsten Dunst, che non ha più il facciotto da orsetto che mi perseguita dai tempi in cui interpretava la bambina malefica di Intervista col vampiro. Qui, nella stanchezza della maturità, dà un’interpretazione sofferta e convincente. Che dire, alla fine? Beh, bello sapere che si faccia ancora del cinema così, dove le aspirazioni si accompagnano alle capacità e la regia non cerchi shock a buon mercato ma sappia lavorare sulle nuance. (Due settimane dopo Il potere del cane ha vinto il premio Oscar come miglior regia. Bene). (Netflix, 14/2/22)
 1929 – I predatori di Pietro Castellitto, Italia 2020
1929 – I predatori di Pietro Castellitto, Italia 2020
Pietro Castellitto, attore (Speravo de morì prima, Freaks Out) cresciuto nel Vietnam di Roma Nord (cit.) e figlio di una coppia sicuramente ingombrante (Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini) esordisce alla regia, neanche trentenne, con questo interessante I predatori che ha fatto strage di allori negli sfiatati premi nostrani. Giungle indocinesi a parte, Castellitto Jr. dimostra stoffa, coraggio, anche noncuranza di certe buone maniere italiane che tutto edulcorano, tutto sbiancano e sanificano. Il film è curioso, con alcune cadute e ingenuità (da irruenza, da ignoranza, da giovane età) ma anche tanta vitalità e un finale che rischiara a posteriori quanto visto, con una pietas che rende più sincero l’indeterminato ribellismo che permea tutta la pellicola. La trama è un astuto intrico che mette a confronto due mondi lontanissimi: la famiglia di un medico con moglie regista radical chic e figlio nietzschiano esagitato e quella di un fascistone amante delle armi e con diversi agganci con la microcriminalità. La descrizione di questa seconda famiglia è coraggiosa, non scontata. Più banale e piagata da qualche cliché quella della famiglia borghese cinica, con arie intellettuali ma lercia dentro. Bravissimo attore Giorgio Montanini, tanto quanto l’ho sempre trovato irrisolto come comedian, e in generale ben diretto il cast, cosa non da poco per un esordiente. Interessante anche la fotografia. Decisamente discutibile – ma sembra veramente qualcosa di insormontabile, in Italia – la cattura dell’audio, tanto più che la parlata dei protagonisti è spesso difficoltosa. A conti fatti comunque ne viene fuori un’opera prima interessante, non consolatoria né compiaciuta, e che sa uscire dai confini augusti della cinematografia nazionale. Non male. (Amazon, 15/2/22)
 1931 – Ennio di Giuseppe Tornatore, Italia/ Belgio/ Cina/ Giappone 2021
1931 – Ennio di Giuseppe Tornatore, Italia/ Belgio/ Cina/ Giappone 2021
Un documentario commovente. Montato benissimo e previsto da dio da Tornatore, è un caleidoscopio di dichiarazioni, testimonianze, brani di film, canzoni e spettacoli. Verso l’ora e mezza sembra che ci sia una flessione e invece si va avanti così, con te che ti aspetti che prima o poi la fatica abbia la meglio su di te spettatore e sulla narrazione, e invece no: il documentario continua a rinvigorirsi e chiude benissimo. Morricone, compositore eccelso, allievo di accademici che lo hanno messo in soggezione per una vita, arriva a far pace col suo mestiere e coi suoi risultati incredibili. E tu piangi con lui. E sei cullato da questa musica straordinaria e dall’abbinamento con scene che è un piacere immenso rivedere sul grande schermo. Molto molto bello. (Cinema Anteo CityLife, 27/2/22)
 1933 – Marx può aspettare di Marco Bellocchio, Italia 2021
1933 – Marx può aspettare di Marco Bellocchio, Italia 2021
Bellocchio racconta la sua famiglia scegliendo (e sciogliendo) il nodo del suicidio del suo fratello gemello Camillo. Sette fratelli e sorelle, con un padre autoritario e una madre religiosissima; un primogenito, Paolo, autistico e schizofrenico; una sorella oggi novantenne e sordomuta; e poi gli altri, tutti di vario e importante successo, a partire dall’intellettuale Piergiorgio, fondatore dei Quaderni piacentini. Camillo rimane così l’unico senza una strada, una vocazione, ma anche meno debole di altri tanto da non richiedere un’attenzione particolare. Attraverso il ricordo della sua storia vengono fuori i caratteri dei fratelli, legati anche dai tanti momenti cinematografici di Marco che ha sempre attinto dal vissuto più intimo l’ispirazione per la sua cinematografia. Bellocchio ha una voce stentorea, è dritto come un bacco, non cerca scappatoie, è spietato nella sua indagine familiare come lo era nei suoi film e non si risparmia imbarazzi o reticenze, rischiando anche di sembrare – più che intellettualmente onesto – proprio cinico, freddo, distaccato, insomma uno stronzo. Ma invece è una lezione di onestà rara. Il film commuove e ci racconta un’Italia completamente diversa, che si stava facendo, divisa tra “Cristo e Stalìn” (cit.), dove si lottava e si pagava, anche la propria inadeguatezza. Bello. (Amazon, 2/3/22)
 1934 – Once Upon a Time in America di Sergio Leone, Italia/ USA 1984
1934 – Once Upon a Time in America di Sergio Leone, Italia/ USA 1984
Questo l’ho visto la prima volta quando ero un ragazzo che si faceva invadere dai film, senza pensarci troppo. E m’era piaciuto. Poi l’ho rivisto verso i 30 anni quando invece cercavo risposte, intellettualizzando tutto (o provando a intellettualizzare tutto) e stando più attento ai presunti difetti che ai pregi di ogni opera. Che stupido. Oggi, a 50 anni passati, vedo finalmente C’era una volta in America nella versione integrale di oltre 4 ore, con la giusta distanza, con l’emozione per quel cinema italoamericano superlativo che vedeva registi e maestranze in comune, con l’Italia che poteva e sapeva ricostruire l’America a Cinecittà, con la voglia di racconti fluviali che si interrogavano sul passare del tempo e sulla persistenza della memoria. Qui è un continuo traguardare porte e vetri, fissarsi sui riflessi illusori degli specchi o intravedere attraverso fessure, buchi e crepe, anche dell’anima. Orologi, ticchettii, telefonate senza risposte, rumori ossessivi che dilatano il tempo e chiavi che aprono porte, valigie e segreti. Com’è possibile che un film su un uomo come Noodles ci piaccia così tanto, con un protagonista enigmatico, senza scrupoli, assassino, traditore e pure violentatore? Perché lo sceglie Leone? E se non è questo gangster, cos’è allora che ci fa amare il film: il riconoscere i nostri peccati di fronte allo scorrere inesorabile del tempo? I rimpianti? Le occasioni perdute? Noodles (Robert De Niro) è un uomo mai cresciuto e che forse non ha neanche vissuto, visto che l’amico Max (James Woods) confessa di avere fatto lui la sua vita: ha avuto i suoi soldi, il suo amore – Deborah -, il suo dolore, credendolo morto. Noodles va in carcere ancora adolescente e perde la giovinezza ma ai nostri occhi non ha neanche una maturità, non sapendo cosa abbia fatto nei 30 anni in cui è andato a dormire presto. In questa versione integrale il fatto che dopo l’assalto a Deborah Noodles vada subito con un’altra donna, la futura compagna Eve, mi fa supporre che quella in macchina fosse una tentata violenza, non riuscita. Non che cambi molto ma forse è un modo per rendere meno odiosi i suoi crimini. Io, all’ennesima visione, sono rimasto abbacinato dalla bellezza della messa in scena, dalla grandiosità di tutto, ma tant’è ho sempre dei dubbi sui personaggi, sull’indeterminatezza di Noodles e sul cambiamento di Max che mi pare ancora molto repentino. Se però oggi ho apprezzato il film come merita è anche grazie al magnifico libro di Piero Negri Scaglione Cosa hai fatto in tutto questo tempo, lettura che racconta l’iter produttivo e creativo di questo capolavoro. E si comprendono così, del film, presenze e assenze, illusioni, travisamenti: è tutto un inganno, il tempo che passa, le amicizie, i patti, la giustizia, l’amore. Forse anche il film stesso è un sogno a cui vogliamo credere. Molto molto bello e malinconico, come un sigillo su un mondo che stava finendo senza che ce ne rendessimo conto. (Dvd, 5/3/22)
 1935 – The Cold Blue di Erik Nelson, USA 2018
1935 – The Cold Blue di Erik Nelson, USA 2018
Le immagini girate da William Wyler durante il secondo conflitto mondiale tornano a nuova vita attraverso le testimonianze di 9 reduci dell’Ottava Air Force americana. Gente tra i 19 e 25 anni che, dal 1943 al 1945, volò sulla Germania nazista. Delle 13000 fortezze volanti B17 in missione 5000 furono abbattute, al costo di circa 28000 soldati morti. I danni alla Germania furono decisivi: dopo attacchi mirati a porti, strade, raffinerie e industrie cominciarono i bombardamenti a tappeto, con centinaia di migliaia di vittime tra i civili. Numeri allucinanti che ho voluto riportare in cifre. E immagini invece bellissime, di cieli azzurri e di giovani sorridenti davanti all’obiettivo. E terrorizzati in missione. Su aerei che tornavano a terra distrutti, coi motori fuori uso e le lamiere bucherellate: velivoli senza pressurizzazione con temperature interne insostenibili, nonostante l’illusorio bel tempo, dai 20 ai 40 gradi sotto zero. I quasi centenari superstiti raccontano la loro vita inconsapevole, la paura, le superstizioni, le amicizie e la permanenza per anni in Gran Bretagna (2 milioni di soldati!). Un film terribile, non retorico e prezioso, musicato tra l’altro da Richard Thompson con una partitura composta e non invadente. Sono passati 75 anni da allora e non s’è ancora imparato nulla. (HBO, 5/3/22)
(Continua – 82)
Altre Divine Divane Visioni su Twitter e Facebook
Oppure binge reading qui, su Carmilla.
]]>