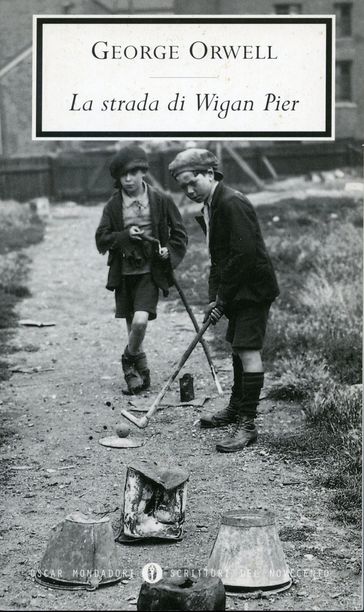 Ultimamente ho incassato un po’ di delusioni da diverse persone sulle quali contavo in modo particolare: tutta gente che frequento da almeno quarant’anni, si sappia. È stata la loro intelligenza a deludermi, le loro esternazioni a sorprendermi negativamente. E a parole che fanno male, ho pensato di porre rimedio con parole che fanno bene: è una vita che mi curo coi libri. Sono entrato in sala dove tengo esposti gli oltre cinquecento libri letti di cui ho preferito non liberarmi e, col magone, ho cercato lo spazio dedicato ai titoli di George Orwell: in qualche angolo del mio cervello [...]]]>
Ultimamente ho incassato un po’ di delusioni da diverse persone sulle quali contavo in modo particolare: tutta gente che frequento da almeno quarant’anni, si sappia. È stata la loro intelligenza a deludermi, le loro esternazioni a sorprendermi negativamente. E a parole che fanno male, ho pensato di porre rimedio con parole che fanno bene: è una vita che mi curo coi libri. Sono entrato in sala dove tengo esposti gli oltre cinquecento libri letti di cui ho preferito non liberarmi e, col magone, ho cercato lo spazio dedicato ai titoli di George Orwell: in qualche angolo del mio cervello [...]]]>
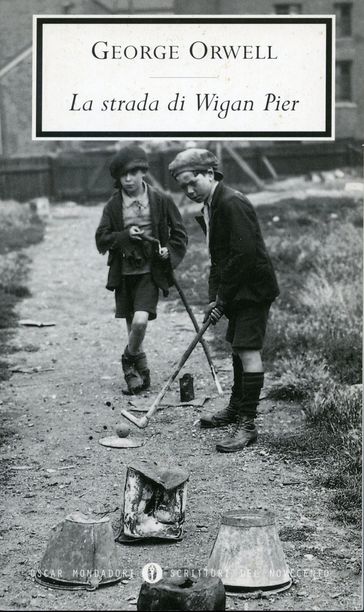 Ultimamente ho incassato un po’ di delusioni da diverse persone sulle quali contavo in modo particolare: tutta gente che frequento da almeno quarant’anni, si sappia. È stata la loro intelligenza a deludermi, le loro esternazioni a sorprendermi negativamente. E a parole che fanno male, ho pensato di porre rimedio con parole che fanno bene: è una vita che mi curo coi libri. Sono entrato in sala dove tengo esposti gli oltre cinquecento libri letti di cui ho preferito non liberarmi e, col magone, ho cercato lo spazio dedicato ai titoli di George Orwell: in qualche angolo del mio cervello c’era la certezza che un libro dello scrittore inglese potesse aiutarmi. Guardo La fattoria degli animali, ma il cervello non reagisce. Una boccata d’aria? Senza un soldo a Parigi e a Londra? Niente. Forse Omaggio alla Catalogna oppure 1984? Neppure. Nel ventre della balena? Zero assoluto. Possibile che quell’angolo del mio cervello abbia preso un tale abbaglio? Data l’età sì. E invece no che non l’ha preso! Eccolo lì il ricercato, stranamente fuori posto: La strada di Wigan Pier. Mi affretto a cercare in terza di copertina tutte le note che richiamano ogni mia sottolineatura di quando l’ho letto nell’aprile del 2005 – non è buona memoria: ho trovato la data in calce alle note –, e inizio a sfogliare il libro cercando le frasi sottolineate, l’urgente medicamento.
Ultimamente ho incassato un po’ di delusioni da diverse persone sulle quali contavo in modo particolare: tutta gente che frequento da almeno quarant’anni, si sappia. È stata la loro intelligenza a deludermi, le loro esternazioni a sorprendermi negativamente. E a parole che fanno male, ho pensato di porre rimedio con parole che fanno bene: è una vita che mi curo coi libri. Sono entrato in sala dove tengo esposti gli oltre cinquecento libri letti di cui ho preferito non liberarmi e, col magone, ho cercato lo spazio dedicato ai titoli di George Orwell: in qualche angolo del mio cervello c’era la certezza che un libro dello scrittore inglese potesse aiutarmi. Guardo La fattoria degli animali, ma il cervello non reagisce. Una boccata d’aria? Senza un soldo a Parigi e a Londra? Niente. Forse Omaggio alla Catalogna oppure 1984? Neppure. Nel ventre della balena? Zero assoluto. Possibile che quell’angolo del mio cervello abbia preso un tale abbaglio? Data l’età sì. E invece no che non l’ha preso! Eccolo lì il ricercato, stranamente fuori posto: La strada di Wigan Pier. Mi affretto a cercare in terza di copertina tutte le note che richiamano ogni mia sottolineatura di quando l’ho letto nell’aprile del 2005 – non è buona memoria: ho trovato la data in calce alle note –, e inizio a sfogliare il libro cercando le frasi sottolineate, l’urgente medicamento.
“La cosa più terribile in [certa] gente […] è il modo con cui ripetono all’infinito sempre le stesse cose.” In effetti, ai personaggi che mi hanno ferito ho troppo spesso scusato il loro frequente ripetersi, mi spiaceva farglielo notare, ma il sopportare questa loro terribile caratteristica non mi ha giovato: quando il problema su cui avrei voluto confrontarmi era di una portata spaventosa, mi è stata detta la stessa banalità che avevo già sentito per il figlio del fruttivendolo sotto casa, che non ha mai mostrato troppa voglia di lavorare.
Qualche pagina più avanti, con l’evidente intento d’infondermi coraggio, Orwell mi dice: “Per quanto abbia tentato, l’uomo non è ancora riuscito a spargere la sua sporcizia dappertutto. La terra è così vasta e ancora così vuota che perfino nel sudicio cuore della civiltà trovi campi dove l’erba è verde anzi che grigia; forse, a cercarli, si potrebbero perfino trovare fiumi e torrenti con dentro pesci vivi anzi che scatole di salmone.”
Questa faccenda di non aver mai fatto notare ai miei interlocutori che si ripetevano, che le loro frasi sfilate dalla faretra della banalità non servivano a nulla, che erano comode solo ai piccoloborghesi per infilzare qualsiasi discorso, ferirlo, se non ucciderlo, potrebbe aver spiegazione nelle mie radici operaie: lo erano i miei nonni, lo era mio padre, lo son stato io per almeno una dozzina d’anni: “Questa faccenda […] di dover fare ogni cosa secondo il comodo altrui è implicita nella vita della classe operaia. Mille influenze costringono di continuo l’operaio in una parte passiva. Egli non agisce, ma subisce l’azione altrui. Si sente schiavo di una misteriosa autorità ed è fermamente convinto che “quelli” non gli permetteranno mai di fare questo, quello, o quell’altro.”
Mi domando se anch’io faccio parte di “quella gente [che] ha cessato di scalciare sotto le frustate.” Fa bene Orwell a farmelo notare.
Che poi, ripensandoci bene, una delle persone che mi ha deluso è un dirigente abituato a sviscerare complessità enormi che spesso “l’uomo comune” ha difficoltà persino a immaginare, a sbrogliare matasse relazionali sviscerando ogni minimo dettaglio; sia chiaro, non per il gusto del vivere pacifico, ma perché ogni risorsa coinvolta in qualsivoglia bega possa rendere al massimo in quella famosissima ditta per cui lavora. Ma anche qui sbagliavo: “…lo sviluppo postbellico di generi voluttuari a buon mercato è stato una fortuna per i nostri governanti. È molto verosimile che pesce e patatine fritte, calze di seta, salmone in scatola, cioccolata a prezzi modici […] il cinematografo, la radio, il tè forte e i Football Pools abbiano fra tutti evitato la rivoluzione. Così che ci sentiamo dire ogni tanto che tutta la faccenda è un’astuta manovra della classe dirigente – una specie di “pane e circensi” – per tenere a bada i disoccupati. Ciò che ho visto della nostra classe dirigente non mi convince che abbia molta intelligenza. La cosa è avvenuta, ma attraverso un processo inconscio: l’interazione affatto naturale tra la necessità da parte dell’industriale di un mercato e il bisogno, da parte di gente semiaffamata, di palliativi a basso costo.”
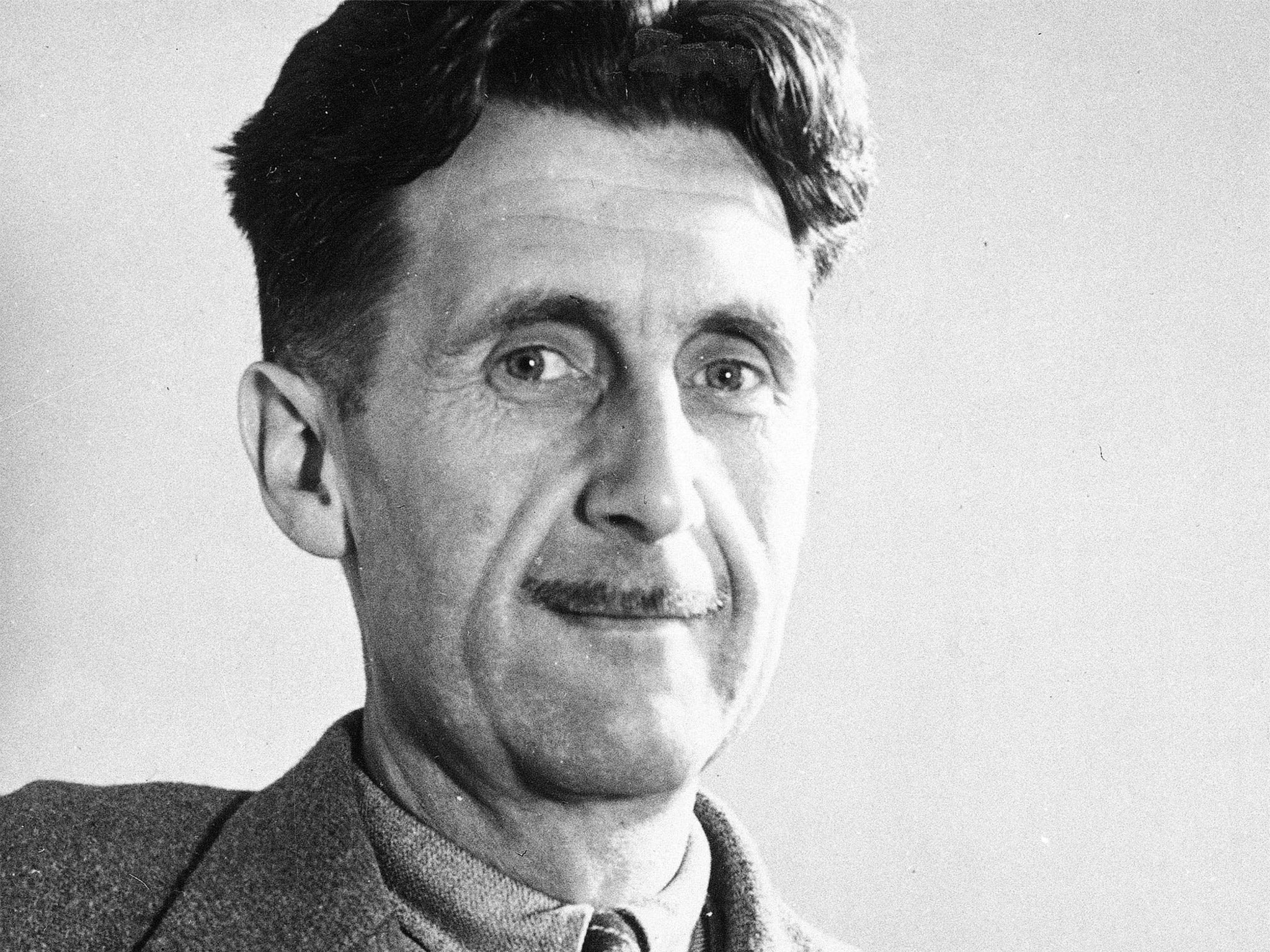 Ciò che ho visto della nostra classe dirigente non mi convince che abbia molta intelligenza, e io l’avevo vista la poca elasticità di questa stirpe, ma avevo dimenticato, o meglio, ritenevo che qualcuno si potesse salvare da questo egocentrismo che riesce a convincerli d’essere in grado di chiudere a loro favore ogni querelle, disputa, perché alla fine di questo si trattava: io esprimevo un pensiero rispettando il suo, lui esprimeva il suo ritenendo il mio quello di un idiota. Era un pensiero per nulla profondo, il mio, lo ammetto; mi ero limitato a dire che invidiavo agli stranieri la loro capacità di aprire un’attività in Italia mentre io, che non ho il problema della lingua, non saprei neppure da che parte iniziare, tutto qui. Bene, dall’altra parte mi sentivo ripetere che sbagliavo. In cosa? Sbagliavo a invidiarli, STOP!, senza alcuna spiegazione del perché ero nell’errore. Detto che la mia era invidia “buona” e che al mio contraltare nulla importava dei sette peccati capitali che lo impregnano da una vita per minimo quattro settimi del totale, mi chiedevo – visto lo stato in cui ero: dignitosamente disperato – non mi fai neppure un piccolo sconto? Perché mi aspettavo uno sconto? Perché nelle case dove sono cresciuto s’è sempre respirato un’atmosfera profondamente umana: “In una casa della classe operaia – non penso per il momento a case di operai disoccupati, ma ad altre relativamente prospere – si respira un’atmosfera calda, onesta, profondamente umana, che non è molto facile trovare altrove.”
Ciò che ho visto della nostra classe dirigente non mi convince che abbia molta intelligenza, e io l’avevo vista la poca elasticità di questa stirpe, ma avevo dimenticato, o meglio, ritenevo che qualcuno si potesse salvare da questo egocentrismo che riesce a convincerli d’essere in grado di chiudere a loro favore ogni querelle, disputa, perché alla fine di questo si trattava: io esprimevo un pensiero rispettando il suo, lui esprimeva il suo ritenendo il mio quello di un idiota. Era un pensiero per nulla profondo, il mio, lo ammetto; mi ero limitato a dire che invidiavo agli stranieri la loro capacità di aprire un’attività in Italia mentre io, che non ho il problema della lingua, non saprei neppure da che parte iniziare, tutto qui. Bene, dall’altra parte mi sentivo ripetere che sbagliavo. In cosa? Sbagliavo a invidiarli, STOP!, senza alcuna spiegazione del perché ero nell’errore. Detto che la mia era invidia “buona” e che al mio contraltare nulla importava dei sette peccati capitali che lo impregnano da una vita per minimo quattro settimi del totale, mi chiedevo – visto lo stato in cui ero: dignitosamente disperato – non mi fai neppure un piccolo sconto? Perché mi aspettavo uno sconto? Perché nelle case dove sono cresciuto s’è sempre respirato un’atmosfera profondamente umana: “In una casa della classe operaia – non penso per il momento a case di operai disoccupati, ma ad altre relativamente prospere – si respira un’atmosfera calda, onesta, profondamente umana, che non è molto facile trovare altrove.”
Case dove ho imparato molto, dove s’impara molto: “…so che si può imparare molto in una casa operaia, sol che vi si possa andare a vivere. Il punto essenziale è che i vostri ideali e pregiudizi borghesi sono messi alla prova dal contatto con altri ideali e pregiudizi che non sono necessariamente migliori, ma sono certo diversi.”
Case in cui non si va tanto per il sottile, dove si dice pane al pane e vino al vino, dove regna la schiettezza: “Un’altra caratteristica operaia, sconcertante in un primo momento, è la schiettezza nei riguardi di chiunque l’operaio ritenga suo pari. Se offrite a un operaio qualcosa che egli non vuole, vi dirà che non la vuole; una persona del ceto medio l’accetterà evitando così di offendervi.” Forse sarà stata la mia schiettezza a infastidire, chissà.
Di certo qualcuno era infastidito: io. E lo ero per via della pena capitale che avrebbe volentieri inflitto chi stava dall’altra parte del telefono, al ragazzo su cui si stava disquisendo, un giovane che, in fondo, aveva soltanto ripetuto più volte d’avere in testa un unico progetto di vita pressoché impossibile da realizzare, denunciando così tutto il proprio grande disagio e che questo – il Grande Disagio – andava analizzato, null’altro: “La maggioranza della gente approva la punizione capitale, ma quella stessa maggioranza non vorrebbe fare il lavoro del boia. E ancora… Non ho mai messo piede in una prigione senza sentire […] che il mio posto era dall’altra parte delle sbarre. […] il peggior criminale che abbia mai camminato su questa terra è moralmente superiore al giudice che lo condanna alla forca.” Ma quanti passaggi interessanti ci sono in questo libro?!
Le delusioni a cui sto facendo riferimento, le ho incassate sia parlando al telefono sia vis à vis e anche nei silenzi che dialogando faccia a faccia, spesso, dicono più di tante parole: “…sfortunatamente non mi ero allenato ad essere indifferente all’espressione della faccia umana.”
Nonostante tutto, a parte l’impatto iniziale di questi scontri imprevisti, ne sono uscito certamente più forte: “È solo quando s’incontra qualcuno di cultura ed educazione differenti dalle nostre che si comincia a scoprire quali siano realmente le nostre opinioni.”
Eppure, me lo ricordo bene quel dirigente quand’era ragazzo, verso la fine degli anni Settanta, quando girava con in testa la cresta colorata dei punk dell’epoca: “…si può osservare […] il triste fenomeno del borghese che è un ardente socialista a venticinque anni e un conservatore tutto sussiego a trentacinque.”
Se non vi ho ancora annoiato, termino con l’ultima grande delusione: una persona che raccoglie per anni le mie confidenze e un giorno scopro non aver tenuto per sé nulla, ogni mia personalissima parola l’aveva data in pasto ad altri. Motivo? “Perché così potrai riappacificarti con un po’ di persone.” Ma uno potrà ancora avere almeno la libertà di decidere da sé quando, come e con chi riappacificarsi? Purtroppo, pare non essere così, c’è sempre qualcuno che si erge genitore benché tu abbia ormai tutti i capelli grigi, e ti indichi la retta via. Questa persona credente cattolica, fottendosene ampiamente del segreto previsto dal sacramento della (mia) confessione, mi ha gettato al vento un mondo intero, perlomeno una dimensione di questo: “Come avviene per la religione cristiana, la peggior pubblicità al socialismo è rappresentata dai suoi fautori”, sempre il buon George.
 Niente. Non mi resta altro da fare che ammettere tutta la mia imbecillità: a cosa serve leggere, rileggere, sottolineare Orwell se poi penso ad altro e abbasso la guardia? Appena l’ho abbassata, subito mi hanno fiocinato come un polpo, anzi, di più, mi hanno battuto come un polpo, legato, incaprettato e trascinato per lo scalpo. Consegnata ai posteri la mia ammissione d’imbecillità, mi viene in mente che una cosa ha accomunato tutte queste delusioni: gl’interlocutori m’interrompevano continuamente. Mi si voleva silenziare, in pratica. Insomma, era stato messo in opera un genocidio nei miei confronti: “…c’è una differenza sostanziale fra genocidio e tortura. Il genocidio cerca di mettere a tacere, mentre la tortura è l’antidoto contro il silenzio.” Questo non è più Orwell, è John Biguenet e il suo libro s’intitola Elogio del silenzio, un saggio da non perdere: “…un mondo in cui il destino, anzi Dio stesso si son fatti famosi anzitutto perché ci fronteggiano col silenzio.”
Niente. Non mi resta altro da fare che ammettere tutta la mia imbecillità: a cosa serve leggere, rileggere, sottolineare Orwell se poi penso ad altro e abbasso la guardia? Appena l’ho abbassata, subito mi hanno fiocinato come un polpo, anzi, di più, mi hanno battuto come un polpo, legato, incaprettato e trascinato per lo scalpo. Consegnata ai posteri la mia ammissione d’imbecillità, mi viene in mente che una cosa ha accomunato tutte queste delusioni: gl’interlocutori m’interrompevano continuamente. Mi si voleva silenziare, in pratica. Insomma, era stato messo in opera un genocidio nei miei confronti: “…c’è una differenza sostanziale fra genocidio e tortura. Il genocidio cerca di mettere a tacere, mentre la tortura è l’antidoto contro il silenzio.” Questo non è più Orwell, è John Biguenet e il suo libro s’intitola Elogio del silenzio, un saggio da non perdere: “…un mondo in cui il destino, anzi Dio stesso si son fatti famosi anzitutto perché ci fronteggiano col silenzio.”
È in questo libro che ho realizzato una conclusione tanto scontata quanto sfuggente: chi t’interrompe manifesta la sua superiorità: “…mentre cercavo di perfezionarmi nel mestiere di professore, lessi un articolo sulla tendenza degli insegnanti, sia uomini che donne, a interrompere le studentesse – ma non gli studenti – mentre rispondono alle domande. […] Viviamo in un mondo in cui le donne vengono spesso messe a tacere, a volte anche in modo violento. Ma l’umiliante affronto di zittire le donne con nonchalance è un’esperienza talmente radicata nella nostra quotidianità che questo piccolo esempio di imposizione del silenzio su un altro essere umano – la brusca interruzione […] dell’insegnante – in realtà può aiutare, anche meglio di casi più eclatanti, a chiarire quale ruolo abbia il silenzio nel mantenimento dell’attuale distribuzione del potere nella società.”
 Il tentativo di zittirmi va avanti ormai da una vita. Mi contestano i credenti perché non credo e mi contestano i non credenti perché non sto neppure dalla loro parte, e allora mi consolo con Non ho risposte semplici, un volume che raccoglie una ventina tra interviste e conversazioni con Stanley Kubrick, che delineano il suo genio: “Nella galassia ci sono cento miliardi di stelle e nell’universo visibile ci sono cento miliardi di galassie. Ogni stella è un sole, come il nostro, probabilmente con pianeti che lo circondano. […] Pensi al tipo di vita che potrebbe essersi evoluta su quei pianeti nel corso di millenni, e pensi anche a quali passi da gigante ha fatto la tecnologia dell’uomo sulla terra nei seimila anni in cui è documentata la sua civiltà, un periodo che è più piccolo di un granello di sabbia nella clessidra cosmica. […] Quelle intelligenze cosmiche […] potrebbero essere in comunicazione telepatica simultanea attraverso tutto l’universo; potrebbero aver ottenuto la padronanza completa sulla materia, e quindi potrebbero essere in grado di trasportarsi telecineticamente in modo istantaneo a miliardi di anni luce di distanza; nella loro forma definitiva, potrebbero essersi liberati completamente del guscio del corpo ed esistere in quanto coscienze incorporee e immortali in tutto l’universo. […] tutti gli attributi essenziali di quelle intelligenze extraterrestri sono gli attributi che noi conferiamo a Dio. E se quegli esseri di pura intelligenza dovessero mai intervenire negli affari dell’uomo, i loro poteri sarebbero talmente lontani dalla nostra possibilità di capirli che potremmo giustificarli solo in termini divini o magici.”
Il tentativo di zittirmi va avanti ormai da una vita. Mi contestano i credenti perché non credo e mi contestano i non credenti perché non sto neppure dalla loro parte, e allora mi consolo con Non ho risposte semplici, un volume che raccoglie una ventina tra interviste e conversazioni con Stanley Kubrick, che delineano il suo genio: “Nella galassia ci sono cento miliardi di stelle e nell’universo visibile ci sono cento miliardi di galassie. Ogni stella è un sole, come il nostro, probabilmente con pianeti che lo circondano. […] Pensi al tipo di vita che potrebbe essersi evoluta su quei pianeti nel corso di millenni, e pensi anche a quali passi da gigante ha fatto la tecnologia dell’uomo sulla terra nei seimila anni in cui è documentata la sua civiltà, un periodo che è più piccolo di un granello di sabbia nella clessidra cosmica. […] Quelle intelligenze cosmiche […] potrebbero essere in comunicazione telepatica simultanea attraverso tutto l’universo; potrebbero aver ottenuto la padronanza completa sulla materia, e quindi potrebbero essere in grado di trasportarsi telecineticamente in modo istantaneo a miliardi di anni luce di distanza; nella loro forma definitiva, potrebbero essersi liberati completamente del guscio del corpo ed esistere in quanto coscienze incorporee e immortali in tutto l’universo. […] tutti gli attributi essenziali di quelle intelligenze extraterrestri sono gli attributi che noi conferiamo a Dio. E se quegli esseri di pura intelligenza dovessero mai intervenire negli affari dell’uomo, i loro poteri sarebbero talmente lontani dalla nostra possibilità di capirli che potremmo giustificarli solo in termini divini o magici.”
Mi contesta chi vota perché non voto e mi contesta chi non vota perché non scrivo ciò che lo aggrada: “Un aspetto doloroso della crescita intellettuale e artistica è che implica soprattutto il superamento degli altri: man mano, ci sono sempre meno persone con cui condividere le proprie idee, persone che capiscono, senza semplificare troppo, quello che uno sta cercando di comunicare.” Ancora Stanley Kubrick in Non ho risposte semplici.
Visto che non mi è nuovo questo potere che interrompe, silenzia, irrompe e violenta, da molto tempo mi auto silenzio verso coloro che tanto tengono alla mia bocca chiusa, così da restituire loro un po’ di dolore. E pare che Biguenet abbia nuovamente qualcosa da dire al riguardo: “L’impiego del silenzio […] spesso attraverso il semplice rifiuto di rivolgersi al soggetto, viene largamente utilizzato sia dai governi sia dai singoli individui. Per esempio, il rifiuto dei terroristi di proclamare la propria responsabilità dopo un bombardamento o dopo altre forme di omicidio di massa cerca di amplificare la paura causata dal violento attacco attraverso un silenzio implacabile. Così facendo, si prolunga la paura almeno finché il mistero sui responsabili rimane irrisolto.”
 Non mi spiace affatto l’idea che alle tante delusioni causatemi da ‘sti signori corrisponda loro un po’ di paura, fosse solo che per rivolgermi la parola; certo è che dall’altra parte della barricata sono sempre più numerosi i nemici, ma non mi scoraggio perché se erano numerosi i consigli de La strada di Wigan Pier che avevo dimenticato, un passaggio di un altro romanzo di Orwell – 1984 – lo ricordo bene: “l’essere in minoranza, anche l’esser rimasto addirittura solo, non vuol dire affatto esser pazzo.” Ma anche, come diceva Camillo Berneri, “Non ci posso niente, in questo mio trovarmi d’accordo con quasi nessuno.” La solitudine è scomoda? La posizione scomoda è da sempre una garanzia di sapere come stanno veramente le cose. Sapere come stanno veramente le cose non fa star tranquilli? Bene. Come diceva Errico Malatesta, “Non ho bisogno di stare tranquillo.”
Non mi spiace affatto l’idea che alle tante delusioni causatemi da ‘sti signori corrisponda loro un po’ di paura, fosse solo che per rivolgermi la parola; certo è che dall’altra parte della barricata sono sempre più numerosi i nemici, ma non mi scoraggio perché se erano numerosi i consigli de La strada di Wigan Pier che avevo dimenticato, un passaggio di un altro romanzo di Orwell – 1984 – lo ricordo bene: “l’essere in minoranza, anche l’esser rimasto addirittura solo, non vuol dire affatto esser pazzo.” Ma anche, come diceva Camillo Berneri, “Non ci posso niente, in questo mio trovarmi d’accordo con quasi nessuno.” La solitudine è scomoda? La posizione scomoda è da sempre una garanzia di sapere come stanno veramente le cose. Sapere come stanno veramente le cose non fa star tranquilli? Bene. Come diceva Errico Malatesta, “Non ho bisogno di stare tranquillo.”
Permettetemi un consiglio: agitatevi. Anzi, istruitevi agitatevi organizzatevi.
]]> A metà degli anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti e in maniera analoga, seppure in leggera differita, in buona parte dell’Occidente, mentre sugli schermi televisivi imperversavano Dynasty, Dallas, The A-Team, Cheers e Hill Street Blues, i telepredicatori facevano il pieno di ascolti e alla sobrietà della tv dei decenni precedenti si sostituivano sguaiate risate registrate e fragorosi applausi a comando, quanti avevano letto Nineteen Eighty-Four (1949) di George Orwell potevano rallegrarsi del fatto che, giunti al fatidico 1984, la società in cui vivevano non aveva assunto le sembianze della distopia prospettata dal romanzo.
A metà degli anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti e in maniera analoga, seppure in leggera differita, in buona parte dell’Occidente, mentre sugli schermi televisivi imperversavano Dynasty, Dallas, The A-Team, Cheers e Hill Street Blues, i telepredicatori facevano il pieno di ascolti e alla sobrietà della tv dei decenni precedenti si sostituivano sguaiate risate registrate e fragorosi applausi a comando, quanti avevano letto Nineteen Eighty-Four (1949) di George Orwell potevano rallegrarsi del fatto che, giunti al fatidico 1984, la società in cui vivevano non aveva assunto le sembianze della distopia prospettata dal romanzo.
A trarre un [...]]]>
 A metà degli anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti e in maniera analoga, seppure in leggera differita, in buona parte dell’Occidente, mentre sugli schermi televisivi imperversavano Dynasty, Dallas, The A-Team, Cheers e Hill Street Blues, i telepredicatori facevano il pieno di ascolti e alla sobrietà della tv dei decenni precedenti si sostituivano sguaiate risate registrate e fragorosi applausi a comando, quanti avevano letto Nineteen Eighty-Four (1949) di George Orwell potevano rallegrarsi del fatto che, giunti al fatidico 1984, la società in cui vivevano non aveva assunto le sembianze della distopia prospettata dal romanzo.
A metà degli anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti e in maniera analoga, seppure in leggera differita, in buona parte dell’Occidente, mentre sugli schermi televisivi imperversavano Dynasty, Dallas, The A-Team, Cheers e Hill Street Blues, i telepredicatori facevano il pieno di ascolti e alla sobrietà della tv dei decenni precedenti si sostituivano sguaiate risate registrate e fragorosi applausi a comando, quanti avevano letto Nineteen Eighty-Four (1949) di George Orwell potevano rallegrarsi del fatto che, giunti al fatidico 1984, la società in cui vivevano non aveva assunto le sembianze della distopia prospettata dal romanzo.
A trarre un sospiro di sollievo potrebbero però essere stati soltanto coloro che non avevano letto, o avevano nel frattempo rimosso, il meno celebre Brave New World (1932) di Aldous Huxley in cui la tirannia anziché essere esercitata per via coercitiva aveva saputo rendersi desiderabile.
Insomma, negli anni Ottanta, in Occidente, anziché avverarsi la distopia orwelliana, a compiersi, in sordina, era quella huxleyana, rivelatasi più in linea con le esigenze di una società votata alla mercificazione e al consumismo più sfrenati.
Sebbene nella stretta contemporaneità, segnata da un insistito ricorso a stati emergenziali, i due scenari distopici sembrino non di rado intrecciarsi, si tende a individuare il modello orwelliano, contraddistinto da un tipo di oppressione imposta dall’alto deprivante il popolo della propria memoria e autonomia, nei sistemi esplicitamente dittatoriali, mentre invece quello huxleyano, in cui il potere riesce a far amare al popolo il proprio oppressore e a sostenere le tecnologie tese ad annullare la capacità di pensiero, nei sistemi più democratici.
Convinto dell’importanza delle tecnologie e dei media nella costruzione della realtà, nella definizione delle percezioni, nell’organizzazione delle esperienze e delle relazioni emotive e nell’azione sociale degli individui, in Amusing Ourselves to Death (1985), analizzando gli effetti socioculturali del medium televisivo, il sociologo statunitense Neil Postman ha colto proprio in esso lo strumento principale di attuazione della pratica di dominio prospettata da Huxley nei primi anni Trenta, agli albori di quella che si sarebbe rivelata l’era televisiva.
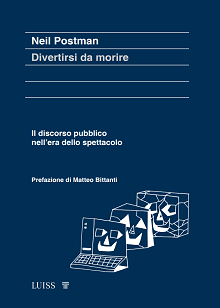 In occasione dell’uscita di una nuova edizione italiana del volume di Neil Postman, Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo, prefazione di Matteo Bittanti e traduzione di Leone Diena (Luiss University Press, 2023), vale la pena evidenziare come diverse riflessioni espresse dal sociologo statunitense, che sarebbero poi in parte da lui stesso riprese e sviluppate nel successivo Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia (Bollati Bornighieri, 1993), nonostante facciano riferimento a un panorama mediatico ormai decisamente cambiato, restino assolutamente valide ai giorni nostri segnati dall’affiancamento di internet al mezzo televisivo.
In occasione dell’uscita di una nuova edizione italiana del volume di Neil Postman, Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo, prefazione di Matteo Bittanti e traduzione di Leone Diena (Luiss University Press, 2023), vale la pena evidenziare come diverse riflessioni espresse dal sociologo statunitense, che sarebbero poi in parte da lui stesso riprese e sviluppate nel successivo Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia (Bollati Bornighieri, 1993), nonostante facciano riferimento a un panorama mediatico ormai decisamente cambiato, restino assolutamente valide ai giorni nostri segnati dall’affiancamento di internet al mezzo televisivo.
Gli anni Ottanta sono passati alla storia come il decennio della superficialità, della frivolezza, del trash e dell’usa e getta, un periodo, come ha sostenuto Tommaso Ariemma (Dark Media. Cultura visuale e nuovi media, Meltemi 2022)1, caratterizzato non tanto dalla sensazione di “mancanza di futuro”, quanto piuttosto dal “futuro già presente” derivata in buona parte dall’estetica della simulazione diffusasi con le nuove tecnologie informatiche, grazie soprattutto al Mac, votata alla celebrazione della sola “superficie visuale”.
All’individualismo degli anni Ottanta si è affiancata, in parte anche in reazione ad esso, una spinta all’isolamento in un universo fittizio in cui si è cercato rifugio in seguito alla delusione indotta dal mondo reale rivelatosi incapace di soddisfare le aspirazioni dei più giovani. Un ripiegamento votato al primato della sensazione, dell’immediato, del mero “significato di superficie”, anticipando di fatto quella web culture che avrebbe finito per sostituire alle relazioni amicali il desiderio del sentire e, come efficacemente sostenuto da Mario Perniola (Del sentire, Einaudi 1991), all’ideologia, socializzazione dei pensieri, la “sensologia”, socializzazione dei sensi.
L’analisi del medium televisivo proposta da Postman in Divertirsi da morire, nel suo porsi, scrive Matteo Bittanti nella prefazione al volume, come sintesi nella dialettica che vede Gli strumenti del comunicare (1964) di Marshall McLuhan e La società dello spettacolo (1967) di Guy Debord occupare rispettivamente il ruolo di tesi e di antitesi, ha il grande merito di mostraci oggi come le premesse della web culture siano ravvisabili nel medium televisivo degli anni Ottanta, nella sua «forma di comunicazione basata unicamente sull’intrattenimento e sullo svago – entertainment, infotaiment, amusement – introducendo un’estetica squisitamente spettacolare».
Un mezzo di comunicazione votato dunque a promuovere contenuti visuali leggeri, trasmessi in rapida e frammentata successione, mercificati, dunque progettati per attrarre e intrattenere il pubblico divertendolo ben oltre i generi storicamente votati a tale compito. Come ha avuto modo di segnalare Carmine Castoro (Clinica della TV, 2015)2, l’inarrestabile flusso casuale di comunicati decontestualizzati supporta pratiche di seduzione consumistica e di istupidimento deprivanti l’essere umano di capacità critica, intrattenendolo attraverso un flusso soporifero di immagini.
Il divertimento/intrattenimento che plasma la televisione degli anni Ottanta, in tutti i suoi programmi, notiziari compresi, si pone per certi versi alla base di quei processi di ludicizzazione3 che si dispiegheranno nel web nei decenni successivi e, più in generale, di quella logica che ha saputo rendere costantemente produttivi gli utenti di internet facendo loro percepire il lavoro non pagato a cui si sottopongono come mera attività ludica.
Se è usuale individuare nella storia statunitense una città che, più di altre, può essere vista come incarnazione dello spirito americano del tempo, per gli anni Ottanta, sostiene Postman, questa è sicuramente Las Vegas e lo è perché in essa vive esclusivamente il divertimento, esattamente come nella televisione. Il problema, sottolinea il sociologo, non è certo dato dall’offerta di divertimento da parte della televisione, quanto piuttosto dal fatto che tutto in essa sia dia all’insegna del divertimento, che l’intrattenimento sia l’inderogabile “superideologia” di ogni discorso televisivo.
“Ed ecco a voi…” è probabilmente una delle frasi più ricorrenti in televisione, tanto da fungere quasi da punteggiatura volta a mettere un punto fermo dopo quanto visto fino a quel momento per aprire un discorso totalmente nuovo. «La frase è fatta apposta per mettere in luce il fatto che il mondo così com’è descritto dai frettolosi mezzi elettronici non ha nessun ordine e nessun senso e non deve essere preso troppo sul serio. Non c’è assassino così efferato, terremoto cosi disastroso, guaio politico così grave […] che non possa essere cancellato dalla nostra memoria con un: “Ed ecco a voi…”».
Con tali parole viene suggerito ai telespettatori che quanto visto fino a quel momento non merita ulteriore spazio, approfondimento o riflessione e che è giunto il momento di proiettarsi su un nuovo frammento di notizia o di pubblicità, che poi così diverse non sono. Certo, il modello “Ed ecco a voi…” non è stato inventato dalla televisione, che lo ha derivato dal connubio tra telegrafo e fotografia, ma sicuramente, sostiene Postman, è stata la tv a condurlo alla sua «attuale perversa maturità» ed è proprio nel telegiornale che tale modello «si mostra nella sua forma più sfrontata e imbarazzante» finalizzata unicamente all’intrattenimento.
Nel suo susseguirsi di frammenti non solo slegati uno dall’altro ma anche neganti importanza al precedente di turno, di cui si palesa la necessità di abbandono frettoloso, la televisione minimizza ogni notizia; per quanto grave possa sembrare, questa sarà presto seguita da una di minor gravità, o da una pubblicità, che provvederà a banalizzarla.
Si è «ormai talmente assuefatti all’universo di “Ed ecco a voi…” – un universo a frammenti, in cui i vari fatti se ne stanno da soli strappati da ogni connessione col passato, o col futuro, o con altri fatti – che sono vanificate tutte le presunzioni di coerenza. E quindi anche ogni contraddizione. Nel contesto di nessun contesto, per così dire, la contraddizione semplicemente svanisce».
Sebbene non sia possibile incolpare esclusivamente la televisione di tutto ciò, afferma Postman a metà degli anni Ottanta, di certo tale medium rappresenta «il paradigma della nostra concezione di informazione» e visto che la pubblicità televisiva si presenta come «la forma più vistosa di comunicazione pubblica nella nostra società», continua il sociologo, «era inevitabile che gli americani dovessero […] accettarla come forma normale e plausibile di discorso».
Occorre aggiungere che se, come sostiene Postman, negli anni Ottanta l’intrattenimento televisivo era indubbiamente fondato sul divertimento, nei decenni successivi l’intrattenimento si sarebbe avvalso anche della “tv del dolore” contraddistinta, come argomenta Carmine Castoro (Il sangue e lo schermo, Mimesis 2017)4, da un’iconografia della paura costruita su pandemie, calamità naturali e attentati spalmati sul nulla di ore e ore di dirette attraversate da narrazioni ripetitive, opinionisti improvvisati, inviati e video amatoriali trasmessi in un estenuante e ansiogeno ripetesi di immagini di soccorritori e di disperazione in un loop di etichette ripetute come un mantra: “crimine efferato”, “tragedia immane”, “apocalisse”, “disastro epocale” e via dicendo.
 In chiusura di libro, riprendendo la distopia prospettata da Brave New World5, Postman sottolinea come ciò che Huxley aveva cercato di dirci è che ciò che affliggeva gli abitanti del mondo nuovo tratteggiato dal suo romanzo «non era ridere anziché pensare, ma non sapere per che cosa ridessero e perché avessero cessato di pensare». Verrebbe da dire che se si pensava di seppellire lor signori con una risata, è finita che oggi si ride davanti agli schermi – televisivi o degli smartphone – senza sapere di cosa e perché e, soprattutto, avendo mandato (da tempo) in vacanza il cervello.
In chiusura di libro, riprendendo la distopia prospettata da Brave New World5, Postman sottolinea come ciò che Huxley aveva cercato di dirci è che ciò che affliggeva gli abitanti del mondo nuovo tratteggiato dal suo romanzo «non era ridere anziché pensare, ma non sapere per che cosa ridessero e perché avessero cessato di pensare». Verrebbe da dire che se si pensava di seppellire lor signori con una risata, è finita che oggi si ride davanti agli schermi – televisivi o degli smartphone – senza sapere di cosa e perché e, soprattutto, avendo mandato (da tempo) in vacanza il cervello.
In una contemporaneità tecnocratico-liberista in cui, come denuncia Bittanti nella prefazione al volume, in ambito accademico l’analisi dei media si riduce al funzionalismo applicato, all’ottimizzazione dei motori di ricerca e alle strategie di gamification volte a generare profitto, «Divertirsi da morire rappresenta un’anomalia tanto anacronistica quanto preziosa». Quello di Postman è un libro che non ha bisogno di like, ma di essere letto e preso sul serio.
Estetiche del potere – serie completa
Cfr. Gioacchino Toni, Dark Media, in “Carmilla online”, 26 giugno 2023. ↩
Cfr. Gioacchino Toni, Estetiche del potere. Virtualizzazione, estetizzazione, neutralizzazione ed altre patologie virali del Tele-Capitalismo, in “Carmilla online”, 4 maggio 2016. ↩
Cfr. Gioacchino Toni, Gamification e controllo comportamentale, in “Pulp Magazine”, 22 febbraio, 2023; Matteo Bittanti, A lezione di Pokémon Go. Da A(lfie Bown) a (Shoshana) Z(uboff), Università Iulm, 18 novembre 2022. ↩
Cfr. Gioacchino Toni, Estetiche del potere. Il sangue e lo schermo. La mercificazione della paura nell’era dei media spacciatori di assenze, in “Carmilla online”, 29 dicembre 2017. ↩
Cfr. Gian Paolo Serino, Aldous Huxley e la distopia, in “Carmilla online”, 8 settembre 2003. ↩
Dedicato a Giovanna e a tutti coloro che subiscono ma, ancora, resistono
Prima li sentivamo muoversi nei muri, come i topi del celebre racconto di H. P. Lovecraft, poi hanno iniziato a muoversi per le stanze di casa e per le vie delle città e oggi sono venuti allo scoperto rivelandoci tutto l’orrore di questa società che si sarebbe voluto tener nascosto dietro a pareti di discorsi democratici, progressisti e green moltiplicati e riproposti all’infinito dai media.
Si sono presentati così, a volto scoperto con la scusa della pandemia e dei provvedimenti di urgenza, con i Dpcm, con [...]]]>
Dedicato a Giovanna e a tutti coloro che subiscono ma, ancora, resistono
Prima li sentivamo muoversi nei muri, come i topi del celebre racconto di H. P. Lovecraft, poi hanno iniziato a muoversi per le stanze di casa e per le vie delle città e oggi sono venuti allo scoperto rivelandoci tutto l’orrore di questa società che si sarebbe voluto tener nascosto dietro a pareti di discorsi democratici, progressisti e green moltiplicati e riproposti all’infinito dai media.
Si sono presentati così, a volto scoperto con la scusa della pandemia e dei provvedimenti di urgenza, con i Dpcm, con i lacrimogeni sparati in faccia a chi si oppone ai loro devastanti e inutili progetti, con la criminalizzazione dei lavoratori in lotta, con la distribuzione di anni di reclusione o di sorveglianza speciale per chi si ostina a battersi contro le miserie dell’esistente e, per finire in “gloria”, con generali in pompa magna che vorrebbero farci credere di essere al servizio della società e della “nostra” salute.
Negano l’evidenza della gestione fallimentare della pandemia e dell’esistente, negano o ignorano l’assoluta dipendenza di ogni loro decisione dalle necessità immediate o future del capitale, rovinano le mezze classi fingendo di rappresentarle e si accaniscono sui lavoratori salariati e i giovani in una epocale trasformazione del lavoro e della distribuzione che lascerà sul campo milioni di disoccupati oppure di lavoratori destinati a compiti sempre più umili, non garantiti e sottopagati.
Per fare ciò, però, non possono accontentarsi di disciplinare la società e il lavoro ma, come si è già detto su queste pagine (qui) devono anche riuscire a reprimere e disciplinare ogni aspetto dell’immaginario, individuale o collettivo.
Per raggiungere questo obiettivo hanno dovuto andare oltre i limiti della normale produzione di narrazioni tossiche cui ci hanno abituato da tempo le fake news sistemiche e di Stato; hanno superato i limiti di una produzione culturale mainstream, contro cui questa rivista si batte ormai da molti anni poiché ritiene l’immaginario un campo di battaglia fondamentale per la definizione del nostro futuro, e hanno iniziato a porre severi limiti alla libertà di immaginare, in ogni sua forma ed espressione.
In tale ipotesi la libertà d’opinione sarà definitivamente seppellita e si potrà essere liberi di immaginare soltanto se si immaginerà ciò che il Capitale e lo Stato riterranno utile e proficuo immaginare. La capacità di immaginazione sarà trasformata in reato della mente, in associazione a delinquere del desiderio e dovrà essere rigidamente controllata da una sorta di polizia politica dei sogni.
 Nemmeno George Orwell con 1984 era giunto a tanto e anche Ray Bradbury, con il suo Fahrenheit 451, era tutto sommato rimasto ancorato ai roghi di libri già visti tante volte nella storia. Tentativi messi in atto, anche in tempi recenti, per cancellare la memoria del passato e la sua cultura.
Nemmeno George Orwell con 1984 era giunto a tanto e anche Ray Bradbury, con il suo Fahrenheit 451, era tutto sommato rimasto ancorato ai roghi di libri già visti tante volte nella storia. Tentativi messi in atto, anche in tempi recenti, per cancellare la memoria del passato e la sua cultura.
Oggi invece si vuole cancellare il futuro e la capacità di immaginarlo insieme al presente.
Presente e futuro che devono certamente preoccupare molto, se non addirittura spaventare, gli attuali signori della guerra economica, sanitaria e psichica per farli giungere ad una pratica che forse solo Philip K. Dick aveva saputo adeguatamente descrivere in alcune sue opere.
Disciplinare la mente significa disciplinare l’immaginario, mentre immaginare significa, il più delle volte, anticipare. Ecco allora che ciò che viene messo in atto oggi, anche attraverso l’operato della magistratura, è proprio questo: il tentativo di negare il futuro o un’immagine altra del presente.
Sia ben chiaro: si tratta di una partita per la vita e per la morte di un presente oscurantista che per rendersi eterno deve uccidere sul nascere qualsiasi ipotesi altra. Anche se presente soltanto in un romanzo.
Come è accaduto nel caso di Marco Boba, al quale va la piena solidarietà di tutta la redazione di Carmilla, che sembra esser precipitato in una dimensione degna dell’Inquisizione tardo medievale, poiché dopo una condanna in primo grado a quattro anni di detenzione per “incendio volontario” a seguito dei frammenti da fuoco d’artificio caduti su un capannone interno al carcere torinese delle Vallette, durante una manifestazione di protesta al suo esterno nel febbraio del 2019, è anche diventato oggetto di un provvedimento di sorveglianza speciale proposto nei suoi confronti, a causa del suo romanzo Io non sono come voi edito nel 2015 dalla cooperativa editoriale Eris di Torino. Infatti, come si afferma nel comunicato della casa editrice:
Giovedì 1 aprile è successa una cosa molto grave, e prima di parlarvene abbiamo voluto prenderci qualche giorno per riflettere. Scusate la lunghezza, ma in certi casi ogni parola è importante.
A un nostro autore, Marco Boba, è stata notificata da parte della Questura e della Procura di Torino una richiesta di sorveglianza speciale. Sino a qua, purtroppo, niente di straordinario. Negli ultimi anni questa misura preventiva molto pesante è stata richiesta e applicata più volte a militant* e attivist* di tutti i movimenti. Per chi non fosse avvezzo, la sorveglianza speciale consiste in un insieme di regole e divieti che vanno a colpire la persona nella propria quotidianità a causa di quella che viene definita “pericolosità sociale”, quindi è un provvedimento che colpisce le persone al di là di uno specifico fatto ma per un “comportamento generale”1.
Quello che noi troviamo davvero pericoloso e allarmante è che all’interno di questa richiesta di sorveglianza speciale sia stato inserito il romanzo –Io non sono come voi– che Marco ha pubblicato con noi nel 2015 come aggravante e/o prova. Anzi, il fulcro di questa prova nello specifico è la frase che noi come editori abbiamo scelto di mettere nel retro di copertina: «Io odio. Dentro di me c’è solo voglia di distruggere, le mie sono pulsioni nichiliste. Per la società, per il sistema, sono un violento, ma ti assicuro che per indole sono una persona tendenzialmente tranquilla, la mia violenza è un centesimo rispetto alla violenza quotidiana che subisco, che subisci tu o gli altri miliardi di persone su questo pianeta.» Una frase che dice il protagonista del libro in un dialogo. Una frase che come sempre estrapoliamo dal romanzo per far capire a chi si ritroverà il libro in mano qual è il cuore della storia, il mood, l’atmosfera, lo stile narrativo.
Parliamo di un romanzo di finzione, con un protagonista di finzione. Il romanzo è scritto in prima persona, al presente, scelta tra l’altro fatta non in origine dall’autore, ma dopo un lungo confronto tra autore ed editore. Editing, normale editing.
Che il romanzo sia di fantasia tra l’altro è dichiarato sin da subito, nella sinossi presente nell’aletta che si discosta totalmente dalla biografia dell’autore e in due pagine esplicative finali.
Non basta lo sfondo, il contesto, l’ambientazione, per decidere che un romanzo è autobiografico. I fatti principali che costituiscono la trama e il motore principale della narrazione sono chiaramente inventati, di finzione.
Ecco, a noi sembra davvero pericoloso che una finzione possa diventare una prova, che il dialogo di un personaggio di un romanzo possa diventare una prova, che le opinioni o le azioni di un personaggio di finzione possano diventare una prova, che una frase scelta dall’editore, per promuovere al meglio un libro, possa diventare un’aggravante e che una questura o una procura si possano occupare di una materia che dovrebbe restare appannaggio di chi fa critica letteraria.
In questi anni più volte si è invocato il reato d’opinione. Dalla vicenda di Erri De Luca, assolto dall’accusa di istigazione a delinquere per essersi espresso a favore dei sabotaggi contro la Tav, alla studentessa accusata di aver partecipato attivamente a delle azioni No Tav solo per aver utilizzato il “noi partecipativo” nella sua tesi di laurea in Antropologia culturale sul movimento stesso.
Ma ci sembra che a questo punto non stia diventando illecito solo avere un’opinione, ma anche il puro e semplice immaginare. Una società in cui non solo si paga per le proprie opinioni, ma addirittura per le opinioni o le azioni dei propri personaggi d’invenzione sarebbe la trama perfetta per un romanzo distopico. Ma per qualcuno, invece, è la realtà, perché sta accadendo.
Per Marco Boba, militante anarchico di lunga data, scrittore, occupante di case ed ex-redattore di Radio Black Out, il pm erede dell’operato anti-movimentista del duo Rinaudo e Padalino ha richiesto un provvedimento di sorveglianza speciale della durata di due anni basato, incredibilmente, su prove costituite non soltanto da una frase tratta dalla quarta di copertina del romanzo edito da Eris, come è stato detto già prima, ma anche da una recensione on line del libro stesso, oltre che dalla cattiva condotta suggerita dalla più che discutibile condanna precedentemente inflittagli nel primo grado di giudizio.
Sembra così, nell’operato della giustizia torinese, che la fantasia sia davvero andata al potere, visto che fantasiosi rappresentanti della magistratura perseguono reati di immaginazione, utilizzando qualsiasi forma o applicazione dell’immaginario per tarpare le ali non solo a quella che in tempi ormai lontani si sarebbe definita creatività, ma ad ogni forma di movimento dalle caratteristiche anti-sistemiche o antagoniste.
Dilungarsi ulteriormente su un episodio che più che appartenere ad una dialettica viva e reale tra le forze e le classi sociali potrebbe essere stato tratto da una farsa di Totò e Peppino, non sarebbe necessario se l’utilizzo a buon mercato e a largo raggio della sorveglianza speciale, accompagnato da accuse fantasiose, non fosse diventato pratica corrente nei confronti dei militanti NoTav, di coloro che come Eddi hanno combattuto per la libertà del Rojava oppure per gli anarchici cagliaritani e le giovani donne giunte da poco alla militanza antagonista, com’è successo recentemente a Firenze.
 Vorremmo poter dire di questa giustizia fai da te, di questi apparati repressivi, dello Stato e dei governi imbelli, non ragionar di lor ma guarda e passa, ma l’unica cosa che possiamo invece affermare in questo momento e in solidarietà con tutti coloro che da questi provvedimenti e dalle violenze sono ormai quasi quotidianamente colpiti è che anche noi non siamo come voi e che molti ancora si aggiungeranno alle nostre fila, poiché il vostro operato sta proprio lavorando in quella direzione.
Vorremmo poter dire di questa giustizia fai da te, di questi apparati repressivi, dello Stato e dei governi imbelli, non ragionar di lor ma guarda e passa, ma l’unica cosa che possiamo invece affermare in questo momento e in solidarietà con tutti coloro che da questi provvedimenti e dalle violenze sono ormai quasi quotidianamente colpiti è che anche noi non siamo come voi e che molti ancora si aggiungeranno alle nostre fila, poiché il vostro operato sta proprio lavorando in quella direzione.
Grazie dunque a tutti coloro che, nel tentativo di ingabbiare e portarci via il nostro immaginario, faranno sì che questo diventi sempre più forte, chiaro, potente e condiviso.
]]>

L’allegoria è esplicita, la metafora trasparente. Un treno di 1.001 vagoni con a bordo 3.000 persone è tutto quanto resta dell’umanità dopo che il fallito tentativo di fermare il riscaldamento globale terrestre ha al contrario scatenato una glaciazione, precipitando la temperatura di superficie a -117 gradi. Il convoglio ad alta velocità continua all’infinito a fare il periplo del pianeta grazie a un motore dal moto perpetuo e la società che l’ha realizzato, la Wilford Industries, guidata dal misterioso magnate Mr. Wilford, ha in mano i destini dei [...]]]>

L’allegoria è esplicita, la metafora trasparente. Un treno di 1.001 vagoni con a bordo 3.000 persone è tutto quanto resta dell’umanità dopo che il fallito tentativo di fermare il riscaldamento globale terrestre ha al contrario scatenato una glaciazione, precipitando la temperatura di superficie a -117 gradi. Il convoglio ad alta velocità continua all’infinito a fare il periplo del pianeta grazie a un motore dal moto perpetuo e la società che l’ha realizzato, la Wilford Industries, guidata dal misterioso magnate Mr. Wilford, ha in mano i destini dei superstiti. Sullo Snowpiercer, in prima viaggiano i ricchi che hanno finanziato la costruzione del treno e ora conducono una vita dissipata e parassitaria. Poi, via via, si scende di livello, dalla Seconda dove alloggia la classe dirigenziale amministrativa e burocratica; alla Terza dove i tecnici assicurano la produzione e l’autosostentamento, gestendo i bisogni primari e secondari di un claustrofobico micro-universo, attraverso la conduzione di allevamenti di bovini, frutteti, acquari, nightclub, bordelli, mercati post-industriali e così via; fino al Fondo, the Tail, la coda del treno, dove sopravvivono in semi-reclusione, quelli che non hanno pagato il biglietto, alimentandosi con barrette a stento commestibili e progettando la rivoluzione: irruzione armata nei settori anteriori del treno e rovesciamento dei rapporti sociali.
L’idea originaria da cui questa storia deriva, nasce da un graphic novel francese, Le Transperceneige – Snowpiercer è la traduzione inglese di Transperceneige, «trafiggineve» o «traforaneve» – bande dessinée post-apocalittica in bianco e nero ideata da Jacques Lob e disegnata da Jean-Marc Rochette, pubblicata a puntate in Francia, con il titolo di La morte bianca, fra l’ottobre del 1982 e il giugno dell’anno successivo prima di essere raccolta in volume dall’editore Casterman nel 1984. Dopo il successo internazionale e la morte di Lob, lo sceneggiatore Benjamin Legrand rimette mano all’universo già delineato, cambia treno sostituendo lo Snowpiercer con il Wintercracker, e fra il 1999 e il 2000 dà alla luce altri due volumi, Il geoesploratore (1999) e La terra promessa (2000), che elaborano ulteriormente gli avvenimenti immaginati dai due autori originari.
Il fumetto è figlio diretto della fantascienza distopica di George Orwell – la data di uscita, del primo episodio, 1984, è già un destino – e, forse ancor di più, Aldous Huxley, ma anche del Robert Heinlein di Universo o Orfani del cielo, che dir si voglia, e di tutte quelle opere appartenenti al sottogenere generation ship, come il ciclo di Rama, di Arthur C. Clarke. Ma i sistemi chiusi non offrono speranza e le piccole comunità replicano e portano all’estremo i meccanismi di stratificazione sociale e diseguaglianza delle grandi: la divisione in classi, qui orizzontale, lì verticale, rimanda al classico cinematografico Metropolis, di Fritz Lang; la derivazione huxleyana si avverte invece nella suggerita identificazione fra disumanizzazione e decadenza dei costumi e per la diffidenza verso l’ipotesi rivoluzionaria vista più come vezzo della borghesia, la seconda classe, che come consapevole necessità del proletariato, gli occupanti delle ultime carrozze del treno, “il terzo convoglio” (richiamo al Terzo stato della Francia pre-rivoluzionaria). Rispetto alle astronavi-mondo di Universo e simili, il microcosmo ferroviario di Transpeirceneige appare assai più cupo, in una vera e propria inversione di orizzonte: in Heinlein la scoperta della reale natura del mondo prospetta nuove speranze e testimonia la grandezza delle capacità umane, esaltate dalla tecnologia; nella trilogia francese, invece, la tecnologia consente solo una finzione di vita, senza scopo, senza obiettivi, destinata alla sconfitta: se i viaggiatori di Heinlein scoprono di avere a disposizione tutto l’universo, quelli di Legrand accettano il dato di fatto che non c’è nulla al di fuori delle loro paratie stagne.
Anche stilisticamente il fumetto si evolve (o involve a seconda dei gusti): se nel primo episodio, La morte bianca, il disegnatore Jean-Marc Rochette si ispira al bianco e nero espressionista della scuola argentina e in particolare al Francisco Solano Lopez de L’eternauta, negli episodi più tardi il passaggio al colore conduce a uno slittamento dal grottesco al realistico che già prelude al cinema. Non per caso quindi il regista sud-coreano Bong Joon-ho scoprirà il fumetto, si innamorerà dell’ambientazione e per anni tenterà di avviare un progetto cinematografico liberamente ispirato alla trilogia francese (in particolare al primo episodio) riuscendo infine a realizzarlo solo nel 2013.
Bong Joon-ho, premio Oscar 2020, sia per il miglior film straniero sia per regia e sceneggiatura originale, con il piuttosto sopravvalutato Parasite, passa al vaglio della critica per un regista interessato a recuperare nel suo cinema il concetto di lotta di classe. In realtà il tema è per lui poco più che un pretesto abbastanza superficiale, almeno per come viene affrontato nei due film che maggiormente entrano in argomento: sia la fin troppo acclamata ultima opera, sia il suo indiretto predecessore, proprio Snowpiercer. In Parasite, ancor più che nel film precedente, la lotta di classe nell’unico senso possibile del termine, quello marxiano, viene rimpiazzata, attraverso una lettura sociologica abbastanza approssimativa, dal desiderio collettivo, dettato dal puro istinto di sopravvivenza (un collettivo, per altro, che non eccede mai gli stretti vincoli familiari), di mera emulazione e asservimento al più forte e al più ricco. Lotta fra poveri dunque, invece di solidarietà di classe, in cui il più veloce e il più furbo vince: il principio hobbesiano dell’homo homini lupus e quello concorrenziale del capitalismo, in cui tutti si abbandonano alla lotta più efferata per impedire l’affermazione altrui. Lo scopo finale è il successo performativo, la realizzazione individuale del neo-capitalismo. Un’impresa criminale è comunque un’impresa tesa alla massima soddisfazione personale. Anche la vendetta, quando si consuma, è dettata solo dalla frustrazione personale, da un impulso improvviso e istintivo. Plasmati sul modello vincente del manager i propri bisogni, coronati i propri egoistici desideri di riscatto, resta solo, incancellabile, l’odore proletario, stigmate che marchia e rivela l’inganno e il dislivello di classe. Il film è un ammiccamento agli esclusi, che non innesca un’immedesimazione per la loro condizione di indigenza ma per l’abilità di sfruttare ogni possibile evento in maniera manipolatoria: niente più che la performance richiesta al capitale umano dalla società neoliberista.
Con analoga affettazione, anche Snowpiercer parrebbe denunciare le disuguaglianze del mondo nella lampante metafora del treno. I diseredati senza biglietto promuoveranno un leader, novello Spartaco che guiderà la rivolta per rovesciare lo stato di cose esistenti. Mentre Porloff, protagonista di Transperceneige versione fumetto, però è quasi un flaneur della rivoluzione e il suo itinerario è più un vagabondaggio che solo per caso lo porterà a raggiungere la testa del treno, il percorso di Curtis (interpretato nel film da Chris Evans) ha almeno velleità rivoluzionarie, anche se, nel suo impulso tutto muscolare, l’eroe intende prendere il potere senza sapere poi bene cosa farsene. Si mette in scena una ribellione di corpi senza testa: il mondo è il treno e il treno è il mondo e nessuno, tra chi lo guida e chi si fa guidare, può contestare questo dato di fatto. Per questo i compromessi sono necessari e il rivoluzionario dovrà allearsi con un esperto di sistemi di sicurezza dipendente da una sostanza allucinogena – un po’ il suo alter ego negativo – e sostenere tutta una serie di combattimenti con il piccolo esercito di sbirri che proteggono l’ordine costituito. L’obiettivo è quello di arrivare fino alla locomotiva, rimuovere Wilford (il capo carismatico, circonfuso quasi da un’aureola sacrale) e sovvertire la brutale organizzazione vigente senza un progetto chiaro di gestione alternativa. I luoghi comuni anche qui abbondano: le rivolte già previste come elemento per mantenere l’equilibrio interno del sistema (un po’ Orwell e un po’ Matrix); l’assassino disposto a nutrirsi dei propri simili che diventa capo della rivolta; il capo carismatico che cederà il proprio ruolo al leader degli insorti: chi uccide il re diventa re; la presa di potere rivoluzionaria risolta con un duello “a due” come in un western; e così via.
Almeno da un punto di vista spettacolare però il film funziona; scenografia e regia sono incisive; tutto il cast, in particolare Chris Evans e Tilda Swinton, efficace e, come prodotto di intrattenimento, non c’è troppo da eccepire. Se rifiutiamo ogni pretesa di interpretazione “politica”, possiamo anche divertirci e ritenerci soddisfatti: come il suo successore Parasite, anche Snowpiercer è un lavoro complessivamente riuscito. Il problema sorge invece quando si vuole allungare troppo il brodo e – sfruttando il nome ormai assurto, a torto o a ragione, al Pantheon dei sommi, del cineasta coreano – si cerca di trasformare in serie Tv un testo ben conchiuso proprio nel suo formato breve.
La serie, sviluppata dallo showrunner Greame Manson, condivide con l’omonimo film di Bong Joon-ho l’ambientazione, ma cronologia e trama sono differenti. I fatti raccontati nella pellicola del 2013 si svolgono 15 anni dopo l’apocalisse e principalmente nel Fondo, fra gli ultimi vagoni; il serial visibile sulla piattaforma Netflix, si colloca invece sette anni dopo la glaciazione e, quindi, otto anni prima del film, e molto maggiore spazio viene dato a personaggi e ambienti dei diversi scompartimenti che non sono più quindi, come nel film, solo un territorio ostile da scoprire e conquistare per le avanguardie rivoluzionarie delle carrozze di coda. Il regista coreano figura come produttore esecutivo, così come fra i nomi dei produttori, oltre al suo, compaiono anche quelli di Scott Derrickson (regista di Doctor Strange) e Park Chan-wook (regista di Old Boy e di altri classici del cinema sudcoreano meno noti da noi). Nonostante questi personaggi di rilievo sbandierati; nonostante la raffinatezza del reparto scenografico, che annovera specialisti come Barry Robison, Stephen Geaghan, Paul Alix, Thomas P. Wilkins e Gwendolyn Margetson, a conferire all’ambientazione un’atmosfera sospesa e ambigua di retrofuturo; nonostante le musiche composte da Bear McCreary, che tutti ricorderanno per la colonna sonora di un’altra serie Sci-Fi classica, Battlestar Galactica; il prodotto risulta assai mediocre e di gran lunga inferiore al già non eccelso film. Il fumetto resta alla fine la punta di diamante di tutta la saga multimediale.
Se però film e fumetto almeno erano ben strutturati intorno a un centro, il tema della rivolta sociale – seppur abborracciata – i dieci episodi televisivi tergiversano e debordano, svicolando banalmente sul crime, tanto per allungare il brodo con gli ingredienti più dozzinali, e seguono le indagini di Layton, detective “proletario” cooptato negli scompartimenti “borghesi” per indagare sullo spaccio di droga e medicinali che potrebbe essere all’origine di una catena di omicidi seriali; lo sleuth riluttante, già che c’è, prende anche appunti per scatenare, quando sarà il momento giusto, la rivoluzione: un po’ come voler fare un cocktail fra La Corazzata Potemkin e Assassinio sull’Orient Express…
Anche gli attori appaiono poco convinti, dall’attrice premio Oscar Jennifer Connelly (A Beautiful Mind), al rasta, quasi sosia di Bob Marley, Daveed Daniele Diggs, vincitore di un Grammy e di un Tony per il musical Hamilton. La serie spicca come un bell’esempio di dissipazione di risorse ed è utile guardarla: non solo il bello ma anche il brutto va conosciuto. Certo ci sono dei limiti a questa regola: ad esempio la recente serie horror – si fa per dire – Curon, trionfalmente presentata come debutto di Netflix Italia, è un pastrocchio inguardabile, soporifero e mal scritto sul quale non vale la pena di sprecare neanche un minuto della propria vita di spettatore, ma Snowpiercer non arriva a tanto obbrobrio e una serata con gli amici, a birra, patatine e battute salaci, gliela possiamo anche dedicare… Motivo per cui già la produzione minaccia una seconda stagione: perseverare diabolicum…
]]>
 Vivremo in una democrazia in cui “la libertà sarà stata un episodio”, così inizia Psicopolitica, il libro dell’apocalittico filosofo tedesco-sud coreano Byung-Chul Han. Una democrazia neoliberale sotto il segno del like. O del dislike. Una comunicazione contrappuntata, quando tutto va per il bene, dagli stucchevoli love, o dagli sganasciati haha, o dagli stupefatti wow, quando va per il male dai melanconici sigh o dai livorosi grr. Lo so, sembro ridicolo, eppure anche sotto i post che accompagneranno questo scritto riceverò qualche decina di commenti in neolingua. Una specie di idiot [...]]]>
Vivremo in una democrazia in cui “la libertà sarà stata un episodio”, così inizia Psicopolitica, il libro dell’apocalittico filosofo tedesco-sud coreano Byung-Chul Han. Una democrazia neoliberale sotto il segno del like. O del dislike. Una comunicazione contrappuntata, quando tutto va per il bene, dagli stucchevoli love, o dagli sganasciati haha, o dagli stupefatti wow, quando va per il male dai melanconici sigh o dai livorosi grr. Lo so, sembro ridicolo, eppure anche sotto i post che accompagneranno questo scritto riceverò qualche decina di commenti in neolingua. Una specie di idiot [...]]]>
 Vivremo in una democrazia in cui “la libertà sarà stata un episodio”, così inizia Psicopolitica, il libro dell’apocalittico filosofo tedesco-sud coreano Byung-Chul Han. Una democrazia neoliberale sotto il segno del like. O del dislike. Una comunicazione contrappuntata, quando tutto va per il bene, dagli stucchevoli love, o dagli sganasciati haha, o dagli stupefatti wow, quando va per il male dai melanconici sigh o dai livorosi grr. Lo so, sembro ridicolo, eppure anche sotto i post che accompagneranno questo scritto riceverò qualche decina di commenti in neolingua. Una specie di idiot savant si è inventato questo social network, e di anno in anno come un dio bambino inventa nuovi codici nuovi lemmi, nuove semplificazioni per narrare le relazioni. E ci siamo incamminati verso una semplificazione lessicale ed emotiva che somiglia alla neolingua immaginata da George Orwell in 1984, la semplificata neolingua incaricata di sostituire l’archilingua perché l’archilingua è articolata, la neolingua è funzionale a semplificare il pensiero. Se hai sempre meno parole per dire le cose, immagina Orwell, ovvero “chi parla male pensa male”, per dirla con Nanni Moretti, vedi che la coscienza si restringe. E pure i testi scolastici fascisti o nazisti erano dotati di un lessico semplificato, apposta per semplificare il pensiero. Per un verso allora, nota Han, in questo panottico digitale a cui ci siamo nel volgere di pochissimi anni abituati al punto da non saperne più fare a meno sembra incentivata la comunicazione e lo sproloquio. Per un altro verso c’è un invito alla sintesi e alla semplificazione, i post tanto più vengono letti quanto più sono laconici ed essenziali.
Vivremo in una democrazia in cui “la libertà sarà stata un episodio”, così inizia Psicopolitica, il libro dell’apocalittico filosofo tedesco-sud coreano Byung-Chul Han. Una democrazia neoliberale sotto il segno del like. O del dislike. Una comunicazione contrappuntata, quando tutto va per il bene, dagli stucchevoli love, o dagli sganasciati haha, o dagli stupefatti wow, quando va per il male dai melanconici sigh o dai livorosi grr. Lo so, sembro ridicolo, eppure anche sotto i post che accompagneranno questo scritto riceverò qualche decina di commenti in neolingua. Una specie di idiot savant si è inventato questo social network, e di anno in anno come un dio bambino inventa nuovi codici nuovi lemmi, nuove semplificazioni per narrare le relazioni. E ci siamo incamminati verso una semplificazione lessicale ed emotiva che somiglia alla neolingua immaginata da George Orwell in 1984, la semplificata neolingua incaricata di sostituire l’archilingua perché l’archilingua è articolata, la neolingua è funzionale a semplificare il pensiero. Se hai sempre meno parole per dire le cose, immagina Orwell, ovvero “chi parla male pensa male”, per dirla con Nanni Moretti, vedi che la coscienza si restringe. E pure i testi scolastici fascisti o nazisti erano dotati di un lessico semplificato, apposta per semplificare il pensiero. Per un verso allora, nota Han, in questo panottico digitale a cui ci siamo nel volgere di pochissimi anni abituati al punto da non saperne più fare a meno sembra incentivata la comunicazione e lo sproloquio. Per un altro verso c’è un invito alla sintesi e alla semplificazione, i post tanto più vengono letti quanto più sono laconici ed essenziali.
Il problema (ma ciò era prevedibile, pensateci) è che di questa semplificazione lessicale che genera neolingua si sono impossessati (e ne stanno facendo un uso criminale) dei soggetti dal pensiero semplice, che per lo più non hanno fatto studi approfonditi, non si sono spinti oltre le scuole superiori, spesso istituti tecnici, e se si sono affacciati all’università dopo pochi esami hanno capito che invece di perdere tempo a studiare c’era qualcosa di più pragmatico e redditizio da fare: la politica. Anche perché la politica negli ultimi decenni è cambiata, ha smesso di selezionare i più colti (non voglio dire i più etici, perché non è quasi mai stato così), le menti più sveglie, ma in un darwinismo sociale invertito estrae dal mazzo i più fessi, o i più scaltri, o i più ingordi di potere. E così è capitato che questi idiot savant, dico da un Trump a scendere a un Salvini o – per restare nel nostro orto – a un Di Maio un Di Battista un Toninelli insomma gli utili idioti di questi anni, nel comunicare con neolingua fatta di slogan o frasi secche (finita la pacchia, onestà, a casa loro, governo del cambiamento, prima gli italiani, e così via) sono dei veri talenti. Perché un concetto complesso non saprebbero articolarlo, ma hanno questo dono della sintesi estrema che pare fatto apposta per i social più in voga (Facebook, Twitter, Instagram).
E grazie a questo dono di saper parlare semplice – bastano due neuroni e una sinapsi – eccoli dominatori di un dispositivo panottico che il povero Bentham non avrebbe mai potuto immaginare, e neppure noi, fino a vent’anni fa. Anzi, dieci. Un dispositivo dove siamo in reciproca sorveglianza, quindi un panottico a 360 gradi. Un panottico gigantesco. Mettiamo Facebook. Oggi conta oltre due miliardi di iscritti. Che accedono al panottico più volte al giorno. Facebook ha più seguaci del cristianesimo e dell’Islam. È una chiesa più influente di tutte le altre. I cui praticanti sono sempre connessi o raggiungibili. Per mezzo dello smartphone. Smartphone che tocchiamo in media 2617 volta ogni giorno. Non c’è rosario bibbia o corano compulsato con questa frequenza. Facebook è una chiesa che per amen ha un like. Un like come primitivo sistema di gratificazione a breve termine, a base di dopamina. Fatemi semplificare e fare il riduzionista. Propongo questo sillogismo. La psicosi, secondo la teoria più accreditata, da un punto di vista biochimico è causata da un eccesso di dopamina. Il neurotrasmettitore edonico. Quello che dà piacere, insomma. Come a dire: troppo piacere fa impazzire. I like, si dice, aumentano la dopamina. Gratificazione a breve. I like, dunque, producono psicosi. Ecco. Il manicomio digitale, produce psicosi. Non è un caso che coloro che nel 2009 hanno ideato il bottone del like – Justin Rosenstein e Leah Perlman – siano ora i più accesi sostenitori di una sorta di vangelo apocrifo contro la chiesa di Facebook. Si sono disconnessi.
Insomma, ricapitolo: un idiot savant ha creato un manicomio digitale, un panottico a 360 gradi per un reciproco controllo totale. Altri idiot savant si sono impossessati del giocattolo, lo sanno giocare come nessun altro, twittano postano scrivono slogan o frasi lapidarie (molti nemici molto onore) spesso copiate o citando, sapendo o non sapendo tanto è uguale, dato che la cultura è roba da radical chic (altro slogan) e quando sento la parola cultura metto mano alla pistola (altra citazione, chi lo disse? Boh. Che mi frega). Ciò che conta è che questo giocattolo panottico globale è la nuova agorà dove si fa la politica semplificata, la pseudo democrazia partecipata, la democrazia del like, di cui si sono impossessati gli idiot savant Trump Salvini Di Maio.
L’altro ieri, una mia amica che ha votato per gli idiot savant creati dal comico Grillo mi rimprovera la mia anarchia: è il tuo non voto che ha determinato l’ascesa del ministro razzista e fascista. E difendeva i suoi eletti, meritevoli di aver abolito l’aereo con cui Renzi era andato a vedere una partita. Ma non c’è mai andato! È un news fake, informati, ma esci dal panottico, cazzo!
E mia moglie, dopo che lei è andata via (con lo smartphone in mano, e per strada avrà senz’altro distribuito una decina di like a qualche post farlocco): lo vedi? Faccio bene io, che non sono su Facebook, che resisto ai social network tutti: Twitter, Instagram eccetera?
Ma sei un’idiota allora! Ecco perché ti salvi! Davvero, non ti offendere, non sto scherzando. Sai che dice il filosofo Han? Dice che solo se sei un idiota ti salvi. Aspetta, capiscimi. Perché tra tutti questi tipi diversamente idioti ci confondiamo. Non quel tipo di idiota di cui abbiamo detto finora. Han dice: “Una funzione della filosofia è giocare a fare l’idiota”. La filosofia, e sembra controintuitivo, è fatta da idioti. Ma un altro tipo di idioti rispetto a questi che non sanno ma credono di sapere. “Ogni filosofo che realizza un nuovo idioma, un nuovo linguaggio un nuovo pensiero sarà necessariamente un idiota”. Socrate, per dire, sa però afferma di sapere di non sapere, se così è, è un idiota. Pier Aldo Rovatti, per dire, che sostiene la forza del pensiero debole, dell’epochè, del rifuggire i saperi forti, le certezze, le idee potenti, e propone la pratica di un’etica minima, è un idiota. Franco Basaglia, colui che secondo quel grafomane di Vittorino Andreoli “non sa la psichiatria” – e, ammesso sia vero, forse è per questo che l’ha saputa sovvertire – è un idiota. L’idiot de famille, si definiva lui proprio. Oggi – ancora Han – “la figura dell’outsider, del folle o dell’idiota sembra essere scomparsa dalla società”, perché “la connessione digitale”, l’esserci di nostra sponte internati in questo panottico digitale ha aumentato straordinariamente la “coercizione alla conformità”. L’idiotismo, la riluttanza a questa corsa all’internamento digitale, è forse l’ultima “pratica di libertà” rimastaci. L’idiota è colui che non si connette e dunque non si informa al modo dell’informazione totalitaria della rete o dei social. Il non trasparente, colui che non sciama nella rete.
In questi giorni tutti, nei social italiani, come pecore digitali, belano intorno ad alcuni argomenti: tra questi i migranti: gli invasori, i barbari, difenderci dai barbari, casa loro, casa nostra, pacchia, finita la pacchia, così via. Aizzati da un ministro basico che maneggia ripeto con talento da idiot savant i social e la comunicazione fatta di slogan. È la nuova psicologia delle folle. Però siamo ormai oltre “l’età delle folle” descritta da Gustave Le Bon, perché siamo nell’epoca del gregge digitale, o, per dirla sempre con Han, nell’epoca dello sciame digitale. Ma lo sciame non è folla. I connessi sono soli pur sentendosi insieme. L’uomo digitale resta solo, è un hikikomori, uno schizoide, pur sentendosi parte delle cinquecento o cinquemila amicizie o contatti che il social mondiale ti mette a disposizione. I greggi digitali, gli sciami digitali non sanno marciare, non sanno organizzare rivolte, sanno al massimo indignarsi per la causa del momento – ora sono i migranti, c’è chi li difende e chi li vorrebbe morti anzi ha già cominciato ad ammazzarli, domani saranno di nuovo i vaccini, e così via – sanno indignarsi mediante quella scarica emotiva che rapidamente si esaurisce, la chiamano shitstorm, la tempesta di merda.
 L’idiota disconnesso non lo sa cos’è una shitstorm. Non ne è stato contaminato. Non ne ha mai subito gli schizzi dell’eloquio semplice a base di merda di un Salvini o dei suoi sgherri. L’idiota disconnesso, non sa, non bela. L’idiota disconnesso, non comunica, non è raggiungibile. L’idiota a-digitale è apolide. È in una sorta di esilio. Potrebbe perfino non esistere, nonostante l’anagrafe. È in una dimensione pirandelliana.
L’idiota disconnesso non lo sa cos’è una shitstorm. Non ne è stato contaminato. Non ne ha mai subito gli schizzi dell’eloquio semplice a base di merda di un Salvini o dei suoi sgherri. L’idiota disconnesso, non sa, non bela. L’idiota disconnesso, non comunica, non è raggiungibile. L’idiota a-digitale è apolide. È in una sorta di esilio. Potrebbe perfino non esistere, nonostante l’anagrafe. È in una dimensione pirandelliana.
È l’idiota disconnesso che, nell’era della trasparenza e del panottico digitale, forse saprà organizzare, un giorno, una vera rivolta.
Per cui, in questa sorta di nosologia degli idioti, tiriamo le somme: ci sono tre tipi di idioti, in ballo. L’idiot savant che ha creato il panottico digitale, che ha inventato il gioco (Zuckerberg, per non far nomi); gli idiot savant che sanno meglio di tutti giocare il gioco della neolingua e della psicologia delle folle che il panottico determina (Trump, Salvini, per fare qualche esempio). Infine l’idiota disconnesso che non conosce il gioco non gioca ma organizza la rivolta. È sempre un idiota, ma un altro tipo di idiota, e sarà lui il nuovo uomo in rivolta.
]]>È dovere del cinema trasformare le persone in veri comunisti (Kim Jong Il)
 908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007 Trecento veri uomini, questi Centocelle boys in tanga in similpelle a qualunque temperatura Giove mandi sulla terra, depilatissimi e pettinati ma virili sul serio, mica come quei busoni pedofili degli ateniesi, eh! E la prova ce la dà subito la regina Gorgo (Lena Headley, per inciso: spartanamente gnocchissima) che si spupazza Leonida prima della pugna, venendone fuori una belligerante chiavata in stilizzate posizioni da pornazzo, tanto che per un [...]]]>
908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007 Trecento veri uomini, questi Centocelle boys in tanga in similpelle a qualunque temperatura Giove mandi sulla terra, depilatissimi e pettinati ma virili sul serio, mica come quei busoni pedofili degli ateniesi, eh! E la prova ce la dà subito la regina Gorgo (Lena Headley, per inciso: spartanamente gnocchissima) che si spupazza Leonida prima della pugna, venendone fuori una belligerante chiavata in stilizzate posizioni da pornazzo, tanto che per un [...]]]>
È dovere del cinema trasformare le persone in veri comunisti (Kim Jong Il)
 908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007
908 – 300 di Zack Snyder, USA 2007
Trecento veri uomini, questi Centocelle boys in tanga in similpelle a qualunque temperatura Giove mandi sulla terra, depilatissimi e pettinati ma virili sul serio, mica come quei busoni pedofili degli ateniesi, eh! E la prova ce la dà subito la regina Gorgo (Lena Headley, per inciso: spartanamente gnocchissima) che si spupazza Leonida prima della pugna, venendone fuori una belligerante chiavata in stilizzate posizioni da pornazzo, tanto che per un momento ho pensato a una conclusione con evidente money shot. Del resto questo è un film pornografico. Viceversa i persiani sono guidati dall’equivoco omaccione Serse, inanellato come una cotta di maglia e zeppo di piercing. Nelle file del suo esercito anche dei ninja che sembrano mutanti post nucleari (gli immortali) e l’omunculo traditore Efialte, uno che pare uscito dallo sgabuzzino di Pulp Fiction. Traditi da questo gobbo di Notre Dame (sgorbio = cattivo), i trecento burini spartani andranno incontro alla bella morte. E sapete che vi dico? CAZZI LORO: tenevo troppo per i persiani, io. 300 è un classico film da polemica davanti a una birra. Per cui stappatevene una e vi dico la mia: io l’ho trovato semplicemente non divertente come mi sarei aspettato e abbastanza fascista come invece previsto. Non così divertente perché noiosetto, senza gran ritmo e perché mi aspettavo più botte e azione, qualcosa che almeno appagasse il mio lato pagano. E fascista invece perché è una lagna continua su onore, rispetto, libertà, “non mi arrendo”, “puntate qui al cuore”, “bello morire così” e via via littoriamente declamando, mancando giusto un rauco “Roma ladrona”. Durante la visione ero così distaccato che in testa resuscitavano nomi che non sentivo dalle scuole medie, tipo Milziade. Ma chi cazzo era Milziade? Era lui che aveva corso fino a Maratona? Ma no, dai, con la milza che scoppia non può essere lui… e Filottete, chi era costui? E poi, scusate: ma i persiani dovevano passare esattamente da lì, da quel cunicolo stretto stretto delle Termopili? Con le migliaia di chilometri di costa della Grecia è quello l’unico punto da cui imbucarsi? Maddai! 300 è un fumettone (Frank Miller, infatti) secondo la peggiore accezione del termine, graficamente elegante (e questo lo apprezzo, ma finisce lì, dopo 10 minuti), completamente irreale, fotografato in toni rossobruni virati appena al seppia e sessualmente ambiguo, cosa che di per sé potrebbe anche essere una qualità. Se non fosse che l’omosessualità latente degli spartani sfugge gaiamente di mano alla regia e palesa il tentativo di nasconderla sotto una virilità tutta proclamata, tipica del fascismo. E invece quella degli avversari è esplicitata, sommandola agli altri buoni motivi per difendersi – in questo scontro di civiltà – da chi viene da Est. In 300 non c’è solo il terrore e l’odio per l’invasore diverso (e storicamente potrebbe anche starci) ma anche il fastidio mal celato per ogni devianza: l’omosessualità non meno dell’invasione culturale, l’imbastardimento dei costumi, il drammatico perdere la limpieza de sangre. E tutto mentre nel mondo reale la stessa cultura che ha prodotto questo film riusciva a distruggere manufatti storici che avevano resistito 3000 anni. Un film come questo, per innovazione tecnica, storia raccontata e battage pubblicitario pervasivo entra nell’immaginario, nel repertorio culturale, specialmente di chi è debole neuronalmente. Eroismo, fratellanza, sacrificio e purezza contro lascivia, malvagità, ricchionaggine, mollezza e infingardia (o come si dirà). È tutto narrato per exempla icastici, esasperati, leggibili immediatamente, com’è nella miglior tradizione epica, ma di 30 secoli fa. E per questo 300 è un film pericoloso. Perché diverte (cioè distoglie, o almeno ci prova e dagli incassi direi che ci riesce) ed è (apparentemente) bello da vedersi. Ora: la vicenda la conosciamo tutti e non avremmo certo potuto sperare in una versione politically correct. Non mi scandalizzano certe deformazioni storiche (che leggo esserci state e in gran copia) anche perché è da quando ho sette anni che so delle Termopili e non me l’hanno mai raccontata in maniera molto diversa. Però qui i persiani diventano addirittura creature bestiali. Nel loro esercito (di schiavi, che in realtà i persiani non avevano mentre a Sparta esistevano eccome) militano anche mostri degni de L’armata delle tenebre. La corte di Serse (conciato come una Priscilla in scala 1 e ½ a 1 e con la voce di Amanda Lear) è popolata di debosciati e suicide girls dalla sensualità putrida in un delirio di intolleranza ripugnante, questa sì. È tutto talmente pacchiano che quando Leonida perde la pazienza – cioè quando ha la forza e la velocità di sferrare il colpo di giavellotto che potrebbe chiudere la vicenda – riesce soltanto a sfregiare l’orrido Serse e a strappargli un piercing sulla guancia, una fallibilità umana che agli occhi della regia ingigantisce ancora di più l’eroismo del personaggio di fronte alla natura bestiale dell’avversario.
Ecco: è grave un film così? Bisogna guardarselo senza menate e sentendosi echeggiare nella testa il memento dell’amico un po’ ciula che ti dice “e fattela ‘na risata”? No: vedo che qualunque mentecatto fascistello, su Facebook e nella vita, trova in questo Better dead than red dei tempi classici una fonte ispirazionale. E vi posso dire? Questa non è Sparta, questa è una pericolosa cazzata. (Dvd; 21/1/12)
 909 – Requiem for a Dream di Darren Aronofski, USA 2000
909 – Requiem for a Dream di Darren Aronofski, USA 2000
Madre, figlio, ragazza e amico, finiscono tutti malino causa droghe assortite da cui si crede di poter uscire: drogati di tivù, di soldi, di zucchero, di carne rossa, di successo, di visibilità, di sesso, di soldi, di bellezza, di pillole, di coca, di eroina. Perché la droga è una sostanza che altera stato fisico e mentale con conseguenze sulla salute ed è riconosciuta come tale solo in base al contesto sociale, politico e legislativo in cui viene consumata, al di là della gravità degli effetti fisici che comporta. Può sembrare banale ma ce lo dimentichiamo spesso e il film, invece, va dritto al punto. È bellissimo da vedere ma un po’ angosciante da seguire: con pellicole così grafiche, così stilizzate, io ho un problema: non mi scatta la partecipazione. Requiem for A Dream non è compiaciuto ma è anche troppo tirato a lucido per sembrarmi compassionevole, troppo freddo e distaccato, a mio parere. Per cui non lo partecipo, lo subisco. Detto questo, qualche scintilla di vitalità l’ho provata di fronte a Jennifer Connelly, che – anche truccata da drogata marcia, imbruttita dall’abbrutimento – rimane la ragazza più bella di tutti i tempi. Lo era anche in Phenomena, in The Hot Spot, in C’era una volta in America e pure – paffuta nei suoi quindi anni – in quella fetecchia di Labyrinth. E sapete perché? Ma perché è la più bella ragazza di tutti i tempi, stupidi! Quante volte devo ripeterlo? E continuerà a esserlo anche quando avrà 70 anni. E non vi dico il perché, ci potete arrivare da soli. Ciao. (Dvd; 22/1/12)
 910 – Una palla al cazzo che non t’immagini: Zathura di Jon Favreau, Usa 2005
910 – Una palla al cazzo che non t’immagini: Zathura di Jon Favreau, Usa 2005
Più che Zathura, spazZathura. Buio, noioso, ripetitivo, senza che i protagonisti abbiano un ruolo attivo, subendo invece le bizze di un gioco magico trovato da dei bambini in cantina. E ti chiedi tutto il tempo: “chissà quale sortilegio, chissà quale escamotage”. E invece, niente: il gioco ti proietta nello spazio e son cazzi tuoi. È una sorta di seguito di Jumanji, se non ho capito male, anche se ogni legame col film (e romanzo) è reciso. Anche qui, per salvarsi dal mondo in cui si è proiettati, bisogna giocare e vincere, ma se – per quel che mi riguarda – faceva schifo Jumanji, figuratevi questo. I bimbi protagonisti poi sono simpatici come un herpes e alla fine trovo motivo di soddisfazione solo nel volto scontroso di Kristen Stewart. Film brutterrimo che alle bimbe passa (ma un po’ Sofia si rende conto). Mediamente considerato dai critici (…) e rifiutato dal pubblico, non senza motivo, risultò un flop clamoroso al botteghino, incassando meno della metà del budget speso. Godo. (Dvd; 25/01/12)
 911 – L’onesto Brubaker di Stuart Rosenberg, USA 1980
911 – L’onesto Brubaker di Stuart Rosenberg, USA 1980
Ah, quel solido cinema anni Settanta, con belle storie, ritmo interno e grandi caratterizzazioni! Brubaker non lo vedevo da oltre vent’anni ed è un film carcerario democratico, non individualista come Fuga da Alcatraz, ed è qui che si misura tutta la distanza tra un Clint Eastwood e un Robert Redford, eh! (Vabbeh, la faccio facile. Ma ci siamo capiti). Il film è riformista come il direttore del carcere di Wakefield in Arkansas, uno che porta l’orologio sulla destra, che prova a cambiare le cose dall’interno, iniettando forzosamente un po’ di democrazia tra i detenuti. Gli concede le elezioni e un consiglio del carcere, li chiama a partecipare. Solo che non funziona, troppi nemici. E anche chi potrebbe essere liberato preferisce rimanere schiavo del sistema e chiamarsi fuori dall’assunzione di responsabilità. E alla fine, questo Brubaker, da che parte sta? È un film velleitario, come viene accusato di essere il suo protagonista, o è un film tragicamente realista, che dimostra l’impossibilità della riforma? Io – da menscevico parolaio, quale alla fin fine sono – mi fido della buona fede del regista e penso a un film sincero, che fa vedere quali siano i problemi. E la scena finale coi carcerieri che salutano l’ormai ex direttore è una commovente concessione alla retorica strazzacore, inverificabile nella realtà, che leggo come un augurio onirico: forse un dì ci arriveremo. Per fortuna da noi non è (ancora) in agenda rendere le carceri delle aziende con un profitto economico in attivo, a qualunque costo, con tutto quello che ne consegue quando è il guadagno la legge suprema (va anche detto che peggio di come son messe, certe nostre carceri, non so se si potrebbe… ma vabbeh). Ma in USA ci pensò quel cercopiteco di Reagan e gli effetti sono stati devastanti, con una popolazione carceraria altissima, a livelli dell’Unione Sovietica di Stalin, e non scherzo, tenuta in parte in detenzione proprio perché fonte di profitto (arresti facili per quisquilie, regime carcerario gestito autonomamente che prevede allungamenti di pena in base a regolamenti interni, condizioni di vita atroci per consentire il guadagno, lavoro sfruttato a pochi centesimi all’ora… Orwell fatto e finito). E il film è profetico nel parlarci anche delle dirigenze del PD con 30 anni di anticipo: riformatori e finti liberali che fanno qualche passetto a favore di telecamera, che incassano interviste e stampa e rendita elettorale e tutto rimane come prima. Robert Redford era all’apice della gloria prima della mummificazione e so solo che quando Brubaker affronta i suoi avversari, questi rispondono come i lettori del Giornale e di Libero. Ma di oggi, non nell’Arkansas degli anni Settanta. (Diretta Iris; 29/1/12)
 912 – Più scomoda del previsto, Una poltrona per due di John Landis, USA 1983
912 – Più scomoda del previsto, Una poltrona per due di John Landis, USA 1983
Premetto che vedere questo film a febbraio è come festeggiare il Natale a marzo. E rivedendolo – ahi! – lo ritrovo meno scintillante di quanto ricordassi. Però dobbiamo mettere nel conto il mio precoce invecchiamento e le tantissime visioni passate, per cui, facendo la tara, credo che sia ancora il vecchio amato capolavoro, un’adorabile fiaba natalizia aggiornata agli anni Ottanta. C’è la sapienza chirurgica della costruzione e il crescendo inarrestabile, sono tante le situazioni comiche e in generale il ritmo è sostenuto. Stupisce, oggi che tutto è addomesticato, la mancanza di ogni correttezza politica (su neri, handicap, omosessuali) in un film che poi – fatto salvo l’affetto innegabile – ha invece una morale solo apparentemente eversiva, in anni di reaganomics rampante. Quella dei protagonisti (un cialtrone che si arrangia, un ragazzo “bene” ridotto in povertà e una prostituta dal cuore d’oro) è una rivincita contro gli straricchi e avidi Duke & Duke (con Reagan e Nixon in foto sulla scrivania) per arrivare allo stesso risultato: ricchi sfondati con barca ai tropici, sfruttando gli stessi meccanismi economici e senza metterli in discussione. Mah, consueta confusione ideologica yankee! Ma chi sono io per fare la morale? Sono i sensi di colpa televisivi che mi fanno vedere male i film, ecco cosa, mannaggia. Cast eccezionale (Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Denholm Elliott, Don Ameche, Ralph Bellamy e – gulp! – Jamie Lee Curtis) e musica di Elmer Bernstein che saccheggia alcuni classici (riconosco Mozart ed Elgar). Nel mio personalissimo taccuino rilevo anche una marea di parolacce che rendono felici Elena e Sofia e poi una nota amara che rimanda al talento che fu di John Landis. Ma è comunque Natale, dài, SMETTILA. (Dvd; 5/2/12)
 913 – I nuovi mostri di Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola, Italia 1977
913 – I nuovi mostri di Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola, Italia 1977
Questo l’ho visto la prima volta in un alberghetto in Francia nell’autunno del 1994, in una serata in cui avevo beccato anche un film a episodi giapponese che non mi son segnato e che non saprò mai più quale titolo avesse: c’era un tizio in coda in macchina, ingorgato in non so quale tangenziale nipponica, che metteva fine alle sue sofferenze pisciando in una lattina. Se magari qualcuno l’ha visto e mi dice cos’è, mi fa cosa grata, perché vorrei completare il file con tutti i film della mia vita e questo mi manca. Esiste il file, giuro. Vabbeh. Dunque, de I nuovi mostri questa è l’edizione televisiva, più corta di quella per le sale. Ed è un film che non mi era piaciuto granché allora e non mi fa impazzire neanche stasera: lo trovo – come tanto cinema italiano di quegli anni – di un cinismo un po’ ipocrita, che si appoggia a moduli satirici e grotteschi prevedibili e che tenta degli agganci alla realtà quotidiana per sentirsi gggiovani. Ma se avete la pazienza di leggere fino in fondo troverete anche un parziale pentimento tardivo. Scola ha la parte del leone e firma quattro episodi. L’uccellino della Val Padana vede Ugo Tognazzi sfruttare le qualità canore della moglie Orietta Berti, storia ambientata al Picchio Rosso di Formigine dove, di lì a pochi anni, avrebbe cambiato il corso della storia Vasco Rossi. Ma non c’entra niente (però ho il bootleg). Hostaria è una epocale ed esilarante litigata in cucina tra un cuoco (Tognazzi) e un cameriere (Vittorio Gassman), gay e amanti, tutto mentre la clientela radical chic apprezza un cibo di dubbia fattura. In Come una regina Alberto Sordi abbandona la madre in una tremenda casa di riposo privata. L’elogio funebre è probabilmente l’episodio più famoso del lotto, con Albertone senza freni nel ricordare un collega attore, elogio che culmina nel famoso “stocazzo!” che Blob dedicava spesso al giornalista Onofrio Pirrotta, appena morto mentre scrivo e che, invano, aveva tentato di bloccare l’ingiuria più volte riproposta (che ovviamente tutti hanno carognescamente ricordato anche nei coccodrilli dedicatigli). Dino Risi ha la regia di tre episodi. Tantum Ergo è feroce, ma gli yankee lo definirebbero half baked, perché parte bene e poi rimane sospeso, un po’ lì, con un alto prelato che seda con belle e fatue parole la plebe di una parrocchia di periferia aizzata da un giovane e combattivo prete. Con i saluti degli amici è poco più di un’orrenda barzelletta sui siciliani omertosi anche in punto di morte. Senza parole narra un amore fulminante e falso, con sorpresina finale. E mentre lo vedevo continuavo a chiedermi chi fosse il partner mediterraneo della bella hostess Ornella Muti. Ma dove l’ho visto, questo? E quel nome, Yorgo Voyagis… Lo butto su Google e, patapam!, è Giuseppe nel Gesù di Zeffirelli, ecco chi! Però l’episodio… mah. Infine c’è Monicelli che firma solo due storie. La prima è Autostop con di nuovo la Muti, bella e intelligente (e abbastanza cagna, in termini recitativi), uccisa dal maschilista Eros Pagni (orco qualunquista e reazionario che, pur ritenendosi “femminista”, sfrutta il lavoro nero e non esita a sparare non appena si senta in pericolo). Boh: mi sembra poco sincero nella sua schematicità, come a voler accalappiare facilmente un po’ di pubblico giovane. L’altro episodio è Pronto soccorso, che parte da un’idea bellissima: il ritratto di un nobilastro dissoluto, volgarissimo e legato alle gerarchie ecclesiastiche romane, che dovendo soccorrere un morto di fame mostra il suo vero volto: indifferente più che ipocrita, in definitiva letale. Però è tutto talmente grottesco e spinto in avanti che la macchietta dopo un po’ mi risulta insopportabile e l’episodio dura 14 minuti interminabili. Questo Sordi sembra che ci parli dell’Italia del 2012, dove tutto, e il suo contrario, è confluito nel berlusconismo che lecca il culo al Vaticano e fa contemporaneamente partouzes con le ragazzine raccattate da amici equivoci: Giovan Maria Catalan Belmonte è un ricettacolo di confusione lessicale (linguaggio magniloquente e improvvise impennate volgarissime), culturale (il monumento a Mazzini che diventa dedicato a Mussolini) e religiosa (osservante lefevriano senza pietà alcuna). Però l’amara chiusa finale è un anti climax che mi pare non valga lo sviluppo (eterno). Penso tutto questo e poi la collega Alez che vede lontano, certamente più lontano del mio sguardo appannato, mi fa notare come la chiusura a cerchio abbia un preciso e spietato significato. E in effetti ci sta eccome e quello che forse scambio per pigrizia registica e cinismo è una trovata notevole. Ma che faccio ora, riscrivo tutto? No. Continua a non piacermi la forma, ma sul significato (e quindi sul valore ultimo dell’episodio) credo abbia ragione lei. (Dvd; 10/2/12)
 914 – Fate la storia senza di me di Mirko Capozzoli, Italia 2011
914 – Fate la storia senza di me di Mirko Capozzoli, Italia 2011
Fate la storia senza di me è un documentario intenso e a tratti dolente, molto, che racconta la vita e la morte di Alberto Bonvicini, ragazzo torinese che con la sua vicenda attraversa paradigmaticamente gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Però è come se la regia rimanesse a distanza. Perché la materia è densa ed entrare in un’altra vita è difficile e la vita di Bonvicini era difficile assai, da esplorare e soprattutto da vivere. Il rischio era di fare un bignamino sulle tensioni degli anni della contestazione, okay, perché il protagonista ha vissuto sia il dramma dei manicomi – arrivandoci per burocrazia da un orfanotrofio – che quello delle carceri, ha frequentato attivamente il movimentismo giovanile, sfiorato il terrorismo (rifiutato recisamente) e infine è stato vittima della droga e poi dell’Aids. Il Bignami viene evitato, e ha un senso perché si racconta la Vita e non la Storia. Però, qui, sembra che si faccia sempre un passo indietro anche di fronte all’esistenza del protagonista suo malgrado, dedicando un approfondimento solo al famigerato dottor Coda, l’“elettricista”, che seviziava i suoi pazienti a colpi di elettrochoc. È come se la telecamera si ritraesse di fronte al dolore, allo sgomento e anche alla commozione della famiglia adottiva e intellettuale della Torino borghese, che rimane sconvolta da questo ciclone, un ragazzino che a 14 anni ruba una macchina e finisce in carcere minorile, che rimane coinvolto (e poi assolto) nella vicenda agghiacciante dell’Angelo azzurro, che si dissocia da chi stava abbracciando la lotta armata con la fatidica frase “Fate la storia senza di me”, che finisce in carcere con una marea di addebiti poi rivelatisi fasulli e che, lì dentro, diventa eroinomane. Sono belle e interessanti le testimonianze di compagni di strada, in prigionia e nella politica, sfrondate di ogni retorica e molto umane: Albertino cercava solo un po’ di tranquillità. E la troverà finalmente lavorando prima al quotidiano Reporter con Enrico Deaglio e poi in tivù, con Giuliano Ferrara, morendo infine di Aids. Ma la storia di questo ragazzo – che ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che gli son stati amici – è solo sfiorata, delicatamente, narrando in modo ellittico e lasciando la voglia allo spettatore, secondo me troppa. Ma credo sia colpa mia, ché vorrei sempre un film definitivo che non si potrà mai realizzare. (Dvd; 18/2/12)
 915 – Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, USA 1988
915 – Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, USA 1988
Ullalà! Nei miei primi anni di vita assieme a Barbara, Roger Rabbit era un film visto e stravisto. Lei possedeva il videoregistratore e questo film era uno dei pochi posseduti in Vhs, un regalo natalizio, immagino. Siccome a casa di Barbara le registrazioni erano sempre qualcosa di stocastico (cassette da 90 minuti per film da due ore, programmazioni sballate, nastri smagnetizzati, titoli messi alla cazzo, film scomparsi nel magma della videocassetta da 4 ore) alla fine ricordo di averlo visto più volte, nonostante le proteste di Barbara che se un film lo vede una volta sola, le basta per sempre (mentre io continuerei a rivedere sempre lo stesso film, possibilmente Novecento). Comunque, per farla breve, lo conosco bene, questo Zemeckis, e lo incontro di nuovo a oltre vent’anni dall’ultima volta. Lo regalo a Sofia che si sente adulta pur non capendo una mazza di questo intrigo molti anni Quaranta, con la cantante sciantosa, l’investigatore privato alcolizzato e questioni di testamenti ed eredità. Ma la commistione tra animazione e attori in carne ed ossa, tra Disney e Spielberg e tra atmosfere noir e commedia, funziona anche per lei, che si diverte, perché non c’è niente da fare: pupe, pistole e cascatoni fan divertire chiunque, e gli americani lo sanno bene. Rivisto, il film è simpatico e denso, più per grandi con le loro memorie da bambini che per bambini stessi. Bravissimi gli attori (su tutti lo straordinario Bob Hoskins), oleografica e convincente la ricostruzione degli USA di metà secolo scorso, straordinarie (per l’epoca, ma ancora validissime) le invenzioni e gli effetti speciali. Il gioco metacinematografico è intelligente (tutto il mondo dei cartoni è utilizzato e affettuosamente parodizzato), i rimandi ironici alla modernità azzeccati (la critica alla civiltà delle autostrade) e il ritmo è indiavolato, come certi cartoni insegnano. In effetti, nel suo campo, trattasi di un piccolo capolavoro. (Dvd; 19/2/12)
 916 – Los Cronocrímenes di Nacho Vigalondo, Spagna 2007
916 – Los Cronocrímenes di Nacho Vigalondo, Spagna 2007
Sono solo a casa, temporaneamente abbandonato da tutte le mie donne che provano l’ebbrezza delle nevi. Ho un carico di lavoro pesantissimo e modero il malumore con un film consigliato dall’amico Mauro, sempre raffinato suggeritore, dalla musica brasiliana al cinema con un quid. La tagline di questo film distribuito nel mondo come Timecrimes potrebbe essere pochi soldi, tante idee. E aggiungo: quattro attori, quattro ambientazioni e mille idee di scrittura. Il classico piccolissimo film tutto fosforo dove la mancanza di milioni di euro, di attori di fama e di chissà quali invenzioni tecnologiche non si sente minimamente. La vicenda narra di viaggi nel tempo e detta così sembra che ci sia pure il dottor Enigm. Invece il contesto è il più borghese e innocuo che si possa pensare. Hector (un Toni Servillo iberico e dinamico) è nella sua nuova casa di campagna assieme alla moglie. Guarda al di là del recinto con un binocolo e nota una ragazza che si spoglia. Va a vedere da vicino e un uomo tutto bendato lo ferisce a un braccio. Hector scappa e arriva in un misterioso centro studi, dove l’antitesi visiva dello scienziato pazzo (ma non meno pericoloso) sta facendo degli esperimenti sui viaggi nel tempo. E da lì si rimane prigionieri di un loop temporale ben gestito. Vi dico solo che Hector sarà uno e trino e la vicenda non perde colpi, anzi: alza sempre più la posta in gioco e regge fino alla fine. Bellissimo, nella sua astrusa semplicità: non vi ricordo cosa succede non perché voglia evitarvi spoiler ma proprio perché io, a riassumere trame fantascientifiche con diversi piani della realtà, vado in fusione cerebrale. Comunque: film da vedere, sul serio. (Dvd; 20/2/12)
 917 – Chitarromani! It Might Get Loud di Davis Guggenheim, USA 2009
917 – Chitarromani! It Might Get Loud di Davis Guggenheim, USA 2009
Mi godo l’ultimo giorno di libertà familiare, dedicando un po’ di tempo alla mia passione preferita, la pornografia, e scelgo un film dedicato alla chitarra, quel It Might Get Loud che sembrerebbe il Graal per gli amanti della 6 corde. Ma la chitarra è un paravento neanche troppo occulto, perché qui si parla di creatività, di musica, di rock e di come uno strumento sia esattamente tale, per esprimere ed eventualmente portare al pubblico delle idee. A confronto tre generazioni e tre modi di diversi di essere musicisti. Ci sono: Jimmy Page, la divinità suprema del rock degli anni Settanta; The Edge (chitarrista degli U2), che cresce nella contestazione punk a quel mondo; Jack White, l’ultimo ribelle e inventore, che negli anni Zero ha riportato quelle sonorità nel mainstream, soprattutto grazie all’usurato ma geniale riffone di Seven Nation Army (il po-poppopo-poopoo cantato negli stadi). Si parla di rapporto con la tecnologia, di chitarra come oggetto del desiderio, di tecnica come mezzo e non come fine (non c’è un assolo in tutto il film, uno che sia uno, e non se ne sente minimamente il bisogno): diverse chitarre, diversi modi e diverse capigliature, perché si può essere rockettari anche con un sacco di effetti, un computer e un berrettino sulla pelata, come The Edge. Non c’è un vero sviluppo narrativo, purtroppo, e il film ha un aplomb in palese contraddizione con l’idea di rock che la chitarra suggerisce, ma detto ciò il film si fa vedere: qualche idea è carina (il Jack White adulto che insegna a sé stesso giovane cos’ha imparato crescendo) o lo stesso White che costruisce uno strumento a corda in qualcosa come 5 minuti secchi. Alla fine, però, rimane la sensazione di un elegantissimo lavoro un po’ inerte. (Dvd; 25/2/12)
(Continua – 78)
 E’ in libreria per i tipi di Odoya Divine Divane Visioni – Guida non convenzionale al cinema, con la preazione di Mauro Gervasini (direttore di FilmTV) e la postfazione di Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band)
E’ in libreria per i tipi di Odoya Divine Divane Visioni – Guida non convenzionale al cinema, con la preazione di Mauro Gervasini (direttore di FilmTV) e la postfazione di Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band)
Altre Divine Divane Visioni su Twitter e Facebook
Oppure binge reading qui, su Carmilla
]]> Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, Guanda, Milano, 2016, 220 pp., € 16,00
Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, Guanda, Milano, 2016, 220 pp., € 16,00
Qualcosa là fuori, l’ultimo romanzo di Bruno Arpaia, parla, in forma distopica, soprattutto del nostro tempo, piuttosto che del futuro: non soltanto perché l’intero racconto ruota attorno al reale pericolo del surriscaldamento globale del pianeta, ma anche perché l’autore insiste continuamente sulla fine dell’umanità, intesa sia come razza umana che come humanitas, come sentimento di comprensione, solidarietà e apertura all’altro. Ed è così che, nello specchio dell’Europa del 2070 tratteggiata nel libro, dobbiamo guardare noi stessi. Sembra che [...]]]>
 Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, Guanda, Milano, 2016, 220 pp., € 16,00
Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, Guanda, Milano, 2016, 220 pp., € 16,00
Qualcosa là fuori, l’ultimo romanzo di Bruno Arpaia, parla, in forma distopica, soprattutto del nostro tempo, piuttosto che del futuro: non soltanto perché l’intero racconto ruota attorno al reale pericolo del surriscaldamento globale del pianeta, ma anche perché l’autore insiste continuamente sulla fine dell’umanità, intesa sia come razza umana che come humanitas, come sentimento di comprensione, solidarietà e apertura all’altro. Ed è così che, nello specchio dell’Europa del 2070 tratteggiata nel libro, dobbiamo guardare noi stessi. Sembra che Arpaia abbia utilizzato la stessa strategia attuata a suo tempo da George Orwell in 1984: ambientare un racconto nel futuro per denunciare (a cominciare dal titolo, rovesciamento della data della stesura del romanzo, 1948) le problematiche del suo tempo.
Protagonista della storia è il napoletano Livio Delmastro, anziano professore universitario di neuroscienze, che si ritrova incolonnato insieme a migliaia di altri profughi italiani verso l’Europa del Nord. Siamo intorno al 2070 e tutta l’Italia e l’Europa centrale si sono trasformate in deserto. A causa dell’inquinamento, infatti, il pianeta si è surriscaldato e le fasce climatiche aride si sono espanse; il clima temperato, quello che ha sempre caratterizzato la zona del Mediterraneo e l’Europa, ormai, si è spostato a nord, in Scandinavia la quale, insieme al Canada e ai territori settentrionali del Globo, si presenta come l’unica terra abitabile. Il racconto ci mostra, in forma distopica, un futuro che però non è solo fantascienza, purtroppo: la principale denuncia del romanzo è contro la leggerezza con la quale i governanti affrontano il problema del surriscaldamento globale. Come Arpaia scrive in una Avvertenza finale, il suo racconto si basa sugli scritti e sui saggi di numerosi scienziati, nonché sui rapporti dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) – e non è la prima volta che lo scrittore si confronta direttamente con la scienza: basti ricordare il precedente L’energia del vuoto (2011), ambientato nel mondo dei fisici delle particelle.
Si tratta di un immaginato scenario futuro apocalittico che potrà essere non troppo lontano da quello reale se non si ridurranno drasticamente e rapidamente le emissioni inquinanti. La narrazione prosegue alternando le vicende di Livio e degli altri profughi in viaggio verso il Nord a quelle di un lungo flashback in cui viene raccontata la giovinezza del protagonista: l’amicizia con Victor e la loro diversità di opinioni in fatto di cambiamento climatico, l’innamoramento con la fisica Leila e la loro successiva convivenza, la nascita del figlio Matias, la decisione dei due giovani di trasferirsi in California per seguire le proprie ricerche scientifiche. Sullo sfondo, l’aumento progressivo delle temperature, l’inaridimento della terra e l’innalzamento del livello dei mari, eventi segnati, periodicamente, da terribili catastrofi naturali.
Oltre, quindi, al ‘macrotema’ del cambiamento climatico, il romanzo ci offre altri ed interessanti spunti di riflessione. Come precedentemente accennato, quell’Europa del futuro che si sta sgretolando sotto distruzioni e disumanità non è nient’altro che uno specchio in cui guardare la nostra società. Quelle migliaia di migranti europei che si muovono verso il Nord come profughi in fuga dalla desertificazione e dalle guerre chi altro sono se non i migranti del nostro tempo, che fuggono dalle guerre e dalla progressiva desertificazione di molti paesi africani e asiatici? E quegli stati, Svezia, Norvegia, Finlandia, Canada ecc. che nel racconto di Arpaia si chiudono a riccio in una Unione del Nord e che, dopo un rigidissimo controllo, permettono l’ingresso solo ai profughi che abbiano già dei parenti sul loro territorio cos’altro sono se non la civilissima, attuale Unione Europea, all’interno della quale si erigono muri e si creano sempre maggiori controlli per impedire l’arrivo di profughi dal sud e dall’est del mondo? E quella specie di campi di concentramento, che l’autore descrive con orrore, come veri e propri inferni, che si trovano sulle coste del Mare del Nord e nei quali vengono rinchiusi i profughi che non riescono a entrare in Svezia, cos’altro sono se non i nostri cosiddetti “CPT”, i “centri di permanenza temporanea”, spesso dei veri e propri lager dove vengono rinchiusi gli immigrati?
Vale la pena, a questo proposito, leggere uno dei numerosi flashback presenti nel libro, nel quale, quando ancora Livio e Leila sono giovani e non si è arrivati al disastro finale, si narra una situazione mondiale in netto peggioramento, situazione che sembra avere le sue radici al giorno d’oggi:
Il Mar Mediterraneo era relativamente piccolo e poco profondo: si stava riscaldando molto, perdendo la capacità di mitigare le temperature sulla terraferma dei paesi che bagnava. E l’afflusso di clandestini dalle sue coste meridionali sembrava impossibile da arginare se non con le maniere forti. Alla Germania, alla Francia e ai paesi nordici non era bastato cancellare gli accordi di Schengen per evitare di essere invasi da quei disperati, anche se l’Unione europea aveva deciso di vendere a prezzo ridotto derrate alimentari all’Italia, alla Spagna e alla Grecia per calmare le acque. Il capitano dell’incrociatore Ardito, Olimpio De Falco, era diventato famoso perché era stato il primo a dover eseguire l’ordine di sparare a vista sui barconi degli immigranti. Il numero dei morti non era mai stato accertato (p. 65).
E, successivamente, dopo alcuni anni, quando Livio, Leila e Matias sono tornati in Italia, a Napoli, per stare vicino alle rispettive famiglie, la situazione è notevolmente peggiorata: le strade della città ormai sono irrimediabilmente sconnesse, i cinema, i teatri e le librerie sono scomparsi, dovunque “baraccopoli di cartoni e lamiere che nascevano e si sviluppavano come un cancro alla periferia e nel cuore del centro urbano” e i “pochi ricchi si barricavano in quartieri recintati da poliziotti e cani”, mentre per le strade imperversa la violenza in uno scenario socialmente e politicamente apocalittico:
i moti di piazza di folle affamate e assetate che saccheggiavano supermercati, magazzini, chiese, moschee e palazzi, Venezia che sprofondava in mare, piazza Navona e la fontana del Bernini completamente distrutte durante i violenti scontri del 2068, il Colosseo ridotto a un accampamento di senzatetto, la terra arida delle campagne che si spaccava e luccicava di sale, i profughi africani e italiani che si spostavano in massa verso nord, i palazzi Vaticani razziati da un’orda di miserabili, il mare che lambiva Padova, L’ultima cena ridotta a calcinacci durante gli scontri fra bande rivali per il controllo di Milano, gli Uffizi accartocciati su se stessi sotto un fitto fuoco di mortai, gli attentati ai server e la Rete che funzionava sempre peggio finché una sera non aveva più dato segni di vita e anche l’Italia si era ritrovata catapultata a un secolo prima, ma senza più nessuno che fosse in grado di fare a meno dei computer. Livio l’aveva visto da bambino nei vecchi film di fantascienza, ma non avrebbe mai pensato di potervi assistere davvero: l’ultima finzione di Stato si esaurì per stanchezza, per inutilità. Senza troppa sorpresa, le elezioni non vennero più celebrate e nessuno sembrò sentirne la mancanza. Le bande dei signorotti locali, spesso malavitosi, si spartirono il territorio in miriadi di guerre locali che sembravano non avere mai fine. Era già successo in Spagna e in Grecia, poi avvenne in Francia, in Belgio, nell’Olanda risucchiata dal mare, nella Germania centrale, lontana dalle acque fredde dell’Atlantico e devastata ormai quasi quanto l’Italia. Allora l’Unione del Nord si era chiusa a riccio come l’Inghilterra: aveva arretrato le proprie frontiere allo Skagerrak e al mar Baltico, abbandonando al proprio destino il resto dell’Europa (pp. 190-191).
Si tratta di uno scenario veramente apocalittico: un mondo devastato dal disastro climatico ma anche dall’autodistruzione verso cui l’umanità si è incamminata, un’umanità che, sempre più chiusa in se stessa, ha perduto le sue prerogative ‘umane’. Lo scenario inquietante delineato da Arpaia fa venire in mente un altro bel romanzo italiano di questi ultimi anni, Nina dei lupi (2011) di Alessandro Bertante – venato comunque di tonalità più fantastiche – nel quale si narra di una “sciagura” che avviene in Italia e nel mondo e che provoca una grave crisi finanziaria. Anche nella storia di Bertante, le città vengono abbandonate, tutti si chiudono in se stessi e vige il diritto del più forte: quelli che nella società erano stati i più cinici ed egoisti (rozzi manager e uomini di potere) adesso imbracciano armi e fucili e si organizzano in bande violente. Solo il montanaro anarchico Alessio, intrepido e generoso, erede della Resistenza partigiana, riuscirà, in un paesino perduto fra le montagne, a salvare e proteggere la piccola Nina dalle violenze e dal disastro.
In questa apocalisse infernale, i muri, le barriere, la chiusura non sono altro che sinonimi di autodistruzione. Il più significativo punto di forza di Qualcosa là fuori, perciò, è la capacità di rappresentare questa devastata società del futuro come se fosse la nostra società en travesti, in una narrazione all’interno della quale l’allusione spesso si fa metafora. Come a voler dire: non dimentichiamo, noi europei ‘benestanti’, che, se un tempo fummo noi stessi migranti, potremmo ridiventarlo in futuro a causa di una apocalisse naturale scatenata dall’incuria e dal cinismo degli uomini di potere sottoposti al diktat neocapitalistico. Nel romanzo si possono intravedere, inoltre, altre allusioni alla società contemporanea, soprattutto a quella statunitense. Ad esempio, nel poliziotto corrotto che, a un posto di blocco a Napoli ferma Leila e il piccolo Matias diretti all’ospedale e che, di fronte all’impossibilità di Leila di pagarlo, non esita ad ucciderli, si può incontrare un riferimento alla violenza della polizia nei confronti di molti giovani di colore in America; oppure, nella figura del reverendo Thomas Hayne, della Coalizione di Dio, ferocemente xenofobo, in corsa per la presidenza degli Stati Uniti nel 2050, si può intravedere un riferimento all’attuale candidato repubblicano Donald Trump.
Nei momenti finali del libro, i personaggi, dopo essere stati controllati da poliziotti in tute protettive e rinchiusi in una stanza in attesa (davvero, vengono in mente molte sequenze del toccante documentario Fuocoammare, del 2016, di Gianfranco Rosi, dedicato agli sbarchi dei migranti a Lampedusa), guardano da una finestra la vita che si svolge nella cittadina svedese, una vita ancora ‘normale’. Due bambini, che facevano parte della colonna dei migranti europei e italiani – e che potrebbero essere benissimo bambini africani che al giorno d’oggi vedono per la prima volta una città italiana – la osservano: “loro non avevano mai visto una città calma e ordinata, la gente che passeggiava tranquilla in riva al mare, le auto silenziose, i grattacieli, l’acqua delle fontane sul corso principale, le case dai colori accesi senza una sbavatura nell’intonaco, i giardini così belli e rigogliosi” (pp. 209-210).
Perciò, in quel “qualcosa là fuori”, nella realtà codificata dal nostro cervello, come spiega Livio a Marta, una compagna di sventura con la quale si stabilisce un rapporto di affetto, mentre marciano incolonnati per il Nord, ci dovrebbe essere spazio per l’umanità, per l’apertura all’altro, per l’ibridazione di società e di culture. Nell’erigere muri contro i migranti, nella chiusura a riccio di un’Unione europea che conosce solo le leggi dell’economia e della finanza, dimenticandosi i diritti umani, nell’arringa populista dello xenofobo di turno, c’è la distruzione, la catastrofe, l’apocalisse. Nell’apertura all’altro, nella solidarietà, nell’ibridazione, nel “restare umani”, invece, c’è un mondo da guadagnare.
]]> La memoria percorre strade tortuose. Arrivata alla meta non vi soggiorna per sempre. Dimentichiamo, ritorniamo sui nostri passi, spesso non ricordiamo la via, ma riusciamo a ritrovare luoghi che sappiamo di avere già frequentato, che negli anni abbiamo consumato fino a renderli al tempo stesso familiari ed estranei. Una decina di anni fa mi capitò di parlare di 1984 di George Orwell a ragazzini delle medie. A casa ripresi in mano questo libro, che avevo letto, solo in parte, da studente, dopo averne discusso al liceo durante l’ora di storia, proprio nell’anno 1984.
La memoria percorre strade tortuose. Arrivata alla meta non vi soggiorna per sempre. Dimentichiamo, ritorniamo sui nostri passi, spesso non ricordiamo la via, ma riusciamo a ritrovare luoghi che sappiamo di avere già frequentato, che negli anni abbiamo consumato fino a renderli al tempo stesso familiari ed estranei. Una decina di anni fa mi capitò di parlare di 1984 di George Orwell a ragazzini delle medie. A casa ripresi in mano questo libro, che avevo letto, solo in parte, da studente, dopo averne discusso al liceo durante l’ora di storia, proprio nell’anno 1984.
«Quindi la faccia del [...]]]>
 La memoria percorre strade tortuose. Arrivata alla meta non vi soggiorna per sempre. Dimentichiamo, ritorniamo sui nostri passi, spesso non ricordiamo la via, ma riusciamo a ritrovare luoghi che sappiamo di avere già frequentato, che negli anni abbiamo consumato fino a renderli al tempo stesso familiari ed estranei.
La memoria percorre strade tortuose. Arrivata alla meta non vi soggiorna per sempre. Dimentichiamo, ritorniamo sui nostri passi, spesso non ricordiamo la via, ma riusciamo a ritrovare luoghi che sappiamo di avere già frequentato, che negli anni abbiamo consumato fino a renderli al tempo stesso familiari ed estranei.
Una decina di anni fa mi capitò di parlare di 1984 di George Orwell a ragazzini delle medie. A casa ripresi in mano questo libro, che avevo letto, solo in parte, da studente, dopo averne discusso al liceo durante l’ora di storia, proprio nell’anno 1984.
«Quindi la faccia del Grande Fratello disparve a sua volta e i tre slogan del Partito, invece, apparvero a lettere cubitali:
LA GUERRA È PACE
LA LIBERTÀ È SCHIAVITÙ
L’IGNORANZA È FORZA
Ma la faccia del Grande Fratello, tuttavia, sembrava persistere per parecchi secondi sullo schermo, come se la sua impronta, lasciata sulle pupille di tutti, fosse troppo viva per essere cancellata immediatamente. La donnetta dai capelli color sabbia si gettò riversa sullo schienale della sedia che le stava di fronte. Con un tremulo bisbiglio che parve quasi un “O mio Salvatore!” essa tese le braccia verso lo schermo. Quindi seppellì il volto tra le mani. E fu chiaro che s’era messa a pregare».
L’inizio del libro, mentre lo leggevo con l’intento di rintracciare un’impronta di un passato che non vuole passare, un’immagine rifratta del nostro paese e delle guerre più recenti, mi suggerì questo commento, che poi pubblicai su una rivista.
«Quando la guerra viene definita intervento umanitario e operazione chirurgica, quando si chiama effetto collaterale l’uccisione di civili inermi, quando qualsiasi progetto, intenzione di combattere e superare i rapporti sociali ed economici del mondo presente, affinché gli umani non siano servi, strumenti e merci di altri umani, è indicata come via all’inferno e alla schiavitù, non si deve aspettare a lungo per sentirsi dire e quasi convincersi che l’ignoranza di sé e degli altri, la perpetua distrazione, il consumo smemorato, la sonnolenza digestiva, un’esistenza da sonnambuli, il marciare in truppa al suono di un jingle pubblicitario siano gioia di vivere, prosperità sociale, anzi forza.
Quando finalmente la guerra sarà pace, la libertà schiavitù e l’ignoranza forza, il titolo di un romanzo sulla società totalitaria, utopia negativa del XX secolo, potrà dar nome a un nuovo programma televisivo che ci guidi con dolcezza al nulla quotidiano».
Non riesco a rammentare se quando scrivevo queste parole ero consapevole di creare un piccolo mondo parallelo, piuttosto simile a quello da cui scrivo ora, un mondo in cui il titolo del romanzo più famoso di Orwell è The Big Brother invece di Nineteen Eighty-Four. Non mi importa stabilire se si trattasse di un lapsus o di una scelta, di una sorta di lattice verbale per agguantare rifiuti tossici. Non importa. Ho ricordato un testo scritto un decennio fa perché proprio in quelle pieghe, per l’ultima se non l’unica volta in vita mia, avevo infilato una parola, sonnambulo, di cui mi ero appropriato, qualche anno prima, dopo averla messa a fuoco come parola chiave, come figura centrale di un testo di Franco Fortini, l’autore su cui ho scritto la tesi di laurea.
Sulle poesie di Fortini avevo discusso la tesi un martedì 14 luglio, il giorno della Presa della Bastiglia. L’ho ricordato pochi giorni prima di comprare un libro che sento il bisogno di leggere, un romanzo che si svolge durante la Rivoluzione francese, L’armata dei sonnambuli.
Ho comprato il romanzo di Wu Ming che si intitola L’armata dei sonnambuli. Vorrei cominciare subito a leggerlo, ma la parte più severa della mia mente mi ha imposto di aprirlo solo verso la metà di giugno, quando comincerò a lavorare meno, o magari alla fine del mese, quando sarò già in ferie.
Finché studiavo all’università, ogni sera andavo a letto tardi e mi svegliavo tardi al mattino. Adesso la sera ho sonno, troppo sonno per leggere un romanzo lungo senza frantumarlo tra sera e sera e ancora ogni singola sera nel mio dormiveglia.
Non lavori in miniera o in fabbrica, mi dico. Apparecchio e sparecchio, riempio e svuoto lavatrici, apro e chiudo finestre, faccio spesa e colloco le merci in dispensa e in frigorifero. Non lavo mai la macchina, ma pulisco ogni giorno tavoli o lavandini. Certi pomeriggi vado a prendere mio figlio a scuola e sto con lui ai giardini pubblici. Non so quando finisce il lavoro e inizia il riposo. Lavoro a scuola, compilo e correggo a casa le verifiche, emendo o glosso i libri che i miei alunni dovranno studiare, leggo qualche articolo, scendo in apnea di fronte a questo schermo o, molto più raramente, sul divano, davanti allo schermo più grande. Certe notti, quando mio figlio è già addormentato, riesco a leggere. Non di rado dopo quattro pagine mi cade la testa sul libro.
Prima che si dorma devo ricordarmi chi sono. Ecco la genealogia della morale di stasera, la mia preghiera della buonanotte. Mi sono educato a svegliarmi la mattina presto senza provare rancore per la libertà di quelli che ora ripetono la libertà della mia giovinezza. Possiedo la casa in cui vivo anche perché alcuni miei antenati hanno lavorato per una vita, e ancora lavorato, in nero, dopo il lavoro. Posso permettermi un lavoro retribuito a tempo parziale perché ho una casa. Guadagno circa dieci euro all’ora, quasi il doppio della mia compagna. Mi compiaccio di recuperare razioni dell’unica vita che abbiamo, cedendo lavoro e reddito a chi ne ha più bisogno. «Sono il tuo datore di lavoro», dico ai colleghi e alle colleghe precari. Non pretendo di essere buono solo perché non estorco una quota del loro reddito. Mi persuado di essere decente se penso che un Berlusconi, votato da milioni di berluschini, ci ha governati. L’amor proprio, la minuscola virtù che presumo di intravedere mentre mi taglio la barba sono il modo più facile per sputare in faccia a quei milioni di miei connazionali.
Da qualche tempo, diceva qualcuno, siamo insonni quando vogliamo dormire e ci assopiamo quando dovremmo restare svegli. Non mi lamento, non è sempre così.
La mia compagna esce dalla camera di nostro figlio. Tra poco dormiremo tutti. Dall’ombelico dei miei sogni, fradici, sbucheranno i roditori della Storia. Mi sono laureato sedici anni fa, il giorno della Presa della Bastiglia. Questa sera ho sonno, ma presto, molto presto, lo giuro, leggerò L’armata dei sonnambuli. Mi aspetto di trovarci anche l’altra metà del cosiddetto suffragio universale, la canaglia, il volgo disperso che nome non ha; le periferie, le chiaviche, i depositi alluvionali, i teatri profondi della storia; i limiti scuri della nostra vita, la follia.
«Quand’ero studente, gli anni fuori corso all’università, con i compagni, sono stati una lotta di lunga durata contro la psichiatria: ho preferito pagare le tasse di iscrizione invece delle sedute da un terapeuta», diceva un mio amico. Quando ho scritto la tesi, ero in grado di trovare, sfogliando i suoi libri, qualsiasi frase di Franco Fortini. Ora fatico a ricordare. Prima di dormire, mentre ti vedo, professore delle medie di ruolo, seduto al tavolo su cui non riesci più a correggere le verifiche dei tuoi alunni, io voglio ricordare, voglio ritrovare alcune parole di Fortini. Anche lui, mi ripeto, da qualche parte, ma non ricordo dove, usa la parola sonnambulo. Nei suoi versi, il sonno e la veglia sono immagini insistenti. Alla fine, all’inizio, nelle fessure della sua poesia, una poesia della veglia, troviamo erbe o piccole bestie, i nostri limiti oscuri e il sonno. E questo è il sonno, edera nera…
Un mio amico, Riccardo, un nostro compagno di università, aveva scritto una tesi di dottorato su Fortini. Si uccise gli ultimi giorni dell’estate 2005. Un altro, Matteo, si era ucciso gli ultimi giorni d’estate del 1992.
Non parlo di me, caro prof. Se non hai voglia di ricordare, dormi. Li penso spesso, anche ora, mentre cerco di trovare sonnambuli tra le parole di Fortini. E pensando a Riccardo, non posso fare a meno di ricordare uno scritto di Fortini, Contro la retorica del suicidio: «Dobbiamo esserci tutti», concludeva. Ecco, ho ritrovato i sonnambuli. «I nostri sonnambuli» sono nello stesso libro, uno dei miei preferiti: Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984.
Lo sfoglio, ormai sveglio, e subito ritrovo parole di cui conservavo un’impronta sbiadita: «Parlo di sonnambulismo ma non è una metafora». Ricordo, prendo a rileggere la conclusione dell’articolo, che si intitola Il controllo dell’oblio, già pubblicato il 24 febbraio 1982, sul Corriere della sera, col titolo Perché non vogliamo ricordare?
I limiti oscuri della vita individuale, la storia, la politica: sì, è vero, le ombre si vendicano. Dovrei scrivere un testo di sole citazioni. Lo diceva Brecht? Mi ricordo che c’era un collage di citazioni all’inizio del Libro bianco sulla legge Reale del Centro di iniziativa Luca Rossi… Torno a leggere Il controllo dell’oblio di Fortini: memoria involontaria, surrealismo di massa, sonnambulismo, adolescenze prolungate, espropriazione del «ricordo», colonizzazione, Simone Weil.
«I nostri sonnambuli (questa è la mia conclusione provvisoria) vivono quindi nella dimensione, degradata, dell’ “estetico”».
No, torno indietro: «Come mille volte è stato rappresentato dal teatro comico, finiremo col credere che le cose siano andate in modo diverso dal vero… Sappiamo come si fa a dimenticare e a far dimenticare. Il controllo dell’oblio, ci dice Le Goff, è uno dei più spietati strumenti di potere. Ne sanno qualcosa anche gli odierni cittadini degli Imperi. L’interdetto della memoria – questa affascinante istituzione che varia di età in età e di tirannia in tirannia, fino a noi – non opera mai da solo, ha bisogno di un’altra istituzione sorella, il cui nome risale alla rivoluzione giacobina: l’amalgama. Con il principio dell’amalgama, soprattutto se introdotto o coltivato dalla legislazione, si possono estendere criminalizzazione e ostracismo a strati sempre più vasti. L’importante è che, anche se in minima misura, ognuno sia colpevole o colpevolizzabile; dunque bisognoso di dichiararsi “uomo” di qualcuno, di chiedere una qualsiasi protezione…».
Protezione, amalgama. L’amalgama, oggi, ha molteplici forme. E non sempre consiste, nella nostra piccola società, nella remissione di un debito, in uno stipendio o in una carriera.
Vado a dormire. Domani mi sveglio alle sei e venticinque.
Presto leggerò L’armata dei sonnambuli. Posso aspettare la fine di giugno, ma potrei anche iniziare domani sera, capitoletto dopo capitoletto, scena dopo scena. Non ora, però. Domani devo svegliarmi presto. Ho sonno, riuscirei a leggere solo poche pagine. Questa sera mi dispongo a rileggere, a risvegliare pagine che giacciono in qualche cella della memoria: «Qual è, oggi, la durata media di una lettura continuata?».
Torno a leggere, questa volta fino in fondo, Il controllo dell’oblio.
I nostri sonnambuli vivono nella dimensione, degradata, dell’estetico. Abbiamo bisogno di storia, di ricordo volontario: oggetti, strumenti che passino di mano in mano, che in sé contengano giudizio e scelta, che ci strappino al magma dei paradisi e degli inferni interiori. Costruire dure sequenze di una temporalità non individuale, esigere un patto fra persone e generazioni…
Ho iniziato a leggere atto dopo atto, scena dopo scena, lottando contro tutta la stanchezza sedimentata in questi dieci mesi di lavoro, ma con lento piacere, il romanzo L’armata dei sonnambuli. Se tra un paio di settimane non l’avrò finito, potrò leggere o rileggere con più agio durante le ferie, la mattina o nelle ore più pigre del pomeriggio.
Questa sera ho meno sonno del solito.
Apro un cassetto, una scatola, una busta; leggo e riascolto la voce di un vecchio amico che ora sta troppo lontano: «Per portare all’azione dieci partigiani», conclude la lettera, «occorre che essi siano in grado di separarsi subito dopo l’azione e di ritrovarsi in un luogo stabilito. Durante il periodo in cui tutti sono sciolti, ognuno è solo, potenzialmente fa quel che vuole, non ha nessun obbligo particolare, eppure si ritrova con gli altri il giorno dopo. Un’azione individuale e collettiva di questo genere richiede più energie morali di un esercito regolare».
Così penso a volte di ritrovare gli amici e le amiche, le compagne e i compagni lontani. Non mi accontento dei sentieri della memoria: ho nostalgia del futuro, di una fraternità, di una condivisione che, nella vita, nella lotta quotidiana, consenta di ricordare, capire, sentire, afferrare la materialità delle cose che, con troppa fretta, altri chiamano spirituali.
Per vie più strette e tortuose, più vive di quelle della memoria, ci incontreremo in un luogo più alto e visibile, estraneo e familiare, dove si ascolta la voce di chi non trova le parole, dove a tutti s’insegna e s’impara da tutti, anche dagli sconosciuti, forse già incrociati per strada, vicini ma estranei, presto dimenticati, per lungo tempo e ancora oggi senza nome.

Luca Rastello, I buoni, Chiarelettere 2014, pp. 204, € 14,00
“Sì, ma com’è che la vuoi chiamare, ‘sta campagna?” “Il bene a regola d’arte.”
Là dove ogni ottica classista è stata rimossa, là dove il concetto di lotta di classe è stato abolito, là dove ormai regnano soltanto carità cristiana, legalitarismo e denuncia dell’ingiustizia senza ricorso all’unità e alla rivolta degli oppressi… là può serenamente regnare l’empietà. Nella sua forma peggiore e nell’ipocrisia più assoluta. In questa piaga purulenta Luca Rastello ficca il dito. E lo gira. E fa male.
Lo scandalo per lui è reale e [...]]]>

Luca Rastello, I buoni, Chiarelettere 2014, pp. 204, € 14,00
“Sì, ma com’è che la vuoi chiamare, ‘sta campagna?”
“Il bene a regola d’arte.”
Là dove ogni ottica classista è stata rimossa, là dove il concetto di lotta di classe è stato abolito, là dove ormai regnano soltanto carità cristiana, legalitarismo e denuncia dell’ingiustizia senza ricorso all’unità e alla rivolta degli oppressi… là può serenamente regnare l’empietà. Nella sua forma peggiore e nell’ipocrisia più assoluta.
In questa piaga purulenta Luca Rastello ficca il dito. E lo gira. E fa male.
Lo scandalo per lui è reale e doloroso.
Il peccato e il male esistono.
Il Male assoluto travestito da Bene assoluto.
Lo Spirito che si fa carne. Corrotta.
E come un antico cataro urla la sua denuncia.
E’ un urlo assordante e allo stesso tempo pacato quello di Luca.
La rivolta che sgorga dal cuore di chi non vuole levarsi al di sopra, ma che, umanamente si accolla la sua parte di responsabilità.
Ma rigira il dito nella piaga, Luca.
E fa urlare. I potenti.
Giornalisti dal nome altisonante.
Inquisitori incanutiti e irranciditi nella caccia di colpe là dove, spesso, non ci sono.
Critici che non vogliono la critica dell’esistente.
Uomini che vogliono soltanto i “nomi”.
Che nei fatti narrati sanno riconoscere i nomi, ma non la sostanza.
Perché la sostanza fa paura, soprattutto quando attraverso la letteratura si avvicina alla verità.
Anche quando la verità dovrebbe rimanere inconfessabile.
Oppure rimanere custodita dallo sguardo dei servitori del dis/ordine.
Sempre, “c’è un poliziotto che guarda”.
E’ il refrain del libro.
Luca, però, si tiene, almeno nella parte iniziale e in quella finale del suo romanzo, più vicino a “I misteri di Parigi” di Eugène Sue o a “I miserabili” di Victor Hugo, piuttosto che al “1984” di Orwell. Attualizzandoli e immergendoli nelle fogne vere e nel dolore degli ultimi delle metropoli dell’Est.
D’altra parte non può esistere nemmeno l’anti-utopia, là dove non è più possibile alcun tipo di utopia.
Soprattutto quando questa è sostituita dalla “corresponsabilizzazione”, dall’associazionismo, dalla retorica del “bene” e dalla solidarietà pelosa di chi vuol fare di ogni aiuto soltanto un “progetto”.
Soprattutto in quelle città del “fu” triangolo industriale dell’Italia settentrionale che, insieme agli stabilimenti e all’occupazione, sembrano aver perso qualsiasi speranza e qualsiasi tipo di solidarietà di classe.
Là dove l’elemosina di facciata si accompagna al peggiore localismo e al calcolo più cinico spacciato, però, per rinnovamento politico ed economico. E dove la “lotta alla Mafia” è diventata la parola d’ordine destinata a sostituire quelle ben più pericolose dell’antagonismo di classe.
I raffinati custodi della cultura odierna non vogliono sentire parlare di contratti di lavoro. Non vogliono sentire parlare di lavoro precario.
Il volontariato deve bastare e il terzo settore deve trionfare come modello.
Dalle Coop rosse e cattocomuniste alle associazioni, fino a diventare modello unico per il lavoro a venire attraverso il job act.
Dove anche il lavoro offerto nelle condizioni più miserevoli diventa atto di “carità”.
Il “raffinato” intellettuale e il moralista legnoso si danno la mano nel fare la carità.
Sì, ma poi basta…eh!?
Cosa vogliono di più questi disgraziati raccolti in mezzo alla strada?
Non gli basta vivere all’ombra dei loro datori di lavoro?
Non gli basta respirare la stessa aria che respirano loro?
Non gli basta respirare le parole dei Santi?
Il vero “raffinato”, un raffinato ufficiale, avrebbe detto Céline, nel suo libro più proibito, deve: “ frenetizzare l’insignificante, cicalecciare, darsi delle arie, gracidare nei microfoni delle radio… rivelare i miei «dischi preferiti»… i miei progetti di conferenze…”
Deve evitare la critica dei potenti. Evitare la critica dell’esistente, per poterne cantare le lodi.
Raffinato sì, come lo zucchero.
Privato di ogni asprezza, di ogni sostanza nutritiva.
Destinato soltanto alla bulimia oratoria televisiva .
Produttore di diabete da troppa dolcezza, elargita con troppa facilità.
E guai se trova in qualcuno lo spirito di Alfieri che si rifiutava di respirare anche solo l’aria respirata dai tiranni.
Luca non ha più voluto respirare la stessa aria dei tiranni, anche se profumava di incenso. Anche se per lui deve essere stato doloroso, oltre che necessario, narrare le vicende di Aza, Adrian, Alberto, Mauro, don Silvano, Delfino, Isabella, Delia e del giudice grasso. E di molti altri ancora.
Perché l’elemento autobiografico preme con urgenza nella scrittura di Rastello.
Torna alla mente Dante:” Ma se le mie parole esser dien seme / che frutti infamia al traditor ch’i’rodo, / parlar e lagrimar vedrai insieme”1 .
Anche se il traditore non è soltanto uno e non è il nome famoso che tutti vogliono individuare.
No, il tradimento è di tutta una società, di tutto un ambiente fasullo e perbenista.
Fatto di riviste patinate e di giornali ben informati.
Costruito sul nulla delle buone intenzioni.
Che come sempre lastricano la strada per l’inferno.
“Abbiamo bisogno di rimandare la lotta, Adrian, ma abbiamo bisogno anche di fingere di combattere, e di amare la lotta. Abbiamo bisogno di concedere a noi stessi ancora un brandello di questa vita che in fondo non ci impegna, di tenere un francobollo di orizzonte al fondo delle nostre giornate senza cuore. Ed è don Silvano che ce lo permette: lui garantisce che farà il lavoro al posto nostro. Tutti lo amano, i potenti, i belli, i celebri, e la suora che trema sotto il suo sguardo. Tutti sono orgogliosi di essere suoi amici. Perché lui cavalca con le insegne del bene. […] E’ l’eroe di questo tempo, è la consolazione. Combatte lui la battaglia che noi non abbiamo tempo di combattere: non vincerai mai con lui, e neppure gli toglierai la maschera. Ci sarà una suora a impedirtelo, un politico, un cantante famoso e un ragazzo pieno di ideali. Lui è il polmone artificiale che li fa respirare anche quando l’aria è carica di acido e gas velenoso. […] Noi siamo l’acqua in cui cresce la pianta, amico mio: lo difenderemo fino alla morte, pieni di gratitudine per il velo che mette tra noi e il mondo. Lascialo stare, don Silvano. Lui si nutre del disperato bisogno di conciliazione che nasce dalle nostre vite in cattività. Lui è la forma del mondo com’è.”
“Tu, perché lo servi?” “Perché io sono come loro. Mi credi migliore?” (pag. 191)
Perché gli oppressi sono utili e devono essere visibili soltanto quando sono vittime. Non importa se del lavoro, dell’AIDS o della “Mafia”.
L’importante è che rimangano tali e che si possano compiangere.
Guai a loro però se parlano di diritti sindacali o di rivolta.
Perché, allora, devono essere “accompagnati”, essere messi alla porta.
O in prigione.
La parte più crudele della non fiction novel di Rastello, infatti, non sta né all’inizio, nella miseria e nella vita grama delle fogne, né, tanto meno, alla fine, nelle pagine della vendetta.
Ma sta proprio al centro, in quei rapporti ipocriti di potere e sottomissione, in quell’odore di soldi e di partite di giro truccate, in quella misoginia e in quel sessismo diffusi e troppo spesso accettati come norma dalle donne “in carriera” insieme al fascino esercitato da chi detiene anche solo un frammento di potere, di cui tutto il dolore del mondo non costituisce altro che l’ovvia periferia.
La parte centrale del libro, che ne costituisce anche la parte più lunga, metaforicamente rappresenta la centralità della corruzione morale ed economica nella società del dominio capitalistico dell’esistente e dell’ipocrisia che la nasconde e giustifica.
Il denaro, lo sterco del demonio dei patarini e degli eretici medioevali, ha trionfato . Non solo nella pretesa casa di Dio, questo si sapeva, ma anche in quegli ambienti che avrebbero dovuto rappresentarne il rinnovamento.
Invece del Re ad essere nudo, nel romanzo, è il “bene”.
Il buonismo trionfante e ipocrita.
Soprattutto nella sua variante associazionistica, là dove si dovrebbe lavorare solo per il bene di tutti e disinteressatamente. E dove, a farlo disinteressatamente, dovrebbero essere possibilmente gli ultimi.
Grati, come servi o come schiavi.
Già…chissà quanto si saranno commossi coloro che hanno furiosamente criticato Luca e il suo libro guardando il patinatissimo “12 anni schiavo” !
Tutti uniti nel sentirsi buoni…tutti uniti nel criminalizzare gli altri.
Tutti uniti dal “noi” di chi pensa le cose giuste. Legali. Caritatevoli.
Pietismo contro barbarie estremista…che come si sa deve essere estirpata
Gli basterà poi chiedere scusa se vi prenderanno a calci in mezzo alla strada, come a Roma il 12 aprile, oppure dopo avervi sterminati, come in Argentina o durante un pogrom.
Non preoccupatevi.
Leggete questo libro tutto d’un fiato, com’è capitato al sottoscritto, e poi, se li incontrerete per strada o li sentirete predicare in pubblico o sul piccolo schermo, ridetegli pure in faccia.
Il loro Dies Irae sarà sicuramente peggiore del nostro.
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, Canto XXXIII, vv. 7 – 9 ↩
di As Chianese
 Il reale è quello che vede la maggioranza (Jorge Luis Borges)
Il reale è quello che vede la maggioranza (Jorge Luis Borges)
Il regista Alberto Negrin, nel 1972, girò lo sceneggiato poliziesco Lungo il fiume e sull’acqua cercando di superare alcuni limiti tecnici insiti, eppur tacitamente accettati, nella stessa “confezione classica” della narrazione televisiva del Servizio Pubblico Nazionale. Nessun problema di censura, vulnus politico da (pre)lottizzazione, diktat bulgaro o codice di autoregolamentazione da eludere; si cercava unicamente di frantumare una “forma” ma anche, in maniera criticamente legittima quanto [...]]]>
di As Chianese
 Il reale è quello che vede la maggioranza (Jorge Luis Borges)
Il reale è quello che vede la maggioranza (Jorge Luis Borges)
Il regista Alberto Negrin, nel 1972, girò lo sceneggiato poliziesco Lungo il fiume e sull’acqua cercando di superare alcuni limiti tecnici insiti, eppur tacitamente accettati, nella stessa “confezione classica” della narrazione televisiva del Servizio Pubblico Nazionale. Nessun problema di censura, vulnus politico da (pre)lottizzazione, diktat bulgaro o codice di autoregolamentazione da eludere; si cercava unicamente di frantumare una “forma” ma anche, in maniera criticamente legittima quanto proditoria nella modalità risolutiva poi adottata, un limite puro ma già in odore di spuria giustificazione. Per ottenere certe particolari inquadrature, negli angusti spazi degli studi di registrazione forniti dalla Rai, Negrin chiese ai macchinisti di cooperare con l’arredatore affinché fosse la scenografia – la cartapesta e il compensato – ad adattarsi e “muoversi” a seconda delle esigenze della macchina da presa e non viceversa. È una richiesta assolutamente “cinematografica”, all’epoca quantomeno tacciabile di mera vezzosità autoriale. Un ghiribizzo. Per una televisione italiana che aveva addirittura già adattato Delitto e castigo (1963) e I Buddendrook (1971) facendo propria la volontà di perseguire la nobile utilità sociale di biblia pauperum.
In studio, per quelle che furono anche le raffinate messe in scene di Anton Giulio Majano, tutto invece era già allestito su tre robuste pareti, lasciando uno spazio comodo ma fatalmente distante alle possibili soluzioni di regia da adottare. Così Negrin richiese la costruzione e l’arredamento di una “quarta parete”, piazzando i mezzi tecnici al centro esatto della scena, fin dentro l’azione. Ottenne in questo modo una profondità e un dinamismo mai percepiti prima sul piccolo schermo italiano, optando per l’utilizzo di telecamere imbracate sulle spalle dell’operatore e confidando nell’abile capacità mimetica dei microfonisti.
La coraggiosa rinuncia alla macchina fissa servì, quasi da sola, ad attuare una rivoluzione semi-copernicana della percezione stessa dell’azione in una finzione scenica televisiva di largo consumo; lasciando ad altri l’utilizzo di quelle ingombranti macchine fisse che, per stretta volontà degli ingegneri costruttori, riuscivano a realizzare scarsi movimenti, dai novanta centimetri da terra fino ad un’altezza massima di un metro e settanta. L’escamotage era quindi compiuto, la porta sonoramente spalancata.
La soluzione è, idealmente, la progenitrice tecnica di quelle riprese effettuate oggi su L’isola dei famosi dove, accettando la schizofrenia del reality e della tv che rappresenta e celebra se stessa, va in onda una realtà modificata nella sua “mediatica” percezione, mossa unicamente dallo share. Se, come ha affermato Jean Cocteau, “il cinema è la morte al lavoro”, la televisione italiana degli ultimi quattordici anni potrebbe essere stata una strenua, quanto incompiuta, “prova tecnica di resurrezione”. Sull’Isola non esistono pareti arredate ma grandi scenari naturali, l’habitat stesso è inusuale per la finzione. Ancora telecamere mobili e operatori posti nel centro esatto dell’azione, con concorrenti/interpreti che fingono pedissequamente di ignorare l’apparato tecnico e le maestranze che li circondano ogni giorno. La schizofrenia da indurre allo spettatore non è di quelle da considerarsi blande, giustificabile con la sola e abusata “sospensione dell’incredulità”. La “quarta parete” non è più da annettere, da costruire e arredare, ma è assolutamente la prima da abbattere per provvedere, poi, a eliminare l’intero concetto di teatro di posa o studio di registrazione.
La scenografia è una natura resa ostile e perigliosa solo nella narrazione (si pensi a La fattoria), mentre interpreti ed elementi decorativi del set, nella loro libera intercambiabilità affidata al televoto nazional-popolare, vengono messi sullo stesso e identico piano. L’esagerato seno al silicone, esposto da ogni angolazione dalla concorrente di turno del Grande Fratello, nega di per sé la reale utilità di ogni funzionale scenografia di sorta. La protesi è il significante, la sua assoluta ed essenziale (utilitaria) “plastificazione”.
Arriverà a sostituire anche la trama, il filo logico degli stessi eventi. Se “il medium è il messaggio”, la televisione che rappresenta e giustifica se stessa arriva al punto culminante di esser fruita dai suoi stessi realizzatori e viceversa. Ogni ideale “parete” è stata così abbattuta; telecamere nascoste inquadrano corpi da réclame fingendosi colpevolmente, celatamente, calate in un contesto reale e quindi altamente scabroso. Non c’è il pudore dei b-movie scollacciati di quella che fu la “nuova commedia” nostrana degli anni Ottanta, non si rende necessario neanche il pretesto della doccia o l’infantile gioco del dottore e l’infermiera. La barzelletta da caserma dei militari onanisti. Il “buco della serratura” si nobilita nel formato 16:9 della tv al plasma, rigorosamente comprata a rate e collegata al relativo decoder.
Un recente dossier sulle “nuove forme di dipendenza patologica” ha sottolineato come l’utilizzo di siti Internet pornografici gratuiti, veda oggi un incremento di visioni in streaming e di upload di filmati assolutamente amatoriali, realizzati con cellulari moderni e senza prevedere alcun tipo di intenzione preliminare. Il voyeurismo, premeditato o estemporaneo che esso sia, quindi abbatte la parete della forma, elimina il canone di bellezza, spodesta la drammaturgia e prescinde, diabolicamente, dal concetto stesso di responsabilità (il cyberbullismo). Pensare che questo scenario possa essere scaturito da una lettura in chiave profetica, più che criticamente distopica, del film Videodrome (1983) di David Cronenberg, oggi è quanto mai legittimo.
Quasi utilizzassero il principio del periscopio, le telecamere o gli obbiettivi degli smartphone emergono dalla “finzione” per spiare retroscena di delitti agghiaccianti e a sfondo rigorosamente sessuale, ponendo l’indagine e l’introspezione al grado zero dei codici inquirenti e informativi del reportage. Il fine ultimo potrebbe essere quello dello snuff-movie. Il voyeurismo patologico, applicato ad accadimenti di cronaca nera, come il delitto Scazzi, rischia d’essere inserito nel novero identico delle motivazioni del reality. Ne determina lo schema e la liturgia, facendo del dramma reale una messa in scena dove è il colpevole a essere selezionato per mero decadimento empatico.
Così il piccolo schermo ci costringe all’invito a cena con delitto, a un’interminabile sessione collettiva di Cluedo dove fioccano pruriginose accuse, infamie, più che sensati profili psicologici degli imputati, anamnesi di sorta e ricordi edulcorati delle vittime. Nel caso dell’assassinio di Sara Scazzi l’intrusione della televisione è assimilabile a una sorta di pretestuoso, quanto ovviamente disfunzionale, accanimento terapeutico. È il cugino della vittima a giocare a carte scoperte, fra lauti cachet per ospitate nei salotti pomeridiani e pressanti richieste di partecipazione ad Uomini e Donne. E così che, partendo da un delitto atroce, si arriva infine al sorriso tonto ma rassicurante di Lele Mora, alla narcosi narcisista del danaro cash e dell’esposizione mediatica immediata.
Si giunge così in tv, accantonato e quasi vilipeso il merito, al di là del bene e del male. Gli stessi assassini, d’altronde, a più riprese sono comparsi inizialmente sul Servizio Pubblico per dirsi innocenti e chiedere chiarimenti di sorta, giustizia assoluta al “tribunale catodico” composto da disperati spettatori. È il foro degli ultimi, la corte di ladri e imbroglioni, che giudica il delitto più grande assolvendo il proprio status, legandolo alla necessità del campare e mai al piacere. Come in M – Il mostro di Düsseldorf (1931) di Fritz Lang, s’attende la confessione pietosa, il mostro che si rivela bambino abusato o il ghigno sardonico a reti unificate.
La realtà viene strumentalizzata, posta in modo tale da influenzare coscienze e intimi giudizi; la sua rappresentazione diviene dibattito e crea sterile divisione. Si giunge così alle estreme e irrimediabili conseguenze (il caso di Meredith Kercher), da intendersi fallacemente come fisiologica, processuale, “fine dei giochi”. La “quarta parete” è divenuta indispensabile nel solo e risibile plastico della scena del crimine, esposto durante Porta a Porta come vuoto centro dell’azione. Dove, appena un attimo prima, a ogni suono di campanello gentile, si discuteva simpaticamente di diete per l’estate, situazioni politiche da sbrogliare e suicidi di imprenditori, iniezioni di fiducia e di botox, precariato ed operai disperati.
La (s)drammatizzazione è la pietra filosofale del nostro tempo. Lo share ha vestito i panni vistosi del Re Mida e accettato di buon grado la sua mitica e dorata maledizione. Non è metallo nobile ciò che la dittatura della maggioranza elargisce, né pane per denti sani o panacee assolute.
Negli anni Sessanta e Settanta il ritardo tecnico che accettava di evitare, con difficoltà non imbarazzata, le riprese in esterni era l’inautentica ma possibile discolpa della televisione “da camera”. Quella simile al crepitante “caminetto”, magari col corpo spigoloso in legno, dal riflesso catodico capace di creare familiare aggregazione.
Quelle scene dalla fotografia terribile, accentuate negli sceneggiati da un bianco e nero impietoso, per le quali si ricorreva ad una mini-troupe estranea alle stesse maestranze in studio, erano la summa di un posticcio innegabilmente tangibile. Deposito sul fondo del prodotto. La rappresentazione di un falso possibile ma ben tollerato. La clava di cartapesta brandita minacciosamente dal forzuto Maciste, presente in tanti peplum nostrani.
Eppure questo limite, nel codice genetico dello sceneggiato originale (verrebbe quasi da dire nel format), fungeva già da impianto teatrale della narrazione e permaneva nella recitazione enfatica degli stessi attori, come una necessità travestita da punto assoluto di forza. L’influenza del teatro e, soprattutto, della letteratura richiamavano direttamente alla “cultura alta”. Erano parte attiva di quel capitale intellettuale da investire e non da sperperare, la parete da costruire e giammai da abbattere.
Le lunghe pause riflessive di Gino Cervi nei panni di Maigret, che in realtà servivano all’indimenticato attore per spirare i molti “pizzini” incollati alle pareti con le battute da recitare, travestivano d’arte un chiaro bisogno umano. Mostrare il trucco era il vero peccato, smascherare la truffa necessaria per un intrattenimento non fine a se stesso, quasi didascalico nel suo innocente perpetrarsi.
Il gioco di prestigio per la gioia stupita di ogni invitato alla festa catodica.
Rompere l’incanto non è crimine da poco. Abbatte il desiderio, spingendo allo sconforto del “realismo”, verso lidi mai prima lambiti. Mostra al sospiroso spettatore, dalle ultime fila dei posti seduti, le screpolature sui talloni della ballerina di fila dell’avanspettacolo da strapese. Le calze smagliate, il belletto steso per coprire graffi e imperfezioni. Il resto è perversione. Eppure, novità assoluta, al borghese dalle ultime fila – omarino rigorosamente “ad una dimensione” – quel decadimento svelato ed esibito piace. Diviene forma di abietta, lasciva, soddisfazione. Scoprirla è pruriginoso quanto eccitante, violarla gli è oggi necessario. Riprenderla, conservarla in video, è opera di testimonianza preziosa. È l’archivio digitale, un tempo su Ampex, della condizione umana.
Non è la misura della speranza di Borges, liricamente lenitiva, (l’amabile imperfezione che muove la bellezza naturale). Piuttosto il Mondo nuovo di Huxley, “Comunità, Identità, Stabilità”. Concetti emanati, diktat da attuare. Le ultime righe di George Orwell, quelle rivelatrici e necessarie del 1984 ipotizzato e già passato: “…tutto era a posto, la lotta era finita. Era riuscito a trionfare su se stesso. Ora egli amava il Grande Fratello”.
