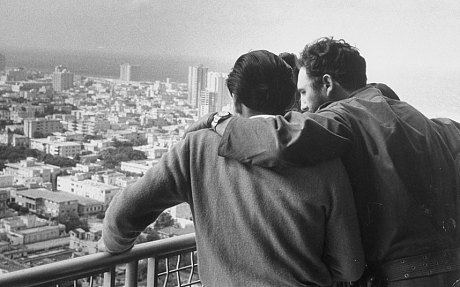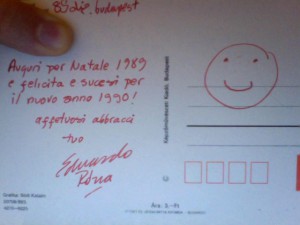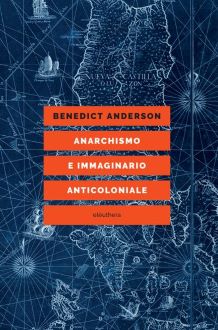 Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro
Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro
Evviva la «zagaglia barbara» («Il Programma Comunista», 24 marzo 1961)
Mentre la centralità dell’ordine occidentale del mondo inizia a venir meno anche in quei settori, come quello ricollegabile allo sviluppo dell’AI, in cui si sentiva più sicuro e mentre la presidenza Trump 2.0 contribuisce a rendere più incerto il sistema delle alleanze che lo hanno garantito negli ultimi ottanta anni, la pubblicazione del testo di Bendict Anderson sulle origini dell’internazionalismo “rivoluzionario” attento ai popoli e alle nazioni estranee al contesto europeo e “biancocentrico” serve [...]]]>
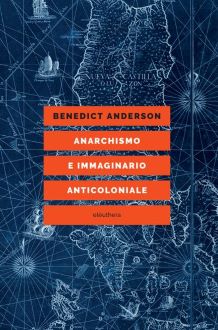 Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro
Benedict Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 446, 24,00 euro
Evviva la «zagaglia barbara» («Il Programma Comunista», 24 marzo 1961)
Mentre la centralità dell’ordine occidentale del mondo inizia a venir meno anche in quei settori, come quello ricollegabile allo sviluppo dell’AI, in cui si sentiva più sicuro e mentre la presidenza Trump 2.0 contribuisce a rendere più incerto il sistema delle alleanze che lo hanno garantito negli ultimi ottanta anni, la pubblicazione del testo di Bendict Anderson sulle origini dell’internazionalismo “rivoluzionario” attento ai popoli e alle nazioni estranee al contesto europeo e “biancocentrico” serve da stimolo per una riflessione che, ancor troppo spesso, appare scontata nelle sue conclusioni.
Infatti, andando ad indagare un periodo in cui il socialismo era rappresentato dalle posizioni della Seconda Internazionale, la ricerca di Anderson rivela un’inaspettata e scarsamente studiata vicinanza tra le posizioni espresse dall’anarchismo e quelle proprie dei primi movimenti nazionalisti nati al di fuori del contesto europeo.
Un contesto in cui la Prima Internazionale o Associazione Internazionale dei lavoratori era nata e si era sviluppata a partire non soltanto dalla solidarietà tra i lavoratori dei vari paesi europei, ma anche da quella nei confronti degli insorti polacchi che proprio in quel periodo si battevano contro la repressione e il dominio zarista sulla loro nazione.
Non a caso un personaggio fortemente simbolico di quella stagione fu Giuseppe Garibaldi, l’”eroe dei due mondi”, guerrigliero e abile condottiero, ma scarsamente dotato dal punto di vista della visione e della capacità critica politica, così come lo ritenevano sia Marx che Engels. I quali, pur potendo essere considerati, insieme a Bakunin e altri esponenti dei movimenti politici dell’epoca come Giuseppe Mazzini, tra i “padri fondatori” di quella esperienza, sorta nel 1864 e destinata a concludersi nel 1876, ma già avviata alla sua fine a partire dall’espulsione di Michail Bakunin e di James Guillaume messa in atto al Congresso dell’Aja sulla base delle decisioni prese alla Conferenza di Londra nel 1871, ne furono contemporaneamente tra i maggiori promotori ed affossatori.
Nel 1889, sei anni dopo la scomparsa di Marx, sarebbe sorta una Seconda Internazionale sulle basi delle idee e delle pratiche socialiste espresse a partire dalla socialdemocrazia tedesca, già fortemente criticate dallo stesso filosofo di Treviri nella sua “critica al programma di Gotha”, scritta nel 1875, ma resa pubblica soltanto nel 1891.
Una seconda internazionale che avrebbe rivolto sempre e soltanto uno sguardo paternalistico, talvolta prossimo al razzismo, alle vicende dei popoli colonizzati e ai loro moti di rivolta. Una posizione che facendo propria, in chiave falsamente classista, il concetto del white man’s burden espresso da Rudyard Kipling in una sua poesia del 1899, spostava sulle spalle del proletariato bianco e occidentale e dei suoi partiti politici il fardello rappresentato dalla necessità di educare i popoli “altri”, ritenuti ancora incapaci di esprimere una propria critica teorica e pratica che, in questo caso davvero, ancora li affardellava.
Una posizione “educazionista” che più che in Marx, sempre attento alla novità rappresentate dalle lotte e dalle esigenze dei popoli posti fuori dai confini tradizionali dell’Europa e spesso schiavizzati per poter sostenere l’ineguale sviluppo economico su cui si era fondata la rivoluzione industriale e la nascita del moderno capitalismo1, aveva tratto spunto dalle considerazioni talvolta liquidatorie con cui il suo sodale Friedrich Engels aveva guardato ai popoli slavi e a tutti quelli che egli riteneva “popoli senza storia”2.
Una posizione che è possibile riscontrare ancora oggi in molte delle posizioni espresse a proposito della lotta del popolo palestinese e che, ammantandosi di classismo di maniera e ultra-sinistrismo, nei fatti nega ciò che invece costituì uno dei punti basilari della politica della Terza Internazionale o Internazionale Comunista: il diritto all’autodeterminazione dei popoli e il tentativo di integrare nella lotta del proletariato internazionale le lotte venutesi a determinare sulla base del primo, senza stravolgerne forme e contenuti specifici (Congresso di Baku – settembre 1920).
Benedict Anderson (1936-2015) è stato uno storico che ha saputo coniugare perfettamente la disciplina che ha insegnato lungamente alla Cornell University, International Studies e Storia dell’Asia orientale, con l’antropologia e ibridare la storia politica con la storia delle idee, cosa che lo ha spinto a studiare come si formi l’immaginario nazionalista e a perlustrarne le complesse vicende. Così, come afferma Stefano Boni nella sua prefazione all’edizione italiana di Anarchismo e immaginario anticoloniale:
Anderson tendeva a osservare i fenomeni non partendo dalle prospettive dominanti, spesso quelle emerse nel Nord Atlantico, ma perlustrando appieno le conseguenze della critica anticoloniale: il posizionamento prospettico a fianco dei colonizzati gli permetteva non solo di denunciare la violenza dell’occupazione europea ma anche di individuare i presupposti epistemologici del colonialismo, per scardinarli. […] La sua sensibilita e le sue conoscenze gli permettevano – e questo è forse il lascito piu importante di Anderson – di mettere in discussione assiomi eurocentrici, come l’origine propulsiva del nazionalismo nel vecchio continente, per dare spazio invece a voci neglette e soppresse3.
L’opera più conosciuta di Anderson è sicuramente Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, pubblicato per la prima volta nel 1983 e ripubblicato in una versione più ampia nel 1991. Comunità immaginate è uscito in italiano nel 1996 ed è un testo che insiste sulla comunità e il suo immaginario come premessa della nascita stessa della nazione e del nazionalismo. Comunità è un termine che, come viene spiegato dall’autore, può anche tradursi nel corso del tempo in nazione, ma, se e quando accade, è per effetto di una serie di passaggi successivi, poiché nella “comunità immaginata” è implicita l’idea che il passaggio da una comunità immaginata a una comunità “istituzionalizzata”, cioè alla nazione, si venga costruendo, nel corso del tempo, con una serie di processi legati all’accelerarsi della comunicazione tra i soggetti appartenenti alla comunità (viaggi, stampa, mercati).
Per l’autore tale processo avvenne prima fuori dall’Europa e non all’interno della stessa come tanta storiografia continua a sostenere. La prima idea di “nazione” fu quella che si formò tra i pionieri creoli delle colonie europee del continente americano: che furono i primi sostenitori di una patria nazionale in conflitto con la madrepatria, con la quale, paradossalmente, condividevano sia la lingua che la religione.
È solo dopo questa prima esperienza che nascono, nei primi decenni dell’Ottocento, i nazionalismi europei, che avrebbero avuto come base le lingue nazionali e che si costruirono con la formazione di una burocrazia di funzionari. Dando vita a una comunità, non più fondata su fattori dinastici, ma sulla borghesia in quanto classe che aveva bisogno per le sue attività produttive di una “nazione”, con territorio e lingua comuni e ben delimitati ai fini dello sviluppo di leggi condivise e mercati “protetti”.
Un modello che tornerà, poi ancora, ad essere riportato nelle colonie attraverso gli stati coloniali, soprattutto in Asia e Africa, per il tramite della formazione e del mantenimento di rigide burocrazie e di una istruzione in grado di dare ai colonizzati una medesima lingua, spesso straniera, che avrebbe poi spinto questi a ritrovare le proprie radici originarie, linguistiche e culturali.
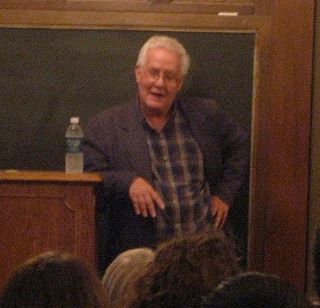 Benedict Anderson era contrario ad una visione eurocentrica della storia e a una tradizione che ignorava l’aspetto emozionale del nazionalismo. Il termine che fa la differenza nella sua opera è, come si è già detto, immaginate, un termine che secondo Anderson evoca emozione, appartenenza e che può far comprendere la mobilitazione per la “patria” cui si aspira. Una scelta spiazzante, che rovescia lo sguardo storico (e geografico!) tradizionale e fa dell’autore un maestro e un anticipatore di tante problematiche odierne.
Benedict Anderson era contrario ad una visione eurocentrica della storia e a una tradizione che ignorava l’aspetto emozionale del nazionalismo. Il termine che fa la differenza nella sua opera è, come si è già detto, immaginate, un termine che secondo Anderson evoca emozione, appartenenza e che può far comprendere la mobilitazione per la “patria” cui si aspira. Una scelta spiazzante, che rovescia lo sguardo storico (e geografico!) tradizionale e fa dell’autore un maestro e un anticipatore di tante problematiche odierne.
Nello specifico del testo ora pubblicato da elèuthera occorre ricordare non solo che l’autore focalizza il suo interesse su quanto avvenne in Indonesia e nelle Filippine a cavallo tra XIX e XX secolo, ma anche sulla funzione che gli ideali anarchici ebbero nello spingere avanti le rivendicazioni politiche anticoloniali, oltre i limiti di un marxismo, di cui si è già detto, incapace di comprendere sia l’aspetto emozionale di tale genere di lotte che il risvolto necessariamente antimperialistico e non eurocentrico delle stesse.
Anarchismo e immaginario anticoloniale riprende una visione decentrata della storia, focalizzata sulla prospettiva dei colonizzati, aggiungendo un nuovo cruciale elemento: gli scambi tra i vari movimenti anticoloniali e tra questi e gli ambienti politici radicali europei. Si tratta di relazioni intellettuali, di sostegno economico e militare, di consigli strategici su come sottrarsi al giogo imperiale per inaugurare una nazione sovrana. Idee e persone circolano; si attivano coordinamenti e circuiti internazionali di mutuo aiuto che collegano lotte distanti in un sodalizio cosmopolita[…] La narrazione conseguentemente si snoda tra Madrid, Parigi e Londra, ma anche tra Cuba e Rio de Janeiro a ovest, e tra Giappone, Hong Kong, Singapore e Manila a est. I filippini guardavano con particolare interesse alle vicende cubane: nel 1895, l’inizio dell’ultima guerra di indipendenza latinoamericana per liberarsi del morente impero spagnolo annuncia infatti la prima insurrezione armata nazionalista in Asia, quella filippina del 18964.
Sulla copertina della prima edizione inglese (2005) del testo erano affiancate tre bandiere: quella delle lotte di indipendenza cubana (bandiera che diventerà quella nazionale), quella del Katipunan (l’organizzazione segreta anticoloniale filippina del 1894) e il vessillo anarchico e, non a caso, il titolo recitava Under Three Flags, Anarchists and the Anticolonial Imagination.
L’attrazione tra nazionalismo e anarchismo, orientamenti accomunati da una tensione per la
libertà sebbene per molti versi antitetici, in particolare per ciò che concerne la riduzione della comunità politica allo Stato, raggiunse il suo apice nel periodo delle lotte anticoloniali. Nonostante Anderson abbia simpatie marxiste, riconosce appieno l’apporto del movimento anarchico che «alla fine del diciannovesimo secolo divenne il principale veicolo per diffondere su scala globale la lotta al capitalismo industriale, all’autocrazia, al latifondismo e all’imperialismo»5.
Mentre le organizzazioni socialiste focalizzavano la loro attenzione sul proletariato industriale delle metropoli, la rete delle organizzazioni anarchiche agì con maggiore eclettismo interagendo con contadini, manovali agricoli, commercianti, artisti e artigiani. Con una flessibilità che rappresentò un indubbio vantaggio inclusivo, soprattutto in aree a bassa industrializzazione, come nelle colonie. Così un «anarchismo ormai globalizzato, grazie anche alle importanti ondate migratorie che fuoriuscivano dal vecchio continente, contribuì a offrire strumenti pratici e teorici alle lotte anticoloniali.»6 Come afferma l’autore nell’introduzione al testo:
Questo libro è un esperimento che prende le mosse in quell’ambito che Melville avrebbe definito «astronomia politica», poiché prova a tracciare una mappa della forza gravitazionale esercitata dall’anarchismo sui movimenti nazionalisti militanti sviluppatisi ai poli opposti del globo.[…] sebbene l’anarchismo avesse spesso attinto al torreggiante edificio del pensiero marxista, in un’epoca in cui l’emersione di un proletariato industriale, inteso in senso stretto, si limitava essenzialmente ai paesi dell’Europa del Nord, il movimento anarchico mirava a coinvolgere anche contadini e lavoratori agricoli. […] Per di piu, ostile quanto il marxismo all’imperialismo, l’anarchismo non nutriva pregiudizi teoretici nei confronti dei «piccoli» e «astorici» nazionalismi, inclusi quelli provenienti dal mondo coloniale. Gli anarchici furono, infine, piu rapidi a cogliere le potenzialità insite negli importanti flussi migratori transoceanici dell’epoca: Malatesta trascorse quattro anni a Buenos Aires, qualcosa di inconcepibile per Marx o Engels che non lasciarono mai l’Europa occidentale, e il Primo Maggio celebra la memoria dei migranti anarchici, e non marxisti, che furono giustiziati negli Stati Uniti nel 18877.
Per certi versi soltanto Lenin avrebbe saputo accogliere nella sua interpretazione del marxismo molti di questi elementi, ma per farlo avrebbe dovuto rompere radicalmente con la tradizione della Seconda internazionale, così come si è già detto all’inizio. Aprendo però una strada che sarebbe stata più significativa per la liberazione dell’Asia dal giogo coloniale che non per la classe operaia occidentale da quello del capitale.
Un libro quello di Anderson da leggere e meditare, ripercorrendo anche con un senso di stupore le vicende collettive e quelle personali di movimenti e personaggi che troppo spesso la tradizione eurocentrica della sinistra ha cancellato, insieme a quelle dei rivoluzionari asiatici che animano le pagine di un altro bel testo sulle rivoluzioni “altre”, Asia ribelle di Tim Harper (qui). Due testi, comunque, indispensabili per orientarsi ancora oggi tra le nebbie e le distorsioni di troppo facili interpretazioni del divenire storico e del ruolo dei rivoluzionari.
Oltre che agli scritti più conosciuti dello stesso Marx sul colonialismo inglese in India e in Cina, si fa qui riferimento a: E. Cinnella, L’altro Marx. Una biografia, Della Porta Editori, Pisa- Cagliari 2014; K. Marx, Quaderni antropologici. Appunti da L.H. Morgan e H.S. Maine, Edizioni Unicopli, Milano 2009: H. Jaffe, Marx e il colonialismo, Edizioni Jaca Book, Milano 1977 e P.P. Poggio, Marx, Engels e la rivoluzione russa, «quaderni di Movimento operaio e socialista» n.1, Genova, luglio 1974. ↩
Si veda: R. Rosdolsky, Friedrich Engels e il problema dei popoli «senza storia». La questione nazionale nella rivoluzione del 1848-49 secondo la visione della «Neue reinische zeitung», graphos edizioni, Genova 2005. ↩
S. Boni, Prefazione a B. Anderson, Anarchismo e immaginario anticoloniale, elèuthera 2024, pp. 7-8. ↩
S. Boni, cit. in B. Anderson, op.cit., p. 11. ↩
Ibidem, p. 12. ↩
ivi, p. 13. ↩
B. Anderson, op.cit., pp. 20-21. ↩
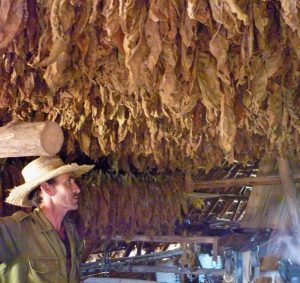 Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma [...]]]>
Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma [...]]]>
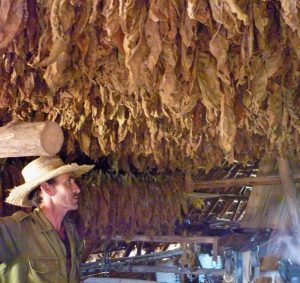 Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma il vento è tiepido.
Valle de Viñales. Giornata faticosa e appagante. Colazione di Nanà: frittata, caffè, latte, pane, succo di goyaba, banana e ananas. Poi pronti via e si parte per la Cueva del Palmerito. Oggi decidiamo di prendercela con calma. Alcuni dicono che la Cueva sia vicina, soltanto un chilometro dal centro, altri dicono che i chilometri siano tre. In entrambi i casi, ci diciamo, fattibilissimo senza troppo sforzo. Alle undici e trenta siamo in cammino, il sole è alto nel cielo, le nuvole rade ma il vento è tiepido.
Sin dai primi metri capiamo che ci stiamo addentrando nella valle: capre, cavalli, maiali, mucche, tori sono i primi nostri incontri. Poi qualche campesinos: il primo alto e magro, con il viso scavato dal sole e le mani ruvide e callose. Con un sorriso ci invita ad entrare nel suo secadero. Ci sembra diverso dalle persone che abbiamo finora incontrato, più povero e disinteressato. La crisi perpetua che a Cuba dura da sempre, dall’indipendenza dalla Spagna, alla dipendenza dagli Stati Uniti fino alla Revolución ha forgiato un popolo dalle risorse e dalla cultura infinita ma anche veri e propri affaristi pronti a venderti qualsiasi cosa. Perché tu sei dollari che camminano. Tu hai ricchezze materiali che molti cubani non hanno mai, nella loro storia, neppure immaginato. Quest’uomo ci ispira davvero fiducia, forse è la campagna dopo la città, forse sono i suoi occhi che sembrano non tradirci. Sicuramente è il suo spalancare le braccia e le porte della sua casa senza chiederci nulla e non facendoci mai dubitare del suo volto rugoso segnato dal sole. Stringiamo le sue mani ruvide e proseguiamo il cammino. Già nostalgici del nostro primo incontro sulla via della Cueva del Palmerito. Ci consoliamo al pensiero di rincontrarlo al ritorno.
Il sole picchia sempre più forte, vari gringos a cavallo ci sorpassano lungo l’arida via terrosa accompagnati da guide locali. Hanno puros in bocca, cappelli da cowboy e zainetti colorati sulle spalle. La nostra meta sembra allontanarsi sempre più e il paesaggio aprirsi per noi. Attraversiamo campi di tabacco, caffè e mandioca. Incontriamo guajiros con secchi pieni di yucca ai quali domandiamo informazioni sulla gustosa radice e riceviamo delucidazioni sui frijoles negros tipici della regione – ma che a lungo andare stancano, parola di campesino – e sui frijoles colorados – indispensabili per variare un po’ la dieta. Un guajiro che sembra avere una trentina di anni ci viene incontro a cavallo, a pochi passi c’è il suo secadero, lo visitiamo. Tre maiali, all’ombra delle migliaia di foglie di tabacco essiccate dormono e respirano piano. Un recipiente rotondo e metallico accoglie i semi di caffè appena tostati. Una campesina robusta, sigaro in bocca e sorriso facile, ci invita a ripassare al ritorno se vogliamo comprare un po’ di caffè. La ragazza ci indica il cammino per la grotta. La cueva sta proprio sotto quella montagna coperta di palme. Non a caso si chiama Cueva del Palmerito. Sembra irraggiungibile. Siamo stanchi e demoralizzati, avanziamo l’ipotesi che in realtà questa cueva che noi immaginiamo come una piscina naturale a pochi passi dal fiume, non sia nulla più che una pozza d’acqua insignificante. Tanto cammino sotto il sole cocente per una pozza d’acqua, ci ripetiamo.
 L’ultima prova prima della vittoria è camminare in bilico su una trave ferrosa larga massimo trenta centimetri. Così facendo possiamo approdare all’altro lato del ruscelletto semi secco che scorre a fatica sotto di noi. I piedi l’uno di fronte all’altro e le mani su un fil di ferro e in un batter d’occhio siamo alla grotta. Un uomo seduto all’ingresso, berretto di paglia e folti baffi, ci saluta. Ha un sorriso profondo solcato da cinquanta o sessant’anni di contrazioni. Senza una guida e una torcia nella grotta non si può entrare perché è molto profonda e non ha aperture. Dopo pochi metri è completamente buia. Procediamo incerti insieme a lui, poi interrompiamo i passi. Ci rassicura, gli occhi devono abituarsi all’oscurità. Non c’è nulla da temere. Solo attenti a non inciampare. Fa una certa impressione addentrarsi nel buio totale e infatti procediamo a tastoni tenendoci per mano. Poi l’uomo dai folti baffi accende la torcia e ne porge una anche a noi. Ricominciamo il passo più sicuri. Dopo duecentocinquanta metri nel cuore della montagna arriviamo a una piscina naturale formatasi grazie alle infiltrazioni dell’acqua piovana nella montagna. Ci assicura che nella pozza non c’è nessun animale e che è totalmente sicuro immergersi e nuotare. Il passo è cauto ma la voglia di entrare nell’acqua è grande. Stiamo attenti a non scivolare. Siamo circondati da stalattiti e stalagmiti, oltre che da gocciolii costanti. L’atmosfera è surreale, rimaniamo a bocca aperta. Ci siamo infilati in un’arteria buia e spigolosa della montagna per duecentocinquanta metri per arrivare a una calmissima piscina naturale scavata dal lavorio e dalle infiltrazioni dell’acqua nella montagna.
L’ultima prova prima della vittoria è camminare in bilico su una trave ferrosa larga massimo trenta centimetri. Così facendo possiamo approdare all’altro lato del ruscelletto semi secco che scorre a fatica sotto di noi. I piedi l’uno di fronte all’altro e le mani su un fil di ferro e in un batter d’occhio siamo alla grotta. Un uomo seduto all’ingresso, berretto di paglia e folti baffi, ci saluta. Ha un sorriso profondo solcato da cinquanta o sessant’anni di contrazioni. Senza una guida e una torcia nella grotta non si può entrare perché è molto profonda e non ha aperture. Dopo pochi metri è completamente buia. Procediamo incerti insieme a lui, poi interrompiamo i passi. Ci rassicura, gli occhi devono abituarsi all’oscurità. Non c’è nulla da temere. Solo attenti a non inciampare. Fa una certa impressione addentrarsi nel buio totale e infatti procediamo a tastoni tenendoci per mano. Poi l’uomo dai folti baffi accende la torcia e ne porge una anche a noi. Ricominciamo il passo più sicuri. Dopo duecentocinquanta metri nel cuore della montagna arriviamo a una piscina naturale formatasi grazie alle infiltrazioni dell’acqua piovana nella montagna. Ci assicura che nella pozza non c’è nessun animale e che è totalmente sicuro immergersi e nuotare. Il passo è cauto ma la voglia di entrare nell’acqua è grande. Stiamo attenti a non scivolare. Siamo circondati da stalattiti e stalagmiti, oltre che da gocciolii costanti. L’atmosfera è surreale, rimaniamo a bocca aperta. Ci siamo infilati in un’arteria buia e spigolosa della montagna per duecentocinquanta metri per arrivare a una calmissima piscina naturale scavata dal lavorio e dalle infiltrazioni dell’acqua nella montagna.
Con una pozza d’acqua illuminata solo dalla luce di una torcia, sotto una montagna coperta di palme, circondata da stalattiti e stalagmiti bisogna prendere un po’ di confidenza. Addomesticarsi. Ci prendiamo il nostro tempo e finalmente ci immergiamo nell’acqua fresca scuotendo il silenzio che ci circonda. Il nostro traghettatore illumina lo specchio d’acqua dolce. È una sensazione incredibile. Sulle nostre teste pendono aghi e protuberanze di roccia. È un bellissimo cielo il nostro. Chi se l’aspettava una cosa del genere? I chilometri sotto il sole cocente sono stati di più del previsto, però ampiamente ripagati.
Ma non è finita. Usciti dall’acqua la nostra guida si prepara a farci vivere un’esperienza mistica. Ci chiede di spegnere la torcia e poi spegne anche la sua, dopodiché non dice una parola e noi facciamo lo stesso. Rimaniamo in silenzio nel buio più assoluto. Non ci sono parole per descrivere il frastuono dell’amplesso tra oscurità e silenzio. Gli occhi si perdono in radicali sinestesie intervallate da flebili gocciolii. Stiamo vivendo qualcosa che non ci era mai capitato prima, straordinario ed extrasensoriale. Sul cammino del ritorno chiediamo al nostro amico con baffi e cappello se possiamo rifarlo con lo stesso tono con cui avremmo chiesto a uno sciamano messicano di ripetere il rito del peyote. Sorride e acconsente. Lo ringraziamo e ci congediamo, dicendogli di lottare affinché questo luogo non diventi facile merce turistica e perda tutta la sua aura magica. Lui è d’accordo con noi, vuole che rimanga così, come quando veniva con suo nonno da bambino a bagnarsi qui. Senza luci artificiali, senza biglietto d’ingresso, senza istituzioni.
Sulla strada del ritorno, rigenerati dalla Cueva del Palmerito, ci fermiamo al secadero della ragazza robusta col sigaro in bocca e l’uomo a cavallo senza maglietta. Compriamo caffè e sigari a un prezzo che riteniamo giusto. La ragazza sembra averci preso in simpatia e in spagnolo ci fa notare che i due gringos a pochi metri da noi – sembrano nordeuropei – sono arrivati fin lì con una guida e una buona dose d’ingenuità: per questo pagheranno cari i loro sigari. Vendono loro tre sigari alla modica cifra di 40 CUC, uno sproposito per i prezzi locali, il prezzo lievita anche in virtù del fatto che una quota del ricavato andrà alla guida. In sostanza stanno inculando i due gringos affianco a noi che però sembrano ugualmente felici. A noi mette quattordici sigari, accuratamente involti in foglia di palma per 10 CUC, offrendocene uno da gustare lungo il cammino.
Il ritorno verso casa è devastante, partiamo sicuri e sollevati con il sigaro fra i denti. Fumiamo tra foglie ancora verdi di tabacco e mogotes ricolmi di vegetazione. È quello che desideravo, godermi le campagne di Viñales con un sigaro in bocca, incontrare guajiros lungo il cammino e farmi raccontare qualche storia. Solo che avevo sottovalutato l’effetto che il sigaro poteva avere su di me sotto questo sole potentissimo. Il risultato è un’insolazione di cui porto i segni sul collo e un mix di mal di testa e mal di pancia che mi fa barcollare e quasi mi offusca la vista. Lungo il cammino ci sediamo qualche minuto per riprenderci, poi rotoliamo verso casa e ci sdraiamo sul letto devastati. Cinque ore sotto il sole, terra rossa sotto i piedi, mogotes tutti intorno e guajiros di tutte le generazioni. Le campagne di Viñales ci stanno piacendo un bel po’, comprese le esperienze mistiche nelle grotte e quelle indotte dalle “botte” di sigaro e sole.
La cena arriva puntualissima alle sette di sera. Nanà ripete le prodezze culinarie del giorno prima arricchendole con yucca bollita e banana fritta, soddisfacendo per metà la mia eterna voglia di patacones costaricensi. Dopo cena l’aria fresca di Viñales ci trascina per il centro per una piacevole passeggiata rigenerativa. Poi torniamo alle nostre ferrose sedie a dondolo, anche questa sera ci mancano i cerini per finire il mozzicone di sigaro iniziato ieri. Domando un fiammifero ai vicini di fronte che con grande gentilezza insistono perché prenda l’intera scatolina, rifiutiamo ma poi cediamo. Sorrisi, ringraziamenti e cenni da una parte all’altra della strada terrosa. I cerini cubani sono strani, il fosforo abbraccia non un rigido pezzetto di legno ma un fascio di filamenti che sezionati e smembrati paiono di semplice carta.
]]> Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.
Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.
Popstars. L’arrivo è scioccante. Non siamo [...]]]>
 Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.
Viñales. Ringraziamo Eloy per l’ospitalità, per le chiacchiere e per le due bottiglie di rum Santiago provenienti direttamente dalla fabbrica. Arrivati all’autostazione compro il Granma e un settimanale. Qui a Cuba non ci sono le edicole, il giornale lo si vende e compra per strada. Il viaggio scorre tranquillo e dopo una breve sosta a Las Terrazas, uno storico villaggio eco-sostenibile, ripartiamo in direzione Viñales. Ci stiamo addentrando nella natura dopo la bellissima esperienza urbana habanense.
Popstars. L’arrivo è scioccante. Non siamo ancora scesi dall’autobus che un’orda di donne sventolanti cartelloni assediano il mezzo. Sono lì solo per noi, l’autobus Via Azul è una cassaforte da scardinare e noi siamo dollari che camminano. Ci sentiamo popstars tra le più commerciali e in effetti siamo merce a tutti gli effetti. Carne da macello, capi che portano ricchezza a chi ha un potere d’acquisto destinato a coprire solo l’indispensabile. Qui si vive di prodotti della terra. I supermercati come li pensiamo noi non esistono, tuttalpiù ci sono piccole botteghe mal fornite. La scelta è ridotta e la spesa non si fa. I prodotti sono sempre gli stessi.
Assalto. Urlano. Alcune sillabano parole in inglese. Prendere lo zaino è un’impresa, ne abbiamo quattro addosso, non ci mollano un secondo. Una signora sulla quarantina ci assilla con insistenza e non accenna a desistere nemmeno dopo un secco rifiuto delle sua offerta. La motivazione principale della nostra diffidenza è l’intolleranza che nutriamo nei confronti di un’invadenza che percepiamo fuori dal normale. Eppure tutto è fin troppo giustificato dai simboli che ci portiamo sulle spalle, stampati sui nostri visi pallidi. Un’altra ci attacca da destra, ora ci contendono. Si lanciano occhiate. Con movimenti rapidi e nervosi sgattaioliamo via dalla folla inferocita e guadagniamo l’aria aperta. Un silenzio allietante invade le nostre orecchie, il tempo di pochi passi. Ci ha visto, ma ci lascia respirare un attimo e poi con calma si avvicina. La guardiamo esausti. È una donna in carne afrodiscendente, porta occhiali a specchio, inizia a parlarci piano, con voce pacata. Ha un altro stile rispetto alle donne che fino a pochi secondi fa tentavano di conquistarci. È più furba. Ci convince a dare un’occhiata a casa sua ma senza impegno. La sua carta vincente è sulla soglia di casa che ci aspetta: una nonnina sdentata ma sorridentissima con la faccia scavata dalle rughe. Capelli bianchi raccolti in una coda, carnagione nera. La contrattazione fa crollare il prezzo della stanza, strappiamo anche la colazione inclusa. A volte ci chiediamo come facciamo a non vergognarci neanche un po’, poi le giustificazioni arrivano a valanghe. Posiamo gli zaini a terra e ci riposiamo sorseggiando il succo d’ananas offerto dalla nonna. Siamo impazienti di scoprire le campagne di Viñales, consigliateci da Cecilia e Alberto.
Puros. C’incamminiamo lungo una strada asfaltata che si snoda tra campi di tabacco e secaderos. L’hotel Jasmin dista due chilometri in salita dal centro di Viñales, lassù dicono si goda di una vista mozzafiato sulla vallata. C’incantiamo osservando una delle immagini più belle della giornata: un signore anziano domina due buoi enormi che arano il suo campo brullo. Non avevo mai visto un aratro a mano, o forse l’avevo visto ma quest’immagine mi colpisce più delle precedenti. Il sole è cocente, la terra scura e il verde degli alberi abbraccia il pezzo di terra del vecchio. Lui porta un cappello di paglia in testa e ha la pelle bruciata dal sole. La seconda immagine degna di appunto è un coltivatore di tabacco con sigaro in bocca, anche lui cappello di paglia sulla testa. Ci viene incontro facendosi largo tra le foglie verdi del suo campo e ci invita a visitare il suo secadero. Qui centinaia di foglie di tabacco aspettano di essere lavorate con il miele per dare vita ai rinomati puros cubani. Il 90% della produzione di tabacco, ci racconta il campesino, si vende allo Stato. Il restante 10% si vende in proprio. Sappiamo benissimo, dal primo istante che ha alzato il cappello per salutarci, che vuole venderci i suoi sigari. Finalmente entriamo nella casetta di legno adibita a secadero e subito veniamo avvolti da un intenso e piacevolissimo odore di tabacco. Centinaia di foglie pendono sulle nostre teste, alcune sono più secche, altre da poco raccolte. Il campesino non esita a offrirci boccate del sigaro che tiene stretto tra i denti: fumiamo con lui il nostro primo sigaro cubano. Purtroppo non vantiamo grandi saperi sul mondo dei sigari, ci guardiamo e concordiamo senza troppa convinzione: molto buono e non eccessivamente forte. Lo comunichiamo al campesino che ci spiega come, incidendo e scartando la nervatura centrale della foglia, si privi il sigaro di quella che lui chiama nicotina, rendendolo meno aspro in gola. Non contento della sua spiegazione orale afferra due foglie di tabacco e ci da una dimostrazione pratica dell’incisione della nervatura e della rollatura di un sigaro. Pensavamo fosse un procedimento più complicato, lui in pochi secondi ne gira uno e ce lo porge, ricordandoci che le foglie che sta usando non sono state ancora trattate col miele e dunque non è ancora possibile fumarlo.
Mogotes. Gli compriamo una ventina di sigari che avvolge con gesti rapidi in foglie di palma. Usciti dal secadero sediamo con la sua famiglia in una delle onnipresenti sedie a dondolo che invadono Viñales. Ogni casa, anche la sua, ne vanta tre o quattro, poste all’ingresso che guardano l’esterno. Intorno a noi galline, cani e pulcini. Un amico del campesino prende un pulcino tra le mani e ce lo porge sorridendo, commentando la rapidità del battito cardiaco. Chiacchieriamo con loro e accarezziamo il cane, visibilmente provato dalla giornata afosa. Provano a venderci anche un tour a cavallo ma rifiutiamo la proposta, li ringraziamo per l’ospitalità e per i sigari e proseguiamo il cammino in salita. La strada è asfaltata e di tanto in tanto sfreccia qualche autobus di turisti. L’asfalto ci dà noia ma tutto quello che si apre ai suoi fianchi non può che spingerci a dimenticarlo. Più saliamo e più la vallata si apre. Arrivati in cima assistiamo allo spettacolo silenzioso della Valle di Viñales, prontamente interrotto dal vociare dei turisti, cappellini bianchi e reflex al collo. Sono appena scesi dall’autobus e un magnetismo degno di Metallo Urlante li attrae in massa verso il piccolo mercatino mangia-gringos al lato dell’hotel. Non contenti di comprare magliette del Che, scatolette di legno e sigari quaranta volte più cari di quelli del campesino che abbiamo incontrato qualche centinaio di metri più a valle i gringos d’assalto pagano per farsi fotografare in sella a una vacca tenuta al lazzo da un guajiro locale. Risate fragorose condiscono la scena anche se le loro eco non rimarranno impresse nella buffona istantanea. Il panorama è incredibile, ci sediamo sotto il sole ad ammirarlo. I mogotes, dominano la verde piana e i loro profili morbidi e tondeggianti proiettano ombre sinuose sui campi colorati. Avevano ragione Cecilia e Alberto, Viñales ha qualcosa di speciale.
A casa ci aspetta la cena di Nanà, la mamma di Mabel, la nonnina che ci ha conquistato al nostro arrivo. Ha fama di essere una cuoca provetta. La tavola, imbandita per noi, presto si colora di tortillas di patate, pomodori e cetrioli freschissimi, congrí – riso e fagioli rossi –, zuppa di verdure, patate dolci, banane, ananas e succo di mango. Le porzioni sono davvero abbondanti, rimaniamo soddisfatti della cena anche se avremmo voluto mangiare in compagnia di Mabel e Nanà. Mabel insiste per preparaci un mojito, accettiamo. Dopo cena ci stravacchiamo sulle immancabili sedie a dondolo di ferro battuto o legno. Queste, poste proprio davanti alla nostra camera, sono dipinte di bianco e arrugginite dal tempo. Siamo distrutti, quasi ci addormentiamo cullati dall’arietta fresca che tira. Davanti a noi scorre la vita quotidiana di una strada secondaria di Viñales: si alternano carretti trainati da cavalli a ragazzine agghindate dirette alla piazzetta centrale. Accendiamo il primo sigaro del nostro viaggio cubano. «Più naturale di questo non ce n’è» ci ha assicurato Ramon, il campesino che ce l’ha venduto. Il gusto è buono e intenso come quello provato nel secadero. Ci rilassa fumare, dondolare e guardare il fumo che esce dalle nostre bocche. Il fumo si confonde con le nuvole che rapidissime sfrecciano davanti a una luna luminosa e incompleta. Il corpo su una sedia e i piedi sull’altra. Intrecciati. Aria fuori, aria dentro. Espira, inspira.
]]>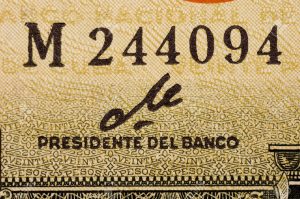 L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana [...]]]>
L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana [...]]]>
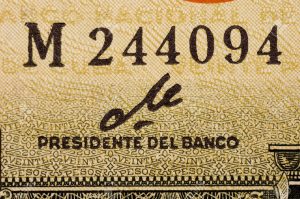 L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana Vieja e ci scarica nei pressi del Capitolio. Lui è quindici anni che lavora come tassista, ci racconta del Che e ci consiglia alcune librerie economiche del centro. Tiene la mano sinistra sul volante e allunga la destra, afferra un quadernetto, me lo poggia sulle gambe e mi ordina di aprirlo. «Guarda un po’ da chi è firmata quella banconota ragazzo?». Tre lettere che sembrano sporgersi sull’orlo di un precipizio. Ci, acca ed e. A formare un semplice intercalare argentino: “che”. Dal 26 novembre del 1959 al 23 febbraio del 1961 il comandante Ernesto Che Guevara in persone assunse la presidenza del Banco Central de Cuba. Immagino quanto lo incomodasse quel ruolo, e quanto quell’informalità della firma lo avvicinasse a un fumettista. Uno che dopotutto, nonostante la Rivoluzione, fosse capace a non prendersi troppo sul serio. Oggi questi dieci pesos che ho in mano grazie a un tassista gentile non hanno nessun valore come moneta corrente ma è roba da collezionisti. Vorrei averli, li bramo, cerco di contrastare il mio malvagio spirito colonial-capitalista trattenendo qualsiasi proposta d’acquisto. E lui non apre bocca, mi guarda negli occhi e la stende in un sorriso. La bocca e la banconota. Poi parliamo del Venezuela e dell’esatta pronuncia di Simón Bolívar. Dove va e dove non va l’accento. Ci scarica davanti a una libreria poco fornita, come la maggioranza delle librerie che abbiamo avuto modo di visitare a La Habana. Sono tentato di comprare l’opera completa di José Marti, cinque tomi a soli due euro. Qui il mio potere d’acquisto è enorme, ma l’idea di camallarmeli sulla schiena per trenta giorni mi fa desistere.
L’Avana. Tassisti. Il primo è un uomo simpatico sulla sessantina che ci porta dal quartiere 10 de Octubre alla stazione degli autobus Via Azul. Durante la mia usuale contrattazione per il prezzo del passaggio sbotta: «Coño vamos! Me pagas quanto quieres! Coño vamos!». Ce la caviamo con poco. Il suo rimprovero me l’ha immediatamente reso simpatico. Ci consiglia alcuni luoghi dell’isola da visitare. Compriamo i biglietti per Viñales, partiremo domani alle nove del mattino. Il secondo ci porta dall’autostazione fino ad Habana Vieja e ci scarica nei pressi del Capitolio. Lui è quindici anni che lavora come tassista, ci racconta del Che e ci consiglia alcune librerie economiche del centro. Tiene la mano sinistra sul volante e allunga la destra, afferra un quadernetto, me lo poggia sulle gambe e mi ordina di aprirlo. «Guarda un po’ da chi è firmata quella banconota ragazzo?». Tre lettere che sembrano sporgersi sull’orlo di un precipizio. Ci, acca ed e. A formare un semplice intercalare argentino: “che”. Dal 26 novembre del 1959 al 23 febbraio del 1961 il comandante Ernesto Che Guevara in persone assunse la presidenza del Banco Central de Cuba. Immagino quanto lo incomodasse quel ruolo, e quanto quell’informalità della firma lo avvicinasse a un fumettista. Uno che dopotutto, nonostante la Rivoluzione, fosse capace a non prendersi troppo sul serio. Oggi questi dieci pesos che ho in mano grazie a un tassista gentile non hanno nessun valore come moneta corrente ma è roba da collezionisti. Vorrei averli, li bramo, cerco di contrastare il mio malvagio spirito colonial-capitalista trattenendo qualsiasi proposta d’acquisto. E lui non apre bocca, mi guarda negli occhi e la stende in un sorriso. La bocca e la banconota. Poi parliamo del Venezuela e dell’esatta pronuncia di Simón Bolívar. Dove va e dove non va l’accento. Ci scarica davanti a una libreria poco fornita, come la maggioranza delle librerie che abbiamo avuto modo di visitare a La Habana. Sono tentato di comprare l’opera completa di José Marti, cinque tomi a soli due euro. Qui il mio potere d’acquisto è enorme, ma l’idea di camallarmeli sulla schiena per trenta giorni mi fa desistere.
Cocchi e gas. Improvvisamente la giornata dei tassisti si trasforma nella giornata del cibo e dei grandi acquisti. A un baracchino compro in pesos una pizza piena di formaggio, un pan con tortilla e un succo fresco di tamarindo. Passeggiamo per Habana Vieja e ritorniamo in Plaza del Cristo, al nostro bar preferito: El Chanchullero. La mia compagna di viaggio vorrebbe il piatto coi calamari ma purtroppo è mancato il gas in tutto il quartiere. Ci consoliamo con uno dei succhi di mango più buoni che abbia mai assaggiato e ritorniamo al baracchino di fiducia della pizza. Niente, anche qui manca il gas. Qualche passo più a est e finalmente, insieme al ritorno del gas, troviamo il nostro pranzo in Calle do Obispo. Lei un riso fritto discutibile e io – alla faccia del gas – mi strafogo con uno squisito gelato al cocco. Ordiniamo altri due cocchi. Estasi dei sensi. Li mangiamo in piedi per la strada vicino a un carretto ricolmo di arance.
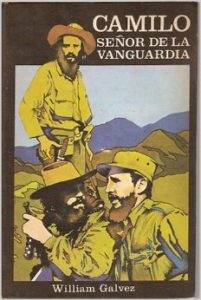 Acquisti. In Plaza de las Armas, dopo aver contrattato con ogni commerciante e averla tediata con la mia eterna indecisione mi decido finalmente a comprare la biografia di Camilo Cienfuegos, el senor de la vanguardia. In un’altra bancarella acquisto un opuscoletto fotografico sempre su Camilo e la pubblicazione che fin dal primo giorno mi aveva impressionato e avevo desiderato: l’album di figurine con la cronistoria illustrata del periodo della Revolución che va dal 1952 al triunfo. Sono molto rammaricato di non ritrovare la signora con la quale avevo fatto amicizia il primo giorno, mi avrebbe fatto piacere omaggiare la mia prima amica cubana, così gentile e premurosa nei miei confronti. Ma così è. La vita è ingiusta. Prima dei grandi colpi editoriali le regalo un paio di bei sandali in pelle e acquisto un porta sigari per un caro amico. Facile fare gli splendidi.
Acquisti. In Plaza de las Armas, dopo aver contrattato con ogni commerciante e averla tediata con la mia eterna indecisione mi decido finalmente a comprare la biografia di Camilo Cienfuegos, el senor de la vanguardia. In un’altra bancarella acquisto un opuscoletto fotografico sempre su Camilo e la pubblicazione che fin dal primo giorno mi aveva impressionato e avevo desiderato: l’album di figurine con la cronistoria illustrata del periodo della Revolución che va dal 1952 al triunfo. Sono molto rammaricato di non ritrovare la signora con la quale avevo fatto amicizia il primo giorno, mi avrebbe fatto piacere omaggiare la mia prima amica cubana, così gentile e premurosa nei miei confronti. Ma così è. La vita è ingiusta. Prima dei grandi colpi editoriali le regalo un paio di bei sandali in pelle e acquisto un porta sigari per un caro amico. Facile fare gli splendidi.
La moneta con la stella. La gentilezza di un signore che lavora come portinaio del Museo di Scienze Naturali ci svela i segreti dei telefoni pubblici cubani. Questi infatti funzionano sì con un peso cubano, ma solo con quelle monete da un peso che hanno raffigurata la stella, con le altre no. Proviamo a contattare lo storico Froilan Gonzalez e dopo alcuni tentativi ci risponde il figlio Levian. Ci informa che il padre attualmente si trova in Messico ma ci invita ugualmente a passare da casa sua in serata. Ceniamo a El Chanchullero, questa volta c’è il gas e ci sono anche i gamberi. Io mi do inspiegabilmente all’alcool, sopravvalutando il mio stomaco vuoto. Comincio con un Catarro – visto il nome non potevo non provarlo –, proseguo con un Daiquiri – il cocktail preferito da Heminguey, vuoi non provarlo? –, e chiudo in bellezza con una Piña Colada magnifica e irrinunciabile. Risultato: io sono sbronzo e lei prova a convincermi ad asciugare con un pezzo di pane che rifiuto categoricamente di comprare.
La Cabaña. Altro giro, altro taxi. Destinazione La Cabaña, il luogo dove Guevara installò la sua Comandancia e dove all’indomani del 1° gennaio 1959 vennero giudicati e condannati a morte molti batistiani. Ogni sera nella fortezza ha luogo la cerimonia del Cañonazo. Un rito dal forte richiamo turistico che mette in scena la parata che precedeva il colpo di cannone che dava l’ordine di chiudere le porte della città di La Habana. La tradizione vigente nel diciannovesimo secolo prevedeva l’esplosione di una cannonata alle nove di sera in punto ed era stata introdotta dai colonizzatori spagnoli. La fortezza de La Cabaña è stata considerata per secoli una delle più inespugnabili di tutte le Americhe e ha tenuto fede alla sua fama: nessuno ha mai provato neppure ad attaccarla. Ora le mura della città non esistono più e la cerimonia, infarcita di un forzato folklorismo, sembra avere meno valore storico e più valenza spenna-gringos! Ce lo meritiamo. Sapevamo che non saremmo dovuti venire. Ci consoliamo con la vista su La Habana di notte e il venticello caldo che soffia dalla baia, il prezzo del biglietto è ripagato.
 Guevara ci osserva. Siamo in ritardo all’appuntamento con Levian, saltiamo ancora una volta su un taxi per raggiungere casa Gonzalez. Insieme a Levian ci accolgono una montagna di ritratti del Che. Roberto mi aveva preparato dicendomi che la loro era una casa-museo interamente dedicata al rivoluzionario argentino, ed è effettivamente così. Addirittura Levian ci mostra un sacchetto pieno di terra, terra boliviana, del luogo dove sono stati ritrovati i resti del Che. Dopo una piacevole conversazione con Levian ci fermiamo ad ammirare le opere dedicate a Guevara, ce n’è per tutti i gusti: di classiche, di ingessate, di pop, di astratte. Poi Levian ci propone di vedere due corto-documentari girati da lui: il primo sui passaggi a Roma del Che e il secondo su Camilo, con una sua interessante testimonianza radio. Ci spaparanziamo sulle sedie a dondolo in legno. I due corti a tratti ridondanti non scavano troppo in profondità e rimangono un po’ in superfice ma sono testimonianze video dell’epoca molto affascinanti che Levian condisce di aneddoti e storie. È una bella visita, Guevara ci osserva da ogni angolazione possibile e immaginabile.
Guevara ci osserva. Siamo in ritardo all’appuntamento con Levian, saltiamo ancora una volta su un taxi per raggiungere casa Gonzalez. Insieme a Levian ci accolgono una montagna di ritratti del Che. Roberto mi aveva preparato dicendomi che la loro era una casa-museo interamente dedicata al rivoluzionario argentino, ed è effettivamente così. Addirittura Levian ci mostra un sacchetto pieno di terra, terra boliviana, del luogo dove sono stati ritrovati i resti del Che. Dopo una piacevole conversazione con Levian ci fermiamo ad ammirare le opere dedicate a Guevara, ce n’è per tutti i gusti: di classiche, di ingessate, di pop, di astratte. Poi Levian ci propone di vedere due corto-documentari girati da lui: il primo sui passaggi a Roma del Che e il secondo su Camilo, con una sua interessante testimonianza radio. Ci spaparanziamo sulle sedie a dondolo in legno. I due corti a tratti ridondanti non scavano troppo in profondità e rimangono un po’ in superfice ma sono testimonianze video dell’epoca molto affascinanti che Levian condisce di aneddoti e storie. È una bella visita, Guevara ci osserva da ogni angolazione possibile e immaginabile.
Altro giro, altro taxi. Questa volta destinazione casa. I nostri compagni di viaggio sono due ragazzoni a bordo della solita auto anni cinquanta semi-scassata. La musica è al massimo e la guida alquanto sportiva. Ci sembra di essere capitati in uno di quei video musicali caraibici. Arriviamo sani e salvi a destinazione. Domani si parte per le campagne dell’est e le piantagioni di tabacco: Viñales ci aspetta o siamo noi che la inseguiamo.
]]> L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática [...]]]>
L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática [...]]]>
 L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática y Comunicaciones. I loro faccioni dai contorni metallici non sorridono e se per Guevara possiamo pure in parte accettarlo, per Camilo no. L’imponente monumento dedicato al padre della patria José Marti si erge altissimo davanti ai due comandanti. Ai suoi piedi un museo a lui dedicato e su lato occidentale della piazza la biblioteca che porta il suo nome. Grazie a un ascensore raggiungiamo la cima del monumento e scopriamo L’Avana da una prospettiva nuova. Le facce di Guevara e Cienfuegos si sono rimpicciolite, e da quassù ora è la piazza a dominarle. Riconosciamo l’inconfondibile architteturra dell’Hotel Nacional e col dito tracciamo nell’aria il profilo del Malecon. Ci ritornano in mente il tramonto di ieri e i pescatori. Il sole batte forte. La piazza è grigia. Il mare azzurrissimo. L’Avana dall’alto è un’esplosione di contrasti che si tuffano nell’oceano.
L’Avana. Plaza de la Revolución. Eloy ci serve la colazione: latte, caffè, goiaba, uovo con pancetta. Poi ci dà qualche consiglio per visitare il quartiere Vedado. Alla modica cifra di dieci pesos moneda nacional, ovvero meno di quaranta centesimi di euro, arriviamo fino a Plaza de la Revolución in taxi. Qui osserviamo le solenni effigi di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos che dominano la piazza, l’una sulla parete del Ministerio del Interior e l’altra sulla facciata del Ministerio de Informática y Comunicaciones. I loro faccioni dai contorni metallici non sorridono e se per Guevara possiamo pure in parte accettarlo, per Camilo no. L’imponente monumento dedicato al padre della patria José Marti si erge altissimo davanti ai due comandanti. Ai suoi piedi un museo a lui dedicato e su lato occidentale della piazza la biblioteca che porta il suo nome. Grazie a un ascensore raggiungiamo la cima del monumento e scopriamo L’Avana da una prospettiva nuova. Le facce di Guevara e Cienfuegos si sono rimpicciolite, e da quassù ora è la piazza a dominarle. Riconosciamo l’inconfondibile architteturra dell’Hotel Nacional e col dito tracciamo nell’aria il profilo del Malecon. Ci ritornano in mente il tramonto di ieri e i pescatori. Il sole batte forte. La piazza è grigia. Il mare azzurrissimo. L’Avana dall’alto è un’esplosione di contrasti che si tuffano nell’oceano.
 Università. Da Plaza de la Revolución ci spostiamo verso l’università, una delle più antiche delle Americhe. Ci arriviamo da una prospettiva inaspettata, dall’alto e di lato, non da sotto risalendo la grande scalinata. Rimaniamo piacevolmente colpiti dalla sua vivacità. Nell’edificio della facoltà di filosofia c’è un ritratto coloratissimo di Simón Bolívar donato a Cuba dal presidente venezuelano Hugo Chavez, stroncato pochi giorni fa da un tumore. Nella stanza d’ingresso sono appesi i ritratti di Fidel, Raul, Camilo ed Ernesto. Ci stupiamo, è molto raro incontrare fotografie del Lider Maximo. Chiedo a un bidello se conosce lo scrittore Daniel Chavarría e se ci sono possibilità di incontrarlo per di là. L’uomo mi guarda perplesso, si dispiace, sembra non conoscerlo. Scendiamo l’imponente scalinata dell’università e ci dirigiamo verso l’Hotel Habana Libre, ex Hotel Hilton espropriato dai guerriglieri all’indomani del 1° gennaio 1959 e diventato il quartier generale dei ribelli e di Fidel. Era stato inaugurato appena nove mesi prima della Rivoluzione. Riusciamo a entrarci, non sappiamo neanche noi bene come, prendiamo un ascensore e arriviamo all’ultimo piano. Nessuno ci ferma. E ora non so più se quello che sto raccontando è accaduto davvero. E non lo sa neppure la persona che ho accanto. C’è una stanza aperta, sembra una suite, la porta socchiusa. Sbrirciamo, esitiamo, poi entriamo. E lì li vedo seduti sui divani, sarà il 6 o 7 gennaio del 1959, ci sono i comandanti, c’è Fidel, c’è Celia. Fumano. Ridono. Ma sono risate tese. La vittoria eccita, l’impazienza regna, la paura. Sento la paura. Mi avvicino al vetro, siamo altissimi. Come possiamo restare quassù?
Università. Da Plaza de la Revolución ci spostiamo verso l’università, una delle più antiche delle Americhe. Ci arriviamo da una prospettiva inaspettata, dall’alto e di lato, non da sotto risalendo la grande scalinata. Rimaniamo piacevolmente colpiti dalla sua vivacità. Nell’edificio della facoltà di filosofia c’è un ritratto coloratissimo di Simón Bolívar donato a Cuba dal presidente venezuelano Hugo Chavez, stroncato pochi giorni fa da un tumore. Nella stanza d’ingresso sono appesi i ritratti di Fidel, Raul, Camilo ed Ernesto. Ci stupiamo, è molto raro incontrare fotografie del Lider Maximo. Chiedo a un bidello se conosce lo scrittore Daniel Chavarría e se ci sono possibilità di incontrarlo per di là. L’uomo mi guarda perplesso, si dispiace, sembra non conoscerlo. Scendiamo l’imponente scalinata dell’università e ci dirigiamo verso l’Hotel Habana Libre, ex Hotel Hilton espropriato dai guerriglieri all’indomani del 1° gennaio 1959 e diventato il quartier generale dei ribelli e di Fidel. Era stato inaugurato appena nove mesi prima della Rivoluzione. Riusciamo a entrarci, non sappiamo neanche noi bene come, prendiamo un ascensore e arriviamo all’ultimo piano. Nessuno ci ferma. E ora non so più se quello che sto raccontando è accaduto davvero. E non lo sa neppure la persona che ho accanto. C’è una stanza aperta, sembra una suite, la porta socchiusa. Sbrirciamo, esitiamo, poi entriamo. E lì li vedo seduti sui divani, sarà il 6 o 7 gennaio del 1959, ci sono i comandanti, c’è Fidel, c’è Celia. Fumano. Ridono. Ma sono risate tese. La vittoria eccita, l’impazienza regna, la paura. Sento la paura. Mi avvicino al vetro, siamo altissimi. Come possiamo restare quassù?
 L’incontro con il figlio di Raul. Passeggiamo per il quartiere del Vedado, compriamo il quotidiano Granma da un signore che grida per la strada e saltiamo su un taxi colectivo per raggiungere Camilo. Ci aspetta all’incrocio tra Avenida 10 de Octubre e Calle Dolores. Insieme compriamo gli ingredienti essenziali per l’aperitivo: rum, cola e patatine. Affacciandomi dall’entrata sopraelevata del negozio, alla vista del parcheggio adiacente, gli occhi mi si colorano. Una decina di auto d’epoca color pastello sono ordinate una accanto all’altra a spine di pesce. Dentro quale film hollywoodiano mi trovo? Camilo ci tiene a farci conoscere la sua famiglia. Incontriamo sua moglie, le sue due figlie e il caro amico Socrates. Socrates è molto simpatico. Ci racconta di sua moglie, dice che lavora come infermiera ma nella vita privata è una vera e propria poliziotta, perché lo controlla sempre. Ha la battuta sempre pronta e una risata grassa e calorosa. Camilo ci racconta un po’ delle sue esperienze in Italia, della sua scuola di arti marziali por la izquierda (in nero), dei suoi incontri illegali di pugilato per farsi qualche soldo e soprattutto del suo ormai ex lavoro per lo Stato cubano. Faceva parte di un dipartimento speciale, ancora attivo, che aveva l’obiettivo di portare capitali stranieri a Cuba. Camilo lavorava quindi legalmente in Italia e in Svizzera ma convinceva i suoi pazienti a recarsi a Cuba per continuare a farsi curare da lui por la izquierda. Buona parte di quello che guadagnava in Italia e in Svizzera andava allo stato cubano. Prima di questo impiego lavorava per la sicurezza del corpo diplomatico all’estero e ha operato in Angola, Congo ed Etiopia. È un invasato di arti marziali e difesa personale. Racconta che una volta ha litigato con il figlio di Raul, e per risolvere i dissidi hanno deciso di sfidarsi in un incontro di boxe. E lui lo ha battuto. Il suo obiettivo nella vita, lo dice con orgoglio, è allenarsi, per essere sempre pronto a difendere la sua famiglia e la sua casa.
L’incontro con il figlio di Raul. Passeggiamo per il quartiere del Vedado, compriamo il quotidiano Granma da un signore che grida per la strada e saltiamo su un taxi colectivo per raggiungere Camilo. Ci aspetta all’incrocio tra Avenida 10 de Octubre e Calle Dolores. Insieme compriamo gli ingredienti essenziali per l’aperitivo: rum, cola e patatine. Affacciandomi dall’entrata sopraelevata del negozio, alla vista del parcheggio adiacente, gli occhi mi si colorano. Una decina di auto d’epoca color pastello sono ordinate una accanto all’altra a spine di pesce. Dentro quale film hollywoodiano mi trovo? Camilo ci tiene a farci conoscere la sua famiglia. Incontriamo sua moglie, le sue due figlie e il caro amico Socrates. Socrates è molto simpatico. Ci racconta di sua moglie, dice che lavora come infermiera ma nella vita privata è una vera e propria poliziotta, perché lo controlla sempre. Ha la battuta sempre pronta e una risata grassa e calorosa. Camilo ci racconta un po’ delle sue esperienze in Italia, della sua scuola di arti marziali por la izquierda (in nero), dei suoi incontri illegali di pugilato per farsi qualche soldo e soprattutto del suo ormai ex lavoro per lo Stato cubano. Faceva parte di un dipartimento speciale, ancora attivo, che aveva l’obiettivo di portare capitali stranieri a Cuba. Camilo lavorava quindi legalmente in Italia e in Svizzera ma convinceva i suoi pazienti a recarsi a Cuba per continuare a farsi curare da lui por la izquierda. Buona parte di quello che guadagnava in Italia e in Svizzera andava allo stato cubano. Prima di questo impiego lavorava per la sicurezza del corpo diplomatico all’estero e ha operato in Angola, Congo ed Etiopia. È un invasato di arti marziali e difesa personale. Racconta che una volta ha litigato con il figlio di Raul, e per risolvere i dissidi hanno deciso di sfidarsi in un incontro di boxe. E lui lo ha battuto. Il suo obiettivo nella vita, lo dice con orgoglio, è allenarsi, per essere sempre pronto a difendere la sua famiglia e la sua casa.
Omosessualità. La figlia di Raul Castro ha preso posizione in favore dei diritti degli omosessuali. Camilo e Socrates riconoscono con una certa umiltà di essere indietro su questi argomenti ma non accettano comunque la sua posizione. «Non è possibile che un gay valga più di un uomo che ha servito lo Stato e ha rischiato la sua vita per lo Stato, e per cosa poi..» sbotta Camilo. Sembrano ricorrere le lamentele di chi ha lavorato per il regime e non vede riconosciuto il proprio servizio dato allo Stato. Oggi Camilo ha deciso di evitare che la sua strada s’incroci con quella del regime. La sua vita, afferma, non è migliorata servendo lo Stato e quelli che non hanno mai fatto niente gli sono passati davanti. Lo dice alludendo agli omosessuali. Afferma di essere fortunato perché sua sorella è fuori, lavora in Spagna, a Murcia, e gli invia spesso dei soldi per mantenere al meglio le sue due bambine. La immagini di Fresa y Chocolate scorrono sotto le sue parole. È solo il terzo giorno che siamo sull’isola e già c’imbattiamo in una interessante conversazione sull’omosessualità con due cubani. Anche Socrates, come Eloy, ha studiato in URSS. Lui è stato cinque anni a Odessa in Ucraina, ha lavorato come ingegnere idroqualcosa e dice che il freddo e la neve gli sono piaciuti molto. La moglie di Camilo è in cucina, ci prepara delle patatine fritte buonissime. Le due bambine corrono a portarcele, scambiano qualche battuta con noi forestieri, e ritornano velocemente in casa. Siamo seduti in giardino, solo noi quattro, di giorno questo quadrato di cemento contornato dal verde si trasforma in palestra, qui Camilo allena se stesso e i suoi allievi a essere sempre pronti a difendersi dai nemici. Guardo la moglie e le figlie di Ernesto, ci conosciamo troppo bene, basta un lieve movimento degli occhi per leggerci i pensieri. Noi siamo spaparanzati a bere e chiacchierare di politica, Europa e omosessualità. Loro sono in cucina. Non si siederanno mai con noi, come nelle migliori famiglie italiane.
L’alcool scende e il rum sale. Il telefono di Socrates squilla e ho il piacere di parlare al telefono con la poliziotta, sua moglie, assicurandogli che il marito entro pochi minuti rientrerà a casa. Grasse risate. Salutiamo Socrates e lui appena arrivato a casa ci richiama. Abbiamo passato una bella serata ma non è finita qui. Ora dobbiamo conoscere la vera casa di Camilo, quella della madre. Saltiamo in macchina. Sulla soglia della porta ci accolgono sorrisi e calorosi abbracci di una donnona nera che non perde tempo ad offrirci un refresco all’arancia. Poi Camilo inizia il suo show e si mette a fare il mago. Non ha grandi doti e lo smascheriamo immediatamente. Nonostante il rum salga ai piani alti della testa ho ancora le forze di controbattere all’egocentrismo di Camilo con le stesse futili armi. I miei cavalli di battaglia sono il trucco di carte più stupido della terra e quello della moneta che entra nel gomito. La mamma di Camilo è felice, ci abbraccia, ci tocca e ride di gusto. Mentre ce ne stiamo per andare, in ingresso, ci accorgiamo dell’altare dedicato a Yemayà, la dea del mare e di tutti gli dei. Vorremmo stare tutta la notte a ridere nel bianco degli occhi di questa donna grassa e nera, ascoltare i suoi racconti sulla Santeria cubana, ma Camilo deve riportarci da Eloy. E proprio mentre apriamo la porta, un forte acquazzone tropicale ci sorprende.
]]>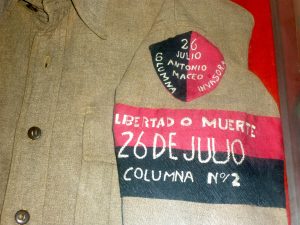 L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico [...]]]>
L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico [...]]]>
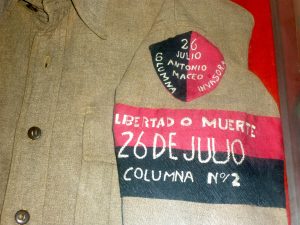 L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico Palacio Presidencial. Ripercorre la storia di Cuba e de la Revolución dal 1953 ai giorni nostri attraverso una quantità innumerevole di foto affascinanti e vari cimeli, tra i quali spiccano le divise con le toppe cucite del 26 de Julio, storici articoli di giornale e documenti originali scritti di pugno da Fidel, dal Che, da Camilo Cienfuegos, da Frank Pais e da molti altri. Fu Celia Sanchez che raccolse i primi materiali che diedero vita al museo. L’area all’aperto ospita il carro armato utilizzato da Fidel durante l’offensiva controrivoluzionaria della Baia dei Porci e il celebre Granma, lo yatch con il quale 78 esuli cubani, accompagnati da un illustre argentino, un italiano (Gino Donè Paro) , un domenicano e un messicano sbarcarono sulle coste della Provincia d’oriente e diedero fuoco alle polveri della Rivoluzione. Altri reperti bellici circondano il Granma: un cingolato con disegnata una stella rossonera con la scritta “26 Julio” in bianco e un aereo pilotato da un militare statunitense durante l’invasione della Baia dei Porci (1961). Nella didascalia esplicativa leggiamo che il governo degli Stati Uniti per ben 19 anni non ha richiesto il corpo del militare caduto per non ammettere la propria implicazione nel tentativo di colpo di stato contro Cuba.
L’Avana. Museo de la Revolución. Svegliati da un’acquazzone tropicale facciamo colazione con uova, latte, caffè e toast. Eloy ha un vassoio in mano, un buongiorno tra i denti e un sorriso stampato poco sopra. Piove a dirotto, è il giorno giusto per visitare il Museo de la Revolución. Un amico di Eloy che fa il tassista ci accompagna fino in centro. Si chiama Juanito e ci fidiamo subito di lui e dei suoi consigli. Il museo è tradizionale e celebrativo e ha sede nell’antico Palacio Presidencial. Ripercorre la storia di Cuba e de la Revolución dal 1953 ai giorni nostri attraverso una quantità innumerevole di foto affascinanti e vari cimeli, tra i quali spiccano le divise con le toppe cucite del 26 de Julio, storici articoli di giornale e documenti originali scritti di pugno da Fidel, dal Che, da Camilo Cienfuegos, da Frank Pais e da molti altri. Fu Celia Sanchez che raccolse i primi materiali che diedero vita al museo. L’area all’aperto ospita il carro armato utilizzato da Fidel durante l’offensiva controrivoluzionaria della Baia dei Porci e il celebre Granma, lo yatch con il quale 78 esuli cubani, accompagnati da un illustre argentino, un italiano (Gino Donè Paro) , un domenicano e un messicano sbarcarono sulle coste della Provincia d’oriente e diedero fuoco alle polveri della Rivoluzione. Altri reperti bellici circondano il Granma: un cingolato con disegnata una stella rossonera con la scritta “26 Julio” in bianco e un aereo pilotato da un militare statunitense durante l’invasione della Baia dei Porci (1961). Nella didascalia esplicativa leggiamo che il governo degli Stati Uniti per ben 19 anni non ha richiesto il corpo del militare caduto per non ammettere la propria implicazione nel tentativo di colpo di stato contro Cuba.
 Gelato. Finita la visita camminiamo verso l’università e ci dirigiamo senza esitazione a Copelia, la gelateria più popolare di L’Avana. Prima di partire per Cuba ci siamo visti Fresa y Chocolate, il bel film di Tomás Guitiérrez Alea, nel quale i due protagonisti, in una celebre scena, mangiano il gelato seduti nel patio della gelateria. Per arrivarci penetriamo nel cuore di L’Avana percorrendo il Centro: davanti a noi si aprono scenari di guerra, case sventrate e strade divelte, ma anche colori e musica di tamburi dalle finestre. Le strade sono piene di gente. L’Avana va scoperta a passo lento, ogni angolo sembra parlarti e obbligarti a riflettere. Non smettiamo di stupirci per le automobili “d’epoca” che sfrecciano per le vie polverose, comete tossiche che si si lasciano alle spalle una scia di tuoni e nuvole nere. I polmoni tremano al rombo dei motori. Copelia è un posto magnifico e incredibilmente accogliente. La fila è lunghissima, ci sorprendiamo quando ci accorgiamo di essere gli unici stranieri e ce ne rallegriamo. Il gelato costa all’incirca 20 centesimi di euro al piatto. Un piatto di gelato è composto da quattro palle di gelato. Non c’è cubano che ne prenda uno soltanto, minimo due a testa. I tavoli sono coperti di piatti e contenitori di plastica. Noi facciamo lo stesso: ne prendiamo rispettivamente tre e due. Non riusciamo a capire l’utilità dei contenitori di plastica ma poi osserviamo e comprendiamo. I cubani si portano da casa i contenitori, poi ordinano cinque o sei piatti a persona, che moltiplicato per quattro palle di gelato, fa tra le 20/25 palle, si mangiano due o tre patti e i restanti li rovesciano nei contenitori, se li portano a casa e li conservano per i giorni successivi. Insomma come fosse gelato d’asporto. Da Copelia il gelato è “statale” e molto economico. Come ci spiegherà Eloy la sera l’80% dei gelati in circolazione sono vendibili soltanto in CUC e sono quindi molto più cari di quello di Copelia. Il restante 20% invece è venduto in peso cubano (moneda nacional). E di quel 20% Coppelia è di gran lunga il maggior azionista.
Gelato. Finita la visita camminiamo verso l’università e ci dirigiamo senza esitazione a Copelia, la gelateria più popolare di L’Avana. Prima di partire per Cuba ci siamo visti Fresa y Chocolate, il bel film di Tomás Guitiérrez Alea, nel quale i due protagonisti, in una celebre scena, mangiano il gelato seduti nel patio della gelateria. Per arrivarci penetriamo nel cuore di L’Avana percorrendo il Centro: davanti a noi si aprono scenari di guerra, case sventrate e strade divelte, ma anche colori e musica di tamburi dalle finestre. Le strade sono piene di gente. L’Avana va scoperta a passo lento, ogni angolo sembra parlarti e obbligarti a riflettere. Non smettiamo di stupirci per le automobili “d’epoca” che sfrecciano per le vie polverose, comete tossiche che si si lasciano alle spalle una scia di tuoni e nuvole nere. I polmoni tremano al rombo dei motori. Copelia è un posto magnifico e incredibilmente accogliente. La fila è lunghissima, ci sorprendiamo quando ci accorgiamo di essere gli unici stranieri e ce ne rallegriamo. Il gelato costa all’incirca 20 centesimi di euro al piatto. Un piatto di gelato è composto da quattro palle di gelato. Non c’è cubano che ne prenda uno soltanto, minimo due a testa. I tavoli sono coperti di piatti e contenitori di plastica. Noi facciamo lo stesso: ne prendiamo rispettivamente tre e due. Non riusciamo a capire l’utilità dei contenitori di plastica ma poi osserviamo e comprendiamo. I cubani si portano da casa i contenitori, poi ordinano cinque o sei piatti a persona, che moltiplicato per quattro palle di gelato, fa tra le 20/25 palle, si mangiano due o tre patti e i restanti li rovesciano nei contenitori, se li portano a casa e li conservano per i giorni successivi. Insomma come fosse gelato d’asporto. Da Copelia il gelato è “statale” e molto economico. Come ci spiegherà Eloy la sera l’80% dei gelati in circolazione sono vendibili soltanto in CUC e sono quindi molto più cari di quello di Copelia. Il restante 20% invece è venduto in peso cubano (moneda nacional). E di quel 20% Coppelia è di gran lunga il maggior azionista.
 Gelato sociale. Discutiamo di giustizia sociale, fanno bene a inculare i turisti con la storia dei CUC pensiamo, chi può permettersi di pagare il gelato di più dovrebbe pagarlo di più. Le belle parole rimangono belle parole, noi la fila l’abbiamo fatta coi cubani e il gelato lo paghiamo in pesos come loro. Solo dopo ci siamo accorti che c’era una corsia preferenziale per gli stranieri, meglio così, se vuoi mangiare il gelato subito, non fai la fila e lo paghi come in Europa. Noi non ci sentiamo turisti, non vogliamo esserlo, nel bene e nel male.
Gelato sociale. Discutiamo di giustizia sociale, fanno bene a inculare i turisti con la storia dei CUC pensiamo, chi può permettersi di pagare il gelato di più dovrebbe pagarlo di più. Le belle parole rimangono belle parole, noi la fila l’abbiamo fatta coi cubani e il gelato lo paghiamo in pesos come loro. Solo dopo ci siamo accorti che c’era una corsia preferenziale per gli stranieri, meglio così, se vuoi mangiare il gelato subito, non fai la fila e lo paghi come in Europa. Noi non ci sentiamo turisti, non vogliamo esserlo, nel bene e nel male.
Tramonto. Sta per tramontare il sole, siamo nel quartiere del Vedado, non lontani dal Malecon, il lungomare di otto chilometri che abbraccia e protegge l’Avana. Lo raggiungiamo. Fra noi e il mare soltanto rocce, la spiaggia non c’è. Sono le sette e mezza, il tramonto è immenso. Ci convinciamo che lo sia davvero. Le tinte arancioni, blu e gialle sembrano non volerne sapere di lasciare il campo al nero della notte. Ma poi accade l’inevitabile e l’oscurità ha la meglio. Dall’altro lato della strada si apre Plaza Tribuna Anti-Imperialista che sfida con la sua toponomastica il palazzo di vetro della Unites States Section, la non-ambasciata degli Stati Uniti in terra cubana, che però, in pratica, ricopre le medesime funzioni di un’ambasciata. Anche a Washington c’è una roba del genere cubana. È presidiata tutta intorno dai militari, disposti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro lungo il perimetro. Voglio vederla da vicino la Us Section e allora senza esitazioni mi butto in mezzo alla strada sfidando il grande stradone a quattro corsie che separa il mare dal palazzo di vetro. I militari cominciano a fischiare con insistenza e mi intimano con ampi gesti di tornare indietro. Mi fermo in mezzo alla strada, tentenno e poi rapidamente ritorno sul lato del mare ancora senza capire. Pensavo di poter attraversare quella strada e camminare sul marciapiede opposto ma non è così. Riprendiamo la passeggiata sul Malecon con un po’ di spavento. Ci chiediamo se abbiamo rischiato la vita. E ci rispondiamo che con ogni probabilità non è successo. Dopo una cinquantina di metri mi siedo sul muretto che dà sul mare nero, ormai fusosi col cielo. Ma il fischietto attraversa inesorabile la strada e ci invita a continuare a camminare e non fermarci.
Rum per ragazze. Torniamo a casa stravolti. Ci accoglie Eloy con un bicchiere di rum. «È un nuovo tipo – dice – un rum dolce, un rum per le ragazze, meno forte». Ci racconta che in Spagna hanno iniziato ad importarlo, che hanno comprato l’intera produzione della ex fabbrica Bacardi che ora si chiama Santiago. Ci racconta che Bacardi era cubano e la fabbrica pure, ma dopo il ’59 si è “trasferito” negli Stati Uniti e il marchio in seguito è stato comprato da statunitensi. Ma la vera fabbrica Bacardi, assicura Eloy, è rimasta a L’Avana.
Sistema politico VS sistema economico. Eloy ha diversi lavori, tra cui uno in questa fabbrica e un altro come installatore di para fulmini. Si è occupato anche di turismo. Deve arrangiarsi e saper fare un po’ tutto, non per sopravvivere, sottolinea, questo è già garantito a chiunque dallo Stato, ma per vivere meglio. Il sistema politico funziona, dice, è quello economico che non va. Con Raul sono cambiate delle cose, Fidel si è incaponito sul politico tralasciando l’economico. Ma di politica non si campa senza un buon sistema economico, ripete. Chiacchieriamo a lungo tra un cicchetto di rum “da ragazze” e un sorriso di Olguita, sua figlia. Ha quattro anni e mi racconta dei suoi amiguitos de la escuela e di come sa fare bene il verso del gatto. Non finisce di dirmelo e già miagola un sorriso furbo.
Acqua. Oggi l’acqua per lavarsi non c’è. Eloy dice che ha piovuto troppo e la gente non è andata a lavorare e per questo non è stata garantita l’acqua. Ma ora, continua, le cose vanno molto meglio, negli anni novanta durante il Periodo Especial l’elettricità era razionata: quattro ore di elettricità e quattro ore no.
Spazi bianchi. Quante cose non sto scrivendo di questa bellissima conversazione. I sigari cubani Cohiba costano un sacco di soldi, il rum ce lo procura lui in fabbrica e i sigari pure se li vogliamo. L’Avana ci piace sempre di più. Proxima estación: Plaza de la Revolucion.
]]> [Le cubane è un diario di viaggio scritto tra il marzo e l’aprile 2013 durante una permanenza di 35 giorni a Cuba in cui ho avuto modo di percorrere da occidente a oriente l’isola. Verrà pubblicato a puntate sulle pagine di Carmilla a partire da questo momento. Buona lettura].
[Le cubane è un diario di viaggio scritto tra il marzo e l’aprile 2013 durante una permanenza di 35 giorni a Cuba in cui ho avuto modo di percorrere da occidente a oriente l’isola. Verrà pubblicato a puntate sulle pagine di Carmilla a partire da questo momento. Buona lettura].
L’Avana. Taxi. Fuori è buio ma sui muri, tra le fronde degli alberi, intravediamo facce barbute e bandiere cubane. Eloy, l’amico del nostro gancio transoceanico Camilo, ci accoglie nell’oscurità della madrugada. Il suo viso è gentile e sorridente [...]]]>
 [Le cubane è un diario di viaggio scritto tra il marzo e l’aprile 2013 durante una permanenza di 35 giorni a Cuba in cui ho avuto modo di percorrere da occidente a oriente l’isola. Verrà pubblicato a puntate sulle pagine di Carmilla a partire da questo momento. Buona lettura].
[Le cubane è un diario di viaggio scritto tra il marzo e l’aprile 2013 durante una permanenza di 35 giorni a Cuba in cui ho avuto modo di percorrere da occidente a oriente l’isola. Verrà pubblicato a puntate sulle pagine di Carmilla a partire da questo momento. Buona lettura].
L’Avana. Taxi. Fuori è buio ma sui muri, tra le fronde degli alberi, intravediamo facce barbute e bandiere cubane. Eloy, l’amico del nostro gancio transoceanico Camilo, ci accoglie nell’oscurità della madrugada. Il suo viso è gentile e sorridente e non mostra i segni di uno svogliato risveglio.
Notte. Il cancelletto bianco, sgualcito dai segni del tempo e dalle cicatrici della ruggine, si chiude alle nostre spalle mentre una casa coloniale bianco e azzurra, illuminata in chiaro scuro dalla luce fioca dei lampioni, si alza di fronte a noi. È una villa spoglia, come scopriremo l’indomani, arredata modestamente e dagli alti soffitti. Eloy è di poche parole, ci mostra la camera dove dormiremo. Orizzontali, godiamo di un materasso morbido, lenzuola bianca e cuscini bombati. La scomodità dei rigidi sedili della compagnia charter che ci ha portato fin qui sfuma via.
Mattino. La luce filtra dalla porta in ferro pesante, il condizionatore ronza. La stanza a piano terra ricorda casa di Silvita in Costa Rica. Il telecomando non risponde, la vecchia televisione non si accende, la radio ha il mangiacassette. Cerchiamo di sintonizzare Radio Rebelde ma il segnale è disturbato. Alcune sedie arrugginite circondano un tavolo massiccio al centro del cortiletto interno, questa notte lo abbiamo circumnavigato ma solo la luce del giorno ci consente di scoprirlo. A pochi metri di distanza, una panca in pietra grigia lo osserva. Un’enorme mangueira domina il patio cementino e una rete protegge la nostra testa dai gustosi frutti maturi in caduta libera. «È la stagione giusta». Sono le parole di un uomo robusto in ciabatte, calzoncini e maglietta. È Eloy. «In questa stagione i manghi sono secchi e dolci. Vi preparo un caffè e vi porto un po’ di frutta». Il caffè è dolce, troppo dolce. «Benvenuti ai Caraibi».
L’URSS e l’Africa. Eloy ha lavorato sette anni in Unione Sovietica come pilota di aerei, lì ha imparato il russo e un po’ di inglese. Ora è fisso a La Habana con la moglie e le sue due bambine. Ha diversi lavori per le mani: aggiusta praticamente tutto quello che gli capita, è specializzato in circuiti elettrici, è un affittacamere, fa l’operaio alla fabbrica di sigari e l’allevatore di maiali a tempo perso. Il suo amico Camilo arriva a metà mattinata, è lui il nostro gancio, lui che ci ha trovato da dormire da Eloy. Nero di carnagione, porta occhiali da sole con lenti a specchio, è alto e muscoloso e ha battuta e sorriso facile. Dimostra una trentina d’anni ma scopriremo che ne ha cinquanta. Dopo i primi convenevoli gli chiediamo che cosa fa nella vita e lui parte da lontano raccontandoci che ha partecipato alla guerra in Angola nell”86 e ha operato in Congo ed Etiopia, non specifica il suo incarico. Poi ha vissuto per qualche anno a Modena e in Austria dove ha lavorato come fisioterapista e naturopata aiutando economicamente e a distanza il Partito. Con i soldi che è riuscito a mettere da parte ha sistemato la casa dove ore abita. «Ma sono rimasto troppo poco tempo fuori da Cuba per diventare ricco» sospira con un sorriso. Anche lui, dopo le esperienze all’estero, vive a l’Avana, è maestro di arti marziali e ha due belle bambine, proprio come Eloy. Tira fuori il portafoglio e ci mostra orgoglioso le loro fotografie. In questi giorni vuole farcele conoscere insieme a tutta la sua famiglia. Non smette di ripeterci che se abbiamo bisogno di qualunque cosa, basta chiamarlo. Lui è qui per noi, una chiamata e arriva. È molto premuroso e protettivo nei nostri confronti. Troppo, pensiamo. Ingrati, siamo degli ingrati.
Economia. Con Eloy e Camilo discutiamo un po’ della situazione economica e politica del paese. Eloy critica il regime che non ha saputo rinnovarsi, l’accomodarsi di alcuni politici e l’incapacità di fare uscire il paese da una crisi economica che dura da più di 54 anni. Sa benissimo che le cause dell’instabilità economica non sono riconducibili soltanto a fattori endemici al regime, ma è stanco e disilluso della crisi perpetua che lo Stato non riesce a fronteggiare. Sostiene che negli ultimi anni alcune politiche di apertura portate avanti da Raul Castro hanno contribuito ad aumentare la diseguaglianza sociale a Cuba, che prima era più contenuta e meno tangibile. Non c’è contraddizione nelle sue parole, la realtà è contraddittoria.
Monete. La loro compagnia è piacevole, rimarremmo ad ascoltarli per ore ma fuori il nuovomondo, quello con la “n” minuscola, ci aspetta. Camilo ci “scorta” per il quartiere 10 de Octubre, vuole accompagnarci fino alla strada dove passano i taxi e insegnarci qualche trucco che ci farà sentire un po’ più cubani e meno gringos in balia dei cubani. Durante il cammino ci riempie le tasche di preziosi consigli e ci avverte di prestare molta attenzione alla differenza tra CUC e pesos, le due monete vigenti a Cuba. In un negozio cambiamo molti CUC in pesos e Camilo ci spiega che la prima è la moneta dei gringos e degli amici dei gringos e vale molto di più, mentre la seconda è la moneta dei cubani e vale molto di meno ma ci permette di comprare più cose a prezzi inferiori. Se useremo i pesos, dunque, spenderemo meno, a patto di conformarci in toto agli usi e costumi cubani, dal mangiare ai trasporti e a tutto il resto.
Colectivos. L’Avenida Santa Catalina è ampia e lunga, non riusciamo a vederne la fine. Per le strade la gente passeggia tranquilla, gli alberi ai lati dei marciapiedi reggono folte chiome verde intenso che rendono meno traumatico l’impatto con il grigio dell’asfalto. Tra le fronde spuntano in serie edifici coloniali dai colori pastello sbiaditi. Il verde qui, quello degli alberi non dei semafori, è verde per davvero. Di tanto in tanto qualche auto d’epoca interrompe la pace borbottando o sfrecciando sull’Avenida. Senza nemmeno accorgercene passiamo dalla tranquillità e dal fischiettio degli uccelli di Avenida Santa Catalina alla caoticità e ai tubi di scappamento delle macchine d’epoca, che ora invadono prepotentemente le strade. Giungiamo all’incrocio tra Avenida Santa Catalina e Avenida 10 de Octubre, il punto dove si concentrano masse di persone intenzionate a raggiungere il centro della città. Camilo ci indica quali macchine dobbiamo fermare: non i taxi ordinari e statali – che pagheremmo in CUC – ma i colectivos. Assordati dalla confusione proviamo timidamente ad alzare il braccio ma nessuno si ferma. Prendiamo coraggio, ci sporgiamo di più dal marciapiede, scendiamo in strada e saltiamo su un colectivo scassato. Sediamo sul sedile posteriore compressi tra un finestrino rotto e un signore col cappello bianco. In tutto, compreso l’autista, siamo in otto nel colectivo, tre seduti davanti, due nei sedili intermedi e tre in quello posteriore. Ne manca uno soltanto per formare una squadra di baseball. E il nono giocatore non si fa attendere, dopo una brusca frenata, salta a bordo: equipo al completo. Davanti a noi una signora afrodiscendente regge un portaoggetti metallico dipinto di bianco e sul cruscotto due bandierine sventolano ad ogni accelerata del conducente. Sono la cubana e la venezuelana che s’intrecciano sospinte dal vento, a sancire un’alleanza politica che potrebbe essere compromessa dalla morte di Hugo Chavez, avvenuta soltanto pochi giorni fa.
Por la izquierda. In serata quando il tassista ci accompagnerà a casa, sottolineerà l’assenza di un’ industria pesante a Cuba e di una fabbrica di automobili. La situazione – ci dice – è aggravata anche dal blocco delle importazioni: «È per questo che abbiamo le auto degli anni ’50, sono quelle che c’erano prima della Revolución e quelle sono rimaste. Ora che c’è Raul le cose stanno gradualmente cambiando, Cuba si sta aprendo». Poi ci racconta che un medico, una delle professioni più pagate a Cuba, guadagna circa 20 dollari al mese mentre lui che non lavora per lo Stato ma come privato – por la izquierda (in nero) – può arrivare a guadagnare quella cifra in un solo giorno. Ha studiato informatica e per un breve periodo ha fatto anche il professore ma guadagnava troppo poco e così tre anni fa ha deciso di fare il tassista. La sua auto, una delle più nuove in circolazione, è del 1988 e ha 24 anni, proprio come lui e come noi.
Supermercati. Per tutto il pomeriggio non facciamo altro che camminare per Habana Vieja. Bellissima e colorata, decadente e vivissima. Si ha la sensazione di essere in un altro mondo, l’impatto è forte come il primo con Rio de Janeiro ma qui sembra che ci sia qualcosa che vada oltre lo shock culturale. Nei supermercati troviamo solo l’essenziale, pochissimi prodotti, pochissime marche, le più potenti: Nestlé e Del Monte. Si percepisce la decadenza guardando gli edifici coloniali abbandonati e tremolanti, sembra che debbano crollare da un momento all’altro e mi fanno tornare alla mente le macerie portoghesi di Porto, Coimbra e Lisbona, i confini d’Europa più vicini alle Americhe. Le strade sono affollate, dicono che in quattro chilometri quadrati si concentrino circa sessantamila persone, forse il dato è un po’ pompato ma sono comunque tante quelle che l’occhio umano scorge. Neppure l’orecchio rimane indifferente alla moltitudine di voci che si accavallano e si confondono nelle piazzette: squarci tra una via stretta e l’altra, affollati di carretti ricolmi di frutta, dove piacevoli folate di vento tiepido si mischiano alla quotidianità cubana.
Baseball e pallone. Non sappiamo bene come ci siamo arrivati, ma ci ritroviamo nel quartiere cinese. Sappiamo però di aver camminato molto perché siamo sfiniti. Decidiamo di fermarci nell’ennesima piazzetta a riposare e sediamo su una panca di pietra insieme a una signora dallo sguardo perso ma gentile. Proprio davanti alla nostra panchina un gruppetto di bambini gioca a calcio, alcuni sono scalzi, altri hanno le scarpe sfondate, la maggior parte sono a petto nudo. Un altro gruppo s’infila nelle mani guantoni da baseball più grandi del loro petto e si scambia battute da una parte all’altra della strada secondaria che lambisce la piazza. Il pallone da calcio finisce costantemente nella via principale dove auto d’epoca – che continuo a chiamare così, ma che chiaramente qui non sono d’epoca – sfrecciano sicure senza sosta. Contemporaneamente la palla da baseball attraversa rapida, da una sponda all’altra, la strada secondaria meno trafficata. Gli automobilisti al loro passaggio suonano ai ragazzini e alla palla da baseball – senza rallentare troppo – e questi prontamente evitano le coloratissime Chevrolet Bel Air, Cadillac Eldorado o Pontiac Star Chief. Saltano sul marciapiede e interrompono, senza lamentarsi troppo, le azioni di gioco.
Libri. Riprendiamo il cammino e arriviamo in una piazza piena di libri usati di cui non ricordo il nome. Mi fermo a una bancarella e faccio amicizia con una signora molto disponibile e sorridente. Lo sguardo si posa immediatamente su un libro con la copertina illustrata che dal formato sembra un album. Non è né un saggio, né un romanzo, né un fumetto ma è effettivamente un album che racconta la storia della Revolución dal ’52 al ’59. E per di più è un album di figurine: disegnate e corredate da didascalie. Ho sempre avuto un’attrazione particolare per le figurine e per la socialità che costringe al baratto e alla condivisione per completare l’opera. Mi esalto, è una pubblicazione che mi piace da morire ma non la compro. È solo il primo giorno – mi dico – ci saranno altre occasioni. Continuo la piacevole conversazione con la signora, lei non cerca pedantemente di convincermi a comprare e così sfogliamo insieme la biografia di Camilo Cienfuegos commentata dall’anziana venditrice. Credo di starle simpatico. Ho già nostalgia della mia prima amica cubana, mi informo sugli orari della bancarella, la saluto e continuo il tour per la piazza alla ricerca – invano – del terzo volume di Memoria del fuoco di Eduardo Galeano. Mi ero illuso di trovarlo qui a Cuba. Sembra introvabile in italiano e in Italia. Fallisco anche qui e mi consolo sfogliando i romanzi di Daniel Chavarría e alcuni scritti di Fidel e Guevara.
Cibo. Oggi abbiamo pranzato benissimo, bevuto un buonissimo succo fresco al mango e un’ottima Pina Colada in un bel posticino in Plaza del Cristo. Un posto caldo e accogliente dal nome simpatico: El Chanchullero. Il barista è cordiale. Unica pecca: troppi gringos urlanti per i nostri gusti.
]]>Seconda parte [Qui la prima parte]
 Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania… Per Eduardo non piango una sola lacrima perché non saprei chi sto piangendo. Ora che sono padre provo a pensare che i suoi genitori sono morti prima di lui: non gli capiterà di leggere e di ascoltare quello che si dice e si scrive di loro figlio. Eduardo Rózsa Flores era un mercenario che voleva uccidere il presidente Evo Morales. Era un neofascista [...]]]>
Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania… Per Eduardo non piango una sola lacrima perché non saprei chi sto piangendo. Ora che sono padre provo a pensare che i suoi genitori sono morti prima di lui: non gli capiterà di leggere e di ascoltare quello che si dice e si scrive di loro figlio. Eduardo Rózsa Flores era un mercenario che voleva uccidere il presidente Evo Morales. Era un neofascista [...]]]>
Seconda parte
[Qui la prima parte]
 Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania… Per Eduardo non piango una sola lacrima perché non saprei chi sto piangendo. Ora che sono padre provo a pensare che i suoi genitori sono morti prima di lui: non gli capiterà di leggere e di ascoltare quello che si dice e si scrive di loro figlio.
Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania… Per Eduardo non piango una sola lacrima perché non saprei chi sto piangendo. Ora che sono padre provo a pensare che i suoi genitori sono morti prima di lui: non gli capiterà di leggere e di ascoltare quello che si dice e si scrive di loro figlio.
Eduardo Rózsa Flores era un mercenario che voleva uccidere il presidente Evo Morales. Era un neofascista che intendeva promuovere l’insurrezione e la secessione del dipartimento di Santa Cruz, ricco di risorse, dal resto della Bolivia. Dunque, prendo nota: organizzazione di una milizia, repressione dell’esercito statale, intervento straniero, riconoscimento dell’indipendenza o di qualcosa di simile.
Prima di partire per l’America Latina ha rilasciato un’intervista a un giornalista ungherese: affermava di non aver nulla contro Morales, ma che presto sarebbe tornato nel paese natale per organizzare la difesa dall’imminente attacco dell’esercito boliviano.
Su un periodico venezuelano si sostiene che chiunque dipinga Rózsa Flores come fascista è un diffamatore: lui era amico del rivoluzionario, prigioniero politico nelle carceri francesi, Ilich Ramírez. Visto che Ramírez, detto Carlos lo Sciacallo, è un pen-friend del presidente Hugo Chávez, alleato fraterno di Evo Morales, allora Rózsa Flores non può che essere un combattente per la libertà e per la giustizia.
Leggo qua e là che Eduardo Rózsa Flores collaborava con la CIA. Faceva il doppio o magari il triplo gioco. È stato chiamato in Bolivia dalle forze di sicurezza governative per decapitare l’organizzazione dei secessionisti: ha esplosivo che può avergli dato solo l’esercito boliviano. Le forze speciali dell’esercito lo hanno ucciso perché non risultasse che era stato reclutato per colpire affaristi, faccendieri, uomini politici secessionisti.
Era legato a croati di estrema destra, residenti in Bolivia nel dipartimento di Santa Cruz, loschi figuri che trafficano armi e droga. Aveva senza dubbio legami stretti con riviste di destra e collaborava con Jobbik, partito di estrema destra ungherese, che pare non disdegni di essere finanziato da potenze straniere del Vicino e Medio Oriente e da gruppi dell’Islam radicale.
Dai magiari più nazi, che per qualche tempo forse lo hanno considerato un camerata o un possibile alleato, ora viene giudicato un ebreo, un falso eroe, un agente bisessuale del Mossad, infiltrato nella destra ungherese.
C’è l’imbarazzo della scelta, insomma. Era uno psicopatico, uno Zelig nazionalista alla ricerca del pericolo per farsi di adrenalina e morire come un Che Guevara? No, dice qualcuno, era un impulsivo che si butta generosamente nella mischia senza riflettere: uno che ha tutti i pezzi del mosaico in tasca, ma li ricompone troppo in fretta e male. Lo possiamo dunque immaginare come una creatura di laboratorio, fuggita dalle gabbie del socialismo autoritario, una chimera che cuciva insieme le membra del cane da guerra e del capro espiatorio? No, assicura un altro, aveva un progetto chiaro. Era un musulmano sincero, la cui memoria viene infangata: un combattente internazionalista dell’Islam politico, vittima di un complotto.
Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania. Vedo altri due uomini, vivi, un croato e un ungherese, che presto saranno chiusi nelle galere della Bolivia: sono incappucciati, in ginocchio, la schiena nuda, segnata. Vedo Eduardo che abbraccia i suoi commilitoni, che ancora ride, che mostra all’obiettivo pistole e munizioni disposte su un tavolo. Lo vedo mentre finge di dormire tra due armi automatiche, con la testa su un guanciale e la mano sinistra poggiata sulla pancia, coperto solo da un lenzuolo che lascia in mostra la maggior parte del suo corpo tarchiato, pesante. Vedo le foto del suo cadavere supino: addosso ha un orologio e un braccialetto di corda sottile, un tatuaggio sulla spalla sinistra, un altro più piccolo sulla spalla destra, i fori delle pallottole. Lo zigomo destro è livido e lacerato, la fronte e il naso sembrano contusi. Tanto sangue rappreso a terra, tra il corpo e il pavimento.
«L’obiettivo del fotografo è dalla parte della testa. Il corpo è disteso e preme lungo una cassettiera. L’avambraccio destro è sollevato da terra, il polso è piegato; le nocche, il pugno semiaperto poggiano sulla parte bassa del torace. Il braccio sinistro, che preme contro la cassettiera, attraversa il petto. C’è un cassetto aperto che pende sul corpo. Non si capisce da dove venga questo cassetto. Sembra che lo abbiano aperto per sostenere uno di quei cartoncini gialli che si mettono sulla scena del delitto. Sul cadavere c’è questo cartoncino giallo e sopra è scritto il numero uno. Il cartoncino poggia sul cassetto e sulla pancia. I genitali e l’ombelico sono coperti dal cartoncino. I capezzoli sono coperti dal braccio sinistro. C’è qualcosa che vela un angolo della foto e la parte superiore della testa, dove i capelli sono più radi».
«L’hanno ucciso senza troppi complimenti, ma sembra che abbia approvato la sceneggiatura. Se è una fiction, dobbiamo aspettarci di rivederlo ancora vivo».
«Nato e morto a Santa Cruz. Ucciso in Bolivia come Che Guevara. Forse tradito. Eroe e vittima… Lo devo dire a Daniele».
«Credi che volesse morire così?»
«Ho trovato l’intervista a un uomo e a una donna ungherese. Sono presentati come il miglior amico e la fidanzata. L’amicizia risale al 1998. Invece con la fidanzata stava insieme da tre o quattro anni. Si erano conosciuti in un parco di Budapest, dove portavano il cane; ma non ci abitavano più a Budapest, si erano trasferiti in una cittadina di campagna. Ho visto la foto della donna. Sullo sfondo c’era un orto».
«Viene fuori qualcosa?»
«L’amico conferma la versione di Eduardo. Quello che dice nell’intervista rilasciata prima di partire: io non ce l’ho con Evo Morales, vado là per difendere Santa Cruz dall’esercito. L’amico dice che Eduardo alle elezioni stava dalla parte di Morales: un indigeno, una bella novità per la Bolivia eccetera eccetera. Ma poi la novità indigena in pochi mesi diventa il rischio di una dittatura ed Eduardo Rozsa Flores doveva salvare la patria, che non è più l’intera Bolivia ma solo il dipartimento di Santa Cruz. Poi va a Santa Cruz e la situazione non è quella che si aspettava…»
«Lo dice questo fantomatico amico? Che cosa vuol dire?»
«Io ti riferisco che il giornalista dice che l’amico magiaro dice che Eduardo diceva… Eduardo si aspettava un’altra situazione. La situazione in cui si trovava era diversa da quella per cui si era preparato un piano. Non lo so, troppo fumo, contraddizioni, ingenuità poco credibili. La fidanzata sostiene che Eduardo non apprezzava la vicinanza tra Morales e Chávez. Però, sei mesi prima che l’uccidano, Eduardo viene intervistato da un venezuelano, vicino a Chávez, nonché ammiratore di Ilich Ramírez, lo Sciacallo, che come sai era una vecchia conoscenza di Eduardo. L’intervistatore chiede a Eduardo: che cosa ne pensi della fase politica, cioè di Hugo Chávez? Eduardo ci gira un po’ intorno, non si sbilancia sulla politica interna venezuelana: la butta sulla fratellanza e l’avvenire dei popoli dell’America Latina, un continente attraversato da un vento di rinnovamento. Poi, però, dice chiaramente di apprezzare la politica estera di Chávez: Palestina, Iran… Non te la faccio lunga. Esiste forse una coerenza nascosta, un filo di qualche colore che tiene unite le toppe. Però Eduardo continua a cantarla in modo un po’ diverso secondo il pubblico… Uno che è fuggito da un paio di golpe in Sud America, che ha servito l’esercito nel Patto di Varsavia, pensa che Evo Morales aspiri alla dittatura? A me sembra ridicolo, assurdo, o almeno molto strano. Forse sono io superficiale. Secondo la fidanzata, Eduardo in Croazia formò la sua brigata internazionale per proteggere gli inviati di guerra, dopo che alcuni giornalisti stranieri erano stati uccisi».
«Era una donna nei secoli fedele. Pensi che sia davvero così ingenua?»
«Il busto di Stalin, che teneva in camera da letto, era stato ricollocato nel giardino di casa loro. Ci aveva scritto sotto: “Vomitate qui”. E quando c’era una festa, gli invitati sbronzi potevano vomitare in faccia a Stalin».
«Ha mai detto una sola volta: io ho sbagliato?»
«Ogni volta dissimula qualcosa. Vuole eliminare le contraddizioni. Forse il busto di Stalin, quando abitava coi genitori, lo teneva in camera per fare un dispetto al padre. O magari gli cambiava di posto, secondo l’ospite… Dopo essere stato in Russia alla scuola del KGB, ha un’illuminazione: “Mi resi conto che tutto era puro teatro, parole vuote, che non significavano nulla”. L’ho trascritto da un’intervista recente. Però a quei tempi continuava a lavorare per i servizi segreti ungheresi. E allora non si capisce bene cosa fossero questo “puro teatro” e queste “parole vuote”. Il teatro gli piaceva moltissimo. E non era solo teatro: la guerra e la polizia segreta le sapevano fare bene. Lui partecipava e ha imparato. Nel regime ci stava di casa, come soldato, come agente segreto».
«Lì non preparava insurrezioni».
«Forse sì, in Romania, per la minoranza magiara. Ma siamo già in un romanzo… In Ungheria non credo, ma a questo punto… Daniele si ricorda che diceva parole di ammirazione per János Kádár, che ha governato l’Ungheria per decenni. Ci indicava la casa. Lo stimava. Forse era riconoscenza…»
«Le parole vuote che sentiva a Mosca potevano essere uguaglianza, proletariato, internazionalismo. Doveva trovarle così vuote che, per dare sostanza al suo teatro, e a se stesso, e forse anche alla sua vaga idea di giustizia, poi ha riempito gli stampi col materiale che trovava per strada».
«La sua idea di autodeterminazione, applicata alla realtà, sembra una versione di destra del frazionismo dell’estrema sinistra. I suoi amici negano che lo facesse per soldi. Ho provato a scrivere su un foglio tutte le definizioni, oltre a mercenario, che mi venivano in mente o che trovavo scritte su di lui. Sei pronta? Islamista rivoluzionario, anti-imperialista e anti-capitalista, ma disposto ad alleanze tattiche con chiunque, con nazionalisti o con potenze locali e mondiali; sovranista, giustizialista, rossobruno, montonero di religione islamica; socialfascista, neofascista, socialista nazionale o, se preferisci, nazional-socialista delle piccole patrie; autonomista differenzialista; nazionalista antiautoritario, anarconazionalista, etnoinsurrezionalista…»
«Basta anche meno».
«Potrei continuare. È più utile rintracciare le contraddizioni, le continuità…»
«Stava nella corrente. Voleva partecipare, ma voleva ancora di più essere un protagonista. Si adeguava ai luoghi e ai tempi, ma non faceva autocritica. Nascondeva le contraddizioni, sbianchettava una parte del suo passato. Le cancellature, gli errori non si dovevano vedere. Desiderava sentirsi al centro del mondo. Aveva un ego smisurato».
«Mostra una vocazione religiosa, missionaria, umanitaria: si converte a ogni cambio di stagione, dopo la caduta di Saddam Hussein si propone come mediatore o come portavoce del governo provvisorio dell’Iraq, porta aiuti umanitari in Sudan e in Indonesia, muore come un martire a Santa Cruz».
«Non poteva scegliere un luogo migliore».
«Rozsa e Croce… Opus Dei, Rosa e Croce. E nel 2007 ha scritto versi sufi in ungherese».
«Già su questo si potrebbe scrivere un romanzo».
«Ma ha un’altra vocazione, forse più sincera, o forse no, per le armi e la guerra. Per lui la lotta di classe era diventata una di quelle parole vuote. Alla fine degli anni Ottanta le minoranze nazionali gli sembrano più tangibili, più disponibili, più facili della lotta di classe».
«Sembra che il conflitto non possa essere altro che lotta armata, guerra di soldati. Guerra tra popoli; mai lotta di proletari, operai, scioperi, movimenti. Mai movimenti di donne. Un affare di maschi armati che si mettono in posa per un film o per una foto, a quanto vedo. Uomini che spargono sangue per spartirsi la Terra. Non mi hai parlato quasi mai di donne. C’era la madre ed è morta. Mi hai raccontato che aveva qualche storia…»
«Delle hostess. Me l’ha ricordato Daniele».
«C’è l’ultima fidanzata che ripete quello che lui dice, e forse ci crede. Dove sono i proletari? Dove sono le donne? Nella sua vita, nella Storia…»
Le donne nella sua vita, nella Storia… Durante il viaggio in Europa, mentre Daniele riusciva a trovare il tempo per leggere qualche pagina in francese del saggio De l’amour, il suo balordo compagno di stanza, che si sentiva in dovere di conoscere molte ragazze, prima di uscir la sera trovava giusto il tempo per lavarsi e cambiare la biancheria. Avremmo incontrato, conosciuto, parlato, solo parlato, con parecchie ragazze ma non a Budapest.
«No, compañera. Le donne in lotta non stavano nel fascio di luce… Era fidanzato. Lei dice che si sarebbero sposati presto».
«Che poi fosse bisessuale o no non cambia niente. Sui diritti dei gay scommetto che la pensava più o meno come il collega Vladimir Putin. Direi che gli piacevano le persone che affascinava, che accettavano la sua autorità».
«Una donna c’è: sua sorella ***. Io e Daniele non l’abbiamo incontrata perché non era a Budapest. È l’unica rimasta della sua famiglia».
«Già, me l’avevi detto».
«In un’intervista viene fuori che il fratello con le sue donne era un po’ despota. Dice che la relazione più lunga era stata con una chica russa che lo avrebbe definito l’uomo della sua vita. Non so se questa ragazza esiste. Mi pare che a Budapest lui frequentasse un’ungherese. Non era la chica russa di cui parla la sorella. Noi non le abbiamo mai viste. In un parco una sera ci ha presentato un paio di ragazze. Non abbiamo fatto a tempo nemmeno a dire due parole».
«La sorella esiste, però».
«Dirige il Museo di Arte contemporanea a Santa Cruz. In quel museo ci sono anche i quadri del padre».
«Dunque, esiste. Ormai esiste più del fratello».
«Nel film su Eduardo lei non esiste. Il protagonista non ha una sorella».
Verosimile ma falso. Inverosimile ma vero. Ogni verità sembra parte di una menzogna, dice Luisa. Ogni scelta sembra sfuggire a una strategia chiara.
Dovrei prendermi la briga di cercare i suoi libri, i suoi articoli in ungherese. C’era un ragazzo di Napoli o di Salerno che avevo conosciuto in sala studio… Ha vissuto per anni in Ungheria, e chissà dove abita ora: lui potrebbe aiutarmi a tradurre, se trovassi il suo indirizzo, se ricordassi ancora il suo cognome. L’ho rivisto per caso una volta che passava a Bologna; gli ho chiesto se conosceva il nome di Eduardo, che ancora era vivo, e gliel’ho ripetuto tre volte, ma lui niente, mai sentito. Avevo scritto l’indirizzo su un biglietto che ho infilato nel portafoglio, che poi ho svuotato in un cassetto, che poi ho riversato in uno scatolone prima del trasloco… Tre scatoloni sono ancora chiusi, in cantina. La carta è più difficile da falsificare. Le enciclopedie online vengono continuamente modificate. Di Eduardo ci sono poesie, memorie, scritti politici, articoli sui giornali. È tutto una menzogna, un alibi? Devo mettere tra parentesi le sue imprese in Croazia e i suoi rapporti con l’estrema destra ungherese. Provo a prendere sul serio le sue parole.
«L’immoralità, la menzogna, i crimini commessi in nome del “socialismo reale” sono imperdonabili. Bisogna usare molto detersivo per lavare questa ignominia. Ti parlo della realtà, non delle idee. Non della necessità, che davvero esiste, di costruire una società più giusta. Bisogna in primo luogo tenere in considerazione i veri desideri del popolo. Ciò che facciamo non è contro ma per il popolo, nell’interesse delle nostre nazioni. Imparai a odiare le famigerate élite del campo socialista per un semplice motivo: questi miserabili erano più interessati, anzi, erano interessati solo a restare al potere, con i loro privilegi, coi loro vantaggi. Per loro il “socialismo” era solo una copertura, che non aveva nulla a che fare con ciò che in basso, il popolo, sentiva e desiderava. Sono arrivato alla conclusione che non si può parlare di socialismo né realizzarlo se non si rispettano pienamente la libertà e il diritto all’autodeterminazione, sia degli individui che compongono la società, sia dei popoli e delle nazioni. Se no che cosa ci distingue da quelli che diciamo di odiare, se commettiamo i loro stessi errori, i loro stessi crimini. Una cosa è prendere il potere, con o senza armi, imporre una direzione, innescare un processo. Ma più tardi non è possibile prendere tutte le decisioni, necessarie o no, al posto del popolo, per cui abbiamo preso il potere o fatto la rivoluzione o vinto una guerra di indipendenza. Per questo ritengo che uno degli esempi più validi sia quello della Rivoluzione sandinista in tutto il suo sviluppo… Nessuno ha il diritto di soppiantare il popolo. Noi siamo servi, impiegati, schiavi di una causa, e non abbiamo più diritti degli altri. Sulle nostre spalle abbiamo doveri, compiti da adempiere».
Lo pubblica il 31 ottobre e muore ucciso il 19 aprile, in compagnia di un contractor irlandese e di un magiaro transilvano di estrema destra, che cantava e scriveva canzoni.
Bisogna usare molto detersivo per lavare questa ignominia, diceva. Bisogna lavare l’ignominia del passato con un sapone nero, esfoliante. Sapone di Croazia, abluzioni rituali, candeggina Jobbik.
Per loro il socialismo era solo una copertura. I veri desideri del popolo. Nell’interesse delle nostre nazioni.
Quali desideri? Quali nazioni? Quanti desideri, quante nazioni? Bisogna dividere chi canta la ninna nanna in serbo-croato da chi la canta in croato-serbo. I bambini potrebbero confondersi. Gli altri fanno il segno della croce al contrario. Chi vuole ricevere una cartolina in cirillico sta da una parte, chi la desidera in alfabeto latino dall’altra. Quali desideri del popolo? I desideri del popolo prima di colazione o dopo cena? Quale popolo? Il popolo del dipartimento, della provincia, del comune, del quartiere, del condominio… I desideri di un imprenditore sono i desideri del popolo? Sono legali o illegali questi desideri? Per quanto tempo? Quanti giorni prima e quanti giorni dopo aver votato a un referendum o alle elezioni?
Il popolo desidera servire chi parla e prega in dialetto. Non vede l’ora di lavorare per i capaci e i meritevoli della sua piccola grande patria. Equilibrismo, stare a galla, volontà di emergere, cavalcare la tigre. Dal piccolo padre alla piccola patria. Dalla periferia bisogna tornare in centro; poi ci ritiriamo in campagna a coltivare l’orto; e finalmente vai a morire ammazzato sotto la Santa Croce materna. Voleva essere ricordato. Era un protagonista secondario. Ha vissuto molte vite, una vita romanzesca. Ha giocato su più tavoli. Tutte le nazioni giocano lo stesso gioco? Un’alleanza tra una parte dell’islamismo radicale e movimenti nazionalisti di destra contro il nemico. Contro il capitalismo globale, contro l’impero, contro gli imperi? Cerca alleati per combattere il nemico, ma come fa a invitare tutti gli amici al compleanno? Alle feste beveva alcolici? E durante il Ramadan? Perché combatte contro Morales? È troppo moderato, troppo pacifico, troppo indio? Neanche la socialdemocrazia della Svezia era abbastanza eroica. Il presidente indio pianifica di segregare, deculturare, sbattezzare, sterilizzare, drogare, umiliare, sfruttare, torturare, incarcerare, tassare i borghesi cattolici bianchi di Santa Cruz? Chi è questo imprenditore boliviano di destra, questo Branko Marinkovic Jovicevic, figlio di un croato, che vuole la secessione?
Poniamo che Eduardo non fosse in Bolivia per assassinare Morales. Mettiamo che non volesse uccidere qualche notabile locale, a destra o a manca, perché si gridasse al lupo, per giustificare una secessione, per rendere vero il risultato di un referendum ritenuto illegale. Lo hanno ucciso senza armi in pugno, senza processo. E forse lo hanno anche torturato. Ma non riesco, Luisa, a trovare una ragione per il resto. Non riesco a trovare una sola ragione per riabilitarlo, giustificarlo, scagionarlo… Per riconoscerlo come un amico, per perdonargli di avere assunto le sembianze e il ruolo di un nemico. Questo non è un gulag. Qui dentro lo giudico. Voglio e posso confrontare quello che dice con quello che fa, quello che fa oggi con quello che faceva ieri, quello che dice a te con quello che dice a un altro, quello che fa con uno con quello che fa con un altro, quello che dice e fa con i risultati che si producono nel mondo… Perché organizzare una milizia contro il governo boliviano? Infuriava la repressione? Perché favorire una cricca di proprietari bianchi avversi al presidente indio, eletto e confermato dal voto? Perché una faccia nota, un nome noto, uno come Eduardo che scrive e parla volentieri, che si fa notare in mille modi, dovrebbe riuscire a giocare alla guerra senza pagarne il prezzo? Perché sta in posa sul letto di un albergo di non so dove fingendo di dormire tra due armi automatiche? Perché parte in quarta, perché si gingilla con le armi, perché rischia di innescare una guerra civile, la secessione di una regione che non è colonizzata, che non è davvero assediata dall’esercito, che non subisce un’oppressione razzista o di classe?
Volevi evitare che Santa Cruz fosse schiacciata dalle forze armate boliviane? Non mi pare che sia successo. Sulla tua lapide qualcuno potrà scrivere le parole vittima, eroe, sacrificio. Col tuo sacrificio hai impedito che l’esercito della Bolivia mettesse a ferro e fuoco la tua città natale o con la tua morte hai legittimato l’invio di forze militari nella regione? Hai giustificato e favorito, in forma più blanda, quello che ritenevi una minaccia? Hai sventato un complotto contro Morales? Hai aiutato il governo a sgominare una banda di affaristi che volevano la secessione?
Ho letto che negli ultimi anni Evo Morales ha aumentato il suo consenso nel dipartimento di Santa Cruz. Sono ignorante, vivo a migliaia di chilometri. Sono un moralista ottuso. Mi hai fatto bere champagne a digiuno. Mentre ero nudo in un bagno turco, mi hai detto: «No, non credo che siamo pronti per la democrazia: io sono per la monarchia costituzionale».
Vuoi cambiare idea? Ne hai diritto, compagno post-stalinista. Ma prima di passare al nazionalismo del popolo grasso devi chiedere scusa. A qualcuno devi chiedere scusa. Devi chiedere scusa anche a me.
Lo hanno ucciso. Non posso testimoniare che le teste di cuoio lo abbiano torturato. Sulle schiene dei due che sono ancora vivi qualcuno riesce a distinguere segni che i miei occhi non riescono a vedere. Sono quasi sicuro: lo hanno ucciso mentre era disarmato. Forse li hanno lasciati morire dissanguati. La porta è sfondata, il camerata irlandese è a terra bocconi. Si intravede un tatuaggio sull’omero sinistro, il grande letto è disfatto, da una grande borsa fiorisce una sporta di plastica bianca. Il frigo bar è aperto, il televisore che guarda verso i letti è al suo posto, intatto. L’irlandese è morto tra il televisore e il letto. Due sedie stanno attorno a un piccolo tavolo tondo, la camicia di Eduardo è poggiata sullo schienale di una sedia, un’altra camicia sull’altro schienale.
Ecco l’obitorio. Ci sono tre corpi distesi su tre tavoli. Uno, due, tre teste a destra. Tre corpi su tovaglie che sono buste di plastica grigia. Oltre i cadaveri c’è una finestra, piastrelle bianche. Dalla parte dei piedi, in un angolo, appeso alla parete, c’è un tubo di gomma arrotolato. Ci lavano i pavimenti e tutto quello che si può lavare. L’acqua e il sangue escono da un tombino, come in una grande doccia. La luce al neon viene dall’alto. Un uomo canuto, calvo, capelli corti, grandi occhiali, vestito di bianco, guarda Eduardo in faccia. Sul petto del morto è posato qualcosa che somiglia a un piccolo sacco di carta marrone. Il torace dell’irlandese è ancora sporco di sangue. Il mento è alto, la bocca semiaperta. Il terzo cadavere, vicino alla finestra, ha la testa reclinata verso sinistra, le braccia rigide, gli avambracci sollevati. Sembra che i polsi siano legati.
Ti rivedo su un tavolo. La luce è diversa. Ti guardiamo da sopra la testa. Ti tocca un guanto che riveste la mano sinistra di una donna. La mano poggia, copre il pettorale destro. Il corpo è pulito; i capelli corti, radi, sono ancora bagnati. Non saprei dire se quelli che vedo sono i fori di sette pallottole. Un colpo, una ferita, una bruciatura è vicina alla clavicola. Sembra piovuta dall’alto. Ne ho abbastanza. Se gli sbirri boliviani sono cattivi, voi tre mi piacete ancora meno. Non lo so, non me ne intendo, non sono un medico legale, ho la nausea.
L’irlandese è stravolto; tu invece hai la faccia serena, quasi sorridi. Si dice spesso: sembra che dorma. Ti hanno ricomposto il viso, ti hanno lavato. Ti hanno portato fuori dall’albergo. Qualcuno, immagino, ha riconosciuto il tuo cadavere. Eri davvero tu il parassita inquieto che sommuoveva il sacco sigillato di finta pelle?
«Aveva pubblicato questa intervista, nel suo blog, sei mesi prima di morire in Bolivia. Qui, leggi tu dallo spagnolo, dichiara di apprezzare la Rivoluzione sandinista. In tutto il suo sviluppo, dice. Direi che si riferisce al sandinismo fino a oggi… Esiste l’Alleanza bolivariana per l’America Latina. Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Cuba, quando è stato ucciso, erano già alleati. Perché lui dovrebbe andare a uccidere Morales? Perché dovrebbe favorire la secessione del dipartimento di Santa Cruz? Se si prendono sul serio le sue parole, queste sue parole… Forse non dovrei prenderlo troppo sul serio. A volte immagino, non ci credo, non sono così matto, ma immagino che sia vivo da qualche parte. E mi viene da pensare al Nicaragua. Forse c’è stato negli anni Ottanta. Prima di te. Era un militare. Un giornalista italiano scrive che gli mostrò una foto, un ritaglio di giornale, in cui Eduardo, con occhiali da sole, col kalashnikov in mano, stava dietro a Daniel Ortega…»
«È possibile. Quando i paesi socialisti europei rifornivano di armi i paesi fratelli, c’erano degli esperti che accompagnavano la spedizione…».
«Eduardo diceva che l’uomo della foto non era lui. Era un sosia. Penso che sia vero in ogni caso. Lui è stato più volte il sosia di se stesso… Mi viene da pensare che in Nicaragua vive un sosia di Eduardo che forse è Eduardo. Me lo immagino su una spiaggia. Non so se gli piacesse il mare. Gli piacevano i bagni turchi, le saune e le piscine. E senz’altro gli piaceva tenere pochi vestiti addosso. Tu, Giorgio, vorrei che mi dicessi se c’è un posto in Nicaragua dove ti saresti rifugiato, per viverci, per nasconderti».
«A Casares, all’hotel El Casino. Era una vecchia costruzione in legno, stile coloniale: un enorme patio interno, dove si mangiava, e tutte le stanze al piano di sopra… Tra una stanza e l’altra c’erano solo divisori: i letti, i rumori, gli odori, ogni cosa sotto lo stesso grande soffitto, e anche i pipistrelli che volavano dentro. Ai piedi dei letti c’era la polverina gialla contro le zecche. Sembrava di tornare indietro di un secolo. Ricordo che servivano le langostas tamaño familiar. Ogni tanto si sentiva ovunque un sibilo, più che altro un acuto. Annunciava l’ennesima aragosta che finiva viva nella pentola dell’acqua bollente di Doña Florinda, che poi morí sotto le macerie del suo hotel. E poi si digeriva con la solita media de Flor de Caña 7 años… El Casino fu distrutto dal maremoto del 1992. Sì, sul Pacifico. L’hanno ricostruito…»
«Forse un giorno mi arriverà una cartolina dal Nicaragua».
Ogni verità sembra parte di una menzogna, dice Luisa. Ogni sua scelta sembra sfuggire a una strategia univoca: «C’è chi ritiene che ci siano strategie senza stratega. Alcuni strateghi possono essere piccoli azionisti di una strategia più grande. Chi possiede quote di una piccola strategia, che controlla a sua volta quote minoritarie di una strategia più grande, si accontenta di piccoli guadagni, strategici per lui ma solo tattici per la strategia più grande. Molti possiedono quote di una strategia, ma ignorano o non si preoccupano di sapere che questa detiene un pacchetto di azioni di un’altra».
Per moltiplicare le trame, per evocare teorie più o meno fondate, per fornire materiale a parecchi libri e fiction televisive, mi bastava andare a cercare fra le vecchie lettere, disseppellire agende, quaderni impalliditi in un cassetto.
89 dic. Budapest
Caro Alberto!
Auguri por Natale 1989
e felicita e succesi per
il nuovo anno 1990!
affetuosi abbracci
tuo
Eduardo Rózsa
Mi scriveva questa cartolina, chiusa in una busta, forse pochi giorni prima della fucilazione del dittatore rumeno Ceaușescu. Non trovavo più l’involucro, ma la cartolina, che al posto del mio indirizzo recava una faccina sorridente, doveva essere arrivata in una busta affrancata.
Tra la rivolta di Timisoara, la sollevazione popolare nella capitale della Romania e finalmente l’uccisione del tiranno, voluta da un’ampia fazione del partito comunista rumeno, passarono meno di dieci giorni. La scintilla della rivolta di Timisoara era stata la repressione poliziesca contro László Tőkés, un pastore protestante, un cittadino rumeno della minoranza ungherese, che dal 2007 siede nel Parlamento europeo.
Eduardo conosceva certamente László Tőkés, forse ce ne aveva anche parlato. Non posso sapere se avesse contatti con lui, se il pastore fosse un agente segreto ungherese, come oggi in Romania qualcuno si permette di dire. Non so se Eduardo fosse andato in quel periodo a trovarlo, quale sia stata la rilevanza dell’azione di Eduardo in quegli anni, se Eduardo lo abbia incontrato in quei giorni o in altre occasioni. Immagino che fosse una impresa difficile, rischiosa, magari superflua… Quella cartolina così buffa, tenera, innocente, scritta a penna rossa, su cui Eduardo aveva disegnato una faccina tonda, allegra, rubiconda, quella cartolina che a gennaio del 1990 mi aveva fatto sorridere, dopo più di vent’anni, ora che mi fermavo a osservare sull’altra facciata l’immagine spettrale, invernale, notturna – il disegno di una casa, la finestra sbarrata, accesa tra due grandi alberi spogli – quella cartolina mi ricordava il giorno, l’assemblea in cui l’avevo conosciuto e avevo ascoltato per la prima volta la sua denuncia della persecuzione di una minoranza etnica, la sua difesa dei magiari della Romania.
Lungo questo filo – un filo che avevo toccato, che avevo intercettato per caso, un filo che era mio, che avevo afferrato perché non ne avevo altri, perché a Eduardo arrivai così – lungo questo filo forse si collegavano, si traducevano, si scaricavano, fluivano l’uno nell’altro il prima e il dopo, il comunista, che oltre frontiera difendeva un’immagine violata del se stesso ungherese, e il nazionalista, un nazionalista ubiquo, che si separa da una potestà considerata, sentita come illegittima. Era una vicenda per certi versi simile a quella di molti attori, grandi e piccoli, del socialismo reale: ceto politico, burocrazie, militari, agenti segreti, che si erano convertiti, se si trattava di conversione, in apparenza senza trauma e tormenti interiori, talora al mercato e a interessi privati non sempre legali, talora invece al nazionalismo separatista, allo stato etnico, allo sciovinismo e alla geopolitica. Eduardo forse si era preso qualche rischio in più, dava l’impressione di svolte più inspiegabili, radicali, individuali. Ma era davvero così? Nel primo Eduardo, che difendeva i magiari rumeni dal dittatore della Romania, non si trovava già una prefigurazione dell’Eduardo futuro?
Eduardo forse era andato in Croazia per vigilare sulle frontiere di una Grande Ungheria certo defunta, sepolta, immaginaria, ma che si doveva inventare di nuovo, che poteva rinascere solo trasfigurata. La Slavonia, la regione della Croazia dove Eduardo aveva combattuto per la secessione dalla Iugoslavia, confinava con l’Ungheria. La Croazia e l’Ungheria, come l’Austria, dove Eduardo si era affiliato all’Opus Dei, dovevano tornare a essere delle nazioni cattoliche. La Croazia, una Croazia alleata, più centro-europea e meno ingombrante della Iugoslavia, era una via d’accesso al Mediterraneo per uno stato come l’Ungheria che poteva sporgersi fino al mare solo attraverso il lungo corso tortuoso del Danubio. I reduci della Guerra d’indipendenza croata avrebbero potuto seguirlo in altre imprese. La conversione all’Islam poteva servire a creare prossimità, amicizie, alleanze, magari a collegare nuovi oleodotti, con stati dell’Asia ricchi di petrolio. La missione in Bolivia, a favore dei separatisti o anche dei loro nemici bolivariani, poteva rientrare nella stessa strategia di conquista delle risorse energetiche fossili.
Dio, petrolio, patria, famiglia… L’origine è la meta. In Bolivia Eduardo doveva lacerare ma allo stesso tempo ricucire la propria intimità, doveva riparare l’ordine corrotto da quel padre che soltanto dopo il matrimonio aveva confessato alla madre di essere comunista ed ebreo. La leale, la fedele, la cattolica Nelly Flores Arias aveva amato il comunista György Rózsa. La madre non aveva accettato, come il marito le suggeriva, di rifugiarsi con i figli a Panama: aveva scelto di non allentare i vincoli della famiglia, aveva deciso di rimanere sempre al fianco del marito, di abbandonare la patria per seguirlo in Cile, in Svezia, in Ungheria…
Qui potrebbe iniziare la storia di Eduardo in un universo possibile che assomiglia abbastanza a quello in cui viviamo.
Troppo, troppo in fretta. Eccessivo come Eduardo György Rózsa Flores. Devi diffidare del troppo, ma non sai di quale eccesso si tratti. Diffida delle storie troppo chiuse e complete; di quelle troppo piene; di quelle troppo romanzesche. Dovresti trovare il tempo, il coraggio di parlarne con la sorella di Eduardo. Dovresti parlarne con Eduardo, che forse ora è vivo in Nicaragua, in Iran… Per le strade di Budapest, sul filobus o sul tram, ma per questo sarebbe meglio chiedere conferma alla memoria di Daniele, Eduardo ci diceva che Il fu Mattia Pascal era il suo romanzo italiano preferito. E ora lui è libero dal passato, si è separato da quell’identità troppo faticosa.
Voleva chiudere il libro, uscire dal romanzo. La serie era troppo lunga, poco credibile. Voleva una vita nuova, nuda, senza peso. Voleva smettere.
Nell’isola, su una spiaggia del Pacifico, Eduardo ha trovato la pace, un Venerdì lo ha rieducato a uno stato di natura vero, riposante come la morte. Le cellule si disgregano, i liquidi fluiscono, impastano la terra, gli atomi di carbonio viaggiano tra genti e mari oltre ogni frontiera. Il conflitto è nella storia, nella natura, ovunque: non dico la guerra ma il conflitto sì. Gli interessavano i conflitti tra nazioni, dice Luisa, non i conflitti di classe e di genere, che così allo stato puro, fuori dalla mente, se sei privilegiato, spesso si faticano a vedere, richiedono discrezione, autocritica più che armi, risvegliano contraddizioni che lacerano gli individui, le famiglie ma non i territori, non sempre i corpi. Non guerre tra stati; lui voleva guerre di popolo che fondano nuovi stati, spezzando quelli vecchi. Guerre per affrontare i piccoli tiranni senza decapitare la sua piccolissima tirannia.
Volevi essere un capo. Fare quel cazzo che ti pare con il silenzio assenso degli Ordini superiori, con il beneplacito del Capo supremo: Dio, la dura Necessità, il grande Alleato, la Nazione, i veri desideri del Popolo… Purché si mantenga un privilegio, un capitale di prestigio, una patente di ribelle che sa adattarsi all’ordine mondiale.
I conflitti ti andavano bene se potevi essere un eroe. Uno dei tanti non ti accontentavi di essere. Perché quelle tre ragazze italiane se la prendono con il tipo che interviene all’assemblea? Solo perché porta una maglietta su cui sono disegnate cosce e reggicalze? Per il tono arrogante? Per la mascella? Per quello che dice? Lasciatelo parlare, su ragazze, fate le brave. Non è il caso di contestare il Rettore. Ci ha invitati in gita fino a qui, ci ospita a casa sua, questa sera siamo in vacanza. Operai, donne, fabbrichette occupate, centri sociali, giovinastri dei collettivi, gruppetti di femministe, volantini di due cartelle, riunioni in ritardo, contestazioni isteriche, cortei di studenti, conflitti di classe palesi e occulti, reduci irriducibili, assemblee fumose, precari, anarchici, anarcoidi, sindacati di base, occupanti di case, gruppi di autocoscienza, frocie in movimento, antagonisti… Siete fuori dalla vera storia. C’è qualcuno che oserebbe darti torto? Avresti dovuto restare confuso fra tanti; e tanti, per te che sei una moltitudine, sono sempre troppi. Non ti potevamo assoldare in una guerra seria. Conflitti disarmati, scioperi selvaggi, vetrine infrante ma assicurate, calci negli stinchi, manganellate, sputi vaganti, slogan, balletti, qualche sasso, lividi, nasi rotti, picchetti, qualche anno di carcere, rarissimi i morti. Niente di più. Solo guerricciole senza armi automatiche. E tu eri un soldato. Eri un soldato a cui l’esercito regolare andava stretto. «Niente di più noioso che fare il soldato in tempo di pace», dicevi. E allora meglio servire in segreto, nei sotterranei, per poi uscire a combattere le guerre che ci sono e magari quelle da inventare.
A Budapest guardavo le vetrine dei negozi, che in Italia non mi interessavano più; annotavo il salario di un operaio, il costo di un’automobile. Ti chiedevo: «Gli appartamenti di quei palazzoni quanto sono grandi? Quanta gente ci abita?» Tu sorridevi, non sapevi rispondere alle mie domande filistee, e io mi giustificavo in modo maldestro, o forse con ironia, ormai chi può dirlo: «Sai, per noi, in Occidente, la casa in cui vivi è importante».
Ero un ragazzo cresciuto lontano dalla guerra. Nella mia città poteva scoppiare una bomba alla stazione, una banda di poliziotti poteva rapinare e uccidere per anni, ma niente di più. Contraddizioni, conflitti, violenze alla periferia della storia: l’ombra di un colpo di stato, la mafia, qualche omicidio politico, ma lontano dalle grandi e piccole guerre tra stati. Fin da bambino vedevo la guerra al cinema, alla tivù, nei libri illustrati, la ascoltavo nei racconti degli antenati: guerre lontane come il Vietnam e la Linea Gotica, come l’invasione degli alieni, come la fine del mondo civile dopo una guerra con armi nucleari.
«Ricordo che in pullman, mentre si andava a San Leo dal Rettore, qualcuno cantava. Lui si buttava sempre nella mischia. Stava in piedi in coda al pullman: cantava, rideva, raccontava barzellette. Si cantava di tutto. Un festival della prima stronzata che ti viene in mente. A me, con un faccia giuliva, uscì fuori: dai, cantiamo anche gli inni nazionali degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica. Credo che non ci fosse un solo studente di questi paesi. Non ti so dire. Credo di no. Forse pensavo alla parodia di un videoclip sulla pace nel mondo. We are the world. Non mi ricordo. Lui si fece serio per un attimo e mi disse quasi sottovoce che non era il caso. Lo diceva come a uno che sta facendo una gaffe. Perché? Che cosa voleva dire?»
«Non lo so, Alberto, non ne ho idea. Ci dovrei pensare».
«Tu pensi che ne faccio una questione personale… Non lo è. Ma se uno ti dice “sei un amico”, è anche un fatto personale».
Dove vivrebbe, Eduardo, se fosse ancora vivo?
Con la fidanzata, forse. Non in questa cartolina.
Si vede il Castello di Praga da un’altura, da un parco innevato. Me l’aveva scritta al tavolo di una birreria o prima di prendere sonno in un albergo. L’aveva affrancata con un bollo da mezza corona, su cui non ci sono timbri, e se l’era portata in valigia o in tasca fino a Budapest, da dove l’aveva spedita dentro una busta su cui riesco a leggere il timbro postale dell’11 gennaio 1989. Sulla cartolina, con una penna di un altro colore, aveva aggiunto: «Sono stato a Praga per Natale e Capodanno». E la data: 8 gennaio 1989.
Caro Alberto,
non me ho dimenticato
di te! Ti ricordo, e nella
mia memoria sei un amico
[illeggibile] … (peccato) e tanto lontano,
ma ho la speranza di rive-
derti un giorno… prossimo!
(Amico! Questa è la seconda
cartolina che ti escribo, espero
che la riceverai e me scriverai!)
un abrascione
tuo
Eduardo Rózsa
Scrivemi e anche enviami una
fotografia di te!
È la sua lettera più vecchia. La precedente, che dice di aver spedito, non l’ho mai ricevuta o non riesco più a trovarla. Forse giace in un archivio della Repubblica Ceca o magari in un cassetto, a casa mia o di Daniele.
Dal Nicaragua non riceverò, non riceveremo mai una lettera. Eduardo non scriverà dall’isola del Pacifico del romanzo di Michel Tournier di cui ci raccontò la storia. Eduardo è morto, ma se anche fosse vivo, più che mai vivo sulla spiaggia più selvaggia del Pacifico, non avrebbe nessuna buona ragione, né il tempo né il desiderio, per scriverci.
Questo pensavo, ricordavo e mi aiutava a ricordare Daniele. Questo raccontavo alla mia compagna. Questo discutevo con Giorgio e con Luisa, finché non ho trovato una sua lettera.
Non era nella buchetta della posta, non era la prova che Eduardo è ancora vivo chissà dove. L’avevo cercata ancora una volta nei soliti cassetti. Avevo rovistato in quelle urne, in quei loculi di colombario che conservano i resti di molti incontri casuali, amicizie spente, frammenti di vecchie conoscenze, polvere di carta, ombre del futuro. Questa volta non mi ero soffermato su ogni brandello di carta, sui volantini consumati, sui biglietti d’auguri, su ogni cartolina ricevuta, sulle lettere scritte a metà e mai spedite. Avevo invece cercato quella sola lettera con una certa ansia, con fretta minuziosa, senza mettermi comodo a sedere, senza il gusto di fermarmi a ricordare chi fosse, che faccia avesse quel nome che a prima vista non mi diceva più niente.
Ecco, l’avevo trovata.
Ma non era la prima lettera che Eduardo diceva di avermi spedito nel dicembre del 1988. Era una lettera dell’anno successivo. Era solo una busta vuota. L’involucro vuoto che aveva custodito le parole, che conoscevo già, di quella cartolina in cui Eduardo, con ortografia incerta, mi augurava successi e felicità per il 1990, mi abbracciava con affetto, mi sorrideva con una buffa imitazione della sua faccia larga e allegra.
Avrei potuto inventarla questa lettera nascosta, rubata, smarrita, rivelatrice, esotica. Avrei potuto inventare altri futuri, inesistenti, del suo passato, e parlarvi di una lettera, minacciosa o consolatoria, giunta fino a me da un rifugio lontano. Avrei potuto rivelare dove Eduardo Rózsa Flores, che negli anni ha cambiato volto e nome, che non è più l’uomo che ho conosciuto, se mai lo è stato, mi ha confessato di vivere ora.
Mentirei. Ho trovato solo una busta vuota su cui un giorno Eduardo scrisse il mio nome e il mio indirizzo. E da qui potrei tornare a raccontare le nostre storie agli amici, ai compagni, alle compagne vicine, lontane, disperse tra le agende di un cassetto. Potrei raccontare quello che non so, quello che ho dimenticato, quello che ancora non mi hanno detto, quello che forse ho taciuto.
 Mentre a Panama è in corso la VII Cumbre de las Américas (Vertice delle Americhe) a cui partecipano 35 paesi, tra cui Cuba, per la prima volta, il Venezuela e gli Stati Uniti, proponiamo di seguito il video: “Incontro con Aleida Guevara March: la hija del Che“. E’ un’intervista a cura di Raùl Zecca Castel e Adriano Zecca. Membro del Corpo Diplomatico Cubano e medico pediatra a L’Avana, Aleida Guevara March, figlia primogenita del Comandante Ernesto “Che” Guevara, risponde ad alcune domande circa i rapporti [...]]]>
Mentre a Panama è in corso la VII Cumbre de las Américas (Vertice delle Americhe) a cui partecipano 35 paesi, tra cui Cuba, per la prima volta, il Venezuela e gli Stati Uniti, proponiamo di seguito il video: “Incontro con Aleida Guevara March: la hija del Che“. E’ un’intervista a cura di Raùl Zecca Castel e Adriano Zecca. Membro del Corpo Diplomatico Cubano e medico pediatra a L’Avana, Aleida Guevara March, figlia primogenita del Comandante Ernesto “Che” Guevara, risponde ad alcune domande circa i rapporti [...]]]>
 Mentre a Panama è in corso la VII Cumbre de las Américas (Vertice delle Americhe) a cui partecipano 35 paesi, tra cui Cuba, per la prima volta, il Venezuela e gli Stati Uniti, proponiamo di seguito il video: “Incontro con Aleida Guevara March: la hija del Che“. E’ un’intervista a cura di Raùl Zecca Castel e Adriano Zecca. Membro del Corpo Diplomatico Cubano e medico pediatra a L’Avana, Aleida Guevara March, figlia primogenita del Comandante Ernesto “Che” Guevara, risponde ad alcune domande circa i rapporti tra Cuba e Stati Uniti, circa la controversa figura della blogger Yoani Sanchez, l’embargo e l’eredità politica ed umana lasciata dal padre.
Mentre a Panama è in corso la VII Cumbre de las Américas (Vertice delle Americhe) a cui partecipano 35 paesi, tra cui Cuba, per la prima volta, il Venezuela e gli Stati Uniti, proponiamo di seguito il video: “Incontro con Aleida Guevara March: la hija del Che“. E’ un’intervista a cura di Raùl Zecca Castel e Adriano Zecca. Membro del Corpo Diplomatico Cubano e medico pediatra a L’Avana, Aleida Guevara March, figlia primogenita del Comandante Ernesto “Che” Guevara, risponde ad alcune domande circa i rapporti tra Cuba e Stati Uniti, circa la controversa figura della blogger Yoani Sanchez, l’embargo e l’eredità politica ed umana lasciata dal padre.
Oltre ai temi in agenda relativi alla migrazione centroamericana e messicana verso gli USA, alla sicurezza, alla salute, all’istruzione e alla democrazia, i punti politicamente delicati del vertice interamericano sono le negoziazioni tra Stati Uniti e Cuba in questa fase di relativo”disgelo” tra i due paesi e, dall’altra parte, le sanzioni americane contro funzonari di governo del principale alleato di Cuba, il Venezuela, che è stato definito dal governo USA come una “minaccia” per la sua sicurezza nazionale. La politica di Obama punta all’avvicinamento con la Cuba di Raul Castro ma contemporaneamente all’indurimento delle relazioni con il governo venezuelano di Nicolas Maduro.
]]>
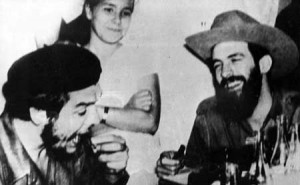 [Da Cuba, un ricordo del rivoluzionario Camilo Cienfuegos, K100, nato a L’Avana il 6 febbraio 1932 e scomparso nell’Oceano Atlantico (?) il 28 ottobre 1959]
[Da Cuba, un ricordo del rivoluzionario Camilo Cienfuegos, K100, nato a L’Avana il 6 febbraio 1932 e scomparso nell’Oceano Atlantico (?) il 28 ottobre 1959]
Porta il nome che fu di Bolívar e passeggia lento intorno alla statua. Il cielo è scuro, il mare agitato e l’acqua s’infrange violenta sugli scogli. L’esplosione schizza gocce fini come aghi sul volto del vecchio e scalfisce lo strato di sale che lo ricopre. Il grande cappello, lo stesso che indossa la statua di [...]]]>
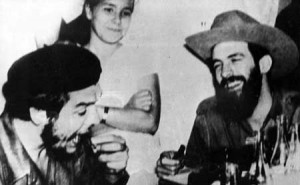 [Da Cuba, un ricordo del rivoluzionario Camilo Cienfuegos, K100, nato a L’Avana il 6 febbraio 1932 e scomparso nell’Oceano Atlantico (?) il 28 ottobre 1959]
[Da Cuba, un ricordo del rivoluzionario Camilo Cienfuegos, K100, nato a L’Avana il 6 febbraio 1932 e scomparso nell’Oceano Atlantico (?) il 28 ottobre 1959]
Porta il nome che fu di Bolívar e passeggia lento intorno alla statua. Il cielo è scuro, il mare agitato e l’acqua s’infrange violenta sugli scogli. L’esplosione schizza gocce fini come aghi sul volto del vecchio e scalfisce lo strato di sale che lo ricopre. Il grande cappello, lo stesso che indossa la statua di pietra, nulla può contro l’attacco del mare. Il vecchio alza lo sguardo e inizia a parlarmi: «era il mio onomastico il giorno che se fue ma diedero l’allarme soltanto l’indomani. Lo annunciarono per radio».
Si dà notizia attraverso questo mezzo all’opinione pubblica, che nel giorno di ieri, 28 ottobre, alle 6:01 del pomeriggio è partito dall’aeroporto di Camaguey, l’aereo bimotore delle FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), modello Cessna 310 No. 53 da cinque posti, in direzione L’Avana, trasportando il Capo dello Stato Maggiore dell’Ejército Rebelde, Comandante Camilo Cienfuegos che viaggiava accompagnato dal pilota del suddetto aereo, Primo Tenente Luciano Fariñas Rodríguez e dal soldato ribelle Félix Rodríguez, i quali disgraziatamente, non sono arrivati a destinazione.
Le ricerche effettuate fino ad ora, quelle che si sono continuate oggi in tutta l’area tra L’Avana e Camaguey, sono risultate infruttuose. La presenza di temporali a quell’ora tra Ciego de Avila e Matanzas, può aver procurato un qualche incidente, supponendosi che sia accaduto in un punto a nord della provincia di Camaguey, Las Villas, Matanzas. Le FAR, supportate dall’aviazione civile e da unità dell’Ejército Rebelde, si sono sforzate nella giornata di oggi, per trovare l’aereo scomparso.
«Io non ci credevo, non ci potevo credere. Mi ripetevo che non poteva averlo ucciso uno stupido temporale. L’uragano Ike nel 2008 non è neppure riuscito a scalfire la sua statua e vuoi che una stupida tempesta a largo di Gibara abbia scaraventato il suo Cessna in mare? A me non la raccontano. E poi quel giorno un caccia con a bordo un ex ufficiale di Batista ha sorvolato Cuba, è atterrato sull’isola per rifornirsi e ha ripreso il volo verso la Florida..»
«Quanti anni hai ragazzo?», ventisette. Borbotta qualcosa, quel numero sembra averlo irritato. Mi domando perché, ma non vado oltre i volti di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e di quello stronzo di Dave, che mi ha regalato un quadretto con le loro foto per il mio ventisettesimo compleanno.
Ritorno in un lampo con la mente in terra cubana, il vecchio è partito a raccontare, non aspettavo altro: «Gibara non era più riconoscibile dopo il passaggio dell’uragano, il Malecón completamente cancellato, le strade piene di fango e detriti di ogni genere. La statua di Camilo è l’unico baluardo rimasto in piedi in mezzo alla devastazione. La sola immagine verticale che ricordo della costa di Gibara».
 «Lo vedi il cappello che ho indosso? L’ho comprato prima del triunfo, barattandolo con la yuca del mio orto! È identico al suo», mi dice indicando la statua, «mi protegge dal mare quando vado a pescare». «E ha protetto anche Camilo al passaggio di Ike!». Sorrido e ironico gli dico che ora capisco perché lo sguardo del guerrigliero non è voltato verso il mare, in questo modo il cappello lo protegge! Ride di gusto, «Esattamente fratello! Proprio per questo, è quel fottuto cappello da far west che gli ha parato il culo!» Poi lo sguardo si fa duro per ammorbidirsi rapidamente in un riso amaro, «prima di ammazzarlo gliel’hanno sicuramente strappato di dosso, non l’ha ucciso una stupida tempesta ma i potenti mezzi del nemico: i radar, gli aerei da guerra di ultima generazione e il loro odio. Non una tempesta ma l’uragano a stelle e strisce».
«Lo vedi il cappello che ho indosso? L’ho comprato prima del triunfo, barattandolo con la yuca del mio orto! È identico al suo», mi dice indicando la statua, «mi protegge dal mare quando vado a pescare». «E ha protetto anche Camilo al passaggio di Ike!». Sorrido e ironico gli dico che ora capisco perché lo sguardo del guerrigliero non è voltato verso il mare, in questo modo il cappello lo protegge! Ride di gusto, «Esattamente fratello! Proprio per questo, è quel fottuto cappello da far west che gli ha parato il culo!» Poi lo sguardo si fa duro per ammorbidirsi rapidamente in un riso amaro, «prima di ammazzarlo gliel’hanno sicuramente strappato di dosso, non l’ha ucciso una stupida tempesta ma i potenti mezzi del nemico: i radar, gli aerei da guerra di ultima generazione e il loro odio. Non una tempesta ma l’uragano a stelle e strisce».
Le sue parole fanno eco a quelle di Ernesto Che Guevara, grande amico di Camilo, che all’indomani della sua morte scriverà: «Lo ha ucciso il nemico, lo ha ucciso perché voleva la sua morte. Lo ha ucciso perché non ci sono aerei sicuri, perché i piloti non possono acquisire tutta l’esperienza necessaria, perché sovraccarico di lavoro voleva essere a L’Avana in poche ore».
Diretta o indiretta la responsabilità è del nemico e questo il Che lo ha già messo in chiaro. Ma la penna continua a scorrere sul foglio spinta dalla rabbia che lo logora. Ernesto conosce bene Camilo e si riconosce nelle sue azioni sprezzanti del pericolo. Scatta l’ammonimento rabbioso e fraterno, indirizzato tanto al compagno scomparso quanto a se stesso: «…e lo ha ucciso il suo carattere: Camilo non considerava il pericolo, lo utilizzava come divertimento, giocava con lui, toreava con lui, lo attirava e lo maneggiava; nella sua mentalità di guerrigliero una nube non poteva fermare o deviare un percorso tracciato».
Inizia a piovere, una pioggia finissima. «Cos’hai da fare ragazzo? Casa mia è proprio dietro quel rudere, vieni che ci mangiamo un po’ di yuca». Acconsento, felice dell’invito. Poi si ferma di scatto e mi intima di alzare lo sguardo verso la statua: «prima guardala bene!», mi redarguisce. «Non vedi che c’è qualcosa che proprio non torna?!» Non riesco a capire, rimango in silenzio, «seguimi su andiamo!» Mi indica un cumulo di legni imbruniti e mattoni spezzati: «quella era casa mia prima che ci facesse visita Ike».
La nuova dimora è di legno pitturato di verde e giallo. Entro impaziente di gustare la yuca, sorseggiare l’immancabile succo naturale e ascoltare i suoi racconti. Ma il vecchio è più impaziente di me, non faccio in tempo a oltrepassare la soglia che lo vedo accucciarsi e ravanare in uno scassato mobile di legno. Si rialza con un grosso album in pelle fra le mani. Scorgo una scritta ma non riesco a metterla a fuoco, poi il vecchio toglie la polvere dalla copertina con un colpo di manica e la scritta appare più nitida: “rebeldes”, la “r” è minuscola.
Mi guarda con un sorriso condito d’orgoglio e prova a spiegarmi: «per anni ho collezionato le immagini e le fotografie dei rivoluzionari di mezzo mondo». Mi invita a sedere e poggia l’album sulle mie gambe: «sfoglialo ragazzo». Lo apro con cura e attenzione. Non faccio in tempo a sorridere alla vista di Emma Goldman e Vladimir Il’ič Ul’janov (alias Lenin) che il vecchio m’incalza: «guarda i loro volti, osserva la loro severità». Poi vedo Pancho Villa, ma ne ha anche per lui: «non si può dire che Villa non sorrida in queste foto, ma guardalo bene, lo fa solo con gli occhi! I denti non glieli vedi mai!» Mi prende l’album e gira un bel malloppo di pagine, «e anche gli zapatisti! Il subcomandante Marcos e i suoi compagni sorridono solo con gli occhi, non possono fare altrimenti! Loro sì che potrebbero fare concorrenza a Camilo, ma il passamontagna glielo impedisce!»
«Ora ripensa alla statua e guarda queste foto», apre due facciate di fotografie di Camilo Cienfuegos. «Cos’è che non torna ragazzo?» La statua non sorride. «Esattamente ragazzo! Li riesci a contare tutti quei denti su queste pagine?! Li riesci a contare?!», urla in una fragorosa risata. «Camilo è stato il rivoluzionario più sorridente della storia dei rivoluzionari! Ogni volta che vedo una sua foto, penso al suono di quella risata, quasi la posso sentire. E questi incapaci non sono neppure in grado di scalpellare una statua che ride. Hanno appeso il suo volto anche in Plaza de la Revolución, vicino a quello del Che, e anche in quel caso sono riusciti a non farlo sorridere! Ma io dico, lo capiscono o no che quella di Camilo è una rivoluzione nella rivoluzione! È sufficiente sfogliare questo benedetto album per accorgersene!»
 Il vecchio si è infervorato, «scusa lo sfogo ragazzo, ma queste cose mi fanno imbestialire». Non posso fare nient’altro che sorridere e ringraziarlo. Ci dimentichiamo della yuca e ci nutriamo di rivoluzionari. Tutti dovrebbero avere in casa un album come questo, penso. Dovrei cominciare a farlo anch’io, dico. Il vecchio sorride. Vedo le figure di Hatuey e Zumbi, due tra i leggendari ribelli delle Americhe. Il primo lottò sull’isola di Española e a Cuba per la cacciata degli spagnoli, il secondo fu l’ultimo leader del Quilombo dos Palmares, storico avamposto resistente in terra brasiliana. Volto la pagina e passiamo in rassegna i mambises: Carlo Manuel de Céspedes, Máximo Gómez e Antonio Maceo, poi i vietnamiti Ho Chi Minh e Võ Nguyên Giáp e gli africani Thomas Sankara e Stephen Biko. Non posso fare a meno di sorridere ancora quando tra le pagine ingiallite incontro le facce di John Reed e Fela Kuti!
Il vecchio si è infervorato, «scusa lo sfogo ragazzo, ma queste cose mi fanno imbestialire». Non posso fare nient’altro che sorridere e ringraziarlo. Ci dimentichiamo della yuca e ci nutriamo di rivoluzionari. Tutti dovrebbero avere in casa un album come questo, penso. Dovrei cominciare a farlo anch’io, dico. Il vecchio sorride. Vedo le figure di Hatuey e Zumbi, due tra i leggendari ribelli delle Americhe. Il primo lottò sull’isola di Española e a Cuba per la cacciata degli spagnoli, il secondo fu l’ultimo leader del Quilombo dos Palmares, storico avamposto resistente in terra brasiliana. Volto la pagina e passiamo in rassegna i mambises: Carlo Manuel de Céspedes, Máximo Gómez e Antonio Maceo, poi i vietnamiti Ho Chi Minh e Võ Nguyên Giáp e gli africani Thomas Sankara e Stephen Biko. Non posso fare a meno di sorridere ancora quando tra le pagine ingiallite incontro le facce di John Reed e Fela Kuti!
Nel 1953 Camilo Cienfuegos ha ventuno anni quando emigra negli Stati Uniti alla ricerca di un lavoro che possa migliorare la sua condizione sociale e sostentare la sua famiglia. Presto si rende conto che l’impresa è ardua, che gli sfruttati stanno da una parte e gli sfruttatori dall’altra, così a Cuba come negli States. Mantiene però sempre un’ironia sdrammatizzante che conserverà tra le montagne della Sierra Maestra e si paleserà nella corrispondenza con il Che. Camilo si diverte a giocare con le parole come nella lettera inviata ai suoi cari da Kansas City, nella quale trasforma un nome proprio di città americana in un aggettivo in lingua spagnola, aiutato dalla sistematica omissione delle “s” da parte dei cubani: «good morning queridos viejos y hermanos acabamos de arribar a esta bonita ciudad de Kansas un poco KANSADOS después de 7 horas de viaje». E nelle lettere inviate al Che quando non lo sfotte ironicamente firmandosi “tu eterno chicharrón” o “tuo ammiratore segreto”, opta per utilizzare la sigla K-100, ovvero Ca-Cien.
Poi il visto turistico scade e Camilo continua a lavorare clandestinamente finché le autorità non lo rispediscono a Cuba. Sull’isola resta il tempo di partecipare a una manifestazione studentesca, farsi bastonare dalla polizia ed essere ricoverato in ospedale per le ferite riportate a una gamba. Poi riparte per gli States dove rimane dal marzo al settembre 1956, quando decide di raggiungere gli esuli cubani in Messico. Qui incontra Fidel, Guevara e altri settantanove compagni pronti a tutto per liberare Cuba dalla dittatura batistiana. Sono il manipolo di idealisti che il 2 dicembre 1956 innescano la miccia della Revolución, gli ottantadue guerriglieri che partecipano alla rocambolesca spedizione del Granma arenatasi tra i fondali paludosi e le mangrovie nei pressi di Playa Las Coloradas. Camilo è l’ultimo ad aggregarsi alla ciurma e il primo, insieme a Ernesto Che Guevara, a entrare a La Habana il 2 gennaio 1959.
Si è fatto tardi. «Mi dispiace non averti cucinato la yuca». Corre nell’altra stanza, sento dei rumori. Torna e mi porge un sacchetto pieno di yuca. Poi mi ordina: «domani portalo al commesso de El Rapido e chiedigli in cambio un cappello uguale a quello di Camilo. Sarà un bel ricordo di Cuba».
Ci stringiamo la mano con due grossi sorrisi sulla faccia, poi il vecchio si toglie il cappello e finisce il racconto: «era il 28 ottobre 1959, sia io che K-100 avevamo ventisette anni quando lui se fue, ora li hai tu ragazzo e Camilo non è ancora morto. Rinasce ogni 6 febbraio con i denti ben in vista e il cappello in testa».
Accompagnamento musicale (e fotografico): C. Puebla, Canto a Camilo, 1960.
]]>