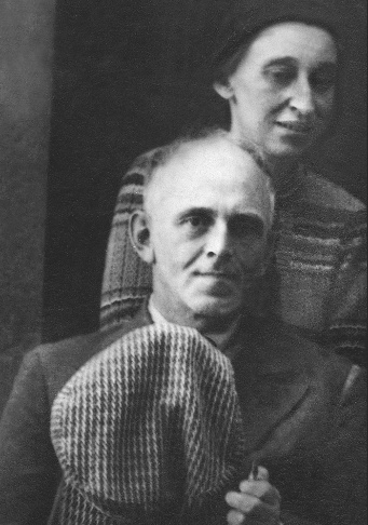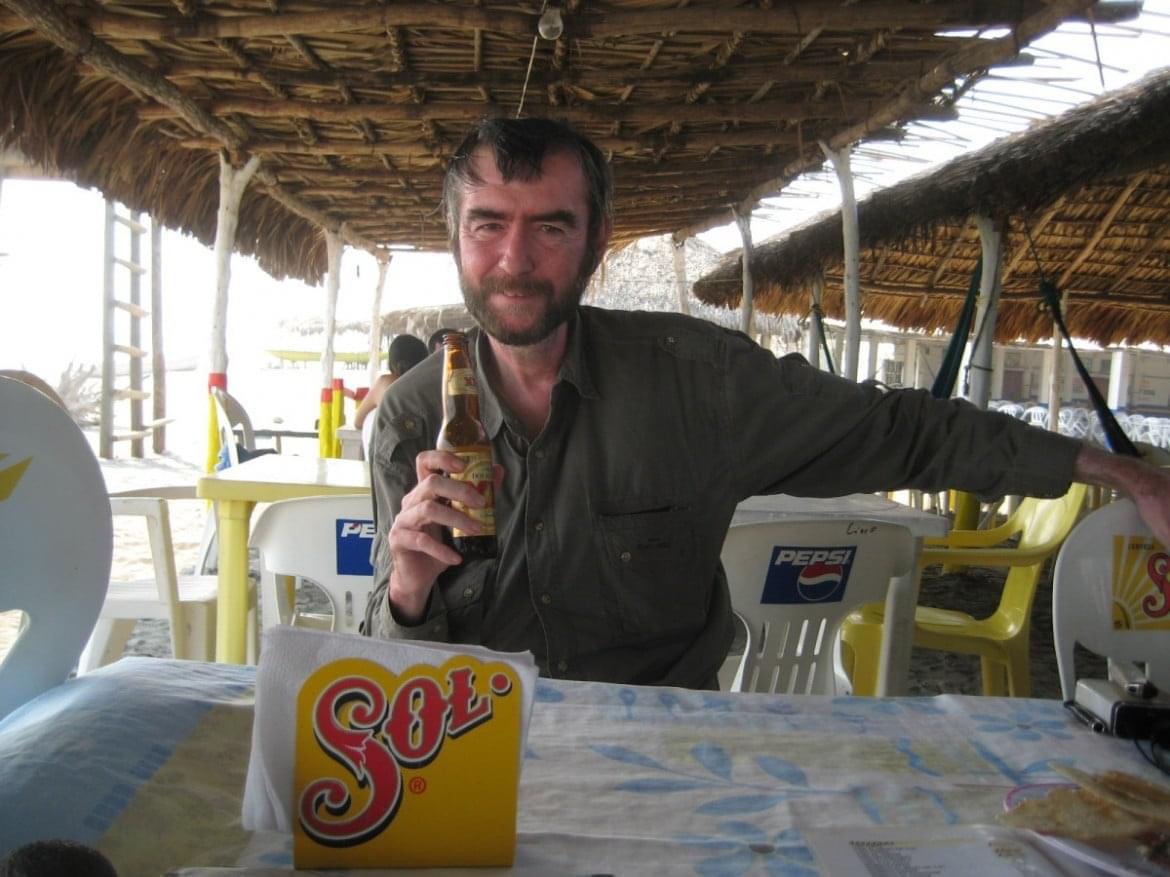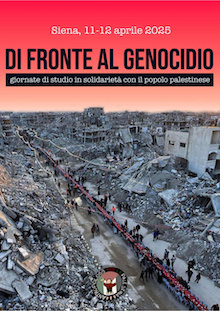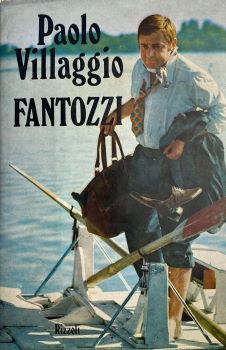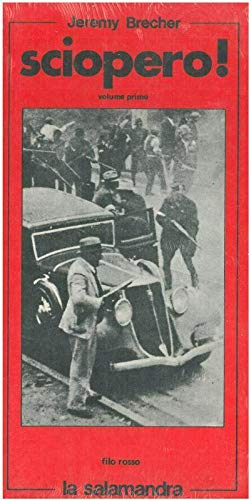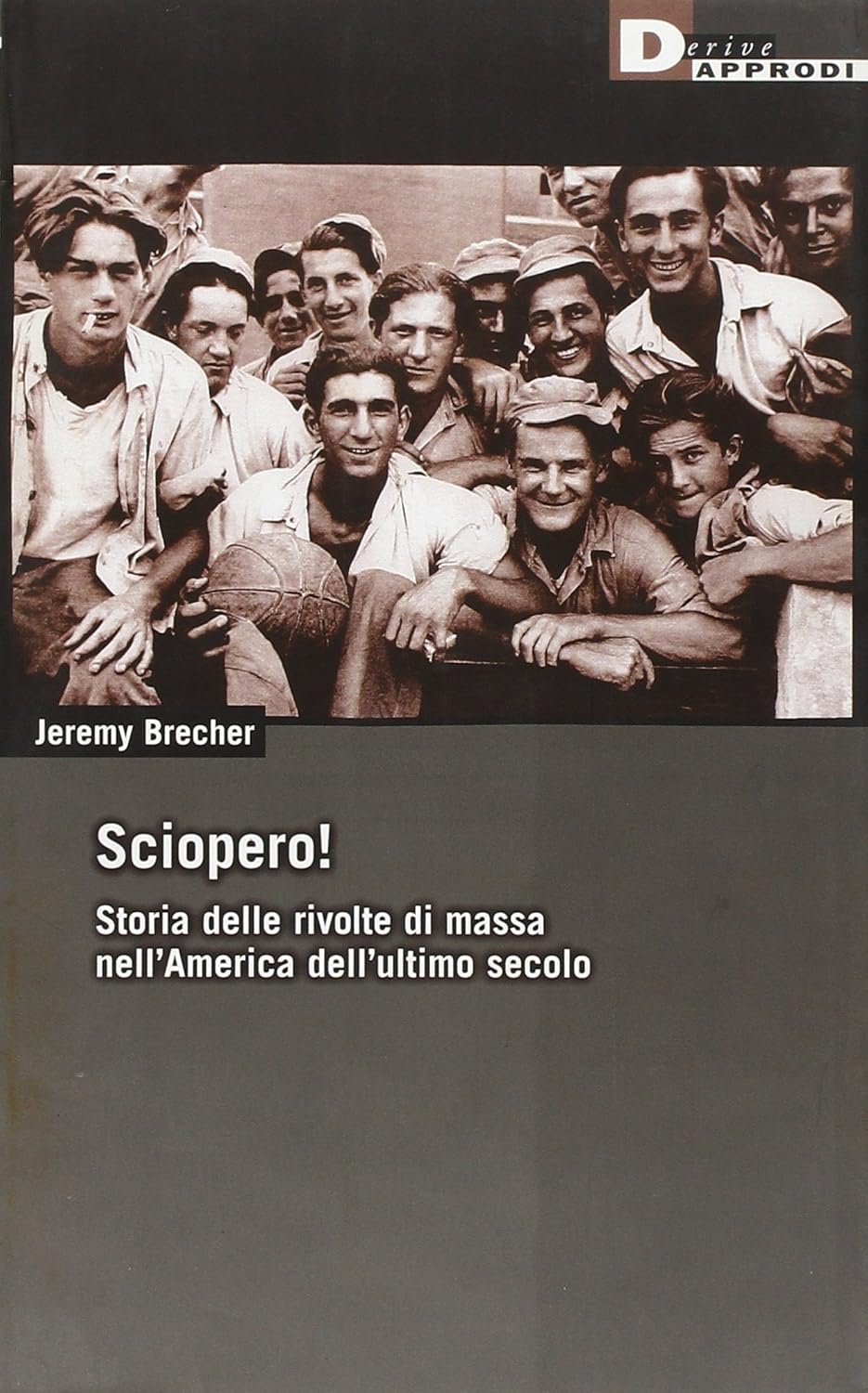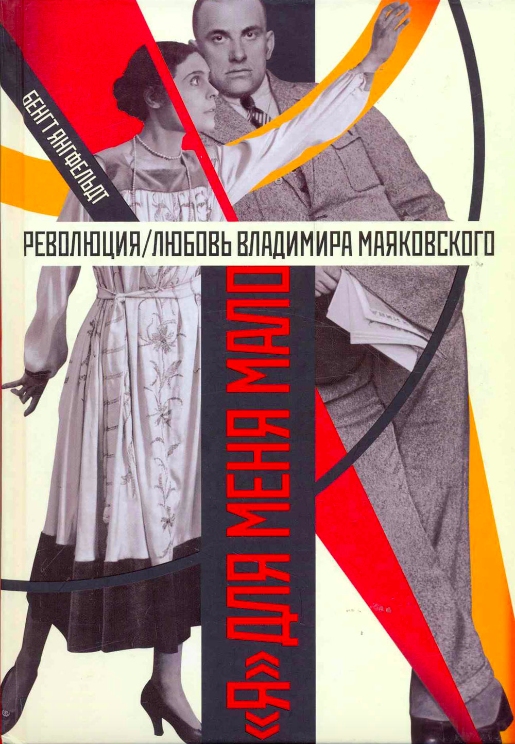 Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo [...]]]>
Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo [...]]]>
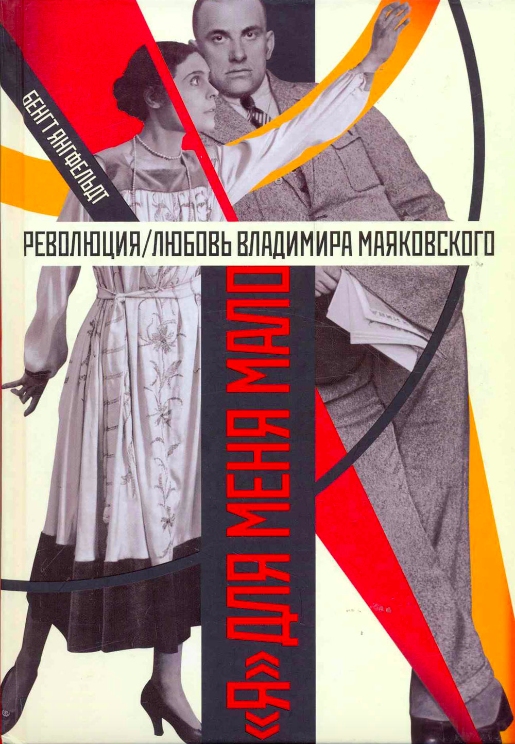 Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo gesto suicidario non era né di resa né di sconfitta, ma annunciava l’impossibilità di accettare che la poesia venisse relegata in uno spazio che non poteva essere abitato secondo le aspirazioni e la prassi di un vero poeta: impossibile continuare a vivere in questo «tradimento».
Quando Vladimir Vladimirovič Majakovskij si tolse la vita, Josif Mandel’štam era in Armenia, la sua «terra promessa». Fu in quel momento che quest’ultimo venne a conoscenza della scomparsa del poeta simbolo della Rivoluzione d’Ottobre. Per Mandel’štam fu la conferma di ciò che aveva sempre sentito dentro di sé: quel mondo in cui ancora in molti credevano ciecamente era definitivamente mutato. La «speranza», come in tutte le rivoluzioni che si rispettano, tramonta in un lasso di tempo quasi immediato e si trasforma in un incubo di uccisioni e terrore. Il messaggio rivolto da Majakovskij ai posteri con il suo gesto suicidario non era né di resa né di sconfitta, ma annunciava l’impossibilità di accettare che la poesia venisse relegata in uno spazio che non poteva essere abitato secondo le aspirazioni e la prassi di un vero poeta: impossibile continuare a vivere in questo «tradimento».
Quasi parallelamente lo stesso Mandel’štam vagava come già morto, in quel luogo bianco, senza strade, senza cieli, senza quotidiano, rappresentato dai versi delle sue incredibili poesie. Majakovskij era stato invece un militante coerente alla sua scelta rivoluzionaria, che non amava «pettegolezzi», sensi di colpa e quella ricerca ossessiva di responsabili verso cui lanciare anatemi per scagionare, forse, se stessi. Così chiosò nel suo testamento di morte: «come si dice, l’incidente è chiuso. La barca dell’amore si è spezzata contro il quotidiano. La vita e io siamo pari. Inutile elencare offese, dolori, torti reciproci». I due poeti ebbero una vita completamente diversa nel vissuto, ma ambedue furono traditi, in modalità differenti, dai valori della rivoluzione. La dimostrazione è nella prassi delle loro esistenze dove si riscontrano, tuttavia, la stessa ferrea coerenza e lo stesso intangibile amore per la poesia.
Si può accettare il tradimento di un’utopia, divenuta realtà seppur in un lasso di tempo breve, di un mondo più giusto e solidale? La realtà e Majakovskij avevano raggiunto le stesse aspettative, realizzato le medesime battaglie, ma l’incantesimo si era spezzato. Il gesto eclatante, simbolico, perfettamente in simbiosi con la vita, era il colpo di rivoltella che, diretto al cuore, glielo avrebbe schiantato. Era il 14 aprile del 1930. Nessuna importanza si ritrova nell’idea e nella ricerca che il suicidio potesse essere stato una messinscena ordita da sinistri agenti di Stalin se non per pura cronaca, come sarebbe capitato negli anni a seguire ad altri personaggi uccisi per mandato di questo mostruoso uomo che incarnava il senso del più bieco potere. Dal canto suo Mandel’štam scrisse un poemetto dal titolo Il montanaro del Cremlino, dichiarando così apertamente di essere disponibile al «suicidio», quello per mano degli sgherri di Stalin: atto puntualmente perpetrato da anonimi aguzzini e laidi carcerieri durante il trasferimento da un campo di transito vicino a Vladivostok, sulla strada verso il gulag di Kolyma, dopo essere stato imprigionato per attività controrivoluzionaria, a temperature disumane. Il poeta morì probabilmente di assideramento, malato, e gettato in una fossa comune il 27 dicembre del 1938 insieme ad altri malcapitati, senza la possibilità che il suo corpo fosse mai più ritrovato. Pochi giorni prima aveva scritto una missiva, un ultimo testamento sulle condizioni che lo stalinismo riservava a poeti come lui: «Sono ridotto allo stremo – quasi irriconoscibile».
Le morti di Majakovskij e di Mandel’štam rappresentano la certezza che la poesia e il potere non possono avere ontologicamente alcuna simmetricità, né un lontanissimo punto di incontro, neppure la possibilità di sfiorarsi. Le vite dei poeti, diverse e agite in modalità lontane nel sentire e nei gesti, hanno in realtà un comune destino, la stessa ellissi di negazione, di asimmetricità, e l’emersione di un’idea del potere che deraglia dall’umano, lo tradisce, lo soffoca. Gli amici Šklovskij, Rodcenko, Pasternak, Tatlin non si aspettavano il gesto di Majakovskij; lui, così virile nella lotta di militante comunista, se ne andava senza far apparire niente a nessuno: disagio, depressione, angoscia, nulla di nulla. Proprio questa condizione di normalità invece prova la veridicità del gesto, la sua «consapevole» testimonianza, la coerenza di non voler e dover tradire la poesia per gettarla alla mercé di filistei meschini e personaggi «iscariotici» partoriti da quella rivoluzione che aveva realizzato, come accadde durante le settimane della Comune francese, le speranze di eguaglianza di una storia emblematica per tutta l’Umanità. Le sue invettive contro il «tradimento» si leggevano fra le righe delle opere ultime, come La cimice (1928) e Il bagno (1929), quest’ultima scritta un anno prima della sua tragica scomparsa.
Fu Pasternak che comprese più di tutti il simbolico epilogo dell’amico, a cui diresse un meraviglioso poema che ne esaltava il poeta e l’uomo: «Il tuo sparo fu simile a un Etna in un pianoro di codardi!» È condivisibile l’idea che Majakovskij non avesse alcuna familiarità con la politica, non ne conosceva i meccanismi autoritari, le ambiguità, né avrebbe mai potuto accettare di essere complice di assurde dinamiche del potere. Per Majakovskij la poesia e la rivoluzione andavano di pari passo: erano due scintille, due fuochi. Al contrario, nella solitudine e nella stasi, Mandel’štam aveva avvertito subito la deriva della rivoluzione, la sua ritualità, il partito come spazio metafisico, il disimpegno dall’umano: aveva percepito che sarebbe arrivato il momento dell’inevitabile erosione dei valori rivoluzionari, soffocanti, estenuanti, ingiusti, disumani, avvinghiati alla burocrazia per esaltare, infine, una forma di un autoritarismo senza appello. Per Majakovskij, scomparso così prematuramente, il popolo nutriva un amore smisurato come smisurato è il tono della sua poesia, deflagrante, meravigliosa, dirompente, tanto da rappresentare per lo stesso Pasternak una sorta di devozione/ossessione senza precedenti. La prova risiede nelle citazioni copiose di quest’ultimo, ad esempio nel libro Il salvacondotto, che si chiude con la morte del poeta: «Quando tornai là, di sera, era già nella bara… gli altri lottavano, sacrificavano la vita e creavano oppure sopportavano sconcertati, ma erano pur tuttavia gli indigeni di un’epoca passata e, nonostante le differenze, erano conterranei da essa imparentati. Solo a lui la novità del tempo scorreva climaticamente nel sangue». Fu Pasternak per primo, infatti, a smascherare il «tradimento» subito da Majakovskij.
Immaginare il poeta come il «rappresentante culturale» e l’intellettuale organico di quel Paese, subito dopo il sogno spezzato della rivoluzione, può ritenersi addirittura un’infamia. I vertici del partito furono ben consapevoli della fascinazione subita dal popolo per un poeta come Majakovskij: fu così che cominciarono a utilizzarlo, sventolarlo, proporlo come il cantore e il canone poetico dei Soviet, naturalmente nella forma decurtata di quella disillusione che ne avrebbe reso la poesia inaccettabile per il regime. Un’ingiustizia per chi ama la poesia, il disagio e la fragilità di accondiscendere agli strumenti del potere. E fu proprio Pasternak, così intelligente e sensibile nel comprendere che cosa stava accadendo, a scrivere una lettera a Stalin con fare «poco coraggioso», ringraziandolo per la liberazione dei familiari della Achmatova verso i quali si era prodigato e aveva «rischiato» personalmente di insospettire il satrapo. Nello stesso momento aveva altresì ringraziato il dittatore di aver messo «Majakovskij al primo posto…» Ma Pasternak, che aveva visione politica e comprensione chiara di quello che stava accadendo, sapeva perfettamente che l’operazione cinica di Stalin riguardo alla figura e all’opera del poeta avrebbe portato col tempo a un disconoscimento della sua poesia: quest’ultima doveva essere «riprodotta» come rivoluzionaria in un momento di stabilizzazione del potere, dove al posto delle idee venivano ormai proposte purghe, gulag e uccisioni di massa. L’operazione di delegittimazione verso l’opera del poeta, dunque, era cominciata silente e ben organizzata, facendola sembrare invece un’alta legittimazione rivoluzionaria e comunista.
Determinanti per la conoscenza e la divulgazione postuma dei due poeti furono le loro compagne di vita e muse ispiratrici: Lilja Brik, nel caso di Majakovskij, e Nadežda Khazina, per Mandel’štam, alla quale dobbiamo anzi in modo esclusivo la conoscenza che abbiamo oggi dell’opera straordinaria del poeta. Le sue poesie erano state vietate dal regime sovietico: un gesto a mio modo di vedere criminale e insensato, come lo sono stati la «negazione» di una sepoltura, la cancellazione del corpo e della persona. Perseguitato e vessato, Mandel’štam non aveva arretrato dalle sue posizioni di opposizione solitaria neppure di un millimetro, con il coraggio dei poeti: costui era folle di umanità, di creatività, di coraggio e, per questo, odiatissimo dal potere. A differenza di Majakovskij, il candore di Mandel’štam risiedeva nella sua indifferenza alla fama, così concentrato sulla ferma volontà di rimanere per sempre esule, come negli anni seguenti capiterà prima della caduta del muro di Berlino a Josif Brodskij. Nadežda conosceva perfettamente l’impeto intellettuale e la statura etica del suo compagno, sapeva quale trattamento gli avrebbero riservato, prevedeva la tragica conclusione e nascondeva i suoi versi nella federa di un cuscino, quando di tanto in tanto i torturatori di Stalin le facevano visita a casa.
Fu il 1° maggio del 1919 che Mandel’štam conobbe la pittrice di origini ebraiche Nadežda Khazina, figlia di una delle prime donne medico della storia della Russia e di un avvocato: si sposarono nel 1922 a Kiev. Nadežda, che significa «speranza», resterà per sempre fedele al poeta anche quando Osip ormai non ci sarà più. La poetessa Anna Achmatova, legata da vincoli di amicizia profondi alla coppia Mandel’štam, dirà dell’amico «martire»: «Osip amava Nadja in modo incredibile, inverosimile… Non permetteva a Nadja di allontanarsi da lui neanche di un passo; non le dava la possibilità di avere un lavoro; era follemente geloso; le chiedeva consigli su ogni parola dei suoi versi». Forse l’unico aspetto negativo che Achmatova sottolinea dell’amico geniale era la sua gelosia in questo rapporto amoroso e letterario senza precedenti. Nadežda Mandel’štam morirà il 29 dicembre del 1980, a Mosca, dove aveva fatto ritorno nel 1964 dopo essere stata in esilio per molti anni. Nadežda è una scrittrice sopravvissuta a Stalin, ai suicidi, alle uccisioni dei sicari, al potere dittatoriale, e ha sempre rappresentato una spina nel fianco al regime sovietico. Nel suo appartamento, si racconta, ebbe a ospitare proprio tutti: poeti, fuggiaschi, perseguitati, derelitti. Due grandi immagini nei racconti di chi l’ha conosciuta ben la rappresentano: una appartiene a Josif Brodskij e l’altra è dello scrittore-viaggiatore inglese Bruce Chatwin. Diceva Brodskij di lei: «Per decenni Nadežda Mandel’štam visse alla macchia, in fuga perpetua, svolazzando tra gli angiporti e oscure città del grande impero, posandosi in un nuovo nido solo per riprendere il volo al primo segnale di pericolo. La condizione di ‘non persona’ divenne a poco a poco la sua seconda natura. Era una piccola donna, di esile corporatura, e col passare degli anni si rattrappì sempre più, come se cercasse di trasformarsi in un oggettino privo di peso che si potesse facilmente ficcare in tasca al momento della fuga».
Brodskij racconta di aver incontrato una prima volta Nadežda Mandel’štam nel 1962, sempre per intercessione di Anna Achmatova: «Abitava in un piccolo appartamento comune, formato da due stanze… Quasi tutto lo spazio era occupato da un letto di ferro a due piazze; c’erano anche due sedie di vimini, un cassettone con un piccolo specchio, e un tavolino da notte, un tavolino tuttofare sul quale si vedevano dei piatti con gli avanzi della cena». Nel giugno del 1972, invece, Brodskij lasciò definitivamente l’Unione sovietica, ma prima di partire fece ancora visita a Nadežda: «Il pomeriggio stava per finire, e lei sedeva, fumando, nell’angolo, nell’ombra profonda proiettata sul muro della grande dispensa. L’ombra era così profonda che le sole cose che si potessero distinguere erano la tenue scintilla della sigaretta e quei due occhi penetranti. Il resto – lo sparuto corpo rattrappito sotto lo scialle, le mani, l’ovale della faccia cinerea, i capelli grigi, anch’essi cinerei – tutto il resto era inghiottito dal buio. Nadežda Mandel’štam sembrava un avanzo di un grande incendio, sembrava una minuscola brace che brucia se la tocchi». Nadežda è stata soprattutto una grandissima scrittrice nonché traduttrice, molto influente fra gli intellettuali russi postrivoluzionari.
Di indicibile tristezza è invece il ricordo di Bruce Chatwin, il quale, pur dipingendola nel bianco a differenza di Brodskij, tracciava una linea di enorme dolore nel descriverla. La incontrò nel 1978 e il testo a lei dedicato è inserito in un suo libro dal titolo: Che ci faccio qui? Il racconto si apre con la visione di una nevicata copiosa. Bianca era la neve che cadeva senza sosta, bianco su bianco il quadro di Vladimir Weisberg appeso alla parete della dimora di Nadežda, e bianco sembrava essere il dolore intorno che tutto soffocava. La cucina aveva un odore forte di kerosene e di pane raffermo, fra il disordine sul tavolo si intravedevano bicchieri abbandonati e un vaso di begonie che sembrava ergersi in quell’abbandono. Entrando nell’appartamento, Chatwin vide un uomo di aspetto sgradevole uscire dalla stanza da letto in cui si trovava Nadežda: «Che cosa ha pensato del mio dottore?» domandò con una smorfia la donna. La risposta è nel testo di Chatwin: «Il dottore presumo, era il suo agente del KGB». Nadežda «aveva i denti ridotti a schegge annerite tra le quali luccicavano bianchi ponti di metallo. Una sigaretta era incollata al labbro inferiore. Il naso era un’arma. Sapevi per certo che quella era una delle donne più forti del mondo, e sapevi anche che lei lo sapeva».
Tanto è l’importanza di questa donna per la letteratura mondiale che anche Doris Lessing affermava, citando gli scritti autobiografici di Nadežda, che «Le testimonianze di una vita sotto l’egida della tirannia sono ormai molte, ma nessuno, nemmeno Solženicyn, ha mai scritto meglio». Di lei Isaiah Berlin, invece, segnalava quanto «Le crude reminiscenze della signora Mandel’štam si leggono come la realtà stessa, cruenta… il suo è un lavoro letteralmente unico». Seamus Heaney, nella nota scritta per la «London Review of Books» nell’agosto del 1981, in occasione della pubblicazione del secondo volume delle testimonianze di Nadežda, sottolinea un aneddoto che la scrittrice racconta in esergo alle sue memorie, proprio in relazione al temperamento del marito: «Dopo lo schiaffo ad Aleksej Tolstoj, Mandel’štam era tornato immediatamente a Mosca, e qui telefonava ogni giorno ad Anna Achmatova, scongiurandola di venire». Che cos’era accaduto di tanto grave? Tolstoj nel 1932 era a capo di una «corte di compagni» presieduta dal Sindacato degli Scrittori per ascoltare una denuncia di Mandel’štam contro i comportamenti del romanziere Sargidžan e di sua moglie. Come sostiene Heaney, i Mandel’štam avevano una «cattiva reputazione» presso le autorità rivoluzionarie e la coppia Sargidžan era stata incaricata di spiarli in condominio, ma questi avevano addirittura colpito Nadežda con violenza. Vagliato il caso, la corte aveva concluso, dando torto a entrambi, che quel comportamento era retaggio di un «sistema borghese». Tolstoj ricevette lo schiaffo due anni dopo come conseguenza di quella decisione «salomonica», Mandel’štam non glielo aveva perdonato. Fu dopo questi eventi che Osip scrisse il componimento contro Stalin, che gli costò il primo arresto e la perquisizione della sua casa, firmando così la sua condanna a morte: fu interrogato e deportato a Čerdyn dove, in stato di sofferenza psicologica, tentò il suicidio. Fu ancora una volta l’onnipresente Pasternak che intercederà per l’amico direttamente con Stalin, facendo commutare in esilio, direzione Voronež, la condanna al carcere. Mandel’štam ebbe ancora la possibilità di comporre versi, declamando e spesso camminando in moto continuo: «il passo, unito alla respirazione e saturo di pensiero: è questo che Dante intende per inizio della prosodia» – per un uomo simile, che riusciva a chiedersi «quante suole abbia consumato l’Alighieri mentre scriveva la sua Commedia», la prospettiva dell’esilio non era in fondo del tutto negativa. Nadežda, donna di indicibile forza, cominciò così il suo progetto mnemonico, la sua risposta al potere, all’autoritarismo, all’ingiustizia, reclamando il corpo del marito ormai cancellato, con il suo libro Speranza contro speranza. Il testo è nient’altro che il «cenotafio» di Osip Mandel’štam: «Salvando i versi di Mandel’štam non osavamo sperare, eppure non smettevamo di credere che un giorno potessero risorgere. E ci aggrappavamo a questa fede. Dopotutto, era la fede nel valore eterno e nel carattere sacro della poesia».
Oggi coloro che parlano delle democrazie malate del nostro Occidente, i cantori della fine ineluttabile, non sanno riflettere, né conoscono le dittature, non le hanno vissute, non le hanno capite, le hanno viste dalle poltrone infeltrite delle loro accademie. Basterebbe semplicemente leggere questo passo per trovare, magari, qualche risposta alle proprie stupide deduzioni: «In epoche come la nostra, dov’è il limite fra ciò che è psicologicamente ‘normale’ e ciò che non lo è? Io e Mandel’štam pensavamo le stesse cose, ma in lui questi pensieri diventavano in un certo senso ‘tangibili’: egli non si limitava a pensare, ma immaginava, vedeva come sarebbero andate le cose. Mi svegliava nel bel mezzo della notte per dirmi che Anna Achmatova era stata arrestata e che in quel momento la stavano conducendo all’interrogatorio. ‘Perché pensi una cosa simile?’ ‘È una impressione precisa’. Camminando per Čerdyn’, cercava il corpo di Anna Andreevna sul fondo di ogni burrone… Certo, questa era già follia. Ma io, dopo essermi destata dal letargo che mi aveva assalita, non riuscivo più a dormire e passavo la notte cercando di indovinare chi fra i nostri parenti e amici fosse già stato arrestato e sotto quali accuse. Se anche non c’era una denuncia precisa, le accuse si potevano sempre inventare».
I Mandel’štam avevano visto giusto e, soprattutto, «lungo»: «Chi vive sotto una dittatura, si permea rapidamente del senso della propria impotenza e vi trova consolazione e giustificazione per la propria passività e inerzia: ‘La mia voce potrà forse fermare le fucilazioni? Non dipende da me… Chi volete che mi dia retta?’ Così andavano dicendo i migliori di noi e l’abitudine al confronto fra le proprie forze e quelle altrui ha fatto sì che qualsiasi Davide, pronto ad assalire, disarmato, un Golia, suscitasse soltanto perplessità e alzate di spalle… Tutti eravamo pronti al compromesso: tacevamo nella speranza che non uccidessero noi, ma il nostro vicino. Non sappiamo nemmeno bene chi fra noi contribuiva a uccidere e chi si salvava tacendo».
Diversa ma, per molti versi non meno drammatica, fu la parabola di Lilja Brik. Lilja era la moglie del commerciante ed editore Osip Brik. Quest’ultimo già nel 1919 cominciò il ménage à trois con sua moglie e il poeta, una dinamica che scatenò pettegolezzi e smascherò il volto moralista del potere dei Soviet. Diceva Lilja di quel periodo: «Io ero la moglie di Volodja, lo tradivo come lui tradiva me. E tutte le chiacchiere sul triangolo e sull’amour à trois non hanno niente a che vedere con quello che in realtà c’era fra noi».
Fu lo stesso Lenin, come ricorda in un suo libro Serena Vitale, a impedire che un decreto sui danni della gelosia presentato da Aleksandra Kollontaj, che si batteva per il superamento del rapporto borghese e bigotto fra le persone, passasse. Tuttavia, in questo campo, si ricorda che il primo provvedimento dopo la rivoluzione dell’ottobre del 1917 fu quello di sancire la possibilità di divorziare facilmente, svuotando di significato religioso e statuale il gesto del legame matrimoniale. Ma già nel 1919, quando la Ceka si insediò, smentendo i primissimi provvedimenti in tema di unioni matrimoniali, la Russia divenne uno stato puritano.
Con Stalin, un certo morboso indagare negli affari intimi, le somministrazioni di purghe e le repressioni anche a discapito degli scrittori si fecero sentire massicciamente, come ad esempio, ricordano le sparizioni e il suicidio dello stesso Sergej Esenin. Si indagava nelle vite private, si indebolivano anche da un punto di vista intimo le persone e si annientavano per la loro ritrosia nell’obbedire al regime. Lilja, a differenza di Nadežda, continuò a credere nella rivoluzione, nonostante i riferimenti ideali dell’utopia rivoluzionaria fossero cambiati. Non a caso in una lettera a Stalin sponsorizzò la divulgazione nel 1935 dell’opera di Majakovskij, chiedendo che divenisse il riferimento artistico e poetico della Russia bolscevica.
Stalin colse l’occasione e Majakovskij venne insegnato nelle scuole come il poeta per eccellenza del regime, chiaramente in una modalità ridotta e in parte censurata, svilendo la sua forza espressiva. Il mito del poeta doveva essere sancito a tutti i costi per dimostrare che quel potere era la sua reincarnazione artistica: infatti le autorità sovietiche formarono un’apposita commissione diretta dal tedesco Oskar Vogt al fine di dissezionare il cervello del poeta, in ottemperanza a quell’ideologia materialista e riduzionista, senza riuscire, tuttavia, a scoprire i «segreti» del suo talento. Accadde lo stesso per il cervello di Lenin, utilizzato come «unità di misura» con la finalità di progettare «l’uomo nuovo», una pratica che tanto fa pensare all’ideologia nazista e suprematista.
Di quell’uomo, che con un linguaggio nuovo aveva cercato di cambiare il mondo attraverso la rivoluzione, tutto era stato stravolto, marginalizzato, reso icona e scorza vuota dell’autoritarismo. La sua lealtà si riassume proprio nel suicidio e ne testimonia la distanza. Se e quanto Lilja Brik si rese conto del fallimento è difficile dirlo, ma la sua intelligenza e il suo temperamento artistico ci fanno pensare alla deriva umana e ideologica vissuta dalla donna. In una delle interviste rilasciate in vita parlò del suo Majakovskij senza abiurare a nulla di quanto fatto, anzi rimarcò quanto fosse importante l’opera di quest’uomo per le future generazioni di giovani uomini e donne.
Il suicidio di Majakovskij secondo Lilja era un evento annunciato, pensato, voluto, e così ricorda: «egli ancora per la centomillesima volta mi parlava del suicidio, mi diceva che l’avrebbe fatta finita, perché non voleva diventare vecchio, malato». Tentò diverse volte di uccidersi fino al punto di riuscirvi, anche perché, aggiunge Lilja: «ci sarebbe da dire dell’altro; se le circostanze degli ultimi tempi fossero state di poco più gradevoli si sarebbe forse potuto evitare. A quali circostanze si appellò Lilja non è dato sapere con precisione, ma di sicuro la macchina del fango del regime aveva cominciato massicciamente a danneggiare l’uomo, il poeta, il rivoluzionario.
Le rivoluzioni in questo si assomigliano molto, per la loro innata utopia, per lo spirito di giustizia che le animano, per la necessità di stabilizzarsi e divenire, inesorabilmente, autoritarismo e bieca persecuzione. Lilja continuò tuttavia a segnalare che per Majakovskij il suicidio fosse «comunque» inevitabile: «egli voleva morire quando voleva lui e non quando avesse voluto il destino». Majakovskij odiava l’«infame buonsenso». Per tutta la vita insieme al terzo marito si dedicò alla diffusione dell’opera di Majakovskij. Quando nel 1978 scoprì di essere affetta da una grave malattia, Lilja Brik si suicidò a Peredelkino il 4 agosto.
- Bruce Chatwin, Che ci faccio qui, Adelphi, Milano 1990.
- Vladimir Majakovskij, Poesie, con un’intervista a Lilja Brik, a cura di Maria Roncali Doria, Newton Compton, Milano 1973.
- Nadežda Mandel’štam, Speranza abbandonata, introduzione di Paolo Nori, Settecolori, Milano 2024.
- , Speranza contro speranza, introduzione di Seamus Heaney, Settecolori, Milano 2022.
- Osip Mandel’štam, Viaggio in Armenia, a cura di Serena Vitale, Adelphi, Milano 1988.
- Renato Poggioli, I lirici russi: 1890-1930, Lerici, Milano 1964.
- Serena Vitale, Il defunto odiava i pettegolezzi, Adelphi, Milano 2015.
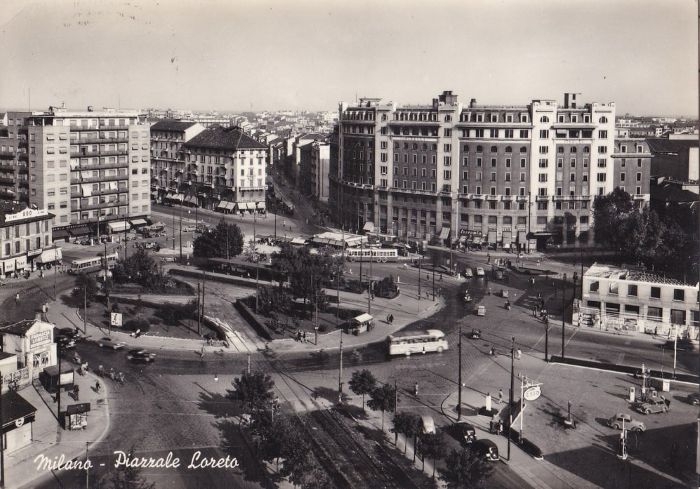 Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?
Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?
Dicono che contano altre cose, dicono. Dicono che a fare la storia è solo l’economia, oppure la geopolitica, o anche le classi, oppure la geografia, o magari l’energia, o invece le materie prime, anzi la demografia. Tutto fa la storia, e le persone no?
E invece furono [...]]]>
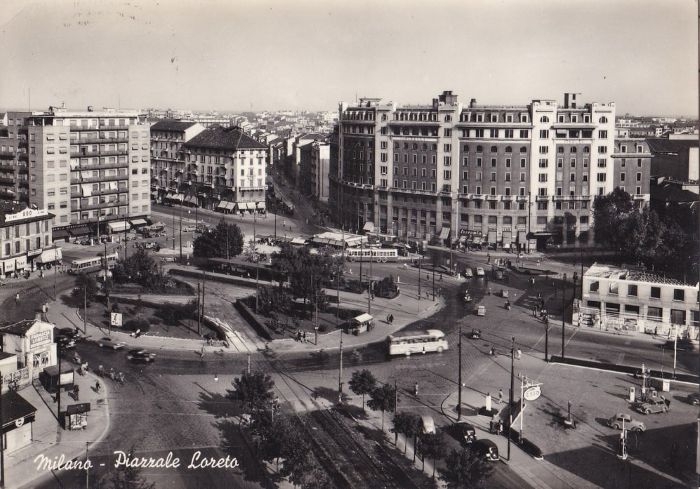 Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?
Dicono che non deve piacerci, dicono. Dicono che fu una cosa brutta, dicono. Qualcuno dice anche che le cifre tonde degli anniversari non significano niente, che sono come tutti gli anni. Ma in tempi neri, mentre i neri occupano tutto, in Italia e fuori, quella fine meritata non la vogliamo ricordare?
Dicono che contano altre cose, dicono. Dicono che a fare la storia è solo l’economia, oppure la geopolitica, o anche le classi, oppure la geografia, o magari l’energia, o invece le materie prime, anzi la demografia. Tutto fa la storia, e le persone no?
E invece furono persone, a impadronirsi del potere. Persone, non cose, forze, numeri, astrazioni, formule, teorie. Lo fecero in pochi anni, tra la fondazione dei Fasci di combattimento, Milano 23 marzo 1919, e le leggi fascistissime dopo il delitto Matteotti del 1924. Furono quelle persone, a massacrare le condizioni del lavoro, della vita, dei rapporti umani. Furono loro, a distruggere la libertà. Vent’anni di macelleria sociale, di prepotenze, di ruberia organizzata, di ottundimento della coscienza, di bugie, di propaganda senza pause e senza ritegno. Furono loro, a scaraventare il popolo italiano in cinque guerre.
Furono loro, a vanificare in poco tempo i successi delle generazioni risorgimentali: loro ricostituirono il potere temporale del papa, quasi subito, nel 1929; loro consegnarono il paese ai tedeschi, pochi anni dopo. Poi per cacciare i tedeschi ci vollero gli Alleati, e adesso le basi degli Usa e della Nato sono ancora qui, anche quelle con armi atomiche, legate a catene di comando imperscrutabili. Se come compimento dell’Unità si guarda alla presa di Roma nel 1870, l’indipendenza dell’Italia è durata – amara realtà – meno della metà di questo secolo e mezzo. E c’è ancora chi dice patria ma si scalda al fuoco fatuo del Msi, liquidato da Pier Paolo Pasolini: «Arista / o tetro vegetale guizza cerea / nel mezzo la fiammella fascista»[1].
Furono loro, a dare al mondo una cattiva lezione. Lo strano popolo ficcato in mezzo al Mediterraneo, aggrappato a una penisola rugosa e a isole in mari diversissimi, rimasto per secoli accomunato da una lingua romanza contesa, sparsa in dialetti lontani sino all’incomunicabilità, e da una cultura con mille varianti orgogliose e capricciose, un popolo stretto da troppo tempo fra la miseria di tanti e il quieto vivere di pochi, aveva dato l’esempio con l’unificazione e col ridimensionamento del potere del clero. Ma di colpo, ecco che insegnava al mondo un modello e una parola, il fascismo, che ancora adesso elettrizza tutti gli sfruttatori, i prevaricatori e gli schiavisti del pianeta.
Chissà perché, di un po’ di pulizia ci si dovrebbe vergognare. Perché chi fa la cosa giusta poi deve dare spiegazioni, farsi l’esame di coscienza, pulirsi le unghie, pettinarsi, darsi il deodorante, mettersi sull’attenti. E anche così, chiedere scusa.
E non va bene che si debba distinguere: perché bisognava fare il processo pubblico, perché fra quelle camicie nere qualcuno era meno carogna, perché la Petacci poverina, perché qualcosa di buono c’era stato, in quegli anni.
E quanto agli argomenti di chi giustifica, in fondo non vanno neanche quelli: cercano il contrappeso, l’appoggio, la motivazione. Non è decisivo neanche il fatto precedente: la fucilazione degli antifascisti, nel 1944, nello stesso posto. Come se fosse accettabile un contrappeso, un prezzo gettato all’ultimo momento su una bilancia. Forse non vanno bene certi argomenti proprio perché giustificano, mettono ordine, e così finiscono per sottintendere una colpa, almeno un’accusa, un sospetto, un’ombra, una macchiolina. Proclamando l’innocenza, finiscono per incolpare.
Ma poche cose sono chiare, necessarie, come quella punizione magra, però punizione, e quel piazzale di Milano, disadorno allora e oggi. Uno slargo con una bruttezza confusa che scorre invariabile, coerente e parlante, dai casamenti dell’Ottocento e del primo Novecento sino a quelli dello sviluppo, poi della Milano da bere e poi della Milano da esposizioni, Milano che corre, Milano che non la ferma neanche il covid, Milano con la cocaina nelle acque di scarico. Quello snodo è un posto da illustrazioni in bianco e nero, di quelle di una volta, con la didascalia; eppure, «saluti da piazzale Loreto» sarà sempre tutt’altro che «saluti da Milano».
I signori del cannone e della cartapesta ebbero il loro degno palcoscenico finale, non c’è che dire. Un piazzale periferico, allora, e ancora adesso informe, convulso, da spartitraffico. Un posto anonimo e distratto. Un piazzale da distributore di benzina.
[1] Pier Paolo Pasolini, Comizio, in Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano 2021, p. 27.
]]>
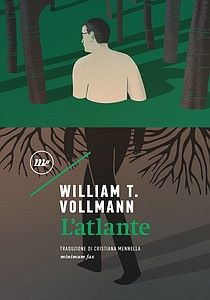 Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro
Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro
Alcune puttane lo fissarono immobili. Altre in stivaloni gli fecero ciao e gli fischiarono dietro allegramente. Andò da tre di loro e disse: Scusate, non ho più soldi, ma potrei baciare una di voi? Va bene, caro, disse una rossa. Ti bacio io. Succhiò un attimo la gomma da masticare, andò da lui, lo prese per la testa e gli sputò in faccia (W.T. Vollmann – Cinque notti solitarie. Berlino, Germania 1992)
Se c’è un tratto che colpisce nei maggiori autori nordamericani degli ultimi decenni [...]]]>
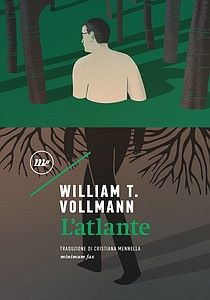 Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro
Wulliam T. Vollmann, L’atlante, Edizioni minimum fax, Roma 2023, pp. 545, 20 euro
Alcune puttane lo fissarono immobili. Altre in stivaloni gli fecero ciao e gli fischiarono dietro allegramente. Andò da tre di loro e disse: Scusate, non ho più soldi, ma potrei baciare una di voi?
Va bene, caro, disse una rossa. Ti bacio io. Succhiò un attimo la gomma da masticare, andò da lui, lo prese per la testa e gli sputò in faccia (W.T. Vollmann – Cinque notti solitarie. Berlino, Germania 1992)
Se c’è un tratto che colpisce nei maggiori autori nordamericani degli ultimi decenni (Auster, De Lillo, Wallace, Pynchon) è sicuramente quello di aver indirizzato la loro letteratura verso una sorta di smaterializzazione, in cui la realtà è spesso rappresentata più da simboli che dalla concretezza dei fatti cui ci aveva abituato il realismo di tanti autori statunitensi precedenti.
Un risultato che sembra dovuto, più che alle riflessioni sulla “leggerezza” contenute nelle Lezioni americane di Italo Calvino1, all’inevitabile influenza culturale esercitata sulla stessa letteratura dal processo, avvenuto in Occidente nel corso degli ultimi quattro decenni in ambito economico e produttivo, che ha portato al trionfo della produzione immateriale su quella concretamente industriale e del capitale fittizio su quello investito nella produzione industriale di beni materiali.
Una sorta di guerra che vede simbolicamente, ma non soltanto, scontrarsi, da un lato, la “volatilità” finanziaria dei giganti del NASDAQ2 e, dall’altro, l’industria manifatturiera che l’attuale presidente statunitense sta cercando di riportare, non senza difficoltà, negli Stati Uniti, insieme al lavoro, da anni in caduta libera nel settore un tempo sviluppatosi in quella che oggi viene ancora definita Rust Belt.
 Una “guerra” in cui lo scrittore e saggista americano William T. Vollman sembra aver scelto di schierarsi dalla parte della Rust Belt, non tanto per il contenuto dei suoi scritti, quanto piuttosto per essersi messo, fin dalle sue prime opere, sulle tracce della concretezza del mondo, convinto che dovesse ancora esistere e che ha saputo ritrovare in ogni occasione possibile. Seguendo percorsi allo stesso tempo simili eppure molto diversi da quelli di Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Steinbeck e dello stesso Kerouac, i cui viaggi on the road rappresentavano una scusa per incontrare le varietà di una società sospesa tra il benessere del dopoguerra e il desiderio di fuggirlo.
Una “guerra” in cui lo scrittore e saggista americano William T. Vollman sembra aver scelto di schierarsi dalla parte della Rust Belt, non tanto per il contenuto dei suoi scritti, quanto piuttosto per essersi messo, fin dalle sue prime opere, sulle tracce della concretezza del mondo, convinto che dovesse ancora esistere e che ha saputo ritrovare in ogni occasione possibile. Seguendo percorsi allo stesso tempo simili eppure molto diversi da quelli di Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Steinbeck e dello stesso Kerouac, i cui viaggi on the road rappresentavano una scusa per incontrare le varietà di una società sospesa tra il benessere del dopoguerra e il desiderio di fuggirlo.
Occorre partire da Kerouac, infatti, per comprendere i viaggi, spesso pericolosi, intrapresi da Vollmann in ogni angolo degli Stati Uniti e del mondo: da San Francsco a New York e dal Madagascar all’Afghanstan fino alla Thailandia e alla Cambogia. A differenza del più significativo scrittore della beat generation, però, i suoi viaggi non avvengono solo nel tempo sincronico del presente della sua scrittura, ma anche lungo diverse coordinate temporali.
Ripercorrere il passato e le origini degli attuali States, o dei fatti che condussero e accompagnarono il secondo conflitto mondiale oppure, ancora, la lunga onda della violenza che sembra aver accompagnato la storia della specie umana, costituisce il nerbo di tutta la sua letteratura in cui il presente non può esistere senza il passato, mentre il passato non avrebbe senso alcun se non ne si ritrovasse ancora traccia nella contemporaneità.
Ma il filo rosso che attraversa crudelmente tutte le sue opere, sempre sospese tra cronaca, autobiografia e invenzione, è rappresentato dal dolore che sembra accompagnare l’esistenza in ogni suo attimo. Che si tratti dei nugoli di zanzare che tormentano selvaggiamente i viaggiatori nelle terre del Nord americano, oppure di quello mascherato da sorrisi delle giovani prostitute dell’estremo oriente oppure malgasce e tedesche, o, ancora, la solitudine di uomini che cercano nel sesso a pagamento un amore perduto o forse mai incontrato, il dolore sembra non abbandonare mai gli esseri umani durante la loro esistenza.
Le storie dei soldati, guerriglieri, nativi americani soppressi con le armi e con il vaiolo, oltre che di esploratori destinati soltanto ad affacciarsi sul nulla dell’esistenza, si accompagnano anche a quelle dei danni, e quindi metaforicamente al dolore, subiti dall’ambiente e dalle altre specie animali. Che si tratti delle zone colpite dal disastro nucleare di Fukushima o delle foche uccise dagli Inuit oppure dai ben più avidi e scellerati cacciatori “bianchi”, le manifestazioni del dolore, fisico e psichico, non cessano mai. In una sorta di muto colloquio dell’autore con un fato che non veste nemmeno i panni razionali della Natura dialogante con un islandese di una delle più note Operette morali di Giacomo Leopardi.
Però, più che Leopardi che, per l’epoca in cui visse, seppe leggere in senso materialistico lo strazio delle vicende umane, individuali e collettive, in Vollmann a trionfare è lo sguardo addolorato, spesso rabbioso, di Louis-Ferdinand Céline. Quello dell’uomo che si rivolta contro le sue condizioni di esistenza, senza però mai intravedere un filo di speranza, impossibilitato a ritrovare il filo di quell’umana social catena che nella Ginestra leopardiana poteva, almeno, fungere da possibile, e forse unica, consolazione.
Nei testi di William T. Vollmann siamo quindi lontani anni luce da qualsiasi forma di leggerezza o immaterialità mentre i suoi simboli sono sempre estremamente concreti, fatti di carne e di sangue, poiché su un altro versante della letteratura si pone l’autore, lontano sia dalla ricerca del sensazionalismo politico e sociale ricercato dagli scrittori muckraker della fine del XIX secolo che dal distacco della scrittura dall'”oggetto” narrato.
Vollmann, invece, guarda in faccia il dolore e ce lo sbatte sul muso, senza inutili pietismi e senza mai risparmiarci il sangue, la merda, la puzza, lo sperma che spesso lo accompagnano. Come per Cèline, l’invito rivolto al lettore è lo stesso: accomodati al mio desco e consuma con me questo piatto indigesto e quasi sempre ripugnante oppure lasciami perdere a vai a farti fottere da chi immagina e parla di un mondo migliore. Magari anche divertente.
Roba per stomaci forti, per proseguire con la metafora gastronomica, di cui il testo pubblicato nel 2023 da minimum fax rappresenta il menù sostanzialmente completo, dagli antipasti ai secondi piatti, dolci assolutamente esclusi. Dall’estremo Nord alla Jugoslavia devastata dalla guerra civile; dalla Somalia alle autostrade americane, dalla Thailandia a Pompei: come si è già detto, non c’è quasi terra o contesto umano che William Vollmann non abbia esplorato e raccontato.
L’atlante costituisce così il diario di viaggio di questa erranza continua e irrequieta, ricostruita attraverso cinquantadue “capitoli” diseguali per lunghezza e per tono, ma accomunati dallo stesso brutale incontro/scontro con la vita concreta. I frammenti e i racconti sono organizzati in una struttura palindroma: il primo testo viene ripreso dall’ultimo, il secondo dal penultimo, e il racconto centrale contiene tutti gli altri, come una silloge ideale. Alcuni testi rappresentano una versione compressa dei libri che Vollmann al momento della pubblicazione aveva già scritto. Mentre altri anticipano, in qualche modo, quelli ancora non scritti all’epoca della loro stesura.
 William Tanner Vollmann è nato a Santa Monica, California, il 28 luglio 1959 e ha vissuto in seguito nel New Hampshire, a New York e San Francisco. Quando aveva nove anni, la sorella di sei anni annegò in uno stagno e lui si sentì responsabile della sua morte e, secondo lo scrittore, questa perdita avrebbe finito con l’influenzare gran parte del suo lavoro.
William Tanner Vollmann è nato a Santa Monica, California, il 28 luglio 1959 e ha vissuto in seguito nel New Hampshire, a New York e San Francisco. Quando aveva nove anni, la sorella di sei anni annegò in uno stagno e lui si sentì responsabile della sua morte e, secondo lo scrittore, questa perdita avrebbe finito con l’influenzare gran parte del suo lavoro.
Dopo l’università, frequentata alla Cornell di Ithaca, lavorò come segretario in una piccola compagnia di assicurazioni, a San Francisco, per alcuni mesi e con i soldi ricavati da questo impiego, partì per l’Afghanistan durante l’invasione sovietica, scrivendo poi le sue esperienze in An Afghanistan Picture Show, or, How I Saved the World (Afghanistan picture show. Ovvero, come ho salvato il mondo, Alet, Padova 2005 e minimum fax, Roma 2020) pubblicato nel 1992, quasi dieci anni dopo quel primo viaggio.
Libro in cui racconta a posteriori un’esperienza sostanzialmente fallimentare, attraverso uno sguardo più adulto e disincantato, capace di guardare senza nostalgia al proprio io più giovane e ingenuo, che riusciva a porre le domande più sbagliate alle persone sbagliate, mentre si contorceva tra i dolori della dissenteria. Tra conversazioni piene di equivoci ed estenuanti camminate nell’impervio territorio afgano, trascinato e talvolta trasportato pietosamente dai mujahiddin, lo scrittore mette in scena l’idealismo ingenuo e il colonialismo dello sguardo americano sul mondo, in un’opera ibrida che si muove già, come molte altre successivamente, tra romanzo e diario, saggio storico e reportage. Che è per molti versi assimilabile agli scritti raccolti da Mark Twain sotto il titolo Gli innocenti all’estero in cui lo scrittore, più che ai paesi visitati durante diversi viaggi intorno al mondo, guardava ai comportamenti dei suoi concittadini messi al cospetto di una realtà molto diversa da quella della madrepatria da cui provenivano.
Successivamente Vollmann avrebbe pubblicato scritti di viaggio e articoli per la rivista «Spin», per il «New Yorker» e nella «New York Times Book Review», mentre all’inizio del 2003, dopo molti rinvii, ha pubblicato Rising Up and Rising Down: Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means (San Francisco, McSweeney’s Books, 2003), un trattato sulla violenza in sette volumi di 3.300 pagine, di cui una versione ridotta a un solo volume, di circa mille pagine, è stata pubblicata l’anno seguente da Eco Press (Come un’onda che sale e che scende. Pensieri su violenza, libertà e misure d’emergenza, Mondadori, Milano 2007; nuova edizione minimum fax, Roma 2022).
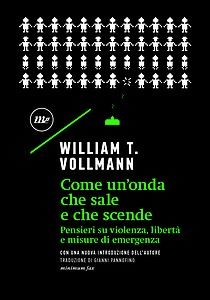 Elaborato nel corso di vent’anni, il testo si basa da un lato su un colossale lavoro sulle fonti (filosofia, teologia, biografie di tiranni, signori della guerra, criminali, attivisti e pacifisti), dall’altro su una serie di esperienze dirette, spesso estreme, che hanno portato l’autore nel cuore dei conflitti di fine Novecento e nelle zone più degradate delle grandi metropoli. Con l’attenzione rivolta sia a figure storiche che a persone comuni che della violenza hanno fatto un metodo, di difesa o di offesa: tutti abbracciati da uno sguardo profondo e partecipe.
Elaborato nel corso di vent’anni, il testo si basa da un lato su un colossale lavoro sulle fonti (filosofia, teologia, biografie di tiranni, signori della guerra, criminali, attivisti e pacifisti), dall’altro su una serie di esperienze dirette, spesso estreme, che hanno portato l’autore nel cuore dei conflitti di fine Novecento e nelle zone più degradate delle grandi metropoli. Con l’attenzione rivolta sia a figure storiche che a persone comuni che della violenza hanno fatto un metodo, di difesa o di offesa: tutti abbracciati da uno sguardo profondo e partecipe.
Opera cui è possibile avvicinare anche Europe Central, che tratta di un ampio gruppo di personaggi coinvolti nella guerra tra Germania nazista e Unione Sovietica nel corso del secondo conflitto mondiale, che ha vinto nel 2005 il National Book Award per la narrativa (Mondadori, Milano 2010.). Romanzo che può ricordare, per molti versi, Vita e destino (in russo Жизнь и судьба, Žizn’ i sud’ba) di Vasilij Semënovič Grossman, scritto in Russia nel 1959 e pubblicato in Svizzera soltanto nel 1980, sedici anni dopo la scomparsa dell’autore (ed. italiane: Jaca Book, Milano 1982; Adelphi, Milano 2008), drammaticamente incentrato sugli avvenimenti ruotanti intorno alla battaglia di Stalingrado e di cui si parlerà nel prossimo futuro in questa stessa serie di articoli.
Sempre di carattere storico è un’altra opera monumentale di Vollmann, ovvero il ciclo di romanzi I sette sogni: un libro di paesaggi nordamericani, previsto in sette volumi, di cui pubblicati fino ad ora soltanto cinque e del quale in Italia sono stati tradotti tre titoli: La camicia di ghiaccio (The Ice-Shirt, New York, Viking, 1990; trad. italiana Alet, Padova 2007), Venga il tuo regno (Fathers and Crows, New York, Viking, 1992; Alet, Padova 2011) e I fucili (The Rifles, New York, Viking, 1994); Minimum Fax, Roma 2018) I due titoli non ancora pubblicati in Italia sono Argall: The True Story of Pocahontas and Captain John Smith (New York, Viking, 2001) e The Dying Grass (New York, Viking, 2015). Mentre i due annunciati e mai pubblicati sarebbero: The Poison Shirt e The Cloud-Shirt.
Si tratta, com’è facilmente intuibile dai titoli, di una lunga e sofferta narrazione della conquista europea del continente nord-americano e della fine delle società native conseguita a ciò, dai tempi dell’arrivo dei Vichinghi alla fine degli Indiani delle pianure, passando per la cristianizzazione dei nativi canadesi e la colonizzazione tecnologica degli Inuit. Raccontando un mondo che è scomparso non soltanto per quanto riguarda le differenti etnie e le loro tradizioni e forme di organizzazione sociale, ma anche, e talvolta soprattutto, dal punto di vista ambientale.
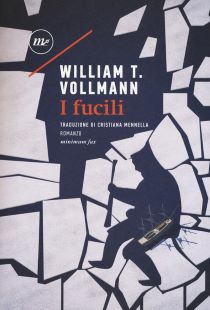 Ad uno dei romanzi, I fucili, rimanda uno dei racconti pubblicati sull’Atlante: Un vecchio dai vecchi kamik grigi – Coral Harbour, isola di Southampton, Territori del Nordovest, Canada (1993).
Ad uno dei romanzi, I fucili, rimanda uno dei racconti pubblicati sull’Atlante: Un vecchio dai vecchi kamik grigi – Coral Harbour, isola di Southampton, Territori del Nordovest, Canada (1993).
Tutti accompagnati dalla precisazione della località in cui sono ambientati e, in un apposito dizionario geografico posto all’inizio dell’antologia, dalle precise coordinate spaziali e geografiche, che le indicano in termini di longitudine e latitudine. In questo caso specifico: 64.10 Nord – 83.15 Ovest. Una precisione che non è pedanteria, ma attenzione a mappare esistenze, storie e drammi destinati a costruire un autentico reticolo del dolore sulla superficie terrestre e a penetrare più in profondità nella coscienza del lettore.
Ma l’opera che, per quanto riguarda chi stende queste note, pare più adatta a riassumere la visione del mondo dello scrittore nordamericano è la cosiddetta Trilogia della prostituzione, composta da tre testi di cui soltanto due pubblicati per ora in Italia: Puttane per Gloria (Whores for Gloria, New York, Pantheon Books, 1991; Mondadori, Milano 2000 e minimum fax, Roma 2024), Storie della farfalla (Butterfly Stories: A Novel, New York, Grove Press, 1993; Fanucci, Roma 1999 e minimum fax, Roma 2019) e The Royal Family (New York, Viking, 2000).
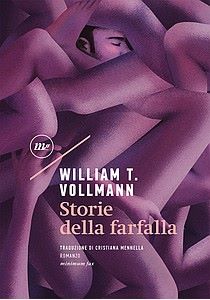 Storie e cronache in cui la ricerca della soddisfazione sessuale e la delusione che deriva dai rapporti con donne obbligate ad “offrirla” permette a Vollmann di esplorare fino in fondo i danni provocati dalla concezione spesso superficiale che un Occidente ricco e colonialista ha del mondo, anche quando questo sembra assumere sembianze innocue, turistiche, umanitarie o, peggio ancora, romantiche. Storie di emarginazione, abbrutimento, miseria e ignoranza che alcuni racconti contenuti nell’antologia sottolineano con vigore, anche se magari in poche pagine: Inutile piangere – Bangkok, provincia di Phra Nakhon-Thumburi (1993); Cinque notti solitarie – San Francisco, California, Usa (1984) – New York, Usa (1990) – Berlino, Germania (1992) – Antananarivo, Madagascar (1992) – Nairobi, Kenya (1993; Storie della farfalla (1 e 2). Queste ultime quasi tutte ambientate a Phnom Penh, Cambogia oltre che a Bangkok, Thailandia e a Sacramento, California tra il 1991 e il 1994.
Storie e cronache in cui la ricerca della soddisfazione sessuale e la delusione che deriva dai rapporti con donne obbligate ad “offrirla” permette a Vollmann di esplorare fino in fondo i danni provocati dalla concezione spesso superficiale che un Occidente ricco e colonialista ha del mondo, anche quando questo sembra assumere sembianze innocue, turistiche, umanitarie o, peggio ancora, romantiche. Storie di emarginazione, abbrutimento, miseria e ignoranza che alcuni racconti contenuti nell’antologia sottolineano con vigore, anche se magari in poche pagine: Inutile piangere – Bangkok, provincia di Phra Nakhon-Thumburi (1993); Cinque notti solitarie – San Francisco, California, Usa (1984) – New York, Usa (1990) – Berlino, Germania (1992) – Antananarivo, Madagascar (1992) – Nairobi, Kenya (1993; Storie della farfalla (1 e 2). Queste ultime quasi tutte ambientate a Phnom Penh, Cambogia oltre che a Bangkok, Thailandia e a Sacramento, California tra il 1991 e il 1994.
Nella vita privata, Vollmann rifiuta la fama letteraria e l’utilizzo di dispositivi moderni quali cellulari e carte di credito e viene talvolta descritto come misantropo e schivo, tanto che in un saggio del 2023, intitolato Life as a Terrorist, Vollmann ha rivelato quanto l’attenzione ai temi di “anti-progresso” e “anti-industrializzazione” dei primi lavori abbia cambiato la sua vita, descrivendo, utilizzando proprio i file ufficiali, ottenuti attraverso il Freedom of Information Act, l’inchiesta a suo carico condotta dal Federal Bureau of Investigation alla metà negli anni novanta, ritenendolo sospettato nel caso Unabomber.
Oltre a diversi romanzi, spesso ancora inediti in Italia, Vollmann ha pubblicato varie raccolte di racconti: I racconti dell’arcobaleno (The Rainbow Stories, New York, Atheneum, 1989 – Fanucci, Roma 2001); Tredici storie per tredici epitaffi (Thirteen Stories and Thirteen Epitaphs, New York, Pantheon Books, 1991- Fanucci, Roma 2005 e minimum fax, Roma 2025) e Ultime storie e altre storie (Last Stories and Other Stories, New York, Viking, 2014– Mondadori, Milano.2016).
Tra le opere lontane dalla fiction vanno segnalate almeno quelle pubblicate in Italia che, oltre a Come un’onda che sale e che scende, comprendono I poveri (Poor People, New York, Ecco, 2007- Minimum Fax, Roma 2020) e Zona proibita. Un viaggio nell’inferno e nell’acqua alta del Giappone dopo il terremoto (Into the Forbidden Zone, New York, Byliner, 2011– Mondadori, Milano 2012). quest’ultimo recensito qui su Carmillaonline.
Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio (Garzanti 1993) è un libro di Italo Calvino basato su una serie di lezioni preparate in vista di un ciclo di sei discorsi da tenere all’Università di Harvard per l’anno accademico 1985-1986. Fu pubblicato postumo nel 1988, vista la morte improvvisa dell’autore prima della partenza per gli States. ↩
National Association of Securities Dealers Automated Quotation, ovvero Associazione nazionale degli operatori in titoli con quotazione automatizzata, primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico, che costituisce, essenzialmente, l’indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana in cui sono quotate compagnie di molteplici settori, tra cui quelle informatiche come Microsoft, Cisco Systems, Apple, Googl, Facebook, Amazon e Yahoo, basato esclusivamente su una rete di computer e sulla capitalizzazione in borsa dei medesimi titoli. ↩
 Ήθος ανθρώπω δαίμων. Il daimon è per ciascuno il suo carattere. (Eraclito, fr. 119 D.-K.)
Ήθος ανθρώπω δαίμων. Il daimon è per ciascuno il suo carattere. (Eraclito, fr. 119 D.-K.)
Oltre la costruzione identitaria del nemico Mai come in questi giorni cupi, in cui l’Antropocene sembra voler immortalare il proprio suicidio simbolico nell’istantanea di un corpo che annega nelle sue stesse deiezioni, la percezione del mondo è per lo più filtrata da una nozione di soggettività posticcia che, come mera appropriazione identitaria, si nutre di separazione; una divergenza progressiva che esaspera, fino a farla esplodere, non solo la dialettica amico/nemico, ma anche la nozione stessa d’identità dell’individuo in quanto tale, espungendone alla radice l’alterità [...]]]>
 Ήθος ανθρώπω δαίμων.
Ήθος ανθρώπω δαίμων.
Il daimon è per ciascuno il suo carattere.
(Eraclito, fr. 119 D.-K.)
Oltre la costruzione identitaria del nemico
Mai come in questi giorni cupi, in cui l’Antropocene sembra voler immortalare il proprio suicidio simbolico nell’istantanea di un corpo che annega nelle sue stesse deiezioni, la percezione del mondo è per lo più filtrata da una nozione di soggettività posticcia che, come mera appropriazione identitaria, si nutre di separazione; una divergenza progressiva che esaspera, fino a farla esplodere, non solo la dialettica amico/nemico, ma anche la nozione stessa d’identità dell’individuo in quanto tale, espungendone alla radice l’alterità intrinseca che la costituzione più intima del soggetto stesso reca in sé, come proprio fondamento inespresso. In forza di questo costante svuotamento di senso, entrambi i termini della relazione – io/altro, amico/nemico – si presentano spesso come significanti vuoti e, soprattutto la nozione di nemico, declinata a uso e consumo di una propaganda dissennata, rimane irrimediabilmente cristallizzata in una sterile costruzione identitaria ad escludendum in forza della quale dalla parte giusta della storia ci siamo noi e da quella sbagliata ci sono gli altri, i nemici, gli stranieri, gli usurpatori, da additare ed eliminare, come gli ultracorpi nel celebre remake del film di Don Siegel. Con buona pace di Edmond Jabès quando ci dice che «lo straniero ti permette di essere te stesso, facendo di te uno straniero»1.
Mai come in questi giorni cupi sarebbe invece opportuna una riflessione ponderata proprio sulla figura del nemico; un’analisi critica, depurata da ogni hybris etnocentrica, capace di restituirne la complessità proteiforme e di scardinare la logica tanatopoietica che, in forza di una fatwa perenne e di una separazione postulata ma fittizia, domina la costruzione del soggetto come mera appartenenza identitaria. Ma di tale riflessione non v’è traccia perché, si sa, la sfida della complessità è merce rara, mentre la semplificazione è in saldo in tutte le vetrine dell’impero. Ciò a cui si assiste, al contrario, è una saga del declino in forma di farsa, messa in scena da una grottesca schiera di saltimbanchi dell’apocalisse che, se non fosse drammaticamente reale, potrebbe a pieno diritto figurare come episodio pilota di una serie distopica di grande successo. Mentre a Gaza va in scena l’atto finale di uno sterminio annunciato e i tecnocrati del dominio giocano a dadi con il nostro futuro. Il vero è diventato un momento del falso, avrebbe detto Debord; e dato che il vero si presenta ormai come un deserto di senso, per trovarne traccia, come spesso accade, è utile volgere lo sguardo proprio al falso, alla finzione, ovvero al territorio dell’immaginario.
Nel vasto panorama della recente produzione fantastica – sia letteraria che cinematografica o seriale – vale la pena di citare almeno due esempi di indubbia originalità e acume. Il primo è il romanzo incompiuto di Valerio Evangelisti intitolato La fredda guerra dei mondi (Mondadori, 2023) che doveva essere composto da 45 capitoli di 5 pagine ciascuno e, nella volontà dell’autore, avrebbe dovuto rappresentare l’ampliamento dell’omonimo racconto uscito nel 2020 in un fascicolo Urania Millemondi chiamato Distopia, (Mondadori, 2020). Data la scomparsa prematura di Evangelisti, del libro, purtroppo, sono disponibili solo i primi 17 capitoli, con l’eccezione del capitolo 10 che il curatore Franco Forte non è mai riuscito a trovare nel lascito dello scrittore bolognese. Il secondo esempio è Scissione (Severance), la serie televisiva creata da Dan Erickson, la cui seconda stagione è da poco andata in onda su Apple Tv.
La fredda guerra dei mondi
Nella Fredda guerra dei mondi Evangelisti mette in scena un conflitto globale che vede come protagonisti da una parte la Terra (o meglio le potenze occidentali) e dall’altra una presunta razza aliena dalle sembianze vagamente umanoidi. Una potenza «straniera» venuta dallo spazio profondo, dotata di tecnologie sofisticatissime che sta distruggendo, uno a uno, tutti i monumenti delle principali città impegnate nei combattimenti, senza però fare alcuna vittima, né tra i civili né tra i militari. L’esistenza degli alieni è nota ai governanti di turno da molti anni – da quando cioè alcuni di loro sono stati catturati – ma è stata tenuta nascosta alla popolazione civile, fino a quando «gli extraterrestri» individuano i loro compagni rapiti e scatenano l’attacco contro la Terra per riportarli a casa. Il conflitto è gestito da un’entità sovranazionale, composta da capi di stato, militari e tecnocrati che, senza alcun mandato, si sono intestati il diritto di condurre la parte sana dell’umanità alla vittoria, costi quel che costi; ed è lecito presumere che il tempo della narrazione, ambientata tra Parigi e Tolosa, sia più o meno quello del nostro presente. Le vicende legate alla guerra, però, intersecano anche quelle di una scalcinata accolita di malviventi dalla raffazzonata quanto traballante vocazione anarchica. Il capo, soprannominato «il Reverendo», durante una rapina a casa di un generale, assiste per caso a una videoconferenza tra i potenti della Terra, dalla quale apprende dell’invasione aliena. Seguendo le gesta del Reverendo e della sua banda di sodali, si scoprirà che in realtà gli invasori alieni non sono altro che gli umani di un lontano futuro che, grazie a un entanglement spazio-temporale, sono tornati a salvare i loro fratelli tenuti prigionieri. Per questa ragione non uccidono i propri presunti nemici: perché la morte di ciascun nemico nel presente eliminerebbe migliaia di loro nel futuro. La chiamata alle armi e la rivelazione della minaccia aliena – con il consueto corredo di fanatismo nazionalista e vaneggiamenti su una imminente sostituzione etnico-culturale – vengono annunciate a reti unificate, senza però svelare la reale provenienza degli invasori. Perché, dice Evangelisti per voce del segretario di Stato americano, «L’uomo del popolo deve individuare confusamente chi è il nemico e starsene al riparo a sostenere chi combatte, oppure arruolarsi e obbedire agli ordini». Lo stato di guerra contro un nemico di cui non si rivela mai il vero volto (perché è il nostro), consente al potere di perpetrare se stesso e di stroncare sul nascere ogni forma di dissenso, così come di giustificare impunito – in nome di una ragione superiore – qualsiasi ripugnante metodo repressivo. Ma la chiamata alle armi nasconde anche un duplice e più agghiacciante obbiettivo: in moltissime città, a contingenti di 20 mila per volta, i riservisti che si sono offerti volontari per combattere gli alieni, vengono sterminati col gas, come bestie da macello. Perché, annuncia tronfio un autorevole burocrate dello sterminio, il sacrificio di 20 mila dei nostri nel presente, annienterà all’istante milioni dei loro nel futuro dal quale provengono.
Il romanzo in sostanza si conclude qui. Purtroppo Evangelisti ci ha lasciati prima di poter comporre il puzzle ma, tenendo fede al finale dell’omonimo racconto del 2020 e avendo una qualche dimestichezza con l’universo narrativo dello scrittore bolognese, è lecito avanzare qualche ipotesi. Fatte salve le sorti, rimaste indecise, del Reverendo e della sua banda possiamo infatti immaginare che un entanglement spiraliforme travolga nel suo vortice il presente della narrazione, per proiettarlo in un tempo X dalla struttura ignota, nel quale però un altro gruppo di ladri e puttane deciderà che resistere non è mai inutile.
Rispetto alle questioni relative allo statuto del nemico/straniero sollevate nella nostra breve quanto sommaria premessa, è utile ribadire come Evangelisti, soprattutto nel ciclo di Eymerich, si sia confrontato principalmente con la natura del potere, che egli incarna nella figura dell’inquisitore catalano: una natura spietata, pervasiva ma, allo stesso tempo, estremamente seducente (tutti i lettori tifano per il Magister) e, per questo, ancor più subdola e pericolosa. Lo stesso personaggio di Eymerich, tuttavia, diventa anche un topos narrativo di sperimentazione nel quale soprattutto da un punto di vista archetipico, agisce proprio la questione del nemico come alterità consustanziale al soggetto. Perché se è vero, da una parte, che il Magister rappresenta il villain per eccellenza (spietato, determinato, feroce, astuto, implacabile e quasi sempre malvagio), dall’altra il lettore è portato a schierarsi sempre dalla sua parte e, in tutto il ciclo, sembra mancare un vero e proprio antagonista in senso narratologicamente codificato. Perché, in realtà, i vari avversari che Eymerich inesorabilmente sconfigge nel corso delle sue imprese e investigazioni (eretici, catari, giudei, alchimisti, falsi profeti e soprattutto donne, alle quali egli imputa il peccato originale dell’empatia e della carnalità), in virtù di un rovesciamento tanto intrigante quanto sofisticato, rappresentano il lato vitale di sé, che egli detesta e dal quale è terrorizzato. Corpus vs dogma, il volto lunare di Ecate e del femminile vs fede e ragione. Ogni forma di partecipazione emotiva e di contatto col corpo vivo del mondo, che Eymerich avverte dentro di sé, viene vissuta come l’azione strisciante del demonio, repressa e esternalizzata in una schiera di nemici da abbattere ad ogni costo.
Nella Fredda guerra dei mondi, per quanto è dato rilevare vista l’incompiutezza del romanzo, questo medesimo meccanismo di rifiuto e outsourcing del rimosso viene declinata in modo più esplicito e secondo uno schema più squisitamente politico e interno alle dinamiche di conservazione del potere. Non importa, infatti, che gli umani si facciano la guerra tra di loro perché, purtroppo, è cosa fin troppo comune; non importa neanche che siano disposti ad annientarsi come specie, perché anche questa, purtroppo, è un’ipotesi sul tavolo. Importa però in maniera cogente che gli umani del futuro, universalmente trattati come nemici da eliminare, vengano costantemente definiti e considerati «alieni», anche e soprattutto da chi è a conoscenza della loro vera natura, che è la nostra. Importa l’incapacità di accettare un corpo – e un volto – che il tempo ha trasformato e verso il quale non si nutre alcune curiosità o empatia, ma disgusto e derisione. Importa la reductio a semplice entità malevola (l’alieno da abbattere) di una specie – la nostra – che ha percorso milioni di anni di storia a ritroso nel tempo e nello spazio per salvare i propri fratelli. Per tornare a Jabès, importa la manifesta e patologica volontà di disconoscere lo straniero che è in noi. Ma, soprattutto, in chiave sociopolitica, importa l’arroganza del potere che, per affermare e salvaguardare se stesso, è disposto a cancellare con un gesto milioni di possibili storie future. E rileva importa che la vera natura degli invasori, tenuta sapientemente nascosta alla popolazione, sembra venir dimenticata anche da chi siede nella stanza dei bottoni. Perché, appunto, il nemico deve rimanere un significante vuoto, uno stereotipo strumentale che definisce per via negationis tanto il soggetto quanto la sua appartenenza ad una comunità di eletti che blinda il proprio perimetro al grido di «Morte all’invasore, morte al mostro!».
Scissione
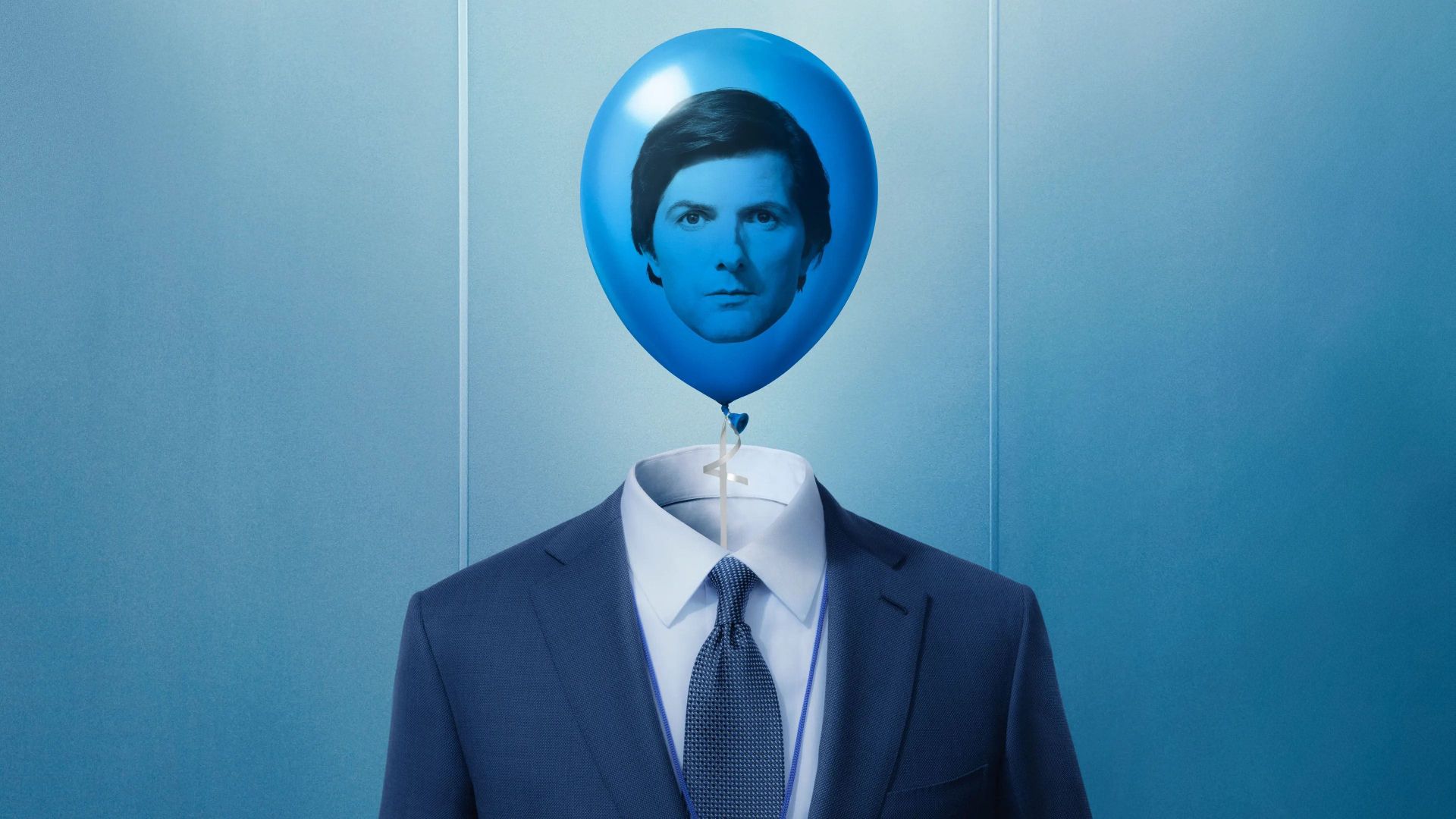 Scissione (Severance) – il secondo dei nostri esempi – è una serie del 2022 targata Apple Tv, di cui per ora sono disponibili due stagioni, anche se è già stata annunciata la messa in onda della terza. Ideata da Dan Erickson e prodotta da Ben Stiller (che dirige magistralmente anche metà degli episodi) rappresenta un piccolo capolavoro, sia per quanto riguarda la scrittura che le scelte estetico-formali. La vicenda, situata in un tempo imprecisato, ma ragionevolmente prossimo tanto al nostro passato recente, quanto al nostro futuro imminente, è ambientata in parte nella desolata cittadina di Kier – nello stato di New York – e in parte negli uffici della Lumen Industries, un’azienda tanto misteriosa quanto potente, che ha brevettato una procedura neurologica in grado di scindere la coscienza dei propri impiegati in due entità completamente distinte e irrelate. I dipendenti che sono stati sottoposti al processo di scissione – gli interni – sono completamente ignari di quanto accade loro al di fuori dell’ambiente lavorativo, mentre i loro corrispettivi mondani – gli esterni – non sanno nulla di ciò che avviene negli uffici dell’azienda con la quale hanno sottoscritto il contratto di assunzione. L’unica differenza di consapevolezza tra le due parti del sé scisso è che gli esterni hanno scelto di sottoporsi alla procedura, mentre gli interni l’hanno subita. Oltre a ciò, ed è un distinguo di non poco conto nell’economia dell’impianto narrativo, solo gli esterni possono risolvere il contratto, a significare che gli interni sono, loro malgrado, imprigionati in una realtà che non hanno scelto e dalla quale, al contrario degli alter ego che gli hanno in qualche modo generati, non possono evadere se non al prezzo del loro stesso autodissolvimento. Quanto alle ragioni che hanno portato ciascuno dei protagonisti a sottoporsi alla procedura e ad avere – si fa per dire – una seconda vita ignara della prima, sono sia di carattere personale (l’incapacità di sopportare il dolore di una perdita, un’omosessualità repressa vissuta come colpa, il senso di fallimento per la mancanza di un lavoro stabile) che dettate da deliri di marketing aziendale (l’erede al trono della famiglia Eagan – proprietaria della Lumen – che decide di sottoporre se stessa al processo di scissione per santificarne la fulgida efficacia).
Scissione (Severance) – il secondo dei nostri esempi – è una serie del 2022 targata Apple Tv, di cui per ora sono disponibili due stagioni, anche se è già stata annunciata la messa in onda della terza. Ideata da Dan Erickson e prodotta da Ben Stiller (che dirige magistralmente anche metà degli episodi) rappresenta un piccolo capolavoro, sia per quanto riguarda la scrittura che le scelte estetico-formali. La vicenda, situata in un tempo imprecisato, ma ragionevolmente prossimo tanto al nostro passato recente, quanto al nostro futuro imminente, è ambientata in parte nella desolata cittadina di Kier – nello stato di New York – e in parte negli uffici della Lumen Industries, un’azienda tanto misteriosa quanto potente, che ha brevettato una procedura neurologica in grado di scindere la coscienza dei propri impiegati in due entità completamente distinte e irrelate. I dipendenti che sono stati sottoposti al processo di scissione – gli interni – sono completamente ignari di quanto accade loro al di fuori dell’ambiente lavorativo, mentre i loro corrispettivi mondani – gli esterni – non sanno nulla di ciò che avviene negli uffici dell’azienda con la quale hanno sottoscritto il contratto di assunzione. L’unica differenza di consapevolezza tra le due parti del sé scisso è che gli esterni hanno scelto di sottoporsi alla procedura, mentre gli interni l’hanno subita. Oltre a ciò, ed è un distinguo di non poco conto nell’economia dell’impianto narrativo, solo gli esterni possono risolvere il contratto, a significare che gli interni sono, loro malgrado, imprigionati in una realtà che non hanno scelto e dalla quale, al contrario degli alter ego che gli hanno in qualche modo generati, non possono evadere se non al prezzo del loro stesso autodissolvimento. Quanto alle ragioni che hanno portato ciascuno dei protagonisti a sottoporsi alla procedura e ad avere – si fa per dire – una seconda vita ignara della prima, sono sia di carattere personale (l’incapacità di sopportare il dolore di una perdita, un’omosessualità repressa vissuta come colpa, il senso di fallimento per la mancanza di un lavoro stabile) che dettate da deliri di marketing aziendale (l’erede al trono della famiglia Eagan – proprietaria della Lumen – che decide di sottoporre se stessa al processo di scissione per santificarne la fulgida efficacia).
L’ambiente lavorativo è asettico, labirintico, claustrofobico, volutamente estraniante, dominato da un bianco privo di spessore e di tempo; mentre la vita lavorativa degli interni – che è l’unica di cui dispongono – è sempre identica a se stessa, se non per il fatto che, di tanto in tanto, è costellata da surreali siparietti fatti di recite, cappellini e premi produzione della portata di un dolcetto in più da consumare durante la pausa pranzo. Per il resto il loro lavoro consiste nell’individuare e rimuovere numeri «pericolosi» da enormi set di dati, senza sapere realmente quale sia il loro significato. Una surreale distopia dell’assurdo che però scompare dalla memoria una volta oltrepassata la soglia dell’azienda. Così come scompaiono lo sfruttamento, le vessazioni e le torture psicologiche a cui vengono sottoposti gli interni ogni volta che cercano di evadere dalla routine alienante.
Un dispositivo espropriante quasi perfetto che però si inceppa quando un ex collega di Mark (il personaggio principale della serie) viene ucciso dopo aver contattato il suo esterno e avergli fatto capire che è possibile la reintegrazione parziale delle due parti scisse e che la Lumen non è esattamente quello che sembra. È questo l’evento scatenante che, in una atmosfera cupa e straniante, nella quale si fondono noir, thriller, spy story e qualche venatura horror, mette in moto il meccanismo che porterà gli interni a voler accedere con la coscienza intatta al mondo dei propri esterni, per carpire le ragioni di un esilio che è tutt’uno con la loro nascita tardiva.
Oltre il rimosso
Come si evince da questa breve ricostruzione la trama, di cui non sveleremo altro, è molto sofisticata e si presta a molteplici livelli di lettura. Se in forma piuttosto esplicita l’idea centrale della serie allude a Freud e al rapporto tra Io e Es (anche se ovviamente in forma rovesciata, visto che la parte rimossa non è quella sofferente ma quella apparentemente felice che trova nel lavoro una distrazione dalla nevrosi del quotidiano), il modo in cui evolve il racconto intercetta una serie di riflessioni e di tematiche ognuna delle quali meriterebbe di essere trattata a parte. Alienazione (nel senso marxiano del termine), disumanizzazione, dominio, controllo, potere, memoria, identità; e, anche se in forma non immediata, ma non per questo meno stimolante, la questione del nemico posta in relazione proprio con il concetto di identità scissa e alterità rimossa. Perché dal momento in cui ciascuno degli interni, grazie a un breve episodio di reintegrazione, entra in contatto con la parte a lui sconosciuta della propria vita, si innesca un movimento a spirale che porterà le due metà della coscienza disgregata a diventare una nemica dell’altra; un processo di progressiva e sistematica ostilizzazione del rimosso che, se declinata in chiave politico-sociale, rischia di congelarsi in una frattura insanabile – quasi un nuovo nomos della Terra in forma di muro – che pone come inaggirabile e costituente del nostro stesso patto fondativo la distinzione fittizia tra «noi» – i buoni – e «loro» – i nemici. Dicevano Chamosieau e Glissant che «Ogni volta che una cultura o una civiltà non è riuscita a pensare l’altro, a pensarsi con l’altro, a pensare l’altro in sé, queste rigide difese di ferro, di filo spinato, di reti elettrificate o di ideologie chiuse si sono innalzate, sono crollate e ora ritornano con nuovi stridori»2. Perché se è vero che l’identità pensata come «muro» è presente in tutte le culture, è in Occidente che ha mostrato (e continua a mostrare) tutta la sua forza di devastazione.
Per ora non è dato sapere se l’umanità presente e futura della Fredda guerra dei mondi troverà un modo di convivere pacificamente o se i personaggi di Scissione riusciranno a ricomporre la lacerazione che, per loro stessa mano, ha precipitato parte della loro identità in territorio ostile. Certo è che solo accettando l’altro che è in noi riusciremo ad abbattere il muro da noi stessi edificato e forse, come auspicava il compianto Alessandro Leogrande, a farci testimoni dell’unicità di ogni ferita, compresa la nostra.
]]>
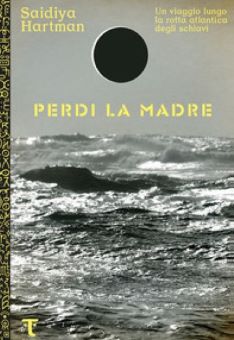 Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro
Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro
«Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi» recitano sia la copertina che il frontespizio del testo di Saidiya Hartman edito da Tamu, ma andrebbe aggiunto che involontariamente lo stesso libro ci accompagna lungo le linee di faglia di un percorso le cui fratture risultano essere altrettanto significative quanto l’apparente unità della sua eredità storica e sociale.
Quello che chi scrive non esiterebbe a definire come un romanzo-saggio, vista la passione e l’impegno compresi nel narrare elementi di storia che poco a poco [...]]]>
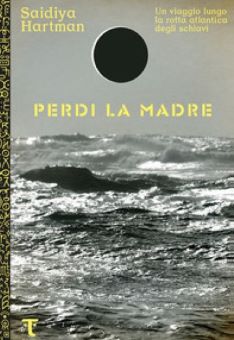 Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro
Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro
«Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi» recitano sia la copertina che il frontespizio del testo di Saidiya Hartman edito da Tamu, ma andrebbe aggiunto che involontariamente lo stesso libro ci accompagna lungo le linee di faglia di un percorso le cui fratture risultano essere altrettanto significative quanto l’apparente unità della sua eredità storica e sociale.
Quello che chi scrive non esiterebbe a definire come un romanzo-saggio, vista la passione e l’impegno compresi nel narrare elementi di storia che poco a poco sembrano fondersi con la vita e le memorie personali dell’autrice, costituisce infatti una sorta di viaggio lungo quella linea del colore che fin dall’epoca coloniale sembrerebbe aver costituito l’unico momento, per quanto doloroso, di unione tra coloro che dall’Africa furono deportati verso le Americhe e i loro discendenti.
Saidiya Hartman, che i lettori di Carmilla hanno avuto modo di incontrare già in occasione di due precedenti recensioni dei suoi libri (qui e qui ), per prima ha cercato di descrivere la “vita della schiavitù dopo la sua morte” ovvero la sopravvivenza di una separazione razziale insuperabile all’interno degli Stati Uniti, e forse dell’intero mondo occidentale bianco, che costituisce di fatto la base dei Black Studies più recenti basati spesso su quello che Kevin Ochieng Okoth ha definito come African Pessimism 2.01. Sempre secondo Okoth, però, a differenza di altri teorici dell’AP 2.0:
Per Hartman, l’abolizione formale della schiavitù negli Stati Uniti non ha prodotto una reale discontinuità nella violenza razziale. Troviamo oggi i segni di tale violenza nelle “ridotte chance di vita, nel limitato accesso alla salute e all’educazione, nelle morti premature, nelle incarcerazioni e nell’impoverimento” della gente nera. L’abolizione formale e la Ricostruzione non hanno portato all’emancipazione. Questi eventi sono piuttosto serviti come tappe della “transizione fra modi di servitù e subordinazione razziale”. Mettendo in primo piano il violento processo di subordinazione razziale, Hartman vuole mostrare che la violenza della schiavitù non è limitata alla “costruzione dello schiavo come oggetto”; infatti l’umanità dei soggetti resi schiavi era fondamentale per il progetto di subordinazione razziale. I neri, perciò, non sono oggetti subumani[…], bensì soggetti razzializzati che sono assolutamente parte della sfera sociale e politica.
Diversamente dall’AP 2.0 Hartman enfatizza la capacità di resistere della gente nera. In Vite ribelli, bellissimi esperimenti (2019) impiega il metodo della “affabulazione critica” per svelare le storie delle giovani donne nere e delle persone di genere non tradizionale negli Stati Uniti a cavallo del ventesimo secolo. In città come New York e Filadelfia, queste donne, a poche generazioni di distanza dalla schiavitù, erano sottoposte a nuove forme di razzializzazione e di asservimento e oppressione di genere. Hartman argomenta che queste donne nere erano impegnate in “piccole” rivoluzioni “per costruire vite autonome e bellissime, sottrarsi alle nuove forme di asservimento che le attendevano, e vivere come se fossero libere”. Hartman crea una contro-narrazione rispetto ai documenti ufficiali, nei quali troviamo silenzio o rimozione quando cerchiamo prove di queste vite ribelli. In una breve annotazione teorica, ci ricorda che il termine “ribelle” fa parte di una famiglia di parole che include “errante, fuggitivo, recalcitrante, anarchico, ostinato, spericolato, fastidioso, riottoso, tumultuoso, ribelle e selvaggio”. Il suo progetto appartiene alla tradizione dell’anarchismo americano (“anche se non ha letto God and the State o What is Property? oppure The Conquest of Bread, il pericolo che lei e altri come lei rappresentano è grande al pari di… Emma Goldman e Alexander Berkman”), tradizione alla quale non è però mai riducibile. Si tratta piuttosto di una pratica radicale nera che non può essere ricondotta ad altre ideologie politiche2.
 In Perdi la madre l’autrice, per ricostruire il passato della sua famiglia e dei suoi antenati e degli schiavi prelevati a forza per secoli dal continente africano, segue le tracce di una linea del colore che fu definita da William Edward Burghardt Du Bois3 fin dagli inizi del XX secolo, in occasione del Congresso panafricano che si tenne a Londra nel luglio del 1900 e da lui stesso presieduto. Occasione in cui i leader dei movimenti panafricani che in tale contesto ebbero modo di incontrarsi avevano ben chiara la rilevanza strategica che avevano e avrebbero avuto per il mondo il colore della pelle, la qualità del rapporto fra gli Stati seguiti alla Rivoluzione Francese e i popoli di colore.
In Perdi la madre l’autrice, per ricostruire il passato della sua famiglia e dei suoi antenati e degli schiavi prelevati a forza per secoli dal continente africano, segue le tracce di una linea del colore che fu definita da William Edward Burghardt Du Bois3 fin dagli inizi del XX secolo, in occasione del Congresso panafricano che si tenne a Londra nel luglio del 1900 e da lui stesso presieduto. Occasione in cui i leader dei movimenti panafricani che in tale contesto ebbero modo di incontrarsi avevano ben chiara la rilevanza strategica che avevano e avrebbero avuto per il mondo il colore della pelle, la qualità del rapporto fra gli Stati seguiti alla Rivoluzione Francese e i popoli di colore.
Una linea che è servita adeguatamente a dividere i bianchi dai “neri”, ma soprattutto un proletariato mai definitivamente formato, sia che si trattasse di quello delle origini della rivoluzione industriale che di quello americano degli ultimi due secoli oppure che si tratti di quello attuale, ancora sempre in via di definizione a causa di migrazioni, crisi, guerre e, come al solito, miseria diffusa, anche se non sempre equamente tra i poveri e i lavoratori dei diversi continenti. Sì, poiché il modo di produzione attuale, in base alla ripartizione coloniale e imperialistica del mondo, riesce comunque a ripartire diversamente non solo la ricchezza, ma anche la povertà, garantendo livelli diversi di consumo e accesso ai beni e ai servizi dello Stato.
Una ricostruzione della linea di discendenza famigliare, dalle origini africane alla sistemazione negli States, che porta Saidiya ad incrociare il cammino di Du Bois anche sul terreno dell’Africa, in quel Ghana dove lo studioso e politico afroamericano era morto nel 1963 ad Accra, la capitale, e dove era stato naturalizzato come cittadino ghanese proprio in quell’anno da Francis Nwia-Kofi Ngonloma (1909 – 1972), meglio noto come Kwame Nkrumah (scritto anche Kwame N’Krumah) e talvolta indicato con lo pseudonimo di Osagyefo, “il redentore” per il ruolo rivoluzionario svolto a favore dell’Africa e in particolare del Ghana, diventato definitivamente indipendente nel 1960. Un fatto che aveva fatto sì che, come documenta il testo della Hartman, dopo l’indipendenza formale raggiunta nel 1957 il Ghana potesse rappresentare un faro di libertà per il movimento dei diritti civili e Nkruma fosse idealizzato come il liberatore di tutti i popoli neri.
Non solo i neri americani si identificarono con la lotta anticoloniale, ma credevano che il loro stesso futuro dipendesse dalla vittoria di quella lotta. Un articolo pubblicato sul «Chicago Defender» nel febbraio del 1957 dichiarava: «Un giorno i neri del Ghana potranno presentarsi davanti all’Onu e perorare la causa dei Neri americani ed essere gli artefici della conquista della completa uguaglianza… Il popolo libero del Ghana potrà liberare i suoi fratelli in America dall’ultima delle catene». [Così] Durante gli anni ‘50 e ‘60, gli africani americani accorsero in Ghana in gran numero4.
Un sogno di libertà e realizzazione individuale e collettiva che, però, ai tempi del viaggio di Saidiya alla ricerca delle origini, mostrava già tutte le crepe della disillusione e, soprattutto, dell’incomprensione tra ghanesi e afro o obruni, come venivano definiti coloro che erano arrivati dagli Stati Uniti nei decenni precedenti. Una distanza che la Hartman avverte subito appena arrivata ad Elmina, una città del Ghana meridionale che è anche il più antico insediamento europeo in Africa occidentale dopo Cidade Velha.
Appena scesi dal bus a Elmina, lo sentii. Risuonò nell’aria tagliente e chiaro, e mi sferragliò nelle orecchie facendomi ritrarre. Obruni, Straniera. Una forestiera d’oltreoceano […] Mentre le parole si facevano strada tra la folla per raggiungermi, immaginai me stessa ai loro occhi […] Il mio aspetto lo confermava: ero la tipica straniera. Chi altro indossava vinile ai tropici? I miei costumi appartenevano a un altro paese […] Mondi vecchi e nuovi marcavano il mio viso, una miscela di popoli e nazioni e padroni e schiavi da molto tempo dimenticati nella confusione dei miei tratti, nessuna linea d’origine certa poteva essere tracciata. Era chiaro che non fossi una fanti, una asante, una ewe o una ga. […] Un viso nero non mi rendeva una di loro. Anche quando passavo inosservata, venivo tradita dalla parlata di Brooklyn di mio padre che increspava la mia pronuncia impostata appena aprivo bocca […] Il mio modo diretto di parlare suonava spigoloso e asciutto se paragonato alla discreta evasività e alla cortese opacità dell’inglese locale […] Ero la straniera del villaggio, un seme errante privato della possibilità di mettere radici […] Tutti evitavano la parola “schiava”, ma ognuno di noi sapeva chi fosse chi. In qualità di “figlia di schiava” rappresentavo ciò che la maggior parte della gente aveva scelto di rifuggire: la catastrofe che era il nostro passato, le vite scambiate per stoffa indiana, perle veneziane, conchiglie di ciprea5, armi e rum. Rappresentavo ciò di cui era proibito discutere: la questione delle origini6.
Non fa sconti a se stessa e a nessun altro l’autrice che, come afferma Barbara Ofosu-Somuah nella presentazione dell’edizione italiana del libro:
Fin dalle prime pagine di Perdi la madre, Saidiya Hartman chiarisce che «se la schiavitù rimane una questione aperta nella vita politica dell’America nera, non è a causa di un’ossessione antiquaria per i giorni andati o per il peso di una memoria troppo duratura, ma perché le vite nere vengono ancora svalutate e messe a repentaglio da un calcolo razziale e da un’aritmetica politica consolidatisi secoli fa». La schiavitù e i suoi lasciti, ovvero il mondo creato da schiavitù e colonialismo, fanno ancora oggi parte del vissuto delle persone della diaspora nera7.
Ma, come si affermava poc’anzi, fa anche i conti con una distanza inaspettata tra coloro che nella blackness dovrebbero, o avrebbero dovuto, riconoscersi nonostante le differenze di nazionalità e classe.
Nkrumah credeva che l’indipendenza del Ghana non significasse nulla se tutti gli africani non fossero stati liberi. Gli emigrati neri condividevano quel sogno. Arrivarono dagli Stati Uniti, dai Caraibi, dal Brasile, dal Regno Unito e da altri paesi africani ancora impegnati nella lotta contro il colonialismo e l’apartheid […] Malcom X visitò il Ghana e vi tenne conferenze nel tentativo di costruire l’Organizzazione dell’unità afroamericana. Frantz Fanon scrisse larga parte dei Dannati della terra mentre si trovava in Ghana […] Con tutta l’arroganza e l’ardore della giovinezza, un gruppetto si autonominò i Reduci Rivoluzionari. I ghanesi li chiamavano gli afro, diminutivo per africani americani. Arrivarono con […] un «terribile desiderio di essere accettati», per condividere il loro destino con quello dei ghanesi e intraprendere il duro lavoro di costruzione della nazione8.
Ma come afferma subito l’intellettuale afroamericana, dopo esser giunta lì diversi decenni dopo, «la mia non era l’epoca del romanticismo. L’Eden del Ghana era svanito molto tempo prima del mio arrivo.» Un Eden che era sparito con la crisi della figura dello stesso Nkrumah che aveva avviato meccanismi sempre più autoritari di governo, non sempre compresi dalla popolazione, che avevano portato ad una sua destituzione da parte dell’esercito nel 1966. Un fatto politico “concreto” che fece sì che molti di coloro che erano giunti in Ghana carichi di speranze e sogni panafricani rimanessero al loro posto subendo, però, nel tempo una sorta di allontanamento dalla popolazione locale.
Dopo aver appreso la notizia che Nkrumah era stato rovesciato, gli africani americani piangevano mentre i ghanesi esultavano e danzavano nelle strade. Gli émigrés non si facevano illusioni circa il loro stato, come spiega Leslie Lacy: «Ci tolleravano perché dovevano sopportare Nkrumah, e se avessero potuto ucciderlo alle otto in punto, alle otto e trenta il nostro destino sarebbe stato il suo». I ghanesi erano risentiti con gli afro perché questi occupavano delle posizioni che spettavano loro di diritto, godevano di alta considerazione e influenza presso il presidente, e avevano la presunzione di sapere cosa fosse meglio per l’Africa. Molti africani americani fuggirono volontariamente, alcuni di loro furono deportati9.
Altri rimasero e sono quelli che l’autrice incontra nel corso del suo viaggio e che gli permettono di narrare una storia quasi altrettanto dolorosa di quella degli schiavi deportati dopo essere stati traditi e venduti dai re locali e detenuti in condizioni orribili nei forti costruiti dai portoghesi e dagli olandesi lungo le coste dell’Atlantico. Una storia anche di neri bianchi intesi come ricchi dai residenti africani che guardano alle loro residenze in città come Elmina con un certo fastidio.
Uno sguardo alle lussuose case che torreggiavano sulla costa, sovrastate soltanto dal castello di Elmina, forniva tutte le evidenze necessarie. Le maestose residenze bianche dei discendenti degli schiavi alimentavano l’invidia, come anche il sospetto che la schiavitù non fosse poi stata così male, vista la ricchezza che gli africani americani chiaramente possedevano. Tutti concordavano che essi fossero arrivati troppo tardi per cambiare qualcosa, e provavano soddisfazione nel vedere sconfitti i desideri dei benestanti […] Altri li deridevano, affermando che i nouveaux riches ostentavano ogni minima loro ricchezza perché avevano il disperato bisogno di mostrare di essere gente che conta. Quelli che erano arrivati troppo tardi, non potendo sbarazzarsi di questa etichetta la accettarono con riluttanza […] non sfoggiavano la loro ricchezza,e non erano neppure ricchi, ma era impossibile non notare la disparità tra il loro stile di vita e quello della maggior parte dgli abitanti di Elmina […] Le elganti abitazioni allineate lungo la costa mi ricordavano le ampie dimore costruite in Liberia dagli ex-schiavi provenienti dalla Carolina del Sud e del Nord e dal Mississippi, che riproducevano quel mondo da cui erano migrati con l’eccezione che ora erano loro i nuovi padroni.
Le case dei ricchi erano anche un promemoria dolceamaro della libertà di cui non avrebbero mai goduto in America. Queste case annunciavano al resto di Elmina che i ricchi erano sbarcati, e che si trattava di neri uomini bianchi. Ogni mattone, ogni pilastro, testimoniava l’impossibilità di un ritorno e l’imprudenza di credere nelle origini, di provare a recuperarle. Costruite all’ombra del castello, a mo’ di provocazione – laddove una volta venivamo marchiati e venduti, ora prosperiamo – queste proprietà erano il frutto di una battaglia ancora in atto tra le razze creditrici e debitrici, predatori e prede, mercanti e schiavi10.
Se si è scelto, all’interno di una recensione che intende essere problematizzante, di soffermare maggiormente l’attenzione sulle vicende di coloro che, lasciandosi alle spalle gli Stati Uniti e credendo nel panafricanismo, avevano raggiunto il continente africano inseguendo un sogno di libertà e giustizia, è soltanto perché quel sogno portava con sé un mito. Lo stesso che insegue, in fin dei conti, anche l’autrice: quello del ritorno, impossibile, alle origini.
Origini talmente crudeli e devastanti da aver cancellato la possibilità di liberare i neri, africani e americani, inseguendo soltanto l’unicità e l’unità rappresentata dalla blackness o da una linea del colore capovolta. Come forse avrebbe voluto lo stesso Du Bois quando propose la formazione di uno stato afroamericano all’interno degli Stati Uniti11. Origini nazionali e culturali che, però, il proletariato non può permettersi di avere una volta formatosi come tale perché, in quanto tale, «non ha più nazione» e, tanto meno, può accettare di razzializzarsi, ovvero interiorizzare una razzializzazione imposta dall’alto secondo le ideologie nazionaliste, razziste o religiose.
 Un sogno, quello abbozzato prima, che, sostituendo invece la razza o il colore della pelle alle classi in lotta tra di loro, indipendentemente dalle linee del colore utilizzate per avvantaggiarne soltanto alcune, è fallito ormai da tempo. Nonostante gli sforzi della borghesia bianca e nera di utilizzarlo contro la lotta di classe, al di qua e al di là dell’Atlantico.
Un sogno, quello abbozzato prima, che, sostituendo invece la razza o il colore della pelle alle classi in lotta tra di loro, indipendentemente dalle linee del colore utilizzate per avvantaggiarne soltanto alcune, è fallito ormai da tempo. Nonostante gli sforzi della borghesia bianca e nera di utilizzarlo contro la lotta di classe, al di qua e al di là dell’Atlantico.
Soprattutto dopo che un afroamericano ha raggiunto la carica più alta dello stato americano per ben due mandati, senza nulla poter o voler cambiare sia sul piano dei rapporti politico-economici che razziali, l’immagine dei neri uomini bianchi ricchi arrivati comunque troppo tardi richiamata dalle parole della Hartman sembra essere pienamente confermata, insieme alla negazione della speranza in quegli “uomini eccezionali” che secondo Du Bois avrebbero dovuto e potuto salvare “la razza Negra”12.
Rivelando così come il libro della Hartman sia allo stesso tempo doloroso e indispensabile, la cui lettura attenta e la riflessione che è destinata ad accompagnarla in ogni caso rimane indispensabile per chiunque voglia avvicinarsi ai problemi e alle difficoltà connesse ai processi di liberazione di un’umanità divisa al suo interno lungo linee di ordine nazionalistico, razziale, religioso e cultural prestabilite, fino ad ora, dall’utopia capitale. Che proprio dall’Africa e dal commercio degli schiavi prese l’avvio per la sua affermazione e il suo dominio su scala planetaria.
K. O. Okoth, Red Africa. Questione coloniale e politiche rivoluzionarie, Meltemi Editore, Milano 2024, pp. 36 -51. ↩
K. O. Okoth, op. cit., pp. 42-44. ↩
Nato nel 1863 nel New England, Du Bois fu il primo afroamericano a prendere il dottorato a Harvard (studiando con William James), si perfezionò a Berlino con Max Weber (e al ritorno fondò la sociologia moderna negli Stati Uniti), creò la National Association for the Advancement of Colored People, promosse i congressi panafricani che preparano le indipendenze africane, morì nel 1960 ad Accra, capitale di un Ghana appena diventato indipendente, dopo essersi iscritto, a novant’anni, al partito comunista. ↩
S. Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, p. 53. ↩
Si veda in proposito: T. Green, Per un pugno di conchiglie. L’Africa occidentale dall’inizio della tratta degli schiavi all’Età delle rivoluzioni, Giulio Einaudi editore, Torino 2021. ↩
S. Hartman, op. cit., pp. 17-18. ↩
B. Ofosu-Somuah in S. Harman, op. cit., p. 7. ↩
S. Hartman, op. cit., pp. 55-56. ↩
Ivi, p. 57. ↩
Ibidem, pp.130-131. ↩
Si vedano gli scritti dello stesso contenuti in W.E. B. Du Bois, Sulla linea del colore. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo, a cura e con un’introduzione di Sandro Mezzadra, Bologna, Il Mulino, 2010. ↩
W.E.B. Du Bois, The Talented Tenth (1903) ora in W.E.B. Du Bois, op. cit., con il titolo Il decimo con talento, pp. 155-177. ↩
 Una delle definizioni che si danno del termine “ideologia” è quella secondo cui per essa si intende “il complesso di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale”.
Una delle definizioni che si danno del termine “ideologia” è quella secondo cui per essa si intende “il complesso di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale”.
Si potrebbe anche aggiungere, a tale larga definizione, anche l’identificazione di una certa ideologia come riferita ad un determinato momento storico più o meno ampio; si potrebbe anche individuare il “gruppo sociale” sopra menzionato con la collettività dei cittadini di un ente politico, come lo stato nazionale.
Ma tutto ciò non toglie nulla al fatto che si tratti di un complesso di elementi che condizionano la cultura [...]]]>
 Una delle definizioni che si danno del termine “ideologia” è quella secondo cui per essa si intende “il complesso di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale”.
Una delle definizioni che si danno del termine “ideologia” è quella secondo cui per essa si intende “il complesso di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale”.
Si potrebbe anche aggiungere, a tale larga definizione, anche l’identificazione di una certa ideologia come riferita ad un determinato momento storico più o meno ampio; si potrebbe anche individuare il “gruppo sociale” sopra menzionato con la collettività dei cittadini di un ente politico, come lo stato nazionale.
Ma tutto ciò non toglie nulla al fatto che si tratti di un complesso di elementi che condizionano la cultura di ogni persona ma che non necessariamente, devono coincidere, ma possono diversificarsi a seconda del livello culturale individuale.
Direi di più; tanto più gli accenti e le motivazioni sono diversificati, tanto più risultano caratterizzati democraticamente, ma ad una condizione, e cioè che si abbia un minimo denominatore valoriale comune.
In tal caso si potrebbe parlare di “ideologia democratica” intesa come senso comune tendente al rispetto del cittadino e delle sue libertà e, sotto tale profilo, si ritiene che nessuno possa essere reso differente da quel termine.
Tuttavia, da diversi decenni a questa parte, l’ideologia è considerata un termine di contenuto negativo, ed è entrata nel novero delle “parolacce” escluse dal politically correct.
Ma, se consideriamo la definizione che abbiamo richiamato in precedenza, non sembra proprio che quella parola debba avere significati così riprovevoli.
Ed allora sarà necessario svolgere alcune considerazioni sul fatto che certi vocaboli, col tempo e nel variare dei contesti socio-politici, possono mutare di significato nella percezione comune.
Ad esempio il concetto di nazione, se usato propriamente per indicare, come si legge nei libri di scuola, un territorio, una collettività di persone, una storia e una volontà culturale, non assume un significato chiuso e aggressivo.
Qualora si utilizzi quel termine, invece, in termini di contrapposizione rivendicativa nei confronti di altre nazionalità, allora il significato cambia e diviene foriero di conflitti; cioè diviene nazionalismo.
Ma anche lo stesso concetto di patria, originariamente inteso come la terra delle proprie origini, può essere utilizzato come rivendicazione nazionalistica, con grave rischio della pace tra i popoli.
Dunque, anche l’ideologia, complici alcune circostanze di carattere storico e geo-politico, ha subito quella distorsione.
E allora cerchiamo di riportare quel concetto nel suo alveo naturale e più oggettivo.
Chi si fa promotore, si identifica o segue una certa ideologia, lo fa in quanto ha nella propria mente un certo disegno di come vorrebbe il mondo, i rapporti individuali e sociali, la organizzazione di una società, gli obiettivi da raggiungere.
Ad esempio, il cristiano-cattolico, desidererebbe una società ispirata alla dottrina sociale e religiosa della chiesa romana, e perciò sottoposta a quei principi morali e alla professione di quella fede.
Chi si professa anarchico vorrebbe una società di uomini liberi e uguali, senza l’assoggettamento a soggetti economici, a regole statali e a precetti religiosi.
Ebbene entrambe le ipotesi, ben diverse tra loro, che abbiamo indicato possono essere considerate, sulla scorta della definizione data all’inizio di questo modesto scritto, delle ideologie.
Ma cosa c’è di riprovevole nell’ipotesi di definizione dell’ideologia cui si è, nell’incipit, fatto cenno?
Che cosa possiamo trovare di sconveniente o negativo, in un contesto di società democratica dove vigono i principi dell’uguaglianza, della libertà, della solidarietà, nella pratica di tali ideologie da parte di coloro che le professano?
E qui entra in gioco il fatto che ciascuno di noi ha, o dovrebbe avere, una propria etica, delle finalità, delle aspirazioni.
E dunque purché tale etica, finalità o aspirazioni siano in qualche modo coerenti con i principi di uguaglianza, libertà e solidarietà, qualsiasi impostazione ideologica compatibile con esse, è non solo conforme, ma addirittura utile proprio per la realizzazione, anche concreta, di quei principi.
Infatti, nell’ambito di tale combinazione, l’ideologia di ciascuno segue o alla quale aderisce, assume il significato di una pulsione ideale, oltre che morale, e conferma pertanto una dimensione etica all’attività dell’uomo.
E ciò sarà tanto più valido e positivo quanto più tali dimensioni etiche, che possono anche essere tra loro differenti, si potranno identificare in quei principi sommari della democrazia, che non abbiamo inventato noi oggi, ma che vigono niente meno che dalla fine del 1700.
Il pericolo dal quale guardarsi è invece quella della manipolazione dell’ideologia in un pensiero unico che, in tempi passati, è stato realizzato con la repressione e forme di stato oppressivo e autoritario, e che oggi viene realizzato con forme più sofisticate, come la concentrazione dei poteri sul governo politico, la concentrazione delle testate giornalistiche, la induzione forzata a certi consumi, l’abbassamento del livello culturale complessivo.
Oggi talune ideologie dominanti tendono ad accreditarsi come se fossero teorie scientifiche descrittive e, nello stesso tempo, accusano le altrui posizioni descrittive come viziate da pregiudizi ideologici, in tal modo confondendo i rispettivi livelli concettuali. Nel caso dell’uguaglianza, il fatto sembra evidentissimo: l’ideologia neoliberista afferma, come se fosse una teoria scientifica, che la disuguaglianza fa bene a tutti, e attacca come ideologicizzati (e cioè non scientifici) gli studi che descrivono le disuguaglianze esistenti e i loro effetti nefasti.
E da quelle insidie, oggi assai diffuse e perfino viste con benevolenza da diversi governi, anche nell’ambito dell’Unione Europea, che bisogna guardarsi e anche combattere per l’abbandono di siffatte tendenze.
Qualora ciò avvenga, non ci sarà più il pericolo che qualsiasi individuo, che si dichiari professante di un’ideologia, possa essere scambiato o additato come uno squallido propagandista.
]]>Nel momento in cui si realizzi che tutte le istituzioni risultano funzionali al nostro sistema economico, si giunge ad una presa di coscienza successiva che potrebbe definirsi il momento della razionalizzazione politica. Infatti, nel loro essere funzionali al sistema, le istituzioni si rivelano direttamente legate ai valori della classe dominante che le crea e le determina, dimostrando come la loro funzione consista essenzialmente nel mantenimento di questi valori e nel garantirne l’efficacia nella manipolazione di un’intera società. L’azione che si vuole attuare in un’istituzione funzionale al sistema non può quindi limitarsi ad un [...]]]>
Nel momento in cui si realizzi che tutte le istituzioni risultano funzionali al nostro sistema economico, si giunge ad una presa di coscienza successiva che potrebbe definirsi il momento della razionalizzazione politica. Infatti, nel loro essere funzionali al sistema, le istituzioni si rivelano direttamente legate ai valori della classe dominante che le crea e le determina, dimostrando come la loro funzione consista essenzialmente nel mantenimento di questi valori e nel garantirne l’efficacia nella manipolazione di un’intera società. L’azione che si vuole attuare in un’istituzione funzionale al sistema non può quindi limitarsi ad un semplice capovolgimento umanitario della situazione specifica, ma dovrebbe agire all’interno della funzionalità dell’istituzione nei confronti del sistema stesso (Franco Basaglia, L’utopia della realtà, p. 176)
Come AntropologƏ per la Palestina, un collettivo di docenti/ricercatori/ricercatrici di Antropologia Culturale, abbiamo organizzato una due giorni a Siena (11 e 12 Aprile: qui il programma) dal titolo “L’antropologia di fronte al genocidio. Giornate di studio in solidarietà con il popolo palestinese”. Abbiamo scelto una formula che ci sembra in grado di rompere l’opposizione fittizia tra teoria e pratica (politica), che è alla base dell’altrettanto fittizia “neutralità” scientifica. Nella prima giornata parliamo di accaparramento delle terre e sfide epistemologiche relative alla questione palestinese con la partecipazione, tra gli altri, di Ruba Salih (Università di Bologna), Rema Hammami (Università di Birzeit), Noureddine Amara (Università di Zurigo), Mahmoud Hawari (Università di Birzeit), Hafsa Marragh (Università di Napoli L’Orientale), Izzeddin Araj (Università di Ginevra) e Ziad Medouck (Al Aqsa University). Mentre nella seconda giornata, che si concluderà con un laboratorio sul cinema palestinese ed alcune testimonianze da Gaza, abbiamo proposto la mattina una discussione assembleare del comparto “istruzione”, dal titolo “Militarizzazione della ricerca e dell’istruzione e silenziamento dei saperi critici: quali direzioni, quali resistenze?”. L’obiettivo è quello di un dialogo tra docenti di ogni ordine e grado, organizzazioni studentesche, realtà organizzate del mondo dell’istruzione, sindacati, rispetto a quello che la questione palestinese, l’accelerazione della tendenza alla guerra, i tentativi di “disciplinamento” dell’istruzione, comportano per il mondo della scuola e dell’università e quali strumenti ci diamo per il controllo e l’opposizione a questi processi.
Diversi mesi fa avevamo ritenuto opportuno intervenire nel dibattito pubblico rispetto a quello che sta accadendo in Palestina, che si differenzia soltanto per grado, e non certo per natura, con quello che in quella terra accade dal 1948: un genocidio che passa per la costante espropriazione della terra, delle risorse e delle possibilità stesse di residenza dei palestinesi; una continuità che solo uno sguardo razzista e coloniale può occultare eleggendo il 7 ottobre del 2023 a origine di tutto, negando la storia, la cultura, l’umanità e la sofferenza dell’altro. Decidemmo di scrivere un appello mentre i nostri tentativi di assumere il boicottaggio accademico in maniera ufficiale furono ampiamente ostacolate dalle organizzazioni di categoria.
Se nelle strade, rispetto al solito “ceto politico” o “di movimento”, si produceva una promettente eccedenza di mobilitazione, la questione palestinese avanzava sempre più come tema all’interno delle università, grazie all’impegno di organizzazioni studentesche che hanno sostenuto presidi, prodotto materiali, e costretto le istituzioni accademiche a scegliere tra il confronto aperto o la esplicita repressione. La questione palestinese era il punto di caduta di altre problematiche del settore istruzione, il cui rischio è di assomigliare a quello israeliano.
La traduzione in Italia del libro Torri d’avorio e di acciaio di Maya Wind condensava tutte le complicità delle università Israeliane con il colonialismo e il suo progetto genocida (appoggio visibile sin dalla visita alle home page di queste istituzioni): da un lato, nei termini di come i saperi (archeologia, storia, scienze sociali) prodotti al loro interno creassero l’ulteriore patina ideologica per l’avanzata del progetto israeliano; dall’altro, sul livello del supporto all’industria bellica: le università israeliane hanno stabilito dei programmi con aziende leader nel settore militare (Iai, Rafael, Elbit) che progettano gli F-16, i carri armati Merkava, gli elicotteri apache usati in tutte le recenti campagne militari contro la striscia di Gaza (2008-2009, 2012, 2014, 2021), puntualmente sanzionate come “crimini di guerra” dal consiglio ONU per i diritti umani. Queste aziende prontamente ricambiano con cospicue borse di studio, posti di lavoro garantiti come sbocco agli studenti e centinaia di migliaia di dollari per la ricerca (inutile sottolineare in che direzione…). Se il primo problema da porsi era dunque quello degli accordi di collaborazione delle nostre istituzioni accademiche con università israeliane direttamente coinvolte nell’oppressione dei palestinesi, come non temere, contestualmente, che questi approcci possano essere dei modelli accattivanti per la nostra università sempre più definanziata e colpita dai tagli al fondo ordinario del luglio 2024 e dalla nuova riforma sul preruolo dell’agosto successivo? Iniziava a irrompere nel dibattito pubblico, anche grazie alla pubblicazione di “università e militarsimo” di Michele Lancione, il tema delrapporto tra università e la filiera bellica: il Legame con Leonardo S.p.a., il ruolo della fondazione Med-Or, le dinamiche di accordo con pezzi dell’esercito, nonché le infinite possibilità determinate dal cosiddetto “dual use”, ovvero la possibilità che le tecnologie (ma anche le etnografie) sviluppate da ricercatori e dipartimenti scientifici possono essere utilizzate sia per usi militari che per usi civili.
In parallelo si amplificava un livello di “disciplinamento” del personale accademico rispetto a quanto già visto nelle precedenti crisi: a livello internazionale Ghassan Hage viene licenziato dal Max Plank Institute per alcune sue affermazioni sulla questione Palestinese, una feroce campagna mediatica viene avviata contro Luciano Vasapollo per aver espresso l’idea che Israele fosse uno stato terrorista, in diverse occasioni incontri che contengono il termine “genocidio” vengono vietati, nonostante le disposizioni di diversi organi di giustizia internazionale, e nonostante la costante aggiunta di migliaia di morti al macabro conteggio, i feriti gravi, i mutilati e un orrore israeliano arrivato a denudare e legare il personale degli ospedali, bruciare tende con bambini, sparare sul personale sanitario, e, soprattutto, parlare pubblicamente della volontà di deportazione di massa dei palestinesi altrove.
Gli accadimenti più recenti non descrivono un cambio di tendenza, ma anzi confermano la complessità e la pericolosità della fase storica che stiamo attraversando: se negli Stati Uniti sono partite direttive per il divieto di alcune espressioni e temi di ricerca, accompagnate alle persecuzioni di coloro che si erano attivati per la questione palestinese, le cose da noi non vanno certo meglio. Le recenti linee guida per la scuola primaria propongono una visione di suprematismo europeo (gli unici a conoscere la storia e la libertà), mentre si propone di sottoporre le strutture universitarie e della pubblica amministrazione all’obbligo di fornire informazioni ai servizi segreti su student_ e docenti, sancendo materialmente e simbolicamente la negazione dell’autonomia dell’università. Difficile immaginare che queste intimidazioni non abbiano processualità reale, soprattutto in un mondo trasformato in lavoro ad alto livello di precarietà e, dunque, di ricattabilità. Lo scorso 22 marzo ad un convegno sull’università organizzato da Cambiare Rotta, Tommaso Montanari ha posto la seguente e sacrosanta domanda “Come è possibile difendere l’università come luogo del sapere critico se è un sistema basato sullo schiavismo?”. Bisogna immaginarci una università diversa, la cui funzione sociale sia invertita rispetto alla mera partecipazione ai processi di valorizzazione e alla produzione di soggettività utili solamente a svolgere compiti specifici nella grande catena di montaggio sociale. Noi non vogliamo tirarci indietro dalla responsabilità di dover svolgere un ruolo, costruendo saperi diversi, antagonisti, anticoloniali, che possano nascere e calarsi immediatamente sul piano delle pratiche.
]]>Mentre non è ancora morto il Poteve Opevaio, schiere di sfruttati continuano a prendere il bus al volo
Per la regia di Luciano Salce, il 27 marzo 1975 usciva nei cinema Fantozzi, e il giorno del cinquantesimo anniversario – giovedì 27 marzo 2025 – tornerà nelle sale questo primo leggendario capitolo della saga del Ragionier Ugo; a festeggiare lo storico personaggio inventato da Paolo Villaggio, sarà una versione del film rimessa a nuovo dal laboratorio di restauro cinematografico L’Immagine Ritrovata, con la supervisione di Daniele Ciprì per il processo di color correction.
Fantozzi nasce nelle storie che Villaggio [...]]]>
Mentre non è ancora morto
il Poteve Opevaio,
schiere di sfruttati
continuano a prendere il bus al volo
Per la regia di Luciano Salce, il 27 marzo 1975 usciva nei cinema Fantozzi, e il giorno del cinquantesimo anniversario – giovedì 27 marzo 2025 – tornerà nelle sale questo primo leggendario capitolo della saga del Ragionier Ugo; a festeggiare lo storico personaggio inventato da Paolo Villaggio, sarà una versione del film rimessa a nuovo dal laboratorio di restauro cinematografico L’Immagine Ritrovata, con la supervisione di Daniele Ciprì per il processo di color correction.
Fantozzi nasce nelle storie che Villaggio scrive per “L’Europeo”, un settimanale d’attualità edito da Rizzoli pubblicato sino al 2013; diventerà un libro nel 1971, quando lo stesso editore del settimanale gli proporrà di raccogliere queste storie in volume.
Nella premessa del libro datata luglio 1971, l’attore genovese scrive: “Con Fantozzi ho cercato di raccontare l’avventura di chi vive in quella sezione della vita attraverso la quale tutti (tranne i figli dei potentissimi) passano o sono passati: il momento in cui si è sotto padrone. Molti ne vengono fuori con onore, molti ci sono passati a vent’anni, altri a trenta, molti ci rimangono per sempre e sono la maggior parte. Fantozzi è uno di questi. Nel suo mondo il padrone non è più una persona fisica, ma un’astrazione kafkiana, è la società, il mondo. E di questa struttura lui ha paura sempre e comunque perché sa che è una struttura-società che non ha bisogno di lui e che non lo difenderà mai abbastanza. Questo per lo meno qui da noi. Ma questo rischia di diventare un discorso politico troppo serio per uno «scherzo» quale deve essere tutta questa faccenda del «libro» e mi fermo qui”.
Era ed è sì un discorso politico: lo era allora, quando sul viso di Fantozzi ritrovavamo tutte le sconfitte dell’impiegato medio italiano, non una caricatura, ma una discarica pubblica dove ci si alleggeriva tutti, in cui si evacuavano le risate amare che le nostre facce da culo producevano guardando le genuflessioni del Ragionier Ugo davanti allo stesso Megadirettore Galattico che ci aspettava l’indomani in ufficio, al quale rispondevamo “faccio subito” intanto che speravamo che qualcuno gli sparasse nelle gambe; lo è al giorno d’oggi, mentre una struttura-società che non ha bisogno di noi e non ci difenderà mai abbastanza, ci sta sfruttando con quella viscida delicatezza che cinquant’anni fa ancora non esisteva, che prevede di non prenderci a manganellate perché, con gli anni, è stata capace di convincerci che dobbiamo essere noi a manganellare i nostri pari che non seguono le direttive dei potenti – non a caso, nella stessa premessa l’autore ci consiglia coi potenti “di essere vischiosi, servili e sempre d’accordo anche su posizioni «fasciste»”, un po’ come certi conduttori televisivi che da decenni non riusciamo a scollarceli di dosso, regnanti indiscussi di squallidi studi televisivi consacrati alle celebrazioni del regime.
Sul manganellare i nostri pari, Villaggio aveva capito che era un processo già iniziato: “[…] la pesantissima boccia di metallo di 42 chili centrò in piena nuca il suo direttore, che aveva accostato alle labbra in quel momento un bicchiere di vino ristoratore. Fantozzi non si fermò neppure a chiedere scusa ma si diede alla macchia sulle montagne. Cominciò allora una delle più feroci cacce all’uomo degli ultimi centovent’anni. Parteciparono alla ricerca cani-poliziotto e feroci molossi napoletani, mescolati ai quali c’erano moltissimi impiegati ruffiani che si erano offerti come cani da riporto per segnalarsi presso la direzione sperando in un aumento. Dopo tre giorni e tre notti di drammatica caccia tra gli acquitrini, Fantozzi fu circondato da un gruppo di colleghi abbaianti, tenuti al guinzaglio da alcuni feroci dirigenti”.
A differenza dei tanti comici che proliferano nei numerosi spettacoli d’oggi creati apposta per far ridere il pubblico e che sempre più raramente raggiungono l’obiettivo, Villaggio non ci parla di una zona dell’Italia – siciliani o calabresi “contro” milanesi, nordisti “contro” sudisti, apologie del romanesco, napoletano, toscano, eccetera – non ci parla di uomini “contro” donne e viceversa – i primi che sporcano di pipì la seduta del water, le seconde che sono intrattabili in “quei giorni” – no, Villaggio non ha alcuna intenzione di anestetizzarci con queste fesserie che fingiamo di credere esistere ancora ridendo fintamente a crepapelle perché intorno a noi altri fanno la stessa cosa, no, Villaggio ci parla dell’autobus preso al volo perché cinquant’anni fa si provava a dormire sino all’ultimo minuto dopo giornate snervanti già allora per la mancanza di senso, che mi ricordano molto da vicino la vita che fanno certe dipendenti della cooperativa che ha in appalto la pulizia degli uffici dove lavoro che, stremate dalla giornata lavorativa precedente, alle cinque del mattino prendono al volo il primo di tre autobus che, dopo un’ora e mezza di viaggio, le porterà a svuotarmi nuovamente il cestino chiedendomi scusa per il disturbo, e il tutto per un pugno di euro all’ora, lo stesso che a volte mi capita di dare in elemosina a Yassir, il ragazzo bengalese che mi riporta a posto il carrello vuoto, dopo che ho riempito l’auto coi sacchetti della spesa, situazione che a volte mi fa sentire come il Megadirettore Galattico Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam, il Direttore Marchese Conte Piermatteo Barambani o un altro qualsiasi feroce padrone o amministratore delegato: è un attimo saltare dall’altra parte della barricata senza neppure accorgersene.
Se è vero che 1984 di Orwell fu un romanzo premonitore, vedete se vi dice qualcosa dei nostri giorni questo estratto del libro Fantozzi: “Cominciò […] una discussione tra giovani sulla contestazione studentesca e l’intervento americano in Vietnam. Fantozzi credeva di essere nel covo della reazione: ma con suo grande stupore s’accorse che più quei gran signori erano bardati con orologi Cartier e brillanti (con uno solo dei quali lui avrebbe vissuto senza patemi il resto dei suoi giorni) più erano su posizioni maoiste. La maggior parte, giudicò Fantozzi, era a sinistra del partito comunista cinese. […] L’indomani mattina lui “timbrava” alle 8: pensando a quei giovani sovversivi che si sarebbero svegliati a mezzogiorno, gli si confondevano le idee”.
Questo è Fantozzi; Villaggio, invece, nella biografia in quarta di copertina della seconda edizione del libro, datata 1981, si definisce “figlio di padre ricchissimo” e per questo “a sinistra del partito comunista cinese”, non solo, sostiene che “a Roma ha fondato con un gruppo di nobili una frangia politica di estrema sinistra molto “in” che si chiama «POTEVE OPEVAIO»”.
Il libro Fantozzi era anche confortante; alla rabbia di mio padre che bestemmiava nel leggere dell’ennesima apparizione mariana a una contadina quattordicenne, piuttosto che a dei bambini impegnati a sorvegliare un gregge o a una bambina belga, il concittadino e quasi coetaneo Paolo Villaggio rispondeva così: “Un giorno c’era un tale caldo che a Fantozzi alle undici del mattino, mentre era in cucina che faceva correre un po’ d’acqua per bere, comparve improvvisamente la Madonna. Era in piedi sull’acquaio e gli sorrideva, poi scomparve. “Sarà questo maledetto caldo” si disse: e decise di raggiungere la moglie in campagna. Mentre si preparava per il viaggio si domandava perché mai la Madonna per il passato si sia limitata a comparire a pastorelli semianalfabeti e in zone montuose, e mai per esempio a Von Braun, al Centro Spaziale di Houston durante una riunione della NASA. Non ricordava infatti di aver mai letto sui giornali notizie di questo tipo: “Ieri alle 16,30 la Santa Vergine è comparsa improvvisamente dietro la lavagna di un’aula gremita di studenti della scuola di ingegneria di Pisa, durante la lezione di “meccanica applicata alle macchine”. Il docente professor Mannaroni-Turri, noto ateo, è svenuto di fronte a duecento studenti”.
Il libro Fantozzi è ancora confortante; alla mia rabbia condita di bestemmie che fa seguito all’ascolto di boiate pazzesche tipo quella espressa da due signore bionde col fisico scolpito che, d’estate, alla spiaggia, lamentano il “sold out” – a giugno! – nelle “location” più “in” di New York che le costringerà a trascorrere il Capodanno da un’altra parte, mentre una donna africana larga quanto le due messe assieme passa loro accanto stracarica di mercanzia che nessuno vuole, le pagine del libro mi consolano così: “A un’ora da Roma, Fantozzi andò in corridoio a fumare. C’erano due bambini molto belli biondi, figli di ricchi: tutti i figli dei ricchi sono biondi e uguali, i figli dei braccianti calabresi sono scuri, disuguali e sembrano scimmie. Erano dei bambini molto educati e non facevano rumore. Una baby-sitter americana bionda li custodiva. Uscirono dallo scompartimento le madri. Erano molto giovani, molto belle, molto ricche, molto profumate, molto eleganti e molto abbronzate: venivano da due mesi sulla neve a Gstaad in Svizzera e parlavano della gente che c’era lassù. Fantozzi le guardava con la bocca semiaperta. Le due donne cominciarono a parlare delle loro prossime vacanze al mare ed erano un po’ in pensiero perché non sapevano più dove andare: dovunque ormai andassero, dalla Corsica alle isole Vergini, trovavano della gente orribile. Fantozzi si commosse quasi per il dramma di quelle poverette. Il treno entrò alla stazione Termini. Sulla banchina c’era una tragica lunga fila di terremotati siciliani del Belice. Erano seduti sulle loro valigie di cartone […] e guardavano muti il vuoto. Una delle due signore disse: “E’ stato un anno davvero disgraziato!”. “Meno male” pensò Fantozzi “che si occupano di questi poveracci!”. “Perché?” domandò l’amica. E l’altra: “Perché non abbiamo mai avuto a Gstaad una neve così poco farinosa!”
Perché mi consolano queste pagine? Perché avere testimonianza scritta che figure così mostruosamente stronze già esistevano più di mezzo secolo fa e che, quindi, certi orrori non sono solo frutto degli sfaceli della mia generazione, solleva un poco il morale: lo so, non sono messo bene.
Perché la mia generazione, e pure quella dopo, di errori ne ha fatti veramente tanti, nonostante gli ammonimenti ricevuti da cinema e letteratura; avvertimenti che, ancor oggi, continuano a esser lanciati vista la produzione di Scissione, una serie televisiva statunitense del 2022 dove gli impiegati di una ditta non conoscono altro al di fuori delle attività svolte all’interno dell’azienda, sono solo schiavi asserviti al raggiungimento di uno scopo il cui significato è loro precluso. Allo sceneggiatore televisivo e produttore statunitense Dan Erickson, l’idea gli è stata ispirata da certe sue deprimenti esperienze lavorative giovanili maturate in ambito impiegatizio, un po’ come Paolo Villaggio quando, da giovane, lavorava all’Italsider di Genova come impiegato e iniziava a mettere in cantiere certe idee, ma per saperne di più su Scissione v’invito a leggere questo pezzo di Walter Catalano: Severance/Scissione: il Corporate Horror e gli incubi di Fantozzi.
Conforto, consolazione, riconoscenza, ecco quello che raccolgo dal genio di Paolo Villaggio, e non sono il solo; scriveva Oreste Del Buono nell’introduzione al libro: “L’ultima apparizione di Paolo Villaggio a cui ho assistito in televisione quasi mi ha fatto piangere per la riconoscenza. La riconoscenza per chi si sobbarca il peso di tutti i diseredati dell’aspetto e del gesto, di tutti gli umiliati e offesi dalla propria bruttezza e goffaggine, di tutti i mutilati del pensiero e della prassi, dell’affabilità e della sintassi. Si era sotto le feste di Natale, magari alla viglia stessa. Avevano chiamato Paolo Villaggio in televisione per commentare insieme natività e austerità, un miscuglio di moda nel nostro disgraziato paese”.
Chi aveva invitato l’attore genovese s’aspettava da lui un po’ d’umorismo, ma sbagliò i suoi conti: Villaggio si presentò trasandato, malmostoso e, parlando con piglio truce, disse “controvoglia una sgradevolezza dopo l’altra” e prese a parlar male di se stesso, perché quello aveva da dire – Paolo Villaggio non fingeva mai.
A proposito di Natale, leggete quest’altro estratto del libro Fantozzi: “A casa la signora Pina gli preparò una minestra calda. Lui si sedette a tavola con uno sguardo da pazzo e diede la prima cucchiaiata. La moglie lo guardò e gli disse: “Buon Natale, amore!”. In quel momento l’albero si abbatté sulla tavola con violenza, centrò Fantozzi in piena nuca e lui tuffò la faccia nella minestra rovente. Si provocò ustioni di quarto grado. Non gli uscì un lamento: più tardi, nel buio della stanza da letto, pare che abbia pianto in silenzio con grande dignità”.
Quella dignità che perdiamo quando siamo preda della sindrome da consumo; ossia, quasi sempre.
Villaggio fa cenno al boom consumistico in un’intervista rilasciata alla Televisione Svizzera nel 1975: “Il piccolo Fantozzi, l’omino che per anni è vissuto nel boom consumistico, ha ricevuto dai mass-media, cioè dalla televisione, dai settimanali e da tutte le informazioni possibili, uno stimolo preciso, quasi un ordine a consumare, ad acquistare, a vivere secondo determinati schemi, e lo schema di questa filosofia era precisissimo: attento!, che se compri e ti attrezzi in determinati modi, cioè secondo la chiave consumistica, potrai essere felice, vivrai in un mondo che sarà felice e contento per mille anni. Improvvisamente, invece, un crack strano; insomma, tutto questo sistema meraviglioso, pieno di promesse, questo mondo fiabesco si è incrinato: è bastato che nel Medio Oriente una forte tensione internazionale chiudesse i rubinetti del petrolio perché tutta la grande economia mondiale entrasse in crisi”.
Villaggio fa riferimento al periodo a cavallo tra il 1973 e il 1974 quando, in seguito alla crisi petrolifera, diversi governi del mondo occidentale, tra cui l’Italia, emanarono disposizioni per contenere drasticamente i consumi energetici: ricordo, per esempio, che ci si metteva d’accordo tra parenti per uscire insieme nei giorni festivi, con l’auto che poteva circolare senza prendere la multa – una domenica toccava alle macchine con targhe che terminavano col numero pari, quella dopo era il turno delle dispari.
Oggi come oggi pare che il consumare, l’acquistare, il vivere secondo determinati schemi, siano azioni che non si riescano a fermare, neppure a rallentare.
E se pensate che anche andare a vedere la versione di Fantozzi rimessa a nuovo faccia parte di questo circolo vizioso, quello del consumare e del vivere secondo determinati schemi, vi rispondo che andrò ugualmente a vederlo lasciandovi alla vostra erre moscia e a quella cagata pazzesca de La corazzata Potëmkin.
E mentre mi si azzera la salivazione per l’emozione dovuta a questa mia intransigente presa di posizione, già sento iniziare lo scroscio dei novantadue minuti di applausi che mi renderanno immortale.
]]>“Il nazismo è una forma di colonizzazione dell’uomo bianco sull’uomo bianco, uno choc di ritorno per gli europei colonizzatori: una civiltà che giustifica la colonizzazione […] chiama il suo Hitler, voglio dire il suo castigo. (Hitler) ha applicato all’Europa dei processi colonialisti afferenti, fino a quel momento, solo agli arabi d’Algeria, ai servi dell’India e ai negri d’Africa” (Aimé Césaire)
“L’antifascismo è il peggior prodotto del fascismo” (Amadeo Bordiga)
La vera novità del nuovo giro di valzer di “The Donald 2.0” e dai suoi cavalieri dell’Apocalisse hi-tech è rappresentata dall’aggressività di carattere economico, ma [...]]]>
“Il nazismo è una forma di colonizzazione dell’uomo bianco sull’uomo bianco, uno choc di ritorno per gli europei colonizzatori: una civiltà che giustifica la colonizzazione […] chiama il suo Hitler, voglio dire il suo castigo. (Hitler) ha applicato all’Europa dei processi colonialisti afferenti, fino a quel momento, solo agli arabi d’Algeria, ai servi dell’India e ai negri d’Africa” (Aimé Césaire)
“L’antifascismo è il peggior prodotto del fascismo” (Amadeo Bordiga)
La vera novità del nuovo giro di valzer di “The Donald 2.0” e dai suoi cavalieri dell’Apocalisse hi-tech è rappresentata dall’aggressività di carattere economico, ma anche politico, nei confronti degli “alleati” europei e non solo. Da lì deriva lo smarrimento manifestato da editorialisti, opinionisti, rappresentati politici e pennivendoli di vario livello di fronte ad un’America che rischierebbe di perdere le sue prerogative di custode dell’ordine liberal-democratico occidentale e, quindi, planetario.
Ecco allora alzarsi, dal World Economic Forum di Davos o dall’aula parlamentare di Bruxelles per voce di Ursula von der Leyen così come dalle pagine di «Repubblica», del «Corriere della sera » o dalla penna di uno stagionato rappresentante dei nouveaux philosophes come Bernard-Henri Lévy, un autentico peana per l’età dell’oro perduta e di rimpianto per quando l’America, gli States, la Land of Freedom svolgevano davvero il lavoro affidatogli dal Manifest Destiny1 ovvero proteggere e sviluppare gli interessi occidentali, quindi anche europei, in tutto il mondo.
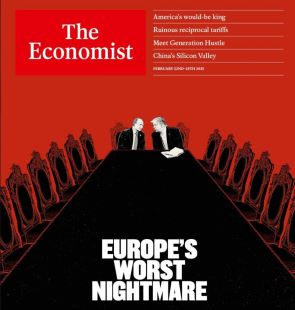 Purtroppo, però, per gli autori di questi plaidoyer per i principi e i diritti perduti, l’attuale politica americana porta alla luce ciò che ha sempre sotteso la democrazia bianca e liberale trionfante nel corso del secolo americano. Una politica di feroci disuguaglianze all’interno e all’estero, di repressione indiscriminata nei confronti di qualsiasi opposizione o resistenza, una politica imperiale sapientemente divisa tra il big stick delle armi, delle flotte e dei bombardamenti indiscriminati e la carota degli aiuti “umanitari” e dei dollari distribuiti a pioggia tra gli alleati più fedeli a garanzia dell’ordine imperiale mondiale.
Purtroppo, però, per gli autori di questi plaidoyer per i principi e i diritti perduti, l’attuale politica americana porta alla luce ciò che ha sempre sotteso la democrazia bianca e liberale trionfante nel corso del secolo americano. Una politica di feroci disuguaglianze all’interno e all’estero, di repressione indiscriminata nei confronti di qualsiasi opposizione o resistenza, una politica imperiale sapientemente divisa tra il big stick delle armi, delle flotte e dei bombardamenti indiscriminati e la carota degli aiuti “umanitari” e dei dollari distribuiti a pioggia tra gli alleati più fedeli a garanzia dell’ordine imperiale mondiale.
Tanto da spingere la giornalista italo-marocchina Karima Moual a chiedere provocatoriamente ai politici italiani ed europei: «Come ci si sente se Trump tratta l’Europa da debole? Come ci si sente se i diritti e la giustizia sono sottomessi al business? Tutto questo lo conoscono bene e da tante tempo i popoli arabi e quelli dell’Africa»2.
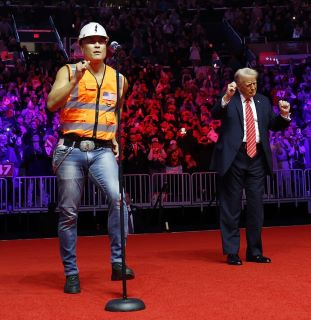 Certo, c’è da dire, le posizioni espresse dall’attuale amministrazione americana, dal possibile ritiro dall’impegno militare in Europa e nella Nato fino ai dazi sui prodotti europei e canadesi (oltre che cinesi) e al disconoscimento di organizzazioni internazionali ormai fallimentari come l’ONU o il tribunale penale internazionale dell’Aja o l’estromissione dei maggiori paesi europei da qualsiasi trattativa diplomatica riguardante le sorti dell’Ucraina, non sono, come molta stampa liberaldemocratica vorrebbe far credere, frutto di decisioni improvvise e inaspettate. Piuttosto, invece, sono il frutto obbligato di una crisi dell’Occidente che ha finito, inevitabilmente, col riflettersi nel voto americano, prima, e nel sistema delle alleanze interne allo stesso ordine occidentale, dopo.
Certo, c’è da dire, le posizioni espresse dall’attuale amministrazione americana, dal possibile ritiro dall’impegno militare in Europa e nella Nato fino ai dazi sui prodotti europei e canadesi (oltre che cinesi) e al disconoscimento di organizzazioni internazionali ormai fallimentari come l’ONU o il tribunale penale internazionale dell’Aja o l’estromissione dei maggiori paesi europei da qualsiasi trattativa diplomatica riguardante le sorti dell’Ucraina, non sono, come molta stampa liberaldemocratica vorrebbe far credere, frutto di decisioni improvvise e inaspettate. Piuttosto, invece, sono il frutto obbligato di una crisi dell’Occidente che ha finito, inevitabilmente, col riflettersi nel voto americano, prima, e nel sistema delle alleanze interne allo stesso ordine occidentale, dopo.
In fin dei conti la brutalità e la “mancanza di tatto” del presidente statunitense, la nuova ricerca di una nuova condivisione del governo del mondo, successivo al tanto agognato nuovo ordine mondiale ventilato fin dalla caduta del muro, e il rifiuto di coinvolgere ancora l’Europa e i suoi rappresentanti nelle politiche globali, ha almeno un pregio: quello di togliere il velo che nascondeva la finzione insita nelle roboanti dichiarazioni atlantiste e liberali sul ruolo dell’Occidente e di un’Europa sempre più evanescente sulla scena politica mondiale, dell’ONU e degli altri organismi internazionali nel governo democratico del mondo e sulla diffusione di valori e diritti liberali dati per scontati, ma scarsamente condivisi in diverse aree del globo.
 Per ll destino del nostro continente il segnale era stato dato immediatamente dal fatto che Trump avesse nominato come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Europea Andrew Puzder, ex-dirigente di alcune delle più note catene di fast food in America, come dire che il buongiorno si vede fin dalla colazione. Il tutto poi aggravato dalle dichiarazioni rilasciate, al canale televisivo Fox News, dal mediatore per la guerra in Ucraina Steve Witkoff, che ha definito i leader europei come dei sempliciotti, “tutti convinti di essere dei nuovi Churchill”3. O, ancor peggio, i giudizi espressi in una comunicazione che avrebbe dovuto rimanere riservata tra J.D. Vance e Pete Hegseth, capo del Pentagono, a proposito di un possibile intervento militare contro gli Houthi dello Yemen, portato a termine nei giorni successivi4.
Per ll destino del nostro continente il segnale era stato dato immediatamente dal fatto che Trump avesse nominato come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Europea Andrew Puzder, ex-dirigente di alcune delle più note catene di fast food in America, come dire che il buongiorno si vede fin dalla colazione. Il tutto poi aggravato dalle dichiarazioni rilasciate, al canale televisivo Fox News, dal mediatore per la guerra in Ucraina Steve Witkoff, che ha definito i leader europei come dei sempliciotti, “tutti convinti di essere dei nuovi Churchill”3. O, ancor peggio, i giudizi espressi in una comunicazione che avrebbe dovuto rimanere riservata tra J.D. Vance e Pete Hegseth, capo del Pentagono, a proposito di un possibile intervento militare contro gli Houthi dello Yemen, portato a termine nei giorni successivi4.
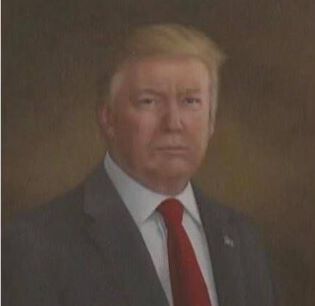 Anche per questi motivi gli europei e gli europeisti si son trovati di fronte al dilemma di come sopperire al venir meno della protezione prima offerta dal fratello maggiore, optando naturalmente per un piano di riarmo che dovrebbe contribuire sia a proteggere l’Europa dalla novella barbarie asiatica di Putin che a rilanciare la stagnante economia europea. Basata principalmente su un antiquato modello guidato dal settore dell’automotive come si è già sottolineato in un precedente articolo (qui).
Anche per questi motivi gli europei e gli europeisti si son trovati di fronte al dilemma di come sopperire al venir meno della protezione prima offerta dal fratello maggiore, optando naturalmente per un piano di riarmo che dovrebbe contribuire sia a proteggere l’Europa dalla novella barbarie asiatica di Putin che a rilanciare la stagnante economia europea. Basata principalmente su un antiquato modello guidato dal settore dell’automotive come si è già sottolineato in un precedente articolo (qui).
Forse mai come in questo periodo lo stretto legame tra crisi dell’imperialismo (economica e politica), corsa agli armamenti e guerra è stato dichiarato, da Draghi a Ursula “bomber” Layen, così apertamente e chiaramente. Passando, altrettanto, dall’inossidabile rampollo della famiglia Agnelli, John Elkann, che nei giorni scorsi ha chiarito, con uno straordinario giro di parole e di non detti, che la riconversione bellica non sarà la soluzione dei problemi dell’industria automobilistica, ma che quest’ultima, nella sua incarnazione in Stellantis, si adeguerà ai flussi di investimenti destinati a risollevarne le sorti. Ovvero che il piano ReArm Europe sarà alla fine il solo disponibile, sia nella sua forma “europea” che in quella degli interessi nazionali.
 Sì perché, intanto, ancora una volta si è palesato il fatto che il vero ostacolo alla tanto strombazzata necessità di costruzione di una difesa europea non è rappresentato per ora dall’opposizione politica, o autodefinentesi tale senza alcun merito, né dalla protervia del nuovo babau americano o dall’aggressività russa, ma semplicemente dal fatto che gli interessi del capitale europeo restano comunque nazionali ed ognuno cercherà di tirare l’acqua al proprio mulino in termini di investimenti, raccolta di flussi finanziari e produzione di armi e mezzi corazzati, aerei, droni, sistemi elettronici e navi. Così come rivelano anche le divisioni, manifestatesi nel più recente vertice europeo del 20 marzo, a proposito di debito comune, eurobond, invio delle truppe in Ucraina e politiche nei confronti dei dazi, della Nato e degli Stai Uniti.
Sì perché, intanto, ancora una volta si è palesato il fatto che il vero ostacolo alla tanto strombazzata necessità di costruzione di una difesa europea non è rappresentato per ora dall’opposizione politica, o autodefinentesi tale senza alcun merito, né dalla protervia del nuovo babau americano o dall’aggressività russa, ma semplicemente dal fatto che gli interessi del capitale europeo restano comunque nazionali ed ognuno cercherà di tirare l’acqua al proprio mulino in termini di investimenti, raccolta di flussi finanziari e produzione di armi e mezzi corazzati, aerei, droni, sistemi elettronici e navi. Così come rivelano anche le divisioni, manifestatesi nel più recente vertice europeo del 20 marzo, a proposito di debito comune, eurobond, invio delle truppe in Ucraina e politiche nei confronti dei dazi, della Nato e degli Stai Uniti.
Una scelta, quella del riarmo, che comunque, nell’intento generale espresso da von der Leyen e Kaja Kallas, ha escluso i produttori di armi degli Stati Uniti dal nuovo massiccio piano di spesa per la difesa dell’Unione Europea, in cui precedentemente gli stessi avevano ormai raggiunto una quota del 64% della stessa, e dal quale anche il Regno Unito è stato, per ora, escluso.
“Dobbiamo comprare di più europeo. Perché ciò significa rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Peccato, però, che nel tentativo di rafforzare i legami con gli alleati, Bruxelles abbia coinvolto paesi come la Corea del Sud e il Giappone e l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) nel suo programma che potrebbe arrivare a una spesa di 800 miliardi di euro per la difesa.
Fino ad ora, circa due terzi degli ordini di approvvigionamento dell’UE sono andati a industrie belliche statunitensi, ma il cambiamento radicale dell’ordine internazionale indotto dalle scelte di Trump e dal suo nuovo rapporto “privilegiato” con la Russia di Putin ha fatto dire a Kaja Kallas, il massimo rappresentante diplomatico dell’UE, che «Non lo stiamo facendo per andare in guerra, ma per prepararci al peggio e difendere la pace in Europa»
La proposta più concreta è l’impegno della Commissione a prestare fino a 150 miliardi di euro ai paesi membri da spendere per la difesa nell’ambito del cosiddetto strumento SAFE.
Mentre i prestiti saranno disponibili solo per i paesi dell’UE, anche gli stati amici al di fuori del blocco potrebbero prendere parte all’acquisto congiunto di armi.
L’aggiudicazione congiunta nell’ambito della proposta SAFE è aperta all’Ucraina; Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein dell’EFTA; nonché “i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, nonché i paesi terzi con i quali l’Unione [europea] ha concluso un partenariato per la sicurezza e la difesa”.
Alla fine di gennaio, l’UE aveva sei partenariati di difesa e sicurezza con Norvegia, Moldavia, Corea del Sud, Giappone, Albania e Macedonia del Nord. Anche la Turchia e la Serbia, in qualità di paesi candidati all’adesione all’UE, potrebbero potenzialmente aderire.
Ciò lascia fuori gli Stati Uniti e il Regno Unito, anche se lo status della Gran Bretagna potrebbe cambiare […] Il Canada ha anche chiarito di volere relazioni di sicurezza più strette con l’UE. Mercoledì la Commissione ha anche proposto una maggiore cooperazione in materia di difesa con Australia, Nuova Zelanda e India. «Ci sono molte richieste in tutto il mondo di cooperare con noi», ha detto un alto funzionario dell’UE5.
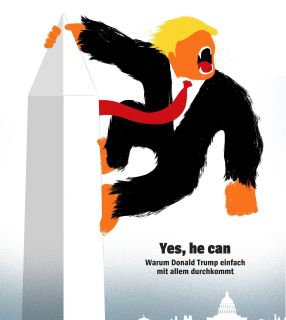 Un invito ad un banchetto finanziario che nasconde come a tale punto di crisi e necessità di riconversione bellica si sia giunti dopo tre anni di conflitto in Ucraina che hanno visto i paladini della democrazia, del liberalismo e dell’antiautoritarismo europeo sposare la causa della guerra e, soprattutto, delle sanzioni alla Russia di Putin senza mai chiedersi quanto tutto questo potesse gravare, così come è stato, sull’economia e le società del continente. Il dato di fatto è talmente visibile da non meritare certo altre contorte considerazioni, se non la sottolineatura del fatto che quegli stessi stati democratici hanno saputo, e tutt’ora sanno, soltanto dichiarare che per ottenere la pace non serve la diplomazia, ma soltanto preparare la guerra.
Un invito ad un banchetto finanziario che nasconde come a tale punto di crisi e necessità di riconversione bellica si sia giunti dopo tre anni di conflitto in Ucraina che hanno visto i paladini della democrazia, del liberalismo e dell’antiautoritarismo europeo sposare la causa della guerra e, soprattutto, delle sanzioni alla Russia di Putin senza mai chiedersi quanto tutto questo potesse gravare, così come è stato, sull’economia e le società del continente. Il dato di fatto è talmente visibile da non meritare certo altre contorte considerazioni, se non la sottolineatura del fatto che quegli stessi stati democratici hanno saputo, e tutt’ora sanno, soltanto dichiarare che per ottenere la pace non serve la diplomazia, ma soltanto preparare la guerra.
In un’autentica orgia di dichiarazioni belliciste una gran parte degli imprenditori europei, e non solo, ha fiutato l’odore dei soldi e del sangue, mentre, senza alcuna vergogna, i governanti si son precipitati a dichiarare l’inevitabilità della guerra, compresa quella nucleare. “La Polonia deve perseguire le capacità più avanzate, comprese le armi nucleari e le moderne armi non convenzionali. Questa è una gara seria – una gara per la sicurezza, non per la guerra” ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk al parlamento di Varsavia all’inizio di questo mese6.
Anche se il dibattito sull’ombrello nucleare europeo ha contribuito a mettere in risalto la differenza di interessi tra Macron, Starmer e dell’avatar di Olaf Scholz che già governa la Germania pur non avendo ancora messo in piedi un vero governo, Friedrich Merz. Oltre che le stesse difficoltà insite nel programma di allargamento del programma nucleare militare ad altri paesi europei, mentre «l’obiettivo di Parigi potrebbe essere quello di scaricare le spese per l’ombrello nucleare sui Partner comunitari, liberando risorse per le spese nazionali […] Parlare poi di buy European in assenza di una politica sulle materie prime fa semplicemente sorridere. Secondo le stime di JP Morgan, il consumo europeo di acciaio derivante dal solo piano di riarmo tedesco registrerà un balzo annuo dell’8-12%, oltre le 10mila tonnellate; ma forse non tutti sanno che oggi in Europa esiste un solo produttore certificato di acciai balistici, il che pone un problema serio di dipendenza. La guerra del rame in corso tra Washington e Pechino potrebbe inoltre creare forti carenze nel mercato dell’ottone, ostacolando i piani di produzione (e di ripristino delle scorte) di munizionamento»7.
Secondo Fabian Rene Hoffmann, ricercatore presso l’Oslo Nuclear Project, anche se una delle potenze europee della Nato fosse intenzionata a sviluppare armi nucleari proprie, anziché semplicemente ospitarle, si troverebbe a partire da zero.
“Il problema principale che i Paesi europei si trovano ad affrontare è che non dispongono di infrastrutture nucleari civili per avviare un programma di armi nucleari o, se dispongono di infrastrutture nucleari civili, che sono altamente ‘resistenti alla proliferazione'”, ha dichiarato a Euronews.
“Per esempio, Finlandia e Svezia hanno solo reattori ad acqua leggera, che non sono adatti alla produzione di plutonio per armi. Inoltre, nessuno di questi Paesi ha impianti di ritrattamento chimico, necessari per separare gli isotopi ricercati da quelli indesiderati nella produzione di materiale fissile”, ha poi spiegato l’esperto.
“Quindi, anche se volessero lanciare un programma nucleare, non potrebbero farlo con le infrastrutture esistenti, almeno nel breve periodo. Questo è il caso di tutti gli Stati europei non dotati di armi nucleari con un programma nucleare civile in questo momento”. Hoffman ha riconosciuto una discutibile eccezione: la Germania.
“Sebbene non disponga più di un’infrastruttura nucleare civile significativa, ha una grande scorta di uranio altamente arricchito per scopi di ricerca”, ha spiegato. “In teoria, queste scorte potrebbero essere riutilizzate per creare materiale fissile per le armi”.
“Ma anche in questo caso sarebbe sufficiente solo per circa 5-15 testate nucleari, quindi non sarebbe sufficiente per dispiegare quello che chiamiamo un deterrente nucleare “robusto””, ha poi detto Hoffman8.
In un contesto in cui anche il concetto di “volenterosi” inventato dal premier inglese si fa di giorno in giorno più ambiguo. Considerata anche la diffusione da parte della testata tedesca «Welt am Sonntag» di una fake news sull’offerta cinese di invio di truppe in Ucraina per garantire la pace, smentita dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun9.
 Naturalmente mentre l’italietta meloniana, ancor più inconsistente della falange comune europea, si adegua al motto secolare: «Franza, America o Alemagna pur che se magna». Travestendo il tutto da raffinata tattica politica e diplomatica, con l’Italia ponte tra Europa, America e Nato, oppure cercando di nascondere l’autentico gioco delle tre carte portato avanti dal ministro dell’economia Giorgetti rispetto al debito italiano e possibilità di investimenti privati nel settore della difesa. Sì, se non ci fosse di mezzo il pericolo, ormai quasi certo, del deflagrare di un nuovo macello imperialista mondiale, ci sarebbe soltanto da ridere.
Naturalmente mentre l’italietta meloniana, ancor più inconsistente della falange comune europea, si adegua al motto secolare: «Franza, America o Alemagna pur che se magna». Travestendo il tutto da raffinata tattica politica e diplomatica, con l’Italia ponte tra Europa, America e Nato, oppure cercando di nascondere l’autentico gioco delle tre carte portato avanti dal ministro dell’economia Giorgetti rispetto al debito italiano e possibilità di investimenti privati nel settore della difesa. Sì, se non ci fosse di mezzo il pericolo, ormai quasi certo, del deflagrare di un nuovo macello imperialista mondiale, ci sarebbe soltanto da ridere.
La risvegliata, ma tutt’ora esanime armata Brancaleobe europea deve, però, fare i conti con un altro problema, rappresentato proprio dalle società che si intendono governare e trascinare nei conflitti a venire e si parla qui di conflitti e non di conflitto poiché, come già sottolineava Trockji nei suoi scritti sulla guerra oppure in altri scritti comparsi anche qui su Carmilla, una volta che la guerra è nell’aria l’unica cosa sicura è che ci sarà, ma su quali saranno alla fine i veri contendenti o i fattori scatenanti sarà solo il disordinato e caotico divenire degli eventi a dirlo.
Infatti, per tornare a quanto si diceva della società europee, è proprio la ritrosia che si manifesta in gran parte dei cittadini delle stesse ad impugnare le armi per cause non meglio definite, ma sicuramente contrarie agli interessi vitali ed economici degli stessi, a sabotare quello che i maggiorenti delle istituzioni europee vorrebbero vendere come unico percorso possibile per uscire dalla crisi dell’Occidente e dei suoi “valori”, oltre che da quella economica e di rappresentanza politica e diplomatica.
Un recente sondaggio dell’istituto Gallup ha infatti rivelato che, a partire dalla Polonia, dove la percentuale di coloro favorevoli alla difesa in divisa della propria nazione, nonostante i propositi sempre bellicosi di Tusk, è del 45 per cento, la medesima percentuale scende rapidamente negli stati i cui governanti con tanta facilità sembrano volersi impegnare in un conflitto. In Germania con il 23 per cento, mentre in Belgio si dice disponibile solo il 19 per cento. Nei Paesi Bassi ancora meno, il 15 per cento. Risale in Francia e Spagna con un 29 per cento e in Austria il 20 per cento e ancora in Gran Bretagna con il 33 per cento. Ultima viene l’Italia con il 14 per cento. Considerati anche gli stati “più combattivi” (Finlandia 74%, Grecia 54 % e Ucraina 62%) si giunge ad una media europea del 34% ben distante da una entusiastica risposta ad una mobilitazione generale10.
Occorre poi ancora sottolineare come il dato ucraino sia poco affidabile, considerata la diffusa resistenza alla leva manifestatasi negli ultimi anni e nell’ultimo periodo che ha visto almeno un milione di uomini di età arruolabile lasciare clandestinamente il paese, mentre numerosi soldati, circa 1.700, dei 5.800 inviati in Francia per essere addestrati hanno preferito disertare una volta giunti lì. Esattamente come hanno fatto, fino ad ora, almeno 100.000 soldati ucraini incriminati per diserzione11. Cui bisogna ancora aggiungere il provvedimento di Zelensky per impedire a giornalisti e artisti di abbandonare l’Ucraina con permessi speciali di cui facevano buon uso non ritornando in patria e la sempre più forte resistenza all’arruolamento forzato dei giovani che ha visto assalti agli uffici di arruolamento e, in alcuni casi, l’omicidio degli ufficiali incaricati dell’arruolamento da parte di parenti dei giovani cercati per essere inviati al fronte12.
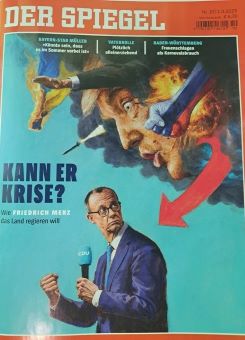 In Germania, dove il progetto di riarmo sembra voler riportare la nazione mitteleuropea ai suoi nefasti splendori militareschi del Primo e Secondo macello imperialista, la resistenza della cosiddetta “Gen Z”, i nati dopo il 1997 che oggi sarebbero i primi reclutati dalla leva, è evidentissima. Lo dimostrano i dati degli obiettori di coscienza (coloro che dopo essersi arruolati hanno poi lasciato le forze armate) che sono aumentati del 500% nel 2023 dopo lo scoppio del conflitto ucraino. Nel dettaglio 1 su 4 dei 18.810 uomini e donne che si erano arruolati nel 2023 hanno lasciato le forze armate entro 6 mesi. Dati guardati con preoccupazione da parte del ministero della Difesa in un momento in cui la Germania punta sempre di più sul rafforzamento della difesa nazionale e che potrebbe prevedere una leva obbligatoria sia per gli uomini che per le donne.
In Germania, dove il progetto di riarmo sembra voler riportare la nazione mitteleuropea ai suoi nefasti splendori militareschi del Primo e Secondo macello imperialista, la resistenza della cosiddetta “Gen Z”, i nati dopo il 1997 che oggi sarebbero i primi reclutati dalla leva, è evidentissima. Lo dimostrano i dati degli obiettori di coscienza (coloro che dopo essersi arruolati hanno poi lasciato le forze armate) che sono aumentati del 500% nel 2023 dopo lo scoppio del conflitto ucraino. Nel dettaglio 1 su 4 dei 18.810 uomini e donne che si erano arruolati nel 2023 hanno lasciato le forze armate entro 6 mesi. Dati guardati con preoccupazione da parte del ministero della Difesa in un momento in cui la Germania punta sempre di più sul rafforzamento della difesa nazionale e che potrebbe prevedere una leva obbligatoria sia per gli uomini che per le donne.
Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, la Germania ha avviato uno sforzo di riarmo su vasta scala. L’esercito tedesco può contare su 181mila soldati, con un’età media di 34 anni (Più dell’Italia che conta 161mila effettivi, mentre la Francia ne ha circa 260mila). Tuttavia un ultimo rapporto ufficiale evidenzia alcune criticità, il 28% delle posizioni nei ranghi più bassi non sono coperte e mancano il 20% degli ufficiali che sarebbero necessari. A questo si aggiungono gli alti numeri delle defezioni del 2023 (il 25% dei neo-assunti). Anche per far fronte a questi problemi in parlamento si è tornato a discutere di leva obbligatoria. La proposta è arrivata dal parlamentare Florian Hahn che ha dichiarato alla Bild che “Già da quest’anno i primi soldati di leva devono entrare nelle caserme”. Ricordando che il mondo è diventato più insicuro e la Germania «ha bisogno di un deterrente credibile dato proprio dalla capacità di aumentare gli effettivi. Obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso cittadini in uniforme siano essi volontari o di leva». In Germania il servizio militare obbligatorio è stato abolito nel 2011. Era stato istituito nel 1956. Tuttavia né la minaccia russa né il crescente clima di tensione internazionale sembrano motivare i giovani tedeschi ad arruolarsi, tanto che, come riporta il Financial Times in un reportage l’esercito ha “Sempre più difficoltà a trovare giovani della Gen Z pronti per la guerra”. «Meglio sotto occupazione che morto», la frase pronunciata da Ole Nymoen, giornalista freelance ventisettenne tedesco, sta facendo discutere la Germania insieme al suo libro dall’eloquente titolo “Perché non combatterei mai per il mio paese”. Il saggio è uscito questa settimana e analizza il punto di vista di molti ragazzi: «La nazione si trasfigura in una grande comunità solidale, che tutti devono servire con gioia. E questo dopo decenni di desolidarizzazione, durante i quali i politici neoliberisti hanno dichiarato che l’impoverimento di ampie fasce della popolazione era l’unica opzione»13.
E adesso, proprio mentre l’America di Trump dimostra, con la sua politica che cerca di ristabilire una equilibrata ripartizione del mondo oggi con la Russia di Putin, ma in un ancora incerto futuro, forse, anche con la stessa Cina, di essere giunta a un punto di non ritorno della sua pretesa egemonia mondiale e i governi europei sbandano dandosi come unico “obiettivo” comune quello di entrare in un’economia di guerra, si riattivano anche i corifei dei diritti umani, delle liberà, delle democrazie solo e sempre parlamentari e dell’antifascismo europeista tornano a dimostrare l’esattezza dell’assunto di Amadeo Bordiga secondo il quale: Il peggior prodotto del fascismo è l’antifascismo. Un’affermazione che va però inserita in una più ampia riflessione sulle caratteristiche del fascismo che vale la pena qui di riportare:
Il fascismo venne da noi considerato come soltanto una delle forme nelle quali lo Stato capitalistico borghese attua il suo dominio, alternandolo, secondo le convenienze delle classi dominanti, con la forma della democrazia liberale, ossia con le forme parlamentari, anche più idonee in date situazioni storiche ad investirsi degli interessi dei ceti privilegiati. L’adozione della maniera forte e degli eccessi polizieschi e repressivi, ha offerto proprio in Italia eloquenti esempi: gli episodi legati ai nomi di Crispi, di Pelloux, e tanti altri in cui convenne allo Stato borghese calpestare i vantati diritti statutari alla libertà di propaganda e di organizzazione. I precedenti storici, anche sanguinari, di questo metodo sopraffattore delle classi inferiori, provano dunque che la ricetta non fu inventata e lanciata dai fascisti o dal loro capo, Mussolini, ma era ben più antica.[…] Divergendo dalle teorie elaborate da Gramsci e dai centristi del Partito italiano, noi contestammo che il fascismo potesse spiegarsi come una contesa tra la borghesia agraria, terriera e redditiera dei possessi immobiliari, contro la più moderna borghesia industriale e commerciale. Indubbiamente, la borghesia agraria si può considerare legata a movimenti italiani di destra, come lo erano i cattolici o clerico-moderati, mentre la borghesia industriale si può considerare più prossima ai partiti della sinistra politica che si era usi chiamare laica. Il movimento fascista non era certo orientato contro uno di quei due poli, ma si prefiggeva d’impedire la riscossa del proletariato rivoluzionario lottando per la conservazione di tutte le forme sociali dell’economia privata. Fin da molti anni addietro, noi affermammo senza esitazione che non si doveva ravvisare il nemico ed il pericolo numero uno nel fascismo o peggio ancora nell’uomo Mussolini, ma che il male più grave sarebbe stato rappresentato dall’antifascismo che dal fascismo stesso, con le sue infamie e nefandezze, avrebbe provocato; antifascismo che avrebbe dato vita storica al velenoso mostro del grande blocco comprendente tutte le gradazioni dello sfruttamento capitalistico e dei suoi beneficiari, dai grandi plutocrati, giù giù fino alle schiere ridicole dei mezzi-borghesi, intellettuali e laici14.
 Ecco allora arrivare oggi alle nostre orecchie lo schiamazzo osceno di chi, non sapendo in quale altro modo chiamare i giovani e le società intere al massacro bellico, non può far altro che riscoprire un antiamericanismo di maniera, patriottico e nazionalista, oppure il richiamo all’antiautoritarismo liberale in difesa della democrazia offesa dall’autocrate Putin, con manifestazioni di piazza e chiamate alle armi velenose e subdole. Degne sì di essere chiamate fasciste e contrarie a qualsiasi altro interesse di classe e della specie, visto che le posizioni espresse dalla Schlein su difesa europea e debito comune sono molto simili a quelle espresse dalla Meloni e dal suo governo. Oppure, come hanno fatto i verdi tedeschi, si ammanta l’approvazione dello sforzo bellico con la necessità di una “transizione ecologica” o ancora, com’è successo l’estate scorsa in Francia, con il voto della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon ai candidati di Macron, il principe dei guerrafondai europei tenuto a freno solo dalle considerazioni di carattere economico della Banca di Francia, per opporsi a Marine Le Pen.
Ecco allora arrivare oggi alle nostre orecchie lo schiamazzo osceno di chi, non sapendo in quale altro modo chiamare i giovani e le società intere al massacro bellico, non può far altro che riscoprire un antiamericanismo di maniera, patriottico e nazionalista, oppure il richiamo all’antiautoritarismo liberale in difesa della democrazia offesa dall’autocrate Putin, con manifestazioni di piazza e chiamate alle armi velenose e subdole. Degne sì di essere chiamate fasciste e contrarie a qualsiasi altro interesse di classe e della specie, visto che le posizioni espresse dalla Schlein su difesa europea e debito comune sono molto simili a quelle espresse dalla Meloni e dal suo governo. Oppure, come hanno fatto i verdi tedeschi, si ammanta l’approvazione dello sforzo bellico con la necessità di una “transizione ecologica” o ancora, com’è successo l’estate scorsa in Francia, con il voto della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon ai candidati di Macron, il principe dei guerrafondai europei tenuto a freno solo dalle considerazioni di carattere economico della Banca di Francia, per opporsi a Marine Le Pen.
Mobilitazioni di carattere principalmente ideologico cui, però, fa da corollario il piano della commissione europea che, mescolando tra di loro i pericoli rappresentati da guerre, pandemie e disastri ambientali affiancati alle politiche securitarie portate avanti da tutti i governi nel corso degli ultimi decenni, è stato presentato in bozza a Bruxelles per una “Strategia di preparazione dell’Unione” o di “Vigilanza” che formula la necessità per le famiglie di accumulare scorte di medicine, batterie e cibo per resistere 72 ore in caso di guerra e per le scuole e gli insegnanti di preparare gli allievi ai “pericoli” della guerra, non certo in chiave antimilitarista (qui e qui).
Il Destino manifesto è un’espressione che indica la convinzione che gli Stati Uniti d’America abbiano la missione di espandersi, diffondendo la loro forma di libertà e democrazia. La frase “destino manifesto” venne all’inizio usata principalmente dai sostenitori della democrazia jacksoniana negli anni 1840, per promuovere l’annessione di buona parte di quelli che oggi sono gli Stati Uniti d’America occidentali (il Territorio dell’Oregon, l’Annessione texana e la Cessione messicana) a partire dalla presidenza di James Knox Polk. Il termine venne riesumato negli anni 1890, questa volta dai sostenitori repubblicani, come giustificazione teorica per l’espansione statunitense al di fuori del Nord America e alcuni commentatori ritengono che questi aspetti del destino manifesto, in particolare il credo in una “missione” statunitense per promuovere e difendere la democrazia in tutto il mondo, abbia continuato a lungo a influenzare la politica statunitense e la sua narrazione, in patria e fuori. ↩
K. Moual, Hey, amici, come ci si sente con la Ue trattata come uno staterello africano?, Huffington Post, 20 Febbraio 2025. ↩
E. Franceschini, “Putin super intelligente, Ucraina falso Paese”. L’assurda intervista di Witkoff, inviato di Trump, «la Repubblica», 24 marzo 2025. ↩
JD. Vance: «Penso che stiamo commettendo un errore: solo il 3% del commercio Usa passa dal Canale di Suez, contro il 40% di quello europeo. C’è il rischio reale che il (nostro) pubblico non capisca perché questa azione sia necessaria […] Se ritenete che dovremmo comunque farlo, allora andiamo. Però detesto l’idea di salvare gli europei ancora una volta».
P. Hegseth: «Condivido in pieno la tua critica degli approfittatori europei. E’ patetico.» in R. Fabbri, Vance-Hegseth e l’odio per l’Ue. La chat segreta, «Il Giornale», 25 marzo 2025.Si veda: G. Sorgi, J. Barigazzi e G. Faggionato, EU slams the door on US in colossal defense plan, «Politico» 19 marzo 2025. ↩
A. Naughtie, Un altro Paese europeo potrebbe sviluppare le proprie armi nucleari?, «Euronews», 23 marzo 2025. ↩
G. Torlizzi, Armi, il piano di Parigi per escludere l’Italia, «Il Giornale», 26 marzo 2025. ↩
A. Naughtie, art. cit. ↩
Cfr: Cina: “Le nostre truppe di peacekeeping in Ucraina? Fake news”, «la Repubblica», 24 marzo 2025. ↩
Per tutto quanto riguarda i risultati del sondaggio dell’istituto Gallup, si vedano: Se scoppiasse una guerra, combatteresti? Cosa farebbero gli italiani, Adnkronos, 18 marzo 2025 e E. Pitzianti, Combatteresti per il tuo Paese? Ecco la risposta degli italiani, Esquire Italia, 7 marzo 2025. ↩
Si vedano: F. Kunkle, S. Korolchuk, Ukraine cracks down on draft-dodging as it struggles to find troops, «The Washington Post», 8 dicembre 2024; A. D’Amato, I soldati ucraini che hanno disertato in Francia: «Erano nelle caserme, avevano diritto di uscire», «Open.online», 7 gennaio 2025; Ucraina diserzioni, 19mila soldati hanno già abbandonato. Kiev depenalizza il reato per chi lascia la prima volta: l’altro fronte odioso della guerra, «Il Messaggero», 8 settembre 2024; D. Bellamy, Decine di migliaia di soldati hanno disertato dall’esercito ucraino, «Euronews», 30 novembre 2024. ↩
N. Scavo, Agguati contro i reclutatori. Kiev teme la rivolta interna, «Avvenire», 4 marzo 2025. ↩
Leva obbligatoria, la Germania vuole reintrodurla ma la Gen Z si rifiuta: «Meglio sotto occupazione che morto», «Il Messaggero», 18 marzo 2025. ↩
Edek Osser, Un’intervista a Amadeo Bordiga, giugno 1970 (qui) ↩
 Donald Trump e il suo entourage sono così confusi, conflittuali e lontani dalla realtà che è difficile prevedere cosa tenteranno effettivamente di fare e quanto saranno in grado di portare avanti i loro progetti. Sappiamo che i loro progetti includono l’eliminazione di tutti i limiti al loro potere, la colpevolizzazione delle categorie sociali che disapprova, la ridistribuzione della ricchezza e del reddito verso l’alto e una guerra a livello mondiale per imporre il dominio degli Stati Uniti e la distruzione dell’ambiente. I loro sforzi per realizzare questi obiettivi si tradurranno in una distruzione enorme. È anche probabile [...]]]>
Donald Trump e il suo entourage sono così confusi, conflittuali e lontani dalla realtà che è difficile prevedere cosa tenteranno effettivamente di fare e quanto saranno in grado di portare avanti i loro progetti. Sappiamo che i loro progetti includono l’eliminazione di tutti i limiti al loro potere, la colpevolizzazione delle categorie sociali che disapprova, la ridistribuzione della ricchezza e del reddito verso l’alto e una guerra a livello mondiale per imporre il dominio degli Stati Uniti e la distruzione dell’ambiente. I loro sforzi per realizzare questi obiettivi si tradurranno in una distruzione enorme. È anche probabile [...]]]>
 Donald Trump e il suo entourage sono così confusi, conflittuali e lontani dalla realtà che è difficile prevedere cosa tenteranno effettivamente di fare e quanto saranno in grado di portare avanti i loro progetti. Sappiamo che i loro progetti includono l’eliminazione di tutti i limiti al loro potere, la colpevolizzazione delle categorie sociali che disapprova, la ridistribuzione della ricchezza e del reddito verso l’alto e una guerra a livello mondiale per imporre il dominio degli Stati Uniti e la distruzione dell’ambiente. I loro sforzi per realizzare questi obiettivi si tradurranno in una distruzione enorme. È anche probabile che questi sforzi provochino una sostanziale reazione che potrebbe sconfiggere il progetto MAGA o semplicemente svanire di fronte alla repressione e alla disperazione.
Donald Trump e il suo entourage sono così confusi, conflittuali e lontani dalla realtà che è difficile prevedere cosa tenteranno effettivamente di fare e quanto saranno in grado di portare avanti i loro progetti. Sappiamo che i loro progetti includono l’eliminazione di tutti i limiti al loro potere, la colpevolizzazione delle categorie sociali che disapprova, la ridistribuzione della ricchezza e del reddito verso l’alto e una guerra a livello mondiale per imporre il dominio degli Stati Uniti e la distruzione dell’ambiente. I loro sforzi per realizzare questi obiettivi si tradurranno in una distruzione enorme. È anche probabile che questi sforzi provochino una sostanziale reazione che potrebbe sconfiggere il progetto MAGA o semplicemente svanire di fronte alla repressione e alla disperazione.
È impossibile sapere se il regime di Trump si autodistruggerà rapidamente, se riuscirà a imporre un regno del terrore che dominerà gli Stati Uniti per gli anni o i decenni a venire o se si troverà in una situazione di stallo indefinito con le forze anti-MAGA. Nel migliore dei casi, ci troveremo di fronte a una versione esagerata della prima amministrazione Trump combinata con l’articolato programma di destra rappresentato da Project 2025. Nel peggiore dei casi, ci troveremo di fronte a un violento assalto fascista su larga scala a ogni aspetto della vita statunitense. Dobbiamo essere preparati per entrambe le eventualità o per una via di mezzo, per sapere come sopravvivere e superarle.
Incognite conosciute e sconosciute
La seconda presidenza di Trump è iniziata in un ordine mondiale caratterizzato da uno stato di policrisi. L’egemonia unipolare degli Stati Uniti è stata sostituita da un moltiplicarsi delle guerre a livello mondiale, dall’aumento dei conflitti tra le Grandi Potenze e dal declino della cooperazione internazionale all’interno e all’esterno delle Nazioni Unite. La policrisi è stata anche caratterizzata dalla frammentazione dell’economia mondiale e dalla lotta delle Grandi Potenze per dominare le reti economiche globali. La protezione internazionale del clima è diventata una evidente finzione e le principali forze politiche, tra cui lo stesso Trump, negano la realtà del cambiamento climatico.
La transizione verso una evidente plutocrazia, associata all’ascesa di movimenti, partiti e leader nazionali che assomigliano ai classici fascisti di un secolo fa, ha indebolito fino a distruggerle le istituzioni residue del governo democratico, seguendo il modello che caratterizza il crescente disordine mondiale. Lo sviluppo futuro e gli effetti di Trump e del MAGA devono essere considerati alla luce della policrisi. [1]
Negli ultimi dodici anni si è assistito in molte nazioni all’ascesa di movimenti che assomigliano al fascismo del 1920-1945. Sono movimenti che perseguono la distruzione delle istituzioni democratiche, il disprezzo per le costituzioni e le leggi, l’uso della violenza a fini politici, la trasformazione delle minoranze in capri espiatori delle minoranze razziali, etniche, di genere, politiche e di altro tipo, l’ostilità verso la cooperazione transnazionale e il “globalismo”, la dittatura autoritaria e tutta una serie di caratteristiche correlate. Per includere le numerose manifestazioni di questo fenomeno, piuttosto che solo quelle che si proclamano fasciste, le si potrebbe definire come novità “para-fasciste”. Donald Trump è un esempio di questo nuovo para-fascismo. La sua ascesa al potere ha coinciso con quella dei para-fascisti di tutto il mondo. Li ammira e li imita, e il suo comportamento in carica potrebbe assomigliare per molti versi al loro.
 Nonostante le sue affermazioni di voler risolvere i problemi che la gente sta affrontando, Trump al potere non farà altro che aggravarli. L’annullamento delle garanzie fornite dalla governance democratica amplificherà l’irrazionalità delle politiche e aggraverà il senso di impotenza e alienazione della popolazione. Gli stravaganti aumenti della spesa militare, progettati per realizzare la fantasia di un rinnovato dominio globale degli Stati Uniti, porteranno invece a rovinose corse agli armamenti nucleari e convenzionali. Lo stile provocatorio di Trump, la sua deliberata imprevedibilità, la prepotenza e la follia sfrenata che manifesta porteranno a un’intensificazione dei conflitti, a imprevedibili cambiamenti nelle alleanze, a un deliberato aumento del caos e delle guerre. Le sue politiche energetiche porteranno rapidamente alla catastrofe climatica. L’inasprimento di questa policrisi produrrà un ciclo di feedback auto-amplificante che aumenterà la paura e la rabbia, che sono le più importanti cause – e le fondamentali risorse – del trumpismo.
Nonostante le sue affermazioni di voler risolvere i problemi che la gente sta affrontando, Trump al potere non farà altro che aggravarli. L’annullamento delle garanzie fornite dalla governance democratica amplificherà l’irrazionalità delle politiche e aggraverà il senso di impotenza e alienazione della popolazione. Gli stravaganti aumenti della spesa militare, progettati per realizzare la fantasia di un rinnovato dominio globale degli Stati Uniti, porteranno invece a rovinose corse agli armamenti nucleari e convenzionali. Lo stile provocatorio di Trump, la sua deliberata imprevedibilità, la prepotenza e la follia sfrenata che manifesta porteranno a un’intensificazione dei conflitti, a imprevedibili cambiamenti nelle alleanze, a un deliberato aumento del caos e delle guerre. Le sue politiche energetiche porteranno rapidamente alla catastrofe climatica. L’inasprimento di questa policrisi produrrà un ciclo di feedback auto-amplificante che aumenterà la paura e la rabbia, che sono le più importanti cause – e le fondamentali risorse – del trumpismo.
Il comportamento di Trump è costantemente incoerente. È impulsivo, dirompente, spudorato, perfido e indifferente alle conseguenze prevedibilmente disastrose. Le azioni di Trump, lungi dal raggiungere i loro presunti obiettivi, non faranno altro che aggravare il caos della policrisi. Al contrario, la policrisi non farà altro che aggravare l’irrazionalità, l’autocontraddizione e la follia delle azioni di Trump. Trump potrebbe proporre, ma la policrisi disporrà.
A questo punto non possiamo sapere quale sarà l’equilibrio tra i gesti stravaganti e ostentati di Trump e il perseguimento calcolato e costante del programma del Project 2025. L’affermazione comune che il secondo regime di Trump è stato ben pianificato ed è guidato ed eseguito da esperti è stata messa in ridicolo molto prima del giorno dell’insediamento. Come ha scritto Karl Rove (tra gli altri) sul Wall Street Journal, “una verifica inadeguata, l’impazienza, il disprezzo per le professionalità e la sete di vendetta hanno creato per il signor Trump caos e controversie prima ancora che entrasse in carica. Il prezzo che si dovrà pagare sarà la perdita di opportunità per rafforzare il sostegno popolare per il presidente entrante.” [2]
I regimi fascisti sono stati storicamente caratterizzati da basi sociali radicalmente mutevoli piuttosto che da interessi stabili. Le loro politiche e le loro azioni oscillano opportunisticamente per corteggiare i settori sociali di cui possono acquisire, anche solo momentaneamente, il sostegno. L’intera carriera politica di Trump illustra questa tendenza, recentemente evidenziata dall’ascesa dei “Tech Bros” nella sua amministrazione. Questa imprevedibilità è aggravata dal personale comportamento opportunista di Trump e dalla variabilità delle sue passioni e dei suoi interessi. Nel costituire il suo gabinetto e nello scegliere i funzionari più importanti, Trump ha deciso di circondarsi di yes-men e yes-women che gli potessero garantire ogni suo capriccio.
Una buona parte dei commenti post-elettorali ha cercato di capire perché l’elettorato ha votato per Trump. Anche qui regna l’incertezza. I fattori specifici spesso elencati includono l’inflazione, l’abbandono della classe operaia da parte dei Democratici, il razzismo, il sessismo, la paura generalizzata dell’immigrazione e di altre minacce percepite, molte delle quali radicate nella policrisi, o semplicemente la credulità nei confronti della Big Lie trumpiana.
Sebbene tutte queste ipotesi abbiano una certa credibilità, potrebbe essere impossibile fornire una spiegazione valida del voto nel suo complesso, per non parlare di ciò che esso comporta per le future elezioni. Ma un argomento cruciale è evidenziato da un sondaggio Reuters/Ipsos di metà dicembre: appena il 40% degli americani ha dichiarato di avere un’opinione favorevole del presidente eletto Trump. Il 55% ha dichiarato di avere un’opinione sfavorevole su di lui [3]. Questo potrebbe indicare una grande vulnerabilità del regime di Trump se i suoi avversari saranno in grado di sfruttare le sue debolezze.
Le condizioni di salute fisica e mentale di Trump, così come sono, probabilmente si deterioreranno ulteriormente nel corso del suo mandato. Esiste un processo costituzionale per la rimozione dei presidenti incapaci dal loro incarico, ma è difficile che un tale scenario venga accettato volontariamente da Trump o imposto contro la sua volontà dalla sua cerchia finché è cosciente. Se fosse sostituito da J.D. Vance, l’imprevedibilità non farebbe che aumentare.
Queste incognite note saranno probabilmente aggravate da una pletora di incognite ancora sconosciute. La valutazione strategica dell’imminente era MAGA deve essere fatta in questo contesto generale di incertezza.
[1] Per un’ulteriore analisi di Trump e della policrisi, si veda Jeremy Brecher, “Trump, Trumpism, and the Polycrisis”, Labor Network for Sustainability, 23 novembre 2024. https://www.labor4sustainability.org/strike/trump-trumpism-and-the-polycrisis/
[2] Karl Rove, “Trump Sends Clowns to Cabinet Confirmation Circus” (Trump manda i clown al circo della conferma del gabinetto), Wall Street Journal, 20 novembre 2024. https://www.wsj.com/opinion/trump-sends-clowns-to-confirmation-circus-mishandled-nominations-gaetz-hegseth-gabbard-not-his-only-mistakes-c43df814?mod=hp_opin_pos_0
[3] Tara Suter, “Less than half of Americans say opinion of Trump is favorable: Poll” (Sondaggio: Meno della metà degli americani dice di avere un’opinione favorevole di Trump), The Hill, 17 dicembre 2024.
Traduzione di Domenico Gallo
L’articolo originale The Trump Onslaught: What We Must Prepare For è tratto da Strike! Jeremy Brecher’s Corner
Jeremy Brecher, attivista politico e sindacale, storico del movimento operaio,è l’autore del più importante contributo dedicato alle rivolte di massa negli Stati Uniti, tradotto in italiano come Sciopero!. La prima edizione è stata curata dall’editore la salamandra e la seconda da DeriveApprodi.
]]>