 L’ultimo libro di Samuel Huntington. Dallo scontro di civiltà all’individuazione nelle culture «subnazionali» dei neri e dei latinos come nuovi nemici degli Stati uniti. Un pamphlet in difesa dell’«eccezionalismo» e del «nazionalismo» statunitense
L’ultimo libro di Samuel Huntington. Dallo scontro di civiltà all’individuazione nelle culture «subnazionali» dei neri e dei latinos come nuovi nemici degli Stati uniti. Un pamphlet in difesa dell’«eccezionalismo» e del «nazionalismo» statunitense
di ROBERTO CICCARELLI
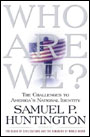 O lui o noi, ma soprattutto l’America, i suoi valori e la sua sicurezza. Alla Convention democratica di Boston, il ticket Kerry-Edwards ha centrato l’obiettivo: l’America «è in guerra contro un nemico che non avevamo mai conosciuto prima» e i democratici sono pronti a prendere il bastone del comando di «una nazione in guerra» contro il terrorismo. Un’esibizione di patriottismo che ha prodotto un buon effetto politico nella competizione con Bush. Perché gli americani sono un popolo patriottico e nell’ultimo quarto di secolo hanno creduto che i democratici non lo fossero altrettanto, almeno nella stessa maniera schietta ed appassionata. Kerry e Edwards hanno così dimostrato di non avere perduto la virtù guerriera, anzi ne hanno profuso a volontà, con richiami all’identità americana, fondata sui «valori comuni». I valori, una parola molto popolare in politica, una stampella che sorregge i discorsi elettorali e le parti eroiche delle biografie dei candidati.
O lui o noi, ma soprattutto l’America, i suoi valori e la sua sicurezza. Alla Convention democratica di Boston, il ticket Kerry-Edwards ha centrato l’obiettivo: l’America «è in guerra contro un nemico che non avevamo mai conosciuto prima» e i democratici sono pronti a prendere il bastone del comando di «una nazione in guerra» contro il terrorismo. Un’esibizione di patriottismo che ha prodotto un buon effetto politico nella competizione con Bush. Perché gli americani sono un popolo patriottico e nell’ultimo quarto di secolo hanno creduto che i democratici non lo fossero altrettanto, almeno nella stessa maniera schietta ed appassionata. Kerry e Edwards hanno così dimostrato di non avere perduto la virtù guerriera, anzi ne hanno profuso a volontà, con richiami all’identità americana, fondata sui «valori comuni». I valori, una parola molto popolare in politica, una stampella che sorregge i discorsi elettorali e le parti eroiche delle biografie dei candidati.
Ma è una parola a dir poco vaga, buona per tutte le stagioni, l’equivalente verbale del tofu: significa tutto quello che si vuole significhi. Per i repubblicani è sinonimo di «non essere squinternato come un hyppie», mentre per i democratici non si riferisce necessariamente alla trinità conservatrice (Dio, patria e pistole). Per tradizione, quello dei valori è un tema molto caldo per i repubblicani, ma i democratici si sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda.
Identità inquinata
Ricorrere all’identità di una nazione in guerra, ai suoi valori, per essere riconoscibili sul mercato politico, allora. Ma l’idea che quella statunitense sia un’identità in qualche modo limitata ad alcuni salienti caratteri culturali tradizionali ed ontologici va ben oltre le ragioni di una competizione elettorale e segue un dibattito ormai consolidato. L’ultimo volume di Samuel Huntington (Who are we? The Challenge to America’s National Identity, Simon & Schuster, $ 27, pp. 428) né è un esempio considerevole per comprendere i risvolti, e le trappole, di una cultura di guerra che va sviluppandosi da molto tempo anche in ambiente accademico.
Due sono i momenti della «rinascita» dell’identità americana, scrive Huntington: la fine della «guerra fredda» ha privato gli Stati uniti di un nemico pericoloso, l’«impero del male» contro il quale definire la propria identità. L’11 settembre le ha invece dato la certezza della direzione verso la quale procedere, consolidare cioè l’identità nazionale contro tutte quelle altre subnazionali, transnazionali, binazionali che si sono affermate sin dalle battaglie per i diritti civili, linguistici e multiculturali delle minoranze negli anni Sessanta e Settanta e hanno «corrotto» il suo nucleo originario, quello fondato sugli imperativi della supremazia anglosassone (wasp): razza bianca, cultura liberale (Locke e Adam Smith) e, la cosa più importante, religione protestante. E’ questo il «nucleo» del credo americano: etica protestante, culto del lavoro e della proprietà, ed infine capitalismo innestato sulla pianta del rule of law britannico. Lingua ufficiale: l’inglese parlato a Yale e Harvard.
Quella americana, avverte Huntington, non è mai stata un’identità razziale, ma culturale, non ha mai fatto riferimento ad una comunità originaria territoriale, quella sul modello «sangue e suolo» tipica del nazionalismo tedesco, sconfitto nella seconda guerra mondiale. S’ispira invece ad un nazionalismo «civico e liberale», ispirato ai principi del liberalismo politico inglese che è stato importato con la prima ondata colonizzatrice proveniente dalle coste inglesi. E’ questa la differenza tra la cultura wasp e tutte quelle importate successivamente con le ondate migratorie successive. Ciò ha permesso di maturare negli americani bianchi e protestanti, aggiunge Huntington, il senso di una superiorità di una nazione «eccezionale» ed «universale», destinata ad essere egemone per i prossimi secoli.
La missione imperiale degli Usa prende in queste pagine le sembianze di un’identità culturale e religiosa in guerra non soltanto contro i suoi due potenziali nemici, la Cina e il mondo arabo-islamico, ma anche contro le numerose «subculture» presenti sul territorio nazionale (nera, cinese, latina). Il nucleo fondante dell’egemonia, quella che Huntington definisce la «religione civile americana», è infatti composto da quattro elementi: un protestantesimo senza dio, ma con un «Essere Supremo», il «Bene», a capo dell’intero edificio costituzionale; un ethos sociale improntato alla glorificazione del lavoro e della proprietà privata; la religione patriottica ed infine l’idea propagandata sin dai tempi di Lincoln, quella dell’elezione divina degli Stati uniti.
La coscienza imperiale americana si basa dunque su due elementi: non ha alcun particolare attaccamento, o identificazione, con un luogo, ma si rivolge al mondo, si sente nel mondo, e da ciò trae il suo intrinseco universalismo e cosmopolitismo. In secondo luogo, questa coscienza ha bisogno di un nemico, interno o esterno, per radicarsi. L’«altro» è stato di volta in volta identificato nel vecchio impero coloniale inglese, nei nativi americani (anche se Huntington sembra non ricordarli affatto), nel comunismo, oggi negli «Stati canaglia». L’«altro» è quindi un elemento costitutivo dell’identità e della vocazione imperiale americana.
Invasioni pericolose
A differenza del suo Scontro delle civiltà, dove l’impero era impegnato insieme all’intera «civiltà occidentale» (attraverso la preziosa protesi della Nato) in una lotta mortale contro i suoi antagonisti culturali ed ideologici, in questo volume Huntington si sofferma sul conflitto che ha segnato dall’interno l’identità americana nel secondo dopoguerra. Sin dal Civil Rights Act del 1964 e dal Voting Rights Act del 1965, infatti, potenti movimenti di contestazione hanno sfidato l’egemonia wasp a favore di un’estensione, e di una sua relativa snaturalizzazione, del «concetto di America», a favore della maggioranza della popolazione composta per lo più da neri e da latinos, che, pur essendo nata negli Usa, era esclusa dalla fruizione dei diritti civili: «L’America – scrive Huntington – non era per loro una comunità nazionale di individui che condividono una cultura, una storia ed un credo comuni, ma un conglomerato di razze, etnie e culture subnazionali differenti, nelle quali gli individui erano definiti dalla loro appartenenza al gruppo, non a quella ad una comune nazionalità». La crescita di queste identità subnazionali ha preceduto la fine della guerra fredda ed ha trasformato l’originario nucleo monoculturale in un melting pot che ha favorito la crescita di azioni positive, oltre che dell’educazione bilingue, facendo dell’inglese solo una delle lingue parlate negli Stati Uniti, e non quella principale.
I nuovi nemici
Per Huntington, dopo l’11 settembre i movimenti per i diritti civili hanno esaurito la loro funzione. E’ iniziata l’epoca in cui i popoli verranno definiti principalmente in base alla loro cultura e alla loro religione, e non sulla rivendicazione di alcuni principi politici, come la libertà individuale o l’uguaglianza. Il ritorno a forme integraliste di cristianesimo, presenti nella società civile americana attraverso il ricorso ad associazioni di ispirazione religiosa per affrontare i problemi legati alla droga, alla criminalità minorile, alle ragazze madri, oltre alla pervasiva retorica pseudo-religiosa usata da Bush è il segnale che la componente religiosa dell’identità culturale sta tornando a galla in vista dello scontro con i militanti islamici e il nazionalismo cinese.
A questo punto Huntington prende le distanze sia dal cosmopolitismo dei liberal che dall’imperialismo dei neo-conservatives protetti sotto l’ala di Bush. I primi, infatti, spingono l’egemonia americana ad abbracciare il mondo, condividendo con esso la propria identità culturale, i principi politici ispirati al liberalismo politico. I secondi cercano al contrario di imporre al mondo la volontà politica degli Stati Uniti, cercando di affermarne i valori presso popoli che non hanno il minimo desiderio di diventare americani e di condividere con gli americani il nucleo protestante e anglosassone della loro religiosità e cultura.
Cosmopolitismo e imperialismo tentano in maniera differente, ma convergente, di ridurre o addirittura eliminare le differenze sociali, politiche e culturali tra l’egemonia americana e le altre società. Quello di Huntington è invece un approccio nazionalistico che tende a sottolineare ciò che distingue gli Usa dalle altre società: la sua religiosità. Storicamente, aggiunge Huntington, religione e nazionalismo sono andati a braccetto: «Parti significative delle élites americane – scrive – sono favorevolmente disposte perché l’America diventi una società cosmopolita. Altre invece desiderano che assuma un ruolo imperiale. La maggior parte del popolo americano si affida all’alternativa nazionalistica per preservare e potenziare l’identità americana che ha resistito per secoli».
A ben guardare, la soluzione proposta da Huntington non esclude per principio l’adozione della strategia cosmopolita o imperialista. Si può governare il mondo attraverso il ricorso ad una democrazia di tipo multiculturale e una governance economica senza per questo rinunciare alla prerogativa nazionalistica. In ogni caso, tutte e tre le opzioni mirano a difendere l’egemonia americana proponendo soluzioni ampiamente convergenti che trovano in questa visione apocalittica, e sostanzialmente falsa, di scontro tra le civiltà e le identità culturali e religiose il medesimo criterio metapolitico: la divisione del mondo in amici e nemici.
E’ stato Étienne Balibar a segnalare la presenza più che visibile nell’argomentazione di Huntington della famosa teoria di Carl Schmitt: la guerra contro il fondamentalismo islamico (una guerra che Huntington potrebbe definire una «guerra di frattura» [fault line war]), è soltanto un nuovo modo di graduare l’ostilità ed individuare i nuovi nemici in base ad un criterio di tipo morale-religioso.
L’eccezione americana
Huntington pensa l’egemonia in un’ottica difensiva. Da qui il suo suggerimento di riconoscere le aspirazioni cinesi sull’estremo oriente, a costo di rinunciare alla presenza americana nella regione, ricostruendo così l’equilibrio tra le due potenze sul modello della guerra fredda. E tuttavia Huntington, una volta registrata la crisi del cosmopolitismo e dell’imperialismo, le due versioni estremizzate della classica alternativa della politica estera americana, non si accorge infatti che la logica profondamente essenzialista che pervade la sua teoria della guerra tra le civiltà è essa stessa produttrice di nuove conflittualità al punto che il suo preteso universalismo è comunque sinonimo di imperialismo.
Sia chiaro, Huntington è pienamente consapevole che la teoria, rivendicata sia a destra che a sinistra, dell’imposizione dei valori occidentali sulle altre civiltà è «falsa, immorale e pericolosa», perchè ogni tipo di universalismo è portatore di guerre. E tuttavia egli riconosce che quella occidentale, e a maggior ragione quella americana, sebbene sotto la forma di una falsa coscienza o di un’illusione bella e buona, sia l’unica civiltà portatrice dell’universalismo.
Questo senso comune hegeliano ha pervaso la politica delle grandi potenze durante il XIX e il XX secolo, ed in particolar modo quella americana, è venuta meno da quando la legittimità dell’egemonia americana è entrata in crisi, diciamo a partire dal 1989. Da allora la storia mondiale non può più essere interpretata come una storia americana. L’unica ragione oggi per guardare agli Stati uniti rimane il valore politico avuto dalle rivendicazioni incrociate di diritti civili e sociali da parte dei lavoratori e delle minoranze che hanno caratterizzato il Novecento statunitense, così come ne hanno parlato C.L.R. James in American Civilization e Eric Foner in Storia della libertà americana.
Ciò detto, Huntington ha lanciato la sua sfida a questa lettura democratica e radicale alla storia americana proponendo un credo mistico-religioso che fa degli Stati Uniti la reincarnazione di un Frankestein crociato che si aggira tra le sabbie mediorientali alla caccia mortale dell’infedele, canaglia e terrorista.
Parabola di uno studioso accusato di razzismo e fondamentalismo protestante
 Professore all’università Albert J. Weatherhead e presidente dell’Harvard Academy of International and Area Studies, Samuel Huntington può essere considerato politicamente un conservatore e, come studioso di relazioni internazionali, un realista. Una carriera che non ha trascurato di frequentare i piani alti del potere nelle vesti di coordinatore del National Security Council della Casa bianca nel biennio 1977-78 e che si è caratterizzata anche per importanti partecipazioni come quella alla «Commissione trilaterale», fondata nel 1973 per sostenere la cooperazione tra quei paesi industrializzati che condividevano una posizione egemonica nel sistema delle relazioni internazionali. In un celebre rapporto scritto per la Trilaterale nel 1975, Huntington rivela la sua critica, ai confini con l’ostilità, dei movimenti politici di base, auspicando nuovi limiti all’esercizio dei diritti civili e politici: «L’essenza delle rivolte democratiche degli anni Sessanta era una sfida generalizzata alle autorità esistenti, sia pubbliche sia private. La vitalità di queste proteste ha posto un problema di governabilità della democrazia negli anni 70. Dobbiamo riconoscere che esistono potenzialmente dei limiti all’indefinita estensione della democrazia politica». Alla luce di queste considerazioni, non si può dire che la sua ricerca abbia nel frattempo sofferto di contraddizioni. Anzi, sia nello Scontro delle civiltà (Garzanti), sia nell’ultimo volume, non ancora tradotto in italiano, Who are we?, Huntington estende l’idea di una democrazia «limitata» ad alcuni soggetti, (le civiltà dominanti, e le élites bianche) escludendo le minoranze che hanno animato negli ultimi trent’anni la battaglia politica statunitense.
Professore all’università Albert J. Weatherhead e presidente dell’Harvard Academy of International and Area Studies, Samuel Huntington può essere considerato politicamente un conservatore e, come studioso di relazioni internazionali, un realista. Una carriera che non ha trascurato di frequentare i piani alti del potere nelle vesti di coordinatore del National Security Council della Casa bianca nel biennio 1977-78 e che si è caratterizzata anche per importanti partecipazioni come quella alla «Commissione trilaterale», fondata nel 1973 per sostenere la cooperazione tra quei paesi industrializzati che condividevano una posizione egemonica nel sistema delle relazioni internazionali. In un celebre rapporto scritto per la Trilaterale nel 1975, Huntington rivela la sua critica, ai confini con l’ostilità, dei movimenti politici di base, auspicando nuovi limiti all’esercizio dei diritti civili e politici: «L’essenza delle rivolte democratiche degli anni Sessanta era una sfida generalizzata alle autorità esistenti, sia pubbliche sia private. La vitalità di queste proteste ha posto un problema di governabilità della democrazia negli anni 70. Dobbiamo riconoscere che esistono potenzialmente dei limiti all’indefinita estensione della democrazia politica». Alla luce di queste considerazioni, non si può dire che la sua ricerca abbia nel frattempo sofferto di contraddizioni. Anzi, sia nello Scontro delle civiltà (Garzanti), sia nell’ultimo volume, non ancora tradotto in italiano, Who are we?, Huntington estende l’idea di una democrazia «limitata» ad alcuni soggetti, (le civiltà dominanti, e le élites bianche) escludendo le minoranze che hanno animato negli ultimi trent’anni la battaglia politica statunitense.
Ma al cuore dell’idea di questa democrazia wasp c’è il nemico. Prima erano i comunisti, il classico «nemico interno» che scatenò la caccia alle streghe di McCarthy, oggi è il «pericolo marrone», dal colore della pelle dei latinos che affollano i sobborghi delle grandi metropoli americane. «Per Huntington – scrive lo scrittore e critico letterario Carlos Fuentes in una recensione apparsa sulla rivista New Perspectives Quarterly (n°21) – il `pericolo marrone’ è un pericolo indispensabile per una nazione che esige, per esistere, una minaccia esterna identificabile». E’ Moby Dick, il modello per tutti i nemici dell’America, oggi impersonificato «dai messicani che lavorano ed arricchiscono le nazioni del Nord del pianeta».
Ma dietro questa crociata contro i latinos manca una seria ricerca demografica. In Who are we?, Huntington si limita «ad elencare aneddoti, storie da giornale e sondaggi, i cui risultati sono spesso contraddittori» scrive Jim Sleeper sul Los Angeles Times, ricavando le differenze tra l’identità americana e quella del meltin pot multiculturale sulla base delle tradizioni culinarie (la seconda reprime le differenze, mentre la prima è rimasta immutata nonostante le spezie e i crauti importati dalle ultime ondate migratorie). Nessuna mescolanza, nessuna assimilazione, dunque. Ma quello che Huntington teme di più, aggiunge Sleeper, è la «denazionalizzazione» delle élites americane: la borghesia globale che viaggia per affari, compra casa a Parigi, parla le lingue del mondo ed insegna nelle più diverse università costituisce un serio attacco all’identità americana. La loro è forse intelligenza con il nemico?
Anche Francis Fukuyama, americano di origini giapponesi, stigmatizza la sindrome da assedio degli 8 milioni di latinos (il 27 per cento degli immigrati) di Huntington: «Culturalmente gli immigrati messicani sono molto meno lontani dagli anglosassoni degli immigrati che provenivano dall’Italia del Sud o dall’Europa dell’est – scrive – Alcuni, come il generale Ricardo Sanchez, servono il loro paese. Senza considerare che molti giovani ispanici sono assorbiti dalle culture marginali delle città americane». Perché allora rifiutarli? Gli Anglo-protestanti non lavorano più abbastanza, «perché non hanno più la religione del lavoro». Oggi sono i coreani, i messicani, i russi, gli indiani a farlo per loro. E poi, a ben guardare, chi può dire che la supremazia bianca sia così uniforme? Congregazionalisti, Anglicani e Presbiteriani sono diversi e, per di più, nota Fukuyama, sono gruppi che lottano per una società multiculturale. Potrà mai accettarlo, questo, Huntington?
[da il manifesto]



