di Gioacchino Toni
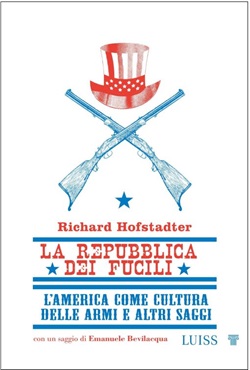 Richard Hofstadter, La repubblica dei fucili. L’America come cultura delle armi e altri saggi, Traduzione di Paolo Bassotti, Saggio introduttivo di Emanuele Bevilacqua, Luiss University Press, Roma 2024, pp. 192, € 17,00
Richard Hofstadter, La repubblica dei fucili. L’America come cultura delle armi e altri saggi, Traduzione di Paolo Bassotti, Saggio introduttivo di Emanuele Bevilacqua, Luiss University Press, Roma 2024, pp. 192, € 17,00
Per capire qualcosa di più degli Stati Uniti contemporanei, più che ai resoconti confezionati dai commentatori dei media nostrani, spesso derivati dai grandi network statunitensi con l’aggiunta di qualche nota di colore, ed alle analisi che anche a sinistra sembrano spesso più inclini a soddisfare desideri che non a confrontarsi con la realtà statunitense, potrebbe essere di qualche aiuto ricorrere a qualche vecchio scritto di Richard Hofstadter che, da storico che si confronta con le scienze sociali, ha incentrato i suoi studi sulla politica e sulla mentalità statunitensi, soprattutto sugli aspetti populisti, mettendo al centro del dibattito questioni fino ad allora trascurate. Per quanto si tratti di studi datati ed in parte superati da ricerche più recenti e per quanto siano nel frattempo cambiati l’universo sociale ed il panorama politico, risultano ancora di una certa utilità al fine di comprendere un po’ meglio un universo come quello statunitense che in Europa si conosce e comprende forse meno di quel che si pensa.
Dopo essersi occupato nel corso degli anni Quaranta degli aspetti ferocemente competitivi del capitalismo americano del periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo – Social Darwinism in American Thought, 1860-1915 (1944) e The American Political Tradition and the Men Who Made It (1948, tr. it. Il Mulino 1960) –, nei due decenni successivi Hofstadter ha concentrato la sua attenzione sul populismo che ha caratterizzano la storia politica americana sin dall’Ottocento – The Age of Reform (1955) – indagando in particolare gli aspetti “paranoici” che si ritrovano in essa, questione al centro di The Paranoid Style in American Politics (1964), testo recentemente pubblicato da Adelphi1.
L’insistito ricorso all’appello al popolo e le visioni paranoiche e complottiste che caratterizzano gli Stati Uniti di Trump hanno dunque una storia radicata in America a cui si ricollega anche la diffusa quanto viscerale ostilità nei confronti di tutto ciò che “odora di intellettuale” e che viene percepito come parte integrante di quella élite che imbriglia la vita dei “veri e genuini americani”, che Hofstadter indaga nel volume Anti-Intellectualism in American Life (1963; tr. it. Einaudi 1967), testo che sarà a breve riproposto da Luiss University Press2.
Venendo a La repubblica dei fucili, il volume raccoglie alcuni testi scritti da Hofstadter a metà degli anni Cinquanta – La rivolta pseudo-conservatrice (1955), sui cui torna all’inizio del decennio successivo con Pseudo-conservatorismo revisited. Un post-scriptum (1962), ed Il mito dell’allegro possidente (1956) – ed un paio di scritti del 1970, anno in cui scompare: L’America come cultura delle armi (1970) e Riflessioni sulla violenza negli Stati Uniti (1970). Ad introdurre il volume è un saggio di Emanuele Bevilacqua che proietta nell’attuale universo digitale alcune riflessioni di Hofstadter circa la violenza ed il culto delle armi negli Stati Uniti.
Secondo lo storico americano, la violenza negli Stati Uniti deriverebbe in maniera considerevole da alcune condizioni culturali specifiche che si sono evolute nel tempo: la cultura della frontiera ed il mito del pioniere armato; il diritto costituzionale a possedere armi, sancito dal Secondo emendamento, vissuto come baluardo della libertà individuale al fine di proteggersi da ogni forma di oppressione; la normalizzazione della violenza a cui avrebbero concorso gli strumenti di intrattenimento popolare come il cinema e la televisione.
Tutte le culture di massa hanno i loro eroi stereotipati, e nessuno è del tutto privo di violenza, ma niente è paragonabile all’insolita passione degli Stati Uniti per figure solitarie e individualiste come il detective, lo sceriffo o il cattivo della situazione. Nelle narrazioni drammatiche americane rispetto a quelle inglesi, per esempio, è molto più difficile che un conflitto venga risolto con l’intelligenza o secondo un ordine morale piuttosto che con un atto di violenza audace e improvviso (p. 50).
Per quanto il ruolo della frontiera sia stato importante nello strutturarsi della cultura delle armi tra gli americani, secondo lo studioso forse ancora di più ha influito la radicata avversione nei confronti dell’esercito organizzato, derivata dai Whig radicali inglesi, da cui è desunta l’idea della creazione di milizie di cittadini armati al fine di difendersi da eventuali forme di autoritarismo statale. Il possesso delle armi è al centro della
tradizione antimilitarista dei Whig radicali inglesi, ripresa e intensificata dall’America coloniale, soprattutto dalla generazione che precedette la Rivoluzione americana, per poi divenire parte integrante della tradizione politica americana. […] Gli americani si convinsero che l’unica soluzione possibile al perenne conflitto tra militarismo e libertà fosse la loro proposta alternativa: un popolo armato (pp. 52-53).
Tale preferenza per la milizia popolare ha esercitato un ruolo importante nella stesura del Secondo emendamento della Costituzione. «Il diritto di possedere armi era un diritto collettivo e non individuale, strettamente correlato all’esigenza civile (soprattutto in mancanza di un esercito nazionale adeguato) di una “ben organizzata milizia”; con esso, il Congresso si impegnava a non impedire agli Stati di fare il necessario per il mantenimento di milizie ben regolate» (p. 55).
Storicamente, l’idea del diritto ad essere armati non è un convincimento esclusivo dei fanatici cultori di pistole e fucili; per molti americani l’accesso diffuso alle armi è visto come contrappeso fondamentale e necessario ad una possibile tirannia. Tale convincimento è «sopravvissuto in tutta la sua gloria e la sua ingenuità anche nell’era tecnologica moderna, venendo ripreso, ad esempio dai giovani neri, soprattutto dalle Panthers, che hanno fatto incetta di armi in modo più letale per loro che per chiunque altro» (p. 57). Così scrive Hofstadter nel saggio L’America come cultura delle armi, pubblicato in apertura degli anni Settanta, palesando una presa di distanza dalle lotte afroamericane che non hanno disdegnato il ricorso ad armi da fuoco. Mentre in altre società la presenza di piccoli gruppi armati non autorizzati viene vista come un pericolo da eliminare a partire dal contrasto all’accesso alle armi, gli Stati Uniti, sostiene lo storico, preferiscono contrastare il pericolo di tali gruppi armandosi maggiormente a loro volta.
Facendo riferimento al periodo in cui scrive, Hofstadter motiva l’accentuata devozione alle armi del Sud e del Sud-Ovest degli Stati Uniti non solo con le radici rurali che contraddistinguono quelle zone, ma anche ricordando che le armi al Sud sono a lungo state prerogativa riservata ai bianchi per esercitare un maggior controllo sugli schiavi, dunque il possesso di armi è nel tempo divenuto un simbolo di status del maschio bianco per poi venir fatto proprio dagli stessi maschi afroamericani.
Per quanto gli Stati Uniti fossero urbanizzati e industrializzati, ancora negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento i parlamenti, tanto a livello locale che nazionale, erano composti in buona parte da uomini di una certa età provenienti dalla provincia rurale. È su tali basi che si sarebbe strutturata la convinzione della legittimità del ricorso alla violenza armata come modalità attraverso cui difendere i diritti individuali. Lo studioso sottolinea anche come tra gli americani sia riscontrabile una tendenza alla rimozione degli effetti negativi della violenza; un’amnesia che minimizza episodi e cause sistemiche e si rivela utile al mantenimento di un’immagine idealizzata della storia nazionale.
In Riflessioni sulla violenza negli Stati Uniti, altro scritto datato 1970, dopo aver sottolineato come gli storici americani abbiano sempre evitato di soffermarsi su quanto la violenza sia ricorrente nella storia del loro Paese e come, nonostante ciò, gli statunitensi tendano a pretendersi una nazione virtuosa come nessun’altra, Hofstadter evidenzia come, a differenza di ciò che accade in altri Paesi, la violenza negli Stati Uniti tenda a dispiegarsi più facilmente tra cittadini piuttosto che tra questi e lo Stato: in America «la violenza non nasce dal desiderio di sovvertire lo Stato, e per questo non danneggia mai la legittimità dell’autorità» (p. 127) e così è sempre stato, con la non irrilevante eccezione della Guerra civile, scrive lo studioso in questo testo del 1970.
Che una mole di violenza come quella che si è dispiegata negli Stati Uniti nel corso della sua storia non abbia preso le mosse dall’intenzione di sovvertire l’autorità statale, induce Hofstadter a passare in rassegna alcune tra le principali forme di violenza che hanno caratterizzato la vita del Paese ponendo l’accento su come in tutte queste sia in qualche modo presente la componente razziale.
Nella storia americana, in conflitto di classe è stato messo nettamente in secondo piano dal conflitto etnico-religioso e razziale. Gli scontri tra gruppi hanno sostituito la lotta di classe, o si sono posti come possibile alternativa. Gli episodi di lotta di classe effettivamente avvenuti raramente si sono svolti “in purezza”, scevri da antagonismi etnico-razziali e dalla nostra complessiva gerarchia d status fondata su caratteristiche religiose, etniche e razziali (p. 132).
Secondo Hofstadter, la violenza legata al mondo dell’industria ha avuto la sua fase più significativa ai tempi delle società segrete Molly Maguires nelle città ove si estraeva l’antracite, tra gli ultimi decenni dell’Ottocento ed i primi del secolo successivo. L’imponente sciopero delle ferrovie del 1877 coinvolse una dozzina di città provocando scontri che condussero a quasi un centinaio di morti. «Per la prima volta, si paventò lo spettro di una forza rivoluzionaria nazionale impossibile da gestire (per quanto l’idea neanche sfiorasse gli scioperanti), cosa che portò al rafforzamento della Guardia nazionale e alla creazione di una catena di armerie nelle città più importanti» (p. 140). Lo stesso grande sciopero delle ferrovie del 1886 si rivelò particolarmente violento così come molti altri scoppiati in apertura di Novecento soprattutto ove erano radicati la Western Federation of Miners e l’Industrial Workers of the World (IWW).
Se la conflittualità di classe negli Stati Uniti, pur rifacendosi meno che in altri Paesi a motivazioni ideologiche, ha dato luogo ad esplosioni di violenza che non trovano forse paragoni altrove, secondo lo storico ciò è da ricercarsi più nell’ethos dei capitalisti americani che non in quello dei lavoratori.
Alcune considerazioni Hofstadter le dedica a come anche la sinistra americana si sia fatta affascinare dall’esercizio della violenza nel corso degli anni Sessanta. In tali riflessioni lo storico statunitense, che in età giovanile aveva per qualche tempo militato nel Partito comunista americano, salvo poi uscirsene in dissenso con la deriva stalinista dei paesi socialisti e dei partiti comunisti occidentali, manifesta più volte il suo distacco dalle frange più radicali delle proteste statunitensi sia del mondo del lavoro che dei movimenti studenteschi ed afroamericani.
Ai saggi stesi da Hofstadter negli anni Cinquanta e Sessanta, presenti in La repubblica dei fucili, sarà dedicato un nuovo scritto su “Carmilla online”.
Richard Hofstadter, Lo stile paranoide nella politica americana, tr. it. di Francesco Pacifico, Adelphi, Milano 2021. Si veda a tal proposito Sandro Moiso, Il “grande complotto” nella tradizione politica americana (e altrove), in “Carmilla online”, 28 Giugno 2021. ↩
Del meccanismo di eroicizzazione dell’individuo qualunque che, come un novello David, trova la forza ed il coraggio di opporsi al Sistema ed alla sua grande cospirazione, che caratterizza la cultura, soprattutto audiovisiva, americana si è recentemente occupato, tra gli altri, Tom Nichols (The Death of Expertise (2017); id., La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia, tr. it. di Chiara Veltri, Luiss University Press, Roma 2023. ↩



