di Marco Sommariva
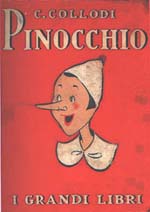 Nel libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, romanzo di Carlo Collodi del 1881, si racconta di un ragazzo che scappa, che si lascia abbagliare dagli incanti e crede alle illusioni; pagine non accomodanti che, attraverso il protagonista, ci preparano alle miserie e alle difficoltà della vita, checché ci racconti la Disney.
Nel libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, romanzo di Carlo Collodi del 1881, si racconta di un ragazzo che scappa, che si lascia abbagliare dagli incanti e crede alle illusioni; pagine non accomodanti che, attraverso il protagonista, ci preparano alle miserie e alle difficoltà della vita, checché ci racconti la Disney.
Quello che accade a Pinocchio e a chi l’ha messo al mondo, Geppetto, è terrificante; per esempio, entrambi finiscono in prigione seppur innocenti: prima il falegname – “il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione” – e poi il burattino: “Il giudice era uno scimmione della razza dei Gorilla (…). Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l’iniqua frode, di cui era stato vittima; dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità: prese vivissima parte al racconto; s’intenerì, si commosse: e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due can mastini vestiti da gendarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro: – Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princisbecco e voleva protestare: ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia”.
Passaggi che, a distanza di quasi un secolo e mezzo, continuano a parlare di noi, di quello che ci sta intorno: è di qualche mese fa la notizia della liberazione di un uomo della provincia di Cagliari di cinquantotto anni – trentadue passati dietro le sbarre –, condannato all’ergastolo perché accusato di triplice omicidio grazie a un testimone che mentì su istigazione di un agente. E non è un episodio: in Italia, nel 2022 sono stati più di cinquecento i casi di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, mentre dal 1991 al 2022 gli errori giudiziari hanno coinvolto ben trentamila persone,
E chissà che mentre si sbattono in cella migliaia di innocenti, non si lascino in giro volpi, gazze ladre e uccellacci di rapina: “arrivarono a una città che aveva nome “Acchiappacitrulli”. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati, che sbadigliavano dall’appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli, che chiedevano l’elemosina d’un chicco di granoturco, di grosse farfalle, che non potevano più volare, perché avevano venduto le loro bellissime ali colorate, di pavoni tutti scodati, che si vergognavano di farsi vedere, e di fagiani che zampettavano cheti cheti, rimpiangendo le loro scintillanti penne d’oro e d’argento, ormai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe, o qualche gazza ladra o qualche uccellaccio di rapina”.
Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino non è un romanzo ubbidiente, addomesticato, quindi non è un libro noioso. Dà ottimi spunti di riflessione: “non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito. Oppure Chi ruba il mantello al suo prossimo, per il solito muore senza camicia”. Offre persino uno slogan su cui, magari, si potrebbe anche iniziare a costruire la nostra ribellione quotidiana: “quando si nasce Tonni, c’è più dignità a morir sott’acqua che sott’olio!…”
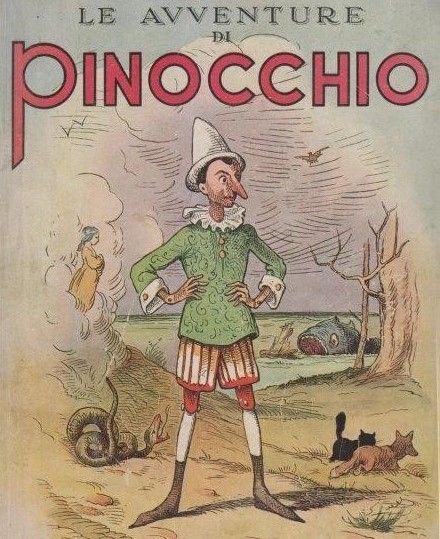 In un Paese come il nostro, pieno di centri commerciali e supermercati, i cui abitanti preferiscono di gran lunga spendere cinquanta euro in un pranzo che non cinque per un libro, dove ogni canale televisivo ha nel proprio palinsesto almeno un programma dedicato alla cucina, Collodi ci ricorda chi eravamo, da dove veniamo: “Il povero Pinocchio corse subito al focolare, dove c’era una padella che bolliva e fece l’atto di scoperchiarla, per vedere che cosa ci fosse dentro, ma la pentola era dipinta sul muro. Figuratevi come restò. (…) Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po’ di pane, magari di un po’ di pan secco, d’un crosterello, d’un osso avanzato al cane, d’un po’ di polenta muffita, d’una lisca di pesce, d’un nocciolo di ciliegia, insomma di qualche cosa da masticare: ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva, e cresceva sempre: e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare: e faceva degli sbadigli così lunghi, che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo avere sbadigliato, sputava: e sentiva che lo stomaco gli andava via. (…) Oh! che brutta malattia che è la fame!”
In un Paese come il nostro, pieno di centri commerciali e supermercati, i cui abitanti preferiscono di gran lunga spendere cinquanta euro in un pranzo che non cinque per un libro, dove ogni canale televisivo ha nel proprio palinsesto almeno un programma dedicato alla cucina, Collodi ci ricorda chi eravamo, da dove veniamo: “Il povero Pinocchio corse subito al focolare, dove c’era una padella che bolliva e fece l’atto di scoperchiarla, per vedere che cosa ci fosse dentro, ma la pentola era dipinta sul muro. Figuratevi come restò. (…) Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po’ di pane, magari di un po’ di pan secco, d’un crosterello, d’un osso avanzato al cane, d’un po’ di polenta muffita, d’una lisca di pesce, d’un nocciolo di ciliegia, insomma di qualche cosa da masticare: ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva, e cresceva sempre: e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare: e faceva degli sbadigli così lunghi, che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo avere sbadigliato, sputava: e sentiva che lo stomaco gli andava via. (…) Oh! che brutta malattia che è la fame!”
Fame dettata dalla miseria. Quella miseria palpabile anche ai bambini, quella che percepivi in casa quando, tra la fine degli anni Sessanta e la metà dei Settanta, si lasciava da pagare nei negozi di alimentari e si comprava a rate il giubbotto che ti avrebbe riparato dal freddo per almeno i dieci anni seguenti, sempre ammesso non ti fosse toccato quello dismesso da tuo fratello più grande.
“soggiunse il burattino […]
– Mi manca l’Abbecedario.
– Hai ragione: ma come si fa per averlo?
– È facilissimo: si va da un libraio e lo si compra.
– E i quattrini?…– Io non ce l’ho.
– Nemmeno io – soggiunse il buon vecchio, facendosi triste.
E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece triste anche lui: perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti: anche i ragazzi”.
Quella miseria che tra la fine degli anni Sessanta e la metà dei Settanta abbiamo vissuto in tanti, era frutto di un sistema che riusciva a far lavorare sedici, diciotto ore al giorno moglie e marito – lei correndo da una conca di bucato lavato a mano al rammendo di qualsivoglia indumento o tessuto di casa; lui spaccandosi la schiena con due giornate consecutive di lavoro, solitamente la seconda in nero –, ma senza mai permettere loro d’aver in tasca un quattrino da spendere per un cinema o un giro di giostra.
“Mangiafuoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò:
– Come si chiama tuo padre?
– Geppetto.
– E che mestiere fa?
– Il povero.
– Guadagna molto?
– Guadagna tanto, quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca”.
 Altro romanzo italiano datato, non accomodante, imperdibile, capace di prepararci alle miserie e alle difficoltà della vita è Sull’oceano di Edmondo De Amicis: “Quando arrivai, verso sera, l’imbarco degli emigranti era già cominciato da un’ora […]. La maggior parte, avendo passato una o due notti all’aria aperta, accucciati come cani per le strade di Genova, erano stanchi e pieni di sonno. Operai, contadini, donne con bambini alla mammella, ragazzetti […] passavano, portando quasi tutti una seggiola pieghevole sotto il braccio, sacche e valigie d’ogni forma alla mano o sul capo, bracciate di materasse e di coperte, e il biglietto col numero della cuccetta stretto fra le labbra. Delle povere donne che avevano un bambino da ciascuna mano, reggevano i loro grossi fagotti coi denti […] molti erano scalzi, e portavan le scarpe appese al collo. Di tratto in tratto passavano tra quella miseria signori vestiti di spolverine eleganti, preti, signore con grandi cappelli piumati, che tenevano in mano o un cagnolino, o una cappelliera, o un fascio di romanzi francesi illustrati, dell’antica edizione Lévy”.
Altro romanzo italiano datato, non accomodante, imperdibile, capace di prepararci alle miserie e alle difficoltà della vita è Sull’oceano di Edmondo De Amicis: “Quando arrivai, verso sera, l’imbarco degli emigranti era già cominciato da un’ora […]. La maggior parte, avendo passato una o due notti all’aria aperta, accucciati come cani per le strade di Genova, erano stanchi e pieni di sonno. Operai, contadini, donne con bambini alla mammella, ragazzetti […] passavano, portando quasi tutti una seggiola pieghevole sotto il braccio, sacche e valigie d’ogni forma alla mano o sul capo, bracciate di materasse e di coperte, e il biglietto col numero della cuccetta stretto fra le labbra. Delle povere donne che avevano un bambino da ciascuna mano, reggevano i loro grossi fagotti coi denti […] molti erano scalzi, e portavan le scarpe appese al collo. Di tratto in tratto passavano tra quella miseria signori vestiti di spolverine eleganti, preti, signore con grandi cappelli piumati, che tenevano in mano o un cagnolino, o una cappelliera, o un fascio di romanzi francesi illustrati, dell’antica edizione Lévy”.
Questo romanzo, edito nel 1889, ha l’ambizione di raccontare le violenze e le ingiustizie della vita affrontando il tema dell’emigrazione dall’Italia – sì, avete letto bene, dall’Italia – un fenomeno di dimensioni tali da incidere profondamente, tra Ottocento e Novecento, sulle sorti demografiche ed economiche del nostro Paese.
Ditemi voi se non riconoscete in questo passaggio ciò che quotidianamente vediamo alla televisione, mentre ci gustiamo il piatto suggerito il giorno prima dal nostro MasterChef preferito: “lo spettacolo eran le terze classi, dove la maggior parte degli emigranti, presi dal mal di mare, giacevano alla rinfusa, buttati a traverso alle panche, in atteggiamenti di malati o di morti, coi visi sudici e i capelli rabbuffati, in mezzo a un grande arruffio di coperte e di stracci. Si vedevan delle famiglie strette in gruppi compassionevoli, con quell’aria d’abbandono e di smarrimento, che è propria della famiglia senza tetto […]. Oppure: […] il peggio era sotto, nel grande dormitorio, di cui s’apriva la boccaporta vicino al cassero di poppa: affacciandovisi, si vedevano nella mezza oscurità corpi sopra corpi, come nei bastimenti che riportano in patria le salme degli emigrati chinesi; e veniva su di là, come da uno spedale sotterraneo, un concerto di lamenti, di rantoli e di tossi, da metter la tentazione di sbarcare a Marsiglia”.
Sull’oceano è un libro feroce, indomabile: “Il prete lungo era un napoletano, stabilito da circa trent’anni nell’Argentina, dove ritornava dopo un breve viaggio in Italia, fatto, diceva (ma era dubbio), per vedere il Papa. […] Si capiva che doveva aver curato altrettanto la borsa propria che l’anima altrui, facendosi pagar matrimoni e sepolture a prezzi d’affezione, tant’è vero che si vantava francamente d’aver messo insieme un buon gruzzolo, e non parlava d’altro che di pesos […]”.
Un libro nient’affatto consolatorio visto che ci ricorda che, quasi un secolo e mezzo prima, già esistevano esseri che s’arricchivano su miserie e disperazioni altrui: Non mi potevo levar dal cuore che ci avevano pure una gran parte di colpa, in quella miseria, la malvagità e l’egoismo umano: […] tanta caterva d’impresari e di trafficanti, che voglion far quattrini a ogni patto, non sacrificando nulla e calpestando tutto, dispregiatori feroci degli istrumenti di cui si servono, e la cui fortuna non è dovuta ad altro che a una infaticata successione di lesinerie, di durezze, di piccoli ladrocini e di piccoli inganni, di briciole di pane e di centesimi disputati da cento parti, per trent’anni continui, a chi non ha abbastanza da mangiare. E poi mi venivano in mente i mille altri, che, empitisi di cotone gli orecchi, si fregan le mani, e canticchiano; e pensavo che c’è qualche cosa di peggio che sfruttar la miseria e sprezzarla: ed è il negare che esista, mentre ci urla e ci singhiozza alla porta. Oppure: […] pensavo ai molti altri che, imbarcati per l’America da agenzie infami, erano stati sbarcati a tradimento in un porto d’Europa, dove avevan dovuto tender la mano per le vie; o avendo pagato per viaggiare in un piroscafo, erano stati cacciati in un legno a vela, e tenuti in mare sei mesi; o credendo di esser condotti al Plata, dove li aspettavano i parenti e il clima del loro paese, erano stati gittati sulla costa del Brasile, dove li avevan decimati il clima torrido e la febbre gialla.
Questa era la nostra miseria. Miseria italiana: “tutta questa miseria è italiana! – pensavo ritornando a poppa. E ogni piroscafo che parte da Genova n’è pieno, e ne parton da Napoli, da Messina, da Venezia, […] ogni settimana, tutto l’anno, da decine d’anni! E ancora si potevan chiamare fortunati, per il viaggio almeno, quegli emigranti [di questo piroscafo], in confronto ai tanti altri che, negli anni andati, per mancanza di posti in stiva, erano stati accampati come bestiame sopra coperta, dove avevan vissuto per settimane inzuppati d’acqua e patito un freddo di morte; e agli altri moltissimi che avevan rischiato di crepar di fame e di sete in bastimenti sprovvisti di tutto, o di morir avvelenati dal merluzzo avariato o dall’acqua corrotta. E n’erano morti”.
Dato che si parla di miseria italiana, potreste pensare che De Amicis ci stia parlando dei “soliti” meridionali. Non è così: “La maggior parte degli emigranti, come sempre, provenivano dall’Italia alta, e otto su dieci dalla campagna. […] A tutti questi italiani eran mescolati degli Svizzeri, qualche Austriaco, pochi Francesi di Provenza. Quasi tutti avevan per meta l’Argentina, un piccolo numero l’Uruguay […]”.
Oppure potreste pensare quello che dicono sempre più italiani quando commentano uno sbarco di migranti sulle nostre coste, che De Amicis ci stia raccontando di bastimenti stipati unicamente da pelandroni e mezzi delinquenti. Non è così: “Certo, in quel gran numero, ci saranno stati molti che avrebbero potuto campare onestamente in patria, e che non emigravano se non per uscire da una mediocrità, di cui avevano torto di non contentarsi; ed anche molti altri che, lasciati a casa dei debiti dolosi e la reputazione perduta, non andavano in America per lavorare, ma per vedere se vi fosse miglior aria che in Italia per l’ozio e la furfanteria. Ma la maggior parte, bisognava riconoscerlo, eran gente costretta a emigrare dalla fame, dopo essersi dibattuta inutilmente, per anni, sotto l’artiglio della miseria. […] Tutti costoro non emigravano per spirito d’avventura. Per accertarsene bastava vedere quanti corpi di solida ossatura v’erano in quella folla, ai quali le privazioni avevano strappata la carne, e quanti visi fieri che dicevano d’aver lungamente combattuto e sanguinato prima di disertare il campo di battaglia”.
L’autore non parla per sentito dire, racconta ciò che vede coi propri occhi quando, nel 1884, decide d’imbarcarsi sul piroscafo Nord-America – tratta Genova-Buenos Aires – apposta per vivere di persona la traversata atlantica dei nostri connazionali e poi descriverla.
De Amicis non ci va molto per il sottile con le considerazioni sociali: “Una politica disposta sempre a leccar la mano al più potente, chiunque fosse; uno scetticismo tormentato dal terrore segreto del prete; una filantropia non ispirata da sentimenti generosi degli individui, ma da interessi paurosi di classe. […] Una passione furiosa in tutti d’arrivare, non alla gloria, ma alla fortuna; l’educazione della gioventù non rivolta ad altro; ciascuna famiglia mutata in una ditta senza scrupoli, che batterebbe moneta falsa per far strada ai figliuoli. […] Metà degli uomini che avevan data la vita per la redenzione dell’Italia, se fossero risuscitati, si sarebbero fatti saltare le cervella. Oppure: […] si spende tutto a mantener soldati, milioni a mucchi in cannoni e in bastimenti, […] e alla povera gente nessuno ci pensa […]”.
Sono circa quarant’anni che leggo, in media, cinquanta libri l’anno, e spesso mi son domandato quanto son stato sfortunato nell’aver trovato con troppa difficoltà in questi circa duemila volumi, pagine capaci di raccontare i nostri tempi con la stessa energia di Collodi e De Amicis, con la stessa crudeltà; pagine con gli stessi lampi di verità, la stessa capacità di frugarmi dentro, farmi saltare sulla sedia, togliermi il fiato, prive di accomodamenti e passaggi costruiti a tavolino e, quindi, bugiardi e noiosi. Però poi mi sono anche chiesto se davvero queste pagine non vengono più scritte perché magari gli stessi autori si autocensurano o se, “per caso”, sono gli editori a non pubblicarle più, forse perché neanche le ricevono: potrebbe essere che siano gli agenti letterari a scartarle prima? Chissà. Nel dubbio, rivolgo un appello a coloro che sanno d’avere delle responsabilità in questo senso: smettetela, per piacere. Perché dovreste smetterla? Perché potrebbe succedere che un giorno – azzerate in qualche modo queste pagine, cancellate definitivamente dalla faccia della Terra – passi la voglia di cercarle o, in crisi d’astinenza, si scambi della scialba mercanzia per dei capolavori e, delle due, non so davvero quale sia la conseguenza peggiore.
Un’ultima cosa, nel caso passasse la voglia di cercare queste pagine entusiasmanti, folgoranti, potrebbe anche passar la voglia di leggerle e poi, chissà, di leggere in generale, e questo è tremendo perché, si sa, i libri esisteranno sino a quando avremo voglia di leggerli, e allora mi domando: non sarà che è già in atto il più grande falò di libri che la Storia abbia mai conosciuto e per di più senza che nessuno abbia innescato questo gigantesco rogo con una vera fiamma? Non sarà che stanno andando in fumo anche le nostre anime?



