di Gioacchino Toni
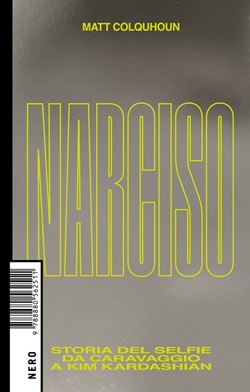 Matt Colquhoun, Narciso. Storia del selfie da Caravaggio a Kim Kardashian, traduzione di Paolo Berti, Nero, Roma, 2024, pp. 260, € 22,00
Matt Colquhoun, Narciso. Storia del selfie da Caravaggio a Kim Kardashian, traduzione di Paolo Berti, Nero, Roma, 2024, pp. 260, € 22,00
Scrive Matt Colquhoun nel suo volume Narciso (Nero 2024) che nel considerare, seppur in maniera per molti versi giustificata, «il selfie un male tipico del tardo capitalismo» in molti casi non ci si accorge che quelli che si giudicano «sintomi di patologie postmoderne sono spesso tratti caratteristici dell’autoritratto fin dal Rinascimento» (p. 209), dunque degli albori di quel capitalismo giunto, da qualche tempo ormai, alla sua fase tarda. La lunga storia dell’io e delle sue autorappresentazioni non è riducibile ad un monolite inscalfibile ed immutabile né a livello diacronico né sincronico. Guardare agli esempi del passato in cui «molti artisti e fotografi hanno affrontato – addirittura contestato attivamente e attaccato – la tensione narcisistica tra l’individuo ed il sociale» (p. 209), può essere utile per aggiornare le critiche al presente.
Tendenzialmente considerato come patologia distintiva dei nostri giorni enfatizzata dal presenzialismo online, il narcisismo potrebbe invece essere visto come risposta ad un bisogno di trasformazione dell’io. Questo, in estrema sintesi, è quanto propone Matt Colquhoun ripercorrendo la storia dell’autoritratto a partire da pittori come Dürer e Caravaggio, passando per fotografi come Lee Friedlander e Hervé Guibert, fino a giungere al ricorso al selfie da parte di celebrità contemporanee.
Per quanto si ritrovino forme figurative di autorappresentazione in tempi antichissimi, l’io raffigurato negli autoritratti contemporanei ha una derivazione decisamente più recente, legata ad un particolare modo di intendere l’individuo. Colquhoun inizia il suo percorso a partire dall’analisi di alcuni autoritratti di Dürer realizzati nel Cinquecento interpretando come aspirazionale piuttosto che autocelebrativa la scelta del tedesco di effigiarsi richiamando palesemente l’iconografia del Cristo dell’epoca, per poi soffermarsi sull’arte italiana alle prese con la costruzione e l’autorappresentazione di un io di stampo borghese, per certi versi ancora dominante oggi.
In particolare lo studioso sottolinea come mentre negli autoritratti analizzati dell’artista di Norimberga è possibile cogliere «un potenziale in fioritura», in quelli di carattere allegorico del Caravaggio sono piuttosto individuabili «le opportunità negate della sua stessa classe sociale» (p. 55). Insomma, alla possibile ed auspicata ascesa sociale suggerita dalla pittura del primo sembra rispondere la volontà di denuncia sociale individuabile in quella del secondo. A proposito delle pagine dedicate all’artista lombardo, occorre dire che, per quanto i confini che delimitano le periodizzazioni artistiche siano labili, opinabili e mutevoli nel tempo e nelle diverse culture, desta un certo stupore la collocazione del Caravaggio all’interno del fenomeno rinascimentale italiano operata da Colquhoun.
Tornando a Dürer, lo studioso sottolinea come il tedesco, fatto proprio il nuovo mondo dell’individualismo nascente, ossessionato dalla propria immagine, nella fase finale della carriera abbia fatto ricorso alla stampa per riprodurre le opere in più esemplari, dunque per diffonderle su “larga” scala. Se con gli autoritratti giovanili il pittore si allinea alla nuova concezione dell’io che sta prendendo piede in Europa, con le opere a stampa sembra allontanarsene, come attesta una produzione artistica sempre più cupa, malinconica e pessimista.
Nel corso del loro avvicendarsi, le manifestazioni culturali europee non di rado, di fronte a un momento di stallo o di insoddisfazione nei confronti della produzione più recente, hanno guardato ad un passato più lontano e lo hanno fatto, più che in funzione nostalgica, per trarvi ispirazioni utili al nuovo. Le culture rinascimentali e neoclassiche, fra tutte, sono forse quelle che più palesemente hanno attinto da un passato lontano, l’antichità, per superare rispettivamente gli immaginari medievali e barocchi. Colquhoun guarda invece al ritorno del Gotico, inteso nelle sue caratteristiche trans-storiche, come ad una forma di reazione o, forse, più precisamente, di resistenza, all’individualismo diffusosi con l’avvento della modernità post-medievale. Scrive Colquhoun che converrebbe guardare alla persistenza del Gotico non tanto come «espressione di un desiderio di tornare alla barbarie dei secoli bui precedenti il Rinascimento, quanto di una spinta verso una società post-individualista – e forse anche post-capitalista» (pp. 100-101). È questa la contraddizione che segna il narcisismo contemporaneo:
se da un lato siamo incoraggiati a valorizzare la nostra unicità, dall’altro le nostre soggettività sono frammentate dai meccanismi di controllo del mercato e, più in generale, dalle istituzioni disciplinari della nostra società.
Siamo tutti Narciso e siamo tutti mostri, intrappolati nei vari modi di vedere ed essere visti. Se abbiamo l’impressione di essere tra l’incudine e il martello, non è un caso; è l’essenza stessa della nostra trappola. Ma questa stabilità è tuttavia volatile, e forse più ne siamo consapevoli, più ci rendiamo conto che qualcosa deve necessariamente cambiare (p. 101).
La seconda parte del volume è dedicata alla «ricerca del post-individuo» che oggi, secondo Colquhoun, è ravvisabile nella fotografia. Piuttosto che guardare al narcisismo dell’autoritratto fotografico per il suo alimentare l’autoreferenzialità che intrappola il soggetto, l’invito dell’autore è quello di focalizzarsi su come esso permetta un’inedita trasformazione attiva dell’io. La fotografia è un medium che più di altri riesce a mettere in luce la mutevolezza del concetto di io propria della modernità. Certo, la fotografia ha svolto e svolge un ruolo di controllo sul soggetto e lo fa schedando, bloccando le identità uniformando o differenziando, ma, sottolinea Colquhoun, «resta uno strumento fondamentale per cambiare il modo in cui osserviamo il mondo che ci circonda»; pertanto l’invito dell’autore è quello di interpretare il selfie «non tanto come segno di una staticità ma come l’indicatore di un processo di trasformazione sempre più indefinito e radicale» (p. 206).
Certo, per certi versi il selfie contemporaneo non produce qualcosa di realmente nuovo, inoltre, il più delle volte, presenta un «io unitario ripetuto» ma, sostiene Colquhoun, il fatto che ci si interroghi insistentemente «sull’impatto del selfie sulla nostra vita dimostra una crescete diffidenza verso l’individualismo capitalista» (p. 210). Quello che però sfugge, ribadisce l’autore, è «il modo in cui il selfie ha esteso il nostro potere personale sulla sfera del sociale, in forme nuove e provocatorie» (p. 211).
Nello scorrere una app di incontri emerge in tutta evidenza come gli individui tendano ad assomigliarsi, nel senso che si inquadrano, si atteggiano e si ritoccano allo stesso modo al fine di attrarre interesse assecondando le «rigide regole di scambio simbolico dell’app» Se tutto questo ci dice poco circa le persone, molto ci suggerisce a proposito «dell’omogenizzazione (della rappresentazione) dell’io da parte del capitalismo in generale». Si tratta in sostanza di un adeguamento agli standard che riteniamo condivisi dagli altri utenti dando così luogo a un circolo vizioso che tende a perpetuare il modello.
Una situazione per certi versi grottesca che però, essendo rappresentata dal volto umano piuttosto che da strutture di scambio più identificabili, ci induce a criticare le persone anziché il sistema che normalizza tali metodi di rappresentazione. Il panico morale sul narcisismo è un esempio lampante di questo punto cieco: condanniamo i partecipanti, ignorando la natura totalizzante di un gioco fondamentalmente truccato, dal quale possiamo liberarci soltanto trasformandoci. Dovremo prendere maggiore coscienza di come il desiderio sia totalmente assoggettato ai regimi capitalistici dello sguardo. […] La vera sfida delle nostre vite online – e la verità non riconosciuta dei social media – è riscoprire il sociale nel momento in cui ci è dato vedere tutto ciò che il controllo ha celato (p. 212).
Che fare, dunque? Quali linee di fuga prendere? Colquhoun ricorda come una parte importante della filosofia francese della seconda metà del Novecento – gli stessi Barthes, Deleuze, Guattari e Foucault – sia permeata da una sorta di profondo sospetto nei confronti della vista e del suo ruolo dominante lungo l’intera storia moderna, forse proprio a partire da quella prospettiva scientifica di matrice rinascimentale con cui questa storia si apre. Al fine di contrastare il privilegio di un ordine visivo o di un regime scopico, piuttosto che proporre un’opzione antivisiva, Martin Jay (Downcast Eyes, 1993) pensa ad una opposizione basata sulla oculo-eccentricità, opzione oggi permessa dall’incredibile moltiplicazione degli occhi fotografici che devono però trovare la forza di proporre un narcisismo capace di evitare la gabbia della perpetuazione sviluppando, piuttosto, direttrici di (auto)trasformazione.
Per quanto in alcuni passaggi le riflessioni proposte da Colquhoun possano destare qualche perplessità, il merito indiscusso di un volume come questo è quello di prospettare uno sguardo diverso sul selfie e sul concetto stesso di narcisismo dei nostri giorni, evitando lo stucchevole moralismo (spesso ipocrita) egemonico.
Il reale delle/nelle immagini – serie completa



