di Neil Novello
Ludwig Wittgenstein, Diari segreti, prefazione di L. Perissinotto, a cura di Fabrizio Funtò,
Milano, Meltemi, 2021, 10,00 euro
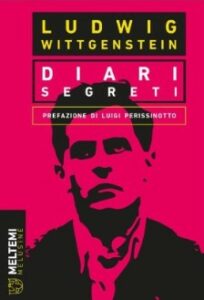 «Io ho voluto la guerra, per quel pochissimo che stava in me di volerla». Queste le parole nel Castello di Udine di Carlo Emilio Gadda a proposito della partecipazione dello scrittore alla Prima guerra mondiale. Volere la guerra e possedere in sé “pochissimo” di questo stesso volere è un sentimento ancipite, contraddittorio. Chi ora si accosti ai “Diari segreti” di Ludwig Wittgenstein si imbatte in un medesimo scenario interiore: il filosofo del «Tractatus logico-philosophicus» desidera andare in guerra, poiché si arruola come «volontario» nell’esercito austro-ungarico. Della guerra contro la Russia però se ne lamenta e dunque opera al solo fine di poter «lavorare» (“scilicet”: pensare e scrivere). La guerra figura allora come un pretesto, non come un’opportunità di combattere in nome del patriottismo. Non c’è il proprio paese nell’orizzonte interiore di Wittgenstein, c’è invece lo sviluppo, già in atto, di un progetto di “cura” attraverso il pensiero e la scrittura.
«Io ho voluto la guerra, per quel pochissimo che stava in me di volerla». Queste le parole nel Castello di Udine di Carlo Emilio Gadda a proposito della partecipazione dello scrittore alla Prima guerra mondiale. Volere la guerra e possedere in sé “pochissimo” di questo stesso volere è un sentimento ancipite, contraddittorio. Chi ora si accosti ai “Diari segreti” di Ludwig Wittgenstein si imbatte in un medesimo scenario interiore: il filosofo del «Tractatus logico-philosophicus» desidera andare in guerra, poiché si arruola come «volontario» nell’esercito austro-ungarico. Della guerra contro la Russia però se ne lamenta e dunque opera al solo fine di poter «lavorare» (“scilicet”: pensare e scrivere). La guerra figura allora come un pretesto, non come un’opportunità di combattere in nome del patriottismo. Non c’è il proprio paese nell’orizzonte interiore di Wittgenstein, c’è invece lo sviluppo, già in atto, di un progetto di “cura” attraverso il pensiero e la scrittura.
Giunto a Cracovia il 9 agosto 1914, il venticinquenne Wittgenstein è già nel teatro di guerra. Il suo primo pensiero («Potrò lavorare ora??!») dichiara un’intenzione paradossale ma reale. Se è vero che «avrò bisogno di “moltissimo” buonumore e filosofia per potermi orientare qui» (10.8.1914), ciò introduce nei Diari un conflitto tra la guerra e il pensare filosofico. È un falso dilemma in cui il pensatore, in apparenza, è al bilico di una doppia ambiguità, voler pensare in guerra e, a causa della guerra, non poter completamente pensare, voler combattere e, a causa della ricerca filosofica, non poter completamente combattere. Eppure, Wittgenstein “pensa” mentre fa la guerra e ancora volontariamente, il 29.4.1916, accetta il rischio di associarsi agli Aufklärer, gli esploratori inviati in avanscoperta a spiare il nemico. Il problema della morte, è evidente, non può essere disgiunto dall’esigenza del pensare filosofico: nonostante tutto, Wittgenstein è in guerra e scrive.
Di tre, il «Quaderno primo» dei Diari data 9.8.1914 – 30.10.1914, il «Quaderno secondo» 30.10.1914 – 22.6.1915, il «Quaderno terzo» infine 28.3.1916 – 19.8.1916. Circa tre mesi di «fatti» il primo, circa otto, a cavallo tra il 1914 e il 1915, il secondo e, dopo un lungo silenzio durato oltre venti mesi (vuoto lasciato da un taccuino probabilmente perduto), alla metà del 1916 circa cinque mesi il terzo. Nell’arcipelago autobiografico di Wittgenstein, la prima e forse più lampante immagine è che la guerra, per come è registrata nei Diari, palpita in una lontana nebulosa, mentre la riflessione filosofica, che pure costituisce il cardine intenzionale di quell’esperienza, avvince più per l’inafferrabilità di un compiuto pensare che non per il suo costruttivo contrario. «Non ho lavorato» (cioè: non ho pensato né scritto) è l’espressione più ricorrente dei Diari. Entro i due margini di una stessa ferita, combattere e pensare, i Diari rivelano un sorprendente scenario. Uno, il più evidente per quel che riguarda la forma testuale, è che dalla metà di agosto del 1914 la scrittura procede in «codice», in seguito dal 22 agosto, nel medesimo taccuino del diario di guerra cifrato compare un secondo testo parallelo, i Quaderni 1914-1916, scritto in chiaro (scorporato, non incluso in questa edizione dei Diari), in seguito, nella traduzione italiana, pubblicato in combinata con il Tractatus. Dal 5.9.1914, a un mese dall’inizio del diario, Wittgenstein ordina i due testi scegliendo il verso per la scrittura codificata dei Diari, il recto è invece destinato ai Quaderni.
Un altro scenario della narrazione riguarda l’opinione di Wittgenstein sull’equipaggio del Goplana, il battello su cui era «servente» al «riflettore»: a bordo infatti vi è una «banda di farabutti!» (15.8.2022). La «banda» cui fa riferimento il pensatore, nei termini della ricerca filosofica in atto, costituisce l’altro. E rispetto all’alterità, Wittgenstein inizia manovre di isolamento per favorire la prediletta condizione della solitudine. L’alterità infatti contribuisce alla perdita del soggetto singolare («Spero di non perdermi mai», 13.9.1914), quello stesso soggetto che ha «orrore della guerra» (18.8.1914) e che non riesce a «riconoscere l’umano nell’uomo» (21.8.1914). Nel lavoro di pensiero, di cui la mansione al riflettore è come una metafora, Wittgenstein non riesce a illuminare, confessa cioè di mancare dell’attitudine di puntare la speculazione su un «punto fermo» (22.8.1914). C’è un singolare episodio nei Diari, in cui, per una volta, il «riflettore» letteralmente non funziona, non illumina lo spazio davanti a sé. L’umanità del Goplana irride il servente del mezzo, il quale rivive, nell’incidente, una vertiginosa e traslata duplicazione della propria crisi personale, quella di un pensatore che stavolta non illumina lo spazio filosofico davanti a sé. E quel che è certo è che l’altro è un problema pratico e non solo relativo all’impegno del pensiero. Ricondursi a se stesso prolungando la segreta tregua personale all’infinito, per Wittgenstein significa evitare una forma di autodistruzione. Entrare in «lotta» con l’alterità equivale a una dolorosa consapevolezza: «distruggerei sicuramente me stesso» (25.8.1914). Il fondamento esistenziale dell’esperienza in guerra è la negazione dell’altro come fonte di una diversa guerra geminata però dentro la vera guerra. Ecco allora che Wittgenstein abbandona l’agone mentale, per un momento rinuncia al dispendio psichico determinato dall’alterità. Troviamo l’indicazione di un buon proposito alla fine di agosto del 1914: «alleggerire per così dire la mia esteriorità, per lasciare indisturbata la mia interiorità» (26.8.1914), imporsi l’«assoluta passività», «Restare presso di sé» (29.8.1914), conservarsi «integro» (17.9.1914). Ancora l’11.10.1914 scrive di voler «raggiungere» l’«indifferenza nei confronti delle difficoltà della vita esteriore». Quando Wittgenstein scrive poi di essere sulla «strada di una grande scoperta» (6.9.1914), il lettore dovrà immaginare che la ricerca filosofica, che si svolge sempre in mezzo al conflitto bellico, nello specifico accompagna il pensatore tra le mansioni al riflettore, la pelatura delle patate e il lavoro di caricare carbone. La promessa di una rivelazione immaginata in fondo al pensare, misteriosa perché mai esplicitata nel testo, pone un problema metodologico. È necessario vederla in anticipo. Ciò determina la prova più difficile, difficile come è cogliere per mezzo di un’illuminazione una «visione globale» (21.9.1914) senza però possedere nessun punto di riferimento. La visione globale, forse intuita e non ancora afferrata, rivela che «ogni problema è il problema principale» (29.9.2022), cioè che ogni impasse parziale si segnala come fonte di inaccessibilità al particolare connotando così la difficoltà di cogliere per intero il disegno, la legge del tutto, lo schema dell’idea, la cosiddetta «soluzione» (15-17.10.1914).
Qual è il «problema» considerato «inafferrabile» nel mezzo del conflitto contro i russi il 25.9.1914? I Diari si costituiscono come il referto di un affannoso inseguimento: «dettagli» scorporati dal «tutto», frammenti dispersi incapaci di riconnettersi in una totalità. Nessun altro segnale, non un indizio, nessun appiglio al lettore dei Diari intento a cogliere lo sviluppo della narrazione autobiografica come luogo di un patimento, una pena vissuta inseguendo, senza gratificazione, una grande promessa. Si sa ormai che Wittgenstein desidera una sola cosa, «preservare la mia intera umanità per la vita intellettuale» (7.10.1914). In altre parole, desidera che la piena conversione egoica, di cui già si sono articolate le coordinate “storiche” di situazione, definisca l’unica prospettiva per lo sviluppo dei particolari nel quadro di un sistema, o meglio di una visione totale. Tuttavia sembra ancora mancare l’oggetto, assentarsi dalle pagine l’ubi consistam del discorso. Permane ancora una mancanza di sul piano della ricerca filosofica. Qui latita quanto è definito il «pensiero liberatore» (17.10.1914). Più volte Wittgenstein confessa di avere la «soluzione del problema sulla punta della lingua!» (19.10.1914), o addirittura scrive: «Ora cingo d’assedio il mio problema» (24.10.1914). La vera guerra e la metafora bellica con cui Wittgenstein riporta al lettore la cronaca della personale battaglia con la ricerca filosofica, alla fine del 1914 intrecciano i campi figurando un unico territorio in cui la vita militare si confonde con la vita intellettuale.
Pensare è diventato più che una guerra. O almeno, è attraverso la metafora bellica che transita il pensiero di Wittgenstein mentre si compie in direzione del suo sviluppo. L’assalto alla «fortezza», la conservazione della «roccaforte in precedenza conquistata», il sogno di prendere infine la «città» (31.10.1914) figurano una filiera di acquisizioni metaforiche direttamente collegate allo sforzo speculativo del pensatore austriaco. E lo sforzo, per così dire, è sempre uguale a se stesso, si compie cioè nella prospettiva di donare soluzione al «problema principale» (1.11.1914), a qualcosa che è collocato nel fuori e dunque inteso nella sua oggettività, oppure nel dentro, come l’elaborazione interiore, soggettiva, apollinea del pensiero. Andare verso «sé stessi» (1.11.1914), verso l’«agognata isola lontana» (9.11.1914) e difendersi dal «mondo esterno» (4.11.1914), nei Diari alimenta il nesso della solitudine come apertura a sé. Essere «DAVANTI alla porta della soluzione» (16.11.1914), è essere davanti a cosa? Oppure, «pronunciare l’unica parola liberatrice» (21.11.1914), veramente permette o promette la liberazione a partire da un filosofema?
Tra le bombe e le mitragliatrici, le cannonate, i colpi di fucile e il gelo sulla Vistola, un piccolo incidente, una «distorsione muscolare» (8.12.1914), e la conseguente richiesta di «trasferimento» (23.11.1914 ss.), si creano le condizioni perché Wittgenstein veda convogliare verso la città quanto ha agognato nei primi quattro mesi guerra. Più propriamente è come se la città, la sua plasticità metaforica, gli venisse incontro. Il suo nome è Nietzsche. A dire però della prima impressione, nella quale si registra l’«avversità al cristianesimo» (8.12.1914) da parte dell’autore dell’Anticristo, ciò che costituisce l’ingresso nella città è fare i conti, seguendo però rotte antinietzscheane, proprio con il cristianesimo, che tra le pagine dei Diari «è l’unica via sicura per la felicità» (8.12.1914). A parte gli scritti wagneriani, l’ottavo volume delle opere di Nietzsche, letto nella circostanza da Wittgenstein, contiene Il crepuscolo degli idoli, Trasvalutazione di tutti i valori e per l’appunto L’anticristo. Ora forse è chiaro che la città personale di Wittgenstein è un’idea che esclude il «mondo esterno» (8.12.1914). In altre parole, che l’incidente al piede, il trasferimento e la controlettura di Nietzsche, una comoda camera e non più la cabina della nave, Cracovia e la terraferma, non più il mare ma l’ufficio, non più il riflettore, nei Diari fungono, per così dire, da piattaforma rotante di pensiero. Per cui il dicembre 1914 costituisce un momento di frattura, segna un marcato confine tra un prima e un dopo. Il mutamento di condizione pratica e, soprattutto, l’incontro critico con L’anticristo, promettono la “presa” di una città personale. Il «miracolo» d’altra parte accade a una condizione, «solo se DA FUORI MI viene levato il velo che sta davanti ai miei occhi» (25.1.1915). Eppure, per tutto l’inizio del 1915 Wittgenstein non lavora, non pensa e non scrive. Trova soltanto le condizioni per credersi «abbandonato», per meditare il «suicidio» (27.2.1914). D’altra parte, la sua biografia è una lunga scia di sangue: nel 1902 si è suicidato il fratello maggiore Hans, due anni dopo, nel 1904, un altro fratello Rudolf. Una catena cui si aggiungerà, nel 1918, il suicidio di un altro fratello, Kurt.
Dal lavoro di ufficio Wittgenstain è passato a mansioni più pesanti: la «fabbrica» (27.4.1915). E quel che più sconcerta, dopo la negazione della fluck di Nietzsche, è di non trovare più alcun riferimento all’unico bagliore che illuminava le mura della città, l’«idea» che lentamente si spostava sulla «punta della lingua» (24.11.1914) senza però trovare ancora la via per essere detta. Dopo circa venti mesi, il Quaderno terzo, come accennato probabilmente il quarto di quattro taccuini, di cui il terzo è andato smarrito, testimonia insieme un lungo silenzio (dal 22.6.1915 al 28.3.1916) e la riemersione del crudo proposito risalente al 27.2.1914: «…e dovrei levarmi la vita». Troviamo tuttavia un’indicazione che raccorda il lungo periodo di silenzio, qualcosa che idealmente unisce il secondo taccuino (Quaderno secondo) e il quarto (Quaderno terzo). Si sutura cioè quanto perduto nella laconicità di un’espressione da cahier de doléances: «Ho sofferto le pene dell’inferno» (28.3.1916). E quel che più conta è che il Quaderno terzo comunque testimonia, con o senza l’anticristianesimo di Nietzsche, il punto in cui è giunta la ricerca filosofica di Wittgenstein. E tale punto coincide, in apparenza, con la confessione di un vertiginoso vuoto. Tra il 6 e il 7.7.1916, dapprima leggiamo «non riesco a stabilire una connessione con i miei ragionamenti matematici», mentre il giorno dopo, camminando su una terra già pienamente da Tractatus, Wittgenstein scrive: «Ciò che non può dirsi, non può dirsi!».
La proposizione 5.61 del Tractatus, nella sua ultima parte recita: «Ciò che non possiamo pensare non lo possiamo pensare; né possiamo, quindi, dire ciò che non possiamo pensare». Un tale abisso, nella ricerca della «passività» assoluta, è qualcosa che caratterizza anche la “persuasione” di Michelstaedter. Essa non andrà intesa come inerzia ma come disincanto del mondo, all’apparenza una negazione di quanto dichiara la celebre prima proposizione del Tractatus: «Il mondo è tutto ciò che accade». Che è la vita svuotata del mondo esterno o dai «fatti»: qui va collocato l’inizio della ricerca filosofica, che è, a bordo del Goplana, una ricerca (uno statuto?), è una promessa di felicità. Wittgenstein aveva fatta sua una considerazione di Faust nell’opera di Goethe: la nostalgia e la speranza sono nemiche dell’uomo. La memoria del passato o ciò che non si ha più e l’immaginazione del futuro o ciò che non si ha ancora, ecco cosa distrae dal presente, cosa allontana dall’hic et nunc di colui che traccia un confine netto al mondo, colui che vive nella passività, senza nostalgia e senza speranza, “persuaso” com’è l’uomo felice. Siamo nei dintorni di quel piccolo universo che è il verbo mèno (rimanere, resistere, attendere) nella Persuasione michelstaedteriana. D’altra parte, neanche un mese di prima di cadere sul Pogdora, l’Esame di coscienza di un letterato di Renato Serra si chiudeva proprio su un’apologia del presente (cieco di avvenire): «Non mi occorrono altre assicurazioni su un avvenire che non mi riguarda. Il presente mi basta; non voglio né vedere né vivere al di là di questa ora di passione».
C’è qualcosa di più. Un frammento della proposizione 5.641 del Tractatus afferma: «Che “il mondo è il mio mondo” è la via attraverso cui l’io entra nella filosofia». E allora è forse possibile capire, qualche anno prima ma attraverso il Tractatus quanto Wittgenstein andava maturando nei Diari. Il pensiero della felicità («Il mondo del felice è un mondo diverso da quello dell’infelice», 6.43), nella parte finale del Tractatus potrà essere letto anche in relazione alla fondamentale proposizione 6.4311: «Se, per “eternità” si intende non una durata temporale infinita, bensì atemporalità, allora eterna è la vita di colui che vive nel presente». Serviva un kairòs secolare, una cairologia personale, per dire il nunc stans dell’uomo felice.



