di Neil Novello
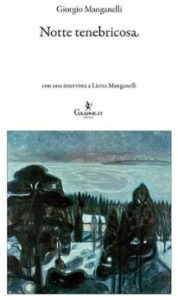 Giorgio Manganelli, Notte tenebricosa, prefazione di A. Zuccari, con un’intervista a Lietta Manganelli, Graphe.it, Perugia 2021, 15,90 euro
Giorgio Manganelli, Notte tenebricosa, prefazione di A. Zuccari, con un’intervista a Lietta Manganelli, Graphe.it, Perugia 2021, 15,90 euro
Non sono passate in lettura che poche righe di questa Notte tenebricosa di Giorgio Manganelli che il lettore di cose sue, a esempio il lettore del suo primo libro, Hilarotragoedia, fa l’esperienza di una ripetizione, o meglio percepisce l’eco, solo appena contraffatta, di quell’empito originario. Nella Notte è ancora vivo il piglio ilare (e macabro-grottesco) dell’opera prima. E se è così, come è evidente nella lettura, vuol anche dire che c’è qualcosa di più. Che uno stesso autore, ormai a distanza di decenni, abbia come riscritto, fedele alla sua ossessiva “ilarità”, il capolavoro d’esordio: riscritto – secondo la celebre persuasione di Proust – come si riscrive, nella memoria del primo ogni libro successivo a quello d’esordio. Ma se allora si compivano carotaggi ilarotragici nella fertile terra dell’Angst e nell’alveo di un’umanità adediretta, o meglio della sua “sulfurea discenditezza”, ora si va, o meglio si sta, in un ambiente consimile: la tenebra. La narrazione, se narrazione potrà essere definita questa danza poetica dell’immaginazione pure così cruda e lugubre, fa della notte, dell’oscurità universale, la “pentola” entro cui tutto l’esistente è concepito, il grande tòpos di una cosmologia culinaria. Anzi, di una “cosmologia gastronomica” in cui la “luna” appare un “truciolo di burro”, le “stelle potranno essere lacrime della massaia”, le “aurore boreali fuoruscite di brodi”, “noi” stessi, quel che più conta, la materia prima del congegno: il cibo-morituro. È la notte-pentola o la notte-“rete” in cui “noi stiamo ora ammucchiati, disordinatamente” come pescato nella nassa del destino terrestre. Un Manganelli heideggeriano parla qui di un essere-per-la morte. E legge lo scibile non come diligentemente (e, in parte, fantasiosamente) si è letto nell’Eternità di Blanqui o in Eureka di Poe. Legge la natura come uno scherzo che lui stesso ha inventato, una facezia dal vero in cui i “nostri nascere e morire e rinascere sono configurabili come arguzie gastriche”, teleologie tanatologiche, o più filosoficamente, nella “concezione che vuole il mondo vigilato da milizie, da sentinelle”, l’immagine stessa di un panopticon globale.
Tutto il libro, tutto il trattatello è un teatro inquisitorio alla ricerca del significato simbolico della notte, o meglio alla ricerca del significato ultimo, radicale della notte. È però una ricerca che di proposito intende fallire ogni orizzonte di conoscenza. Tranne uno. E per far questo Manganelli sonda tutti gli orizzonti. La notte è veduta infine come “inferno”, cioè una sfera di tenebra, una cosmologia del demonio. Essa è linfa alle “curiose favolette” di cui è fatta questa fantastica nottologia. Contrariamente a un manuale, questo di Manganelli, è dunque un anti-manuale ad uso di chi voglia solo assommare ipotesi e congetture sull’identità della notte. Fallendo regolarmente la pronuncia del suo nome, nell’atto di lettura il lettore è trascinato via in caccia di spiegazioni, di saperi e altre cognizioni: una narrazione centrifuga, una catabasi, in apparenza. È così, il lettore, sconcertato da questa novità stilcontenutistica, è attratto nell’“incubatoio” di sogni, manie, ossessioni e paranoie, o con le parole dell’autore tra “concetti predicabili”, “abbozzi di miti, di dogmi”, “appunti per rivelazioni” e “tessere da visione”. Insomma, qui troviamo l’immaginario culturale di un poeta-“profeta”, un vaticinatore della natura, un ermeneuta del mondo. Ma infernale, solo infernale è questa notte-gastronomica in cui il girarrosto-terra è schidione a uomini-cibo rosolati dal sole. E ciò perché il “destino umano di essere mangiati” dall’“Iddio” (che la notte servile segretamente ama e dunque gratifica preparando l’infinito pasto umano) figura il senso primo di Notte tenebricosa. La sbobba umana che il famelico Dio mai sfamerà. Perché mai la notte terminerà il ciclico lavoro di tradurre la materia vivente in materia commestibile per il creatore solo per poi ritradurla, come scrive Manganelli, in metempsicotiche rinascenze. Produzione, si sa, e consumo, cioè produzione è consumo.
Il primo personaggio a venire incontro al lettore è Asmodeo, il Dio “manovratore, il cibernete della mestola”, colui che esercita tutto il suo potere domestico sui terrestri-cibo nella notte-pentola: è il “sommo mescolatore e impastatore”. Qui Manganelli, al culmine della sua grande allegoria comico-cosmica, fa il nome del “Destino”, o meglio dell’invisibile macchina generatrice e distruttrice, produttrice e consumatrice, cioè il congegno immateriale che sviluppa finitudini e fini. Così agisce l’alacre “scherano” della fabbrica apocalittica. Per l’umanità-cibo, nella costruzione di questo formidabile e favolistico nómos, un duplice compito, due furberie per scamparla, “dar l’occhietto a Dio” blandendo e “non farsi scorgere da Asmodeo”, il canto (ferale) di Dio. Poi c’è un secondo personaggio, l’ossimorico Eleuterio, libero di natura ma prigioniero di Asmodeo. Due personaggi, il primo un “uomo di potere”, il secondo un “santo distaccato nelle regioni infernali”. E c’è ancora un fatto, una constatazione liminare, il cosiddetto “martirologio” della colossale farsa allegorica. L’umanità “commestibile”, nella fictio favolistica è destinata a nutrire, con la sua vertiginosa – non ovidiana né kafkiana – Verwandlung, non solo Dio: insieme a Dio, tutto il creato. Generazione, consumo, rigenerazione… Nel sistema allegorico-infero di Manganelli, Saturno, lo “spione”, è una figura panottica e una sorta di agente segreto dell’Onnipotente, un socio di Asmodeo nell’affare del Destino umano. È un burocrate nella meccanica della grande fabbrica. Studia, Saturno, come fregare il prossimo. Somiglia a Eleuterio, tecnico di sistema, che “verifica i decreti”, “controfirma la tortura”, ma fa la parte dell’eminenza grigia, è un colletto bianco. Il loro spazio d’azione, da Grande-Altro voyeur Saturno, da impiegato siderale Eleuterio, è per così dire un mondo-Malebolge: sono gli eredi letterari dei Malebranche. La notte, allora, l’eterno buio dell’universo avvolge, ammanta tra le sue spire anche se stessa, perché “tutto l’universo è notte”. Questo universo così nero (saturnino) e ferale è pensato entro il quadro di una vera e propria “malattia mentale”. Quel che si narra è una follia della natura. La sua “fissazione al lutto”, il suo “cuore sleale” paiono come un sudario grande quanto grande è lei, una croce immensa o una colossale bara interplanetaria, o meglio intergalattica. Essa è spalancata sull’umanità, o se si vuole è una “guaina di affanno”, che avvolge il creato e incidentalmente anche quella scoria sferica nominata terra, l’“aiuola che ci fa tanto feroci” di memoria dantesca. La notte-pentola lavora allora a ingraziarsi il “divin lanzichenecco”, a blandire Dio di prelibatezze umane: a questo servono Asmodeo ed Eleuterio. Il lettore più smaliziato potrebbe anche azzardare la presenza di un’allegoria biopolitica, Hobbes, Foucault e Orwell rigenerati in un mythos surreale.
Nella Teogonia di Esiodo, le tre figlie della Notte, Cloto, Lachesi e Atropo personificano la fabbrica del Destino: Cloto fila la vita, Lachesi srotola il fuso del tempo esistenziale, Atropo lo recide quando vuole. Il Dio di Manganelli sovrintende su questa realtà e vive di una sua vita assoluta. La notte è dunque sospesa tra la “follia” sua personale di totalità infera e una profonda sindrome di Stoccolma: ama cioè il suo sadico Dio absconditus. La sua “demenza” diviene come una clavis hermeneutica in grado di spiegare la raggelante gratuità del male prodotto, l’insensatezza del dolore umano, della malattia, della morte, cioè il sistema di cognizioni fondamentali nel traslato panico della Notte. Nel quale si sogna una sola domanda, come una supplica alla notte: “ora puoi dirci per dove si passa?”. In altre parole, quale sia finalmente il segreto passaggio di dimensione (se uno ve ne è). E se Asmodeo è il Kopfarbeiter dell’impresa, del mattatoio umano, Eleuterio è qualcosa di diverso e insieme di uguale. Agente del male, Eleuterio è un angelo-barometro, un organo di controllo dello stesso male, un Super-io infero, se così si può dire, chiamato a svolgere il ruolo al solo fine di accertare che il male (sopruso, violenza, dolore, ecc.) non travalichi la misura: è un angelo-ispettore. Vigila su quel che è e deve sempre essere: lo “show” regolamentato. Si percepisce un andamento, qui decisamente kafkiano, da Colonia penale, e più in generale un perturbamento da Castello. La grande domanda di Notte tenebricosa, “ora puoi dirci per dove si passa?”, alla fine resta inevasa. Non si dà un transito dall’inferno-terra all’inferno-paradiso: tutto è un inferno sia sulla terra sia in paradiso. Così è. Asmodeo ed Eleuterio sono due e uno, come la terra e il cielo della Notte: “due ipostasi, due parti, due ruoli, due facce, due corpi di una medesima substantia”. Una realtà bina e immaginaria nella quale è racchiusa l’“intera ambiguità del paradiso infernale, e dell’inferno paradisiaco”, cioè la realtà di questa terra, quella che è, quella che solo può essere: una mitologia negativa, un’allegoria tragica, una favola apocalittica.



