di Franco Pezzini
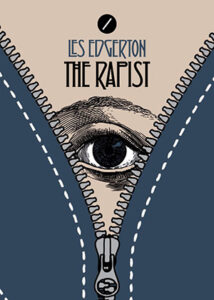 Les Edgerton, The Rapist, ed. orig. 2013, prefaz. di Cortright McMeel, trad. di Annarita Guarnieri, pp. 116, € 14, Meridiano Zero, Città di Castello PG 2019.
Les Edgerton, The Rapist, ed. orig. 2013, prefaz. di Cortright McMeel, trad. di Annarita Guarnieri, pp. 116, € 14, Meridiano Zero, Città di Castello PG 2019.
«Cosa mi dici dell’umanità? Non ti interessano i tuoi simili?»
Lo fisso. Parla sul serio?
«I miei simili? Vuoi dire quelle creature il cui solo scopo nell’esistenza è quello di trangugiare una quantità sempre maggiore delle nostre risorse naturali? O di alimentare il loro enorme ego nel nome del “sapere”? Quell’umanità? Stai scherzando, vero?»
Les Edgerton è un signore texano vissuto a lungo in Indiana, muscoloso, calvo, con baffoni bianchi. Un’aria da duro. E in effetti prima di diventare scrittore, ha fatto di tutto: ha lavorato nella Marina degli Stati Uniti, si è beccato qualche anno di galera per furto con scasso di secondo grado, all’uscita si è illustrato all’Università dell’Indiana, ha spacciato (e usato) droghe ma anche assicurazioni per la vita, lavorato come bodyguard per anziane madame ricche, poi anche in televisione, nel cinema, come giornalista sportivo eccetera. Matrimoni, come prevedibile, vari – forse non quanti i tipi di lavoro. Insomma una vita vivace, che a un certo punto ha trovato la rispettabilità (quella che non spinge gli ospiti, sogghigna, a far la conta dell’argenteria quando esci da casa loro) attraverso la scrittura, diciannove titoli tra romanzi e saggi sulla tecnica della narrazione.
E che questo signore sappia scrivere – e prima ancora leggere, perché è chiaro che si tratta di un lettore forte – lo mostra The Rapist, un romanzo molto bello e molto strano che mixa e sovverte in modo radicale L’ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo (1829), Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij (1864), Accadde al ponte di Owl Creek di Ambrose Bierce (1890) e un mezzo scaffale di altre opere di varia nobiltà. L’efficacia è forte, Edgerton trascina dentro la storia che corre fino all’ultima pagina. Ma una prima caratteristica che spiazza è che l’insieme non segue generi o percorsi narrativi noti: non è un thriller giudiziario né un noir né un romanzo carcerario, né né né… e soprattutto non ti immagini dove ti porterà a distanza di mezza pagina. E tantomeno alla fine, una conclusione del tutto inattesa che pare ammiccare a certe storie popolari dal guizzo malizioso finale – i fumetti neri di Stan Lee, per dire – ma con ben altra solidità narrativa. Lo scrittore ed editore Cortright McMeel nell’introduzione avverte:
Credo che The Rapist sia il tour de force di Les Edgerton in mezzo ai suoi molti altri meravigliosi romanzi noir. Forse si cercherà di classificare e intellettualizzare questo libro. Considerando i suoi temi esistenziali e il tono a volte nichilistico di Truman [il protagonista narrante], potrebbe insorgere la tentazione di paragonarlo a Lo straniero di Camus o a qualche opera teatrale di Sartre, ma vi vorrei mettere in guardia dal farlo. Con la sua forza esplosiva, la sua furia indignata, la sua rabbia verso l’istituzionalizzazione, la sua violenza ribollente vista tanto in una dettagliata gangbang quanto in uno stupro, esso è – perversamente ma intrinsecamente – un’opera di fiction americana, sfacciata e petulante come un cowboy che varca la porta basculante di un saloon, sicura di sé nella sua imparagonabile individualità come un vanaglorioso Charlie Manson e pervasa di una rabbia pura e di una furia indignata del genere che si può trovare solo negli Stati Uniti d’America, la Terra delle Opportunità, dove si abbraccia la democrazia ma a dominare sono la volontà di potenza nietzschiana e il Might Is Right (ovvero “il diritto deriva dal potere”) di Ragnar Redbeard.
L’editore italiano ha scelto di tenere il titolo originale con la sua fredda alienità, ma potremmo tradurlo semplicemente Lo stupratore: ed è appunto per uno stupro con omicidio che il narrante quarantaquattrenne Truman Ferris Pinter si trova in galera, condannato a morte e in attesa del capestro. Fin qui tutto chiaro, come sul fatto che il Nostro sia un sociopatico grave, spocchioso fino all’intollerabilità, dotato per nostra fortuna di un certo humour ma sicuramente non tale da attrarre eccessive simpatie.
Eppure, di nuovo, Edgerton ci spiazza, perché qualsiasi tipo di approccio – rigorista o buonista, e tutte le posizioni intermedie – va in crisi alla voce dell’outsider Truman: lo troviamo orrendo, ogni volta che crediamo di comprenderlo riesce a strapparci il terreno sotto i piedi per l’inaccettabilità di una certa logica, ma poi ogni volta ripropone un nuovo motivo per confondere le tranquillizzanti distanze che vorremmo mettere tra lui e noi. Per renderci impossibile dimenticare che appartiene alla nostra umanità e che qualche volta il suo sguardo – quello che nella copertina italiana si svela come un sesso dietro una zip – coglie dimensioni che ci fanno pensare.
È un ex-bambino morbosamente soffocato nell’infanzia da una madre appiccicosa (“la associo a cose appiccicose, come lo sciroppo di mais o quella pasta bianca per cancellare che ci davano a scuola e che a volte mordicchiavamo per il suo sapore simile a quello del pane”) e ingombrante: candidato a una serie di turbe – di delitto pare ne abbia commesso anche un altro, nel passato, sempre in un contesto malsano – ancora nel braccio della morte abbina a un approccio fantasiosamente infantile una straniante dignità.
È un benestante di piccolo cabotaggio il cui relativo benessere economico – vive con una piccola rendita – è divenuto motivo di invidiosa marginalizzazione al paese, in una provincia americana cattiva e ipocrita.
È un classico represso sessuale, che esplode quando arriva una provocazione – di qui il delitto – ed è un ideale cattivo esempio: un tipo che ancora nell’ultima cella resta a baloccarsi tra uno storytelling di sprezzo di tutto il resto del mondo, di rancorosa pretesa superiorità, e la compulsiva necessità di dimostrare a quel mondo qualcosa…
Si definisce gentiluomo e “democratico – con la d minuscola” ed è dotato di buona cultura: conosce non solo un po’ di Omero, Eschilo, Thoreau e – per dire – i sonetti di Andrew Marvell, ma è in grado di recare nel suo monologo-arringa una serie di critiche non banali e non sempre infondate alla morale corrente, per quanto poi infarcite di commenti spiacevoli e nell’ambito di un discorso eticamente inaccettabile. Certe sferzate di questo show di Truman alla società americana restano in ogni caso esemplari.
Il nostro imbarazzo di fronte a Truman aumenta poi considerando come il suo delitto abbia dettagli particolarmente odiosi. Greta Carlisle, fuggita dopo essere stata picchiata e stuprata, è caduta nel fiume, e lui ha scelto per dispettosa noncuranza di lasciarvela morire. È vero che mentre lui si trovava tranquillo a pescare, Greta era andata a insultarlo con toni di volgare cattiveria (o almeno questo è il punto di vista di Truman, su tale distinguo dovremo tornare): la notte prima lui stava passando in bicicletta nel bosco fuori paese e ha avuto la discutibile idea di fermarsi a occhieggiare Greta, intenta a un’orgetta in situ con tre uomini. Ma l’autore non può essere accusato di equivoca simpatia per il rapist né di aver “giustificato” l’ingiustificabile – tanto più che la scena della violenza, cruda e goffa, è del tutto priva di compiacimenti equivoci. Più semplicemente il quadro complessivo di un certo mondo provinciale è sordido: la stessa supponenza di Truman, la logica del “Feci quello che avrebbe fatto qualsiasi uomo onesto” (cioè, nel caso specifico, rimettersi a pescare dopo il fatto, ignorando la sorte di Greta o piuttosto non ignorandola), presenta in fondo gli stessi stigmi di moralismo autogiustificativo della società degli onesti che godutissima lo condanna alla pena capitale, lo lascia violentare da un altro detenuto, lo sottopone a gratuite vessazioni ancora nel braccio della morte e si appresterebbe a fargli la festa.
Insomma, non si tratta del solito apologo – in fondo tranquillizzante, magari pietistico – dell’uomo che sbaglia e della società che l’ha portato a sbagliare: Edgerton ci precipita in un loop in cui comprensione, ripugnanza, rabbia, disagio si incalzano continuamente, ferocemente. E persino la chiave di un male come miseria, tanto più umana quanto meno vuol esserlo, finisce con lo zoppicare. Questo l’inizio del suo show:
Lasciate che vi dica chi occupa questa cella di prigione. Perfido, il suo nome è Perfidia. Il suo nome è Bugiardo, Blasfemo, Profanatore della Verità, Lingua Marcia. Giace in pari misura con tutti i membri della congregazione e a ciascuno dice che è il suo amante, mentre già passa al successivo nel suo incessante consumare anime.
Un monologo da attore, col Nostro che appare come da una scena buia e annuncia la propria verità: e badiamo ai titoli che si attribuisce. Per i lettori di un’America nata con la Bibbia in mano, sostenere di essere il Mentitore è immediatamente riconoscibile come griffe demoniaca, anticristica; poche righe dopo Truman si definisce “figlio di Moloch” e in cella leggerà I demoni. Un uomo insomma coperto di nomi blasfemi come la bestia che regge la Meretrice di Babilonia, portatore di tutti i mali del mondo. Si può liquidare tutto come enfasi, ma alla luce del provocatorio finale che apre ulteriori soluzioni (“Forse, dopo aver letto questo resoconto, giungerete a una diversa conclusione riguardo a chi sono, o forse no…”) potremmo dover rileggere tutto il romanzo. A farla breve, Edgerton ci caccia in un bel pasticcio, e non è il caso di spoilerare.
Possiamo però parlare un po’ più puntualmente della trama: The Rapist non è un romanzo carcerario anzitutto perché per una generosa parte del testo Truman riesce a star fuori da quelle mura, immerso nel passato o nel futuro – compreso quello virtualmente post mortem. A spalancarsi davanti al lettore è in effetti – potremmo dire – l’intero, vertiginoso repertorio di possibilità che nei millenni l’uomo ha potuto immaginare, temere o sperare per la propria sorte ultima: tra speculazioni teoriche ed esperienze visionarie (deliri, intuizioni, rivelazioni?), Truman queste dimensioni le attraversa tutte, in una straniante odissea pneumatica. Reincarnazioni (“Forse veniamo riportati in vita sotto forma di zanzare, cosa che di certo spiegherebbe come mai ce ne sono così tante”), riduzioni a cellule, fluttuazioni del corpo astrale, diaspore tra multiversi…
Una chiave – parziale, imperfetta – potrebbe essere il definire The Rapist un romanzo sul tempo. Coronato dal dittico di John Donne “Passato, presente e futuro coesistono nello stesso tempo, / come dimostrato dai nostri sogni”, il lungo monologo di Truman è in effetti articolato in tre capitoli, Il Presente, Il Passato, Il Futuro.
Il Presente parla del braccio della morte, della situazione che vi ha portato Truman (apprendiamo la verità poco per volta), del suo rapporto col mondo ma anche della sua rivelazione di essere stato capace, in giovane età, di sollevarsi nell’aria: sia volando in senso vero e proprio, sia staccandosi dal corpo e librandosi su di esso. È davvero convinto di possedere simili capacità? O la sua misantropia ha preso la china del delirio? O piuttosto mente a se stesso, per costruirsi una realtà alternativa protetta? E in tal caso quanto di ciò che abbiamo ascoltato finora appartiene al dominio dell’illusione o della menzogna? Certo, in questo Presente c’è anche molto passato e persino futuro, che noi sentiamo narrato dall’attore monologante in scena: diciamo che qui il personaggio si confronta con il senso del suo presente. Compreso quanto riguarda la decisione polemica di sfuggire all’esecuzione volando via, come volava un tempo, ma per poi tornare a costituirsi: un segno di sprezzo che non cura neppure la dimensione autoconservativa.
E il primo capitolo termina appunto con un’ultima esercitazione notturna, introducendo al secondo, Il Passato, e all’esperienza del Nostro in volo sul pianeta. Qualcosa che lo porta indietro, ai rapporti a volte drammatici in famiglia, ad altre vicende traumatiche vissute o forse no (un attacco di elicotteri col napalm: il Vietnam?), alle domande sul suo status (perché non vede altri spettri come lui?) in una serie di esperienze psichiche e riflessioni filosofiche che sarebbe sciagurato ridurre a un riassunto. Fino all’incontro, davanti a una scacchiera, con il vecchio dagli occhi rosa che per approssimazione teologica potremmo definire demiurgo. Interessa poco che esista sul serio o costituisca una mera istanza interiore: si presenta come un gestore della matassa degli eventi e provoca Truman, svelandogli realtà sulla sua vita che consciamente non ha mai accettato. Fino a spiegare al Nostro, che pretende di brandire la logica contro la stupidità del mondo:
«Truman, credo che la tua “logica” ti abbia fuorviato, e penso che lo imparerai. Spero che tu lo faccia. Non credo che saresti davvero felice di essere un granello di sabbia o una macchiolina d’inchiostro, e che in realtà tu sia soltanto pieno di rabbia. E questo è sconcertante, perché per quanto ne so nessuno ti ha mai fatto del male.»
La provocazione è forte (il corsivo è mio) perché da quanto sappiamo – o crediamo di sapere – il passato col padre è stato anche un passato di violenza, e di violenze dall’ambiente Truman sembra averne subite eccome: perché il vecchio non se ne rende conto? È perché il Nostro, nella sua deriva sociopatica, si è inventato quelle vessazioni e in sostanza finora ha mentito? O perché il vecchio (come emergerà nella terza parte), dal proprio punto di osservazione nel futuro non gode di agevole visione di tutti i nessi causali? Oppure sta solo – appunto – provocandolo, e con successo a giudicare dalla reazione di Truman (“Mi credi uno di quegli organismi senza cervello che spendono la vita reagendo agli stimoli? Mia madre mi picchiava, quindi io picchio mia moglie e i miei figli? Mi ritieni quel genere d’idiota senza cervello?”): forse il vecchio intende spingerlo a un’autonomia di scelte, a non subire passivamente – come Truman sembra fare, persino con quella fuga sterilmente dimostrativa – un destino da frustrato. Ma il senso potrebbe essere molto più semplice, che cioè esistono passati diversi, anche solo perché non riusciamo a ricostruire quello giusto: li percepiamo come un intero ventaglio di possibilità, puntini che siamo noi a dover collegare con linee rette attraverso un ordine che resta dubbio – e così quel passato opinabile entra nella costruzione del nostro futuro. A questo punto comprendiamo che l’oggetto del capitolo non è tanto il passato in sé quanto il senso del passato: e termina con Truman che si prepara al volo.
Il terzo capitolo, Il Futuro – inteso, ormai ci è chiaro, come senso del medesimo – inizia così con i preparativi del Nostro per il giorno fatale, l’evasione in volo… e qui ha senso fermare il riassunto.
Un romanzo dunque sul tempo, sul senso del tempo: quel tempo – memoria/coscienza – che apprendiamo andrebbe percepito non come un filo ma come un cappio (forma che si sarebbe tentati di interpretare come suggerita dalla psiche del condannato, più che da qualche rivelazione metafisica). E quindi sul senso della vita: Truman comprenderà a un tratto che la sua filosofia apparentemente tanto liberante – credere d’aver tutto sotto il proprio controllo e fregarsene di tutto – lo rende invece più schiavo degli altri a cui importa cambiare le cose. Ma niente paura, amico lettore, nessun pistolotto moralistico: il Nostro (scopriremo) resta sempre lui. E a noi non rimane che constatare l’abilità sorniona dell’autore e il tipo di gioco in cui – demiurgo dispettoso – è riuscito a trascinarci.



