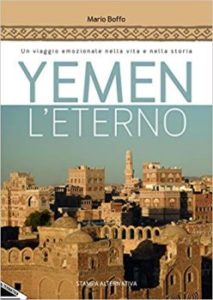di Valerio Evangelisti
[Vi sono libri di tale forza poetica e letteraria che il solo commentarli con linguaggio ordinario toglie loro qualcosa. E’ il caso di Yemen l’eterno, di Mario Boffo (ed. Stampa Alternativa, 2019, pp.283, €22,00). Si tratta di un percorso non lineare in uno dei paesi più belli al mondo, con incontri in case private e nelle strade, descrizioni di luoghi e di vita quotidiana, racconti, leggende, curiosità, meraviglie archeologiche, singolarità di vita e di costume. Mario Boffo, che ricordiamo per il suo pregevole romanzo Femmina strega, è stato ambasciatore italiano nello Yemen, ma non si è limitato alla prassi diplomatica e d’ufficio. Ha voluto conoscere a fondo il contesto in cui agiva, fino a nutrire per esso un amore profondo, esteso dalle cose alle persone. Questo amore emerge da pagine meravigliosamente scritte, emozionanti, coinvolgenti. Sappiamo che oggi anche lo Yemen eterno è minacciato di morte da nemici spietati. In questo libro straordinario è spiegato cosa perderemmo se, nella nostra indifferenza, forze maligne riuscissero a uccidere un lembo di eternità. Presentiamo parte del capitolo iniziale, in cui la capitale, Sana’a, parla di se stessa.]
Ti perderai fra le mia braccia antiche, e nel perderti forse ritroverai te stesso, in quell’area della coscienza che ha radici negli albori del tempo e che nessuna modernità potrà mai cancellare… Sono la città più antica del mondo, la città archetipica, sono l’epitome di tutte le città. Delle città com’erano una volta, conchiuse in se stesse, circondate da alte mura, eppure universo che trovava in sé la propria illimitatezza. Sono la città ancestrale, sono cresciuta al mio stesso interno. Sono intrico, labirinto, budello, scorciatoia, cammino infinito. Sono angoli bui, edifici cadenti eppure sontuosi. Ti perderai, stordito dai ricami architettonici, costretto nelle strettoie, disorientato dalle piazze inattese, carpito dai giardini chiusi, confuso dai mercati improvvisi… Sono la città che tutto ha visto, che tutto ha vissuto, la pace e la guerra, l’amore e la morte, il dolore e la passione. La città che ha conosciuto mille dei e tre volte il vero Dio. Sono il prototipo di tutte le città. Mi diresti uscita da un libro di Calvino, da una visione di Borges, da un resoconto di Gulliver…
In un medio evo mai scomparso, mi percorrono come vitali arterie rivoli di stradine nelle quali ti orienterai con difficoltà, distratto dagli stucchi delle case e dalle vetrate multicolori, tutte uguali, tutte diverse. Ti ritroverai all’improvviso nel quartiere arabo, e poi in quello ebreo, e poi in quello ottomano. Botteghe dei più svariati materiali e articoli attrarranno senza posa la tua attenzione. Sarai assorbito dall’atmosfera ovattata e intrisa dei vapori dell’incenso, nella quale tenui e continui rumori si elidono delicatamente. L’urlo dei muezzin, però, irromperà all’improvviso, al calar del sole, e io ti apparirò più dolcemente adagiata nei caldi toni di un’ocra sensuale. I mercanti, sino allora sdraiati su risicati giacigli, attoniti e imbambolati, le guance gonfie nella masticazione del qat, si leveranno, chiuderanno le botteghe, si recheranno alla preghiera.
L’odore delle spezie mi dona la fragranza che le donne più desiderate ricevono da profumi arditi. Sui banchi e nei negozi, monili d’argento, infiniti modelli di jambiah, la daga della virilità, talleri di Maria Teresa, shisha e madah dai fumi di tabacco e aromi di frutti, guarniscono, quali gioielli, le mie membra urbane. Ti offro tutto questo, a portata di mano, pur nell’intrico di viuzze, passaggi, piazzette, cantoni, nel mercato del sale, in quello dei bovi, in quello dello zibibbo, in quello delle uve, in quello dei fichi, in quello delle corde, in quello del caffè, in quello degli asini… E poi in quelli dei cereali, dei metalli, degli articoli casalinghi… Sarai a tratti investito da odori di carni arrostite e alimenti fritti provenienti da piccole trattorie all’aperto, nel mezzo di slarghi e a ridosso di crocevia, dove potrai ristorarti, magari accanto a gruppetti di uomini accovacciati in terra intenti a negoziare l’acquisto del qat o a condividere la degustazione della salta, la zuppa dall’odore acre e dall’acido sapore. Dappertutto, ragazzini. Giocano a pallone, ma al passaggio ti saluteranno, ti motteggeranno, oppure ti travolgeranno a bordo di biciclette zigzaganti fra la gente. E se non dai ragazzini in bicicletta, dovrai guardarti da altri mezzi di trasporto di varia e creativa natura: carriole spinte da garzoni, infatti, ciclofurgoni assemblati con pezzi di diversa provenienza, autovetture e motociclette, si destreggiano senza tema fra la gente, le bancarelle, le botteghe e i crocchi…
A ogni mio angolo, troverai piccole moschee, bianche cupole, alti minareti. Poi la Grande Moschea, quella che sorse e operò, con il Profeta ancora in vita, nelle immediate vicinanze della precedente cattedrale cristiana. È rettangolare, grigia, squadrata. Gli infedeli non vi possono entrare. Anche all’interno il quadro è spartano, con eccezione dei variopinti tappeti che coprono il pavimento. Sulle colonne, di cui molte provenienti da più antichi templi pagani e dalla stessa vecchia cattedrale, scarne decorazioni. In alto policromi soffitti lignei. Poco in confronto alla vertiginosa architettura delle vostre cattedrali gotiche o delle fughe di volumi delle chiese barocche. Poco anche rispetto alle ricche decorazioni della Moschea Al Amiriya, di Rada’, la quale fu però concepita dal suo costruttore, il sultano Amir ibn’Abd al Wahhab, nel 1504, più come monumento alla propria memoria che come luogo di preghiera. La semplicità, piuttosto, l’oblio, l’obnubilazione del tutto al cospetto di Allah. Non è forse questo il senso dell’Islam primigenio?
Giaccio adagiata accanto al Jebel Nuqum, il grande monte, mio protettore e mio sposo. Una naturale fortezza eretta da Dio a mia difesa. Con i fianchi possenti, mi sovrasta di seicento metri, svettando a tremila metri sul livello del mare. Era lì quando Sem, il figlio maggiore di Noè e capostipite delle popolazioni semitiche, giunse a edificare le mie mura e le mie case alla fine del diluvio universale, dopo aver attraversato il Rub al Khali, il “Quarto Vuoto”, il terrificante deserto sabbioso, l’incubo degli arabi. Per questo fui nota in passato come “la città di Sem ben Nooh”. Più tardi fui conosciuta come “la città di Azal”, o ancora come “la città protetta”, e di me parlano antiche scritture yemenite e il Thowrat giudeo. I monarchi che unificarono questo paese, allora felice, fecero di me la capitale del Regno, e gli stessi abissini, che vennero su ordine dell’Imperatore di Bisanzio a difendere i cristiani perseguitati dai giudei, mantennero il carattere primordiale ed eterno che da sempre alita nelle mie vie, fra le mie case. Fu allora che Abraha, il conquistatore nero, fece costruire Al Qalis, la cattedrale cristiana, a oltraggio e umiliazione della Kaaba della Mecca, adorata allora in nome di strane divinità pagane. Allora, e prima, e dopo, carovane di cammellieri hanno transitato nei miei luoghi, per sosta e ristoro nei lunghi percorsi dell’incenso, mentre stuoli di mercanti confluivano nei miei samsara per vendere merci e per trovarvi alloggio.
Attento, è il tramonto! Le mie case ti appariranno ancora più intriganti, soprattutto se le starai ammirando dalla terrazza di uno dei tanti funduq. Le famiglie si riuniscono per la cena nelle alte magioni, dove scalinate separate impediscono gli incontri delle donne con ospiti maschili non appartenenti alla famiglia. Dopo saliranno in vetta agli edifici, accolti dal mafrej, o dal tairamana, il “nido d’uccello”, dove sorseggeranno tè ammirando dalle larghe e basse finestre i giardini e i quartieri circostanti, e dove nei giorni di festa, o nelle ore più tarde, consumeranno il qat. Talvolta comporranno canzoni o poesie, o indulgeranno in interminabili conversazioni. I miei mafrej… Ne troverai in ogni casa, in ogni funduq, in ogni locanda, all’ultimo piano dei miei alti edifici. In quello del Taj Ahlal, che è piccolo e raccolto, non si trovano quasi mai persone estranee, e lo struggente scorcio dei miei quartieri apparterrà esclusivamente a te e alla donna che ti accompagna; al crepuscolo, allora, quando il canto dei muezzin irrompe a tingere di rosso le case e il cielo, nei suoi occhi trasognati si rifletterà per un attimo l’immagine di tutti i miei minareti.
La mia architettura di pietra, di argilla e di gessi, di legno e di stucchi, di alabastri e di vetri colorati, parla della storia e delle consuetudini di queste genti. Alte come torri, le mie costruzioni ripercorrono la suddivisione di sempre. Il pianterreno, dove in passato giacevano gli animali, il primo piano riservato a riunioni e cerimonie, il secondo piano per le donne e i bambini, i piani superiori per gli uomini. Simili a spuntoni rocciosi, finestre sporgenti, baldacchini di legno traforato, sono protese all’esterno, per consentire alle donne di casa di guardare fuori senza essere viste e di conservare vivande al fresco della notte. Un tempo fui circondata da mura imponenti e torri di controllo i cui resti residui emergono malinconici e quasi invisibili da qualche limitato e nascosto tratto. Ma un viaggiatore venuto di lontano, primo fra gli europei e dopo i romani, a visitare le vestigia ancora intatte, descrisse le mie mura come tanto grandi e possenti da consentire in cima il passaggio di otto cavalli affiancati. Le mie mura avevano quattro porte principali, che venivano chiuse di sera e riaperte di mattina presto. In tutto le porte erano sette, alcune delle quali prendevano il nome dalla direzione verso cui menavano. Bab al Yemen, la più famosa e l’unica ancora in piedi, è volta verso meridione e perciò così chiamata: “la porta verso lo Yemen”. Delle altre è rimasto solo il nome nel luogo in cui sorgevano. Bab al Yemen s’impone maestosa; è la porta di cui non fui mutilata, è l’accesso più facile e nobile alla mia anima. In passato era la sola porta da cui concedere l’ingresso agli stranieri, i quali dovevano segnalarsi tirando la corda di un campanello. Venivano poi attentamente interrogati prima di poter entrare, per essere sicuri che non si trattasse proprio dello straniero che, secondo una vecchia premonizione, avrebbe un giorno causato la mia distruzione. Bab al Yemen compare all’improvviso. Con l’altera imponenza sembra volersi fare drammatica testimonianza delle altre antiche porte, di cui oggi resta solo il nome. Una delle vecchie porte scomparse si chiamava Bab al Rum. Stordita dalle mille suggestioni che ti ispiro, e conscia dei miei antichi legami con la storia del mondo, la fantasia ti porterà forse a pensare che quel nome sia dovuto all’orientamento a nord, nella direzione che conduce verso Roma, luogo di cui gli yemeniti hanno sempre saputo e con il quale a suo tempo indicavano anche Bisanzio e in genere l’Occidente, destinazioni finali del loro commercio… Non ti svelerò se si tratta di una corretta intuizione o di un parto dell’immaginazione: come nel fascino di una bella donna, un po’ di mistero, di enigma, di vago, fa parte di me, contribuisce al mio senso arcano.
Mi vedi così, adesso, dignitosamente circondata dalla modernità. Ma io sono antica, più ancora di quanto le mie case, gli edifici, le moschee possano testimoniare. Gli edifici, materiale forma della mia sostanza, non risalgono a più di quattrocento anni fa, ma ricostruiti e restaurati nei secoli, mantengono intatti stile, struttura e apparenze, e le persone che animano le mie strade formano un popolo identico a quello di mille anni or sono, quando le mie architetture furono nuovamente impiantate su fondamenta ancora più lontane nel tempo. Così si perpetua la mia essenza antica, metafora visibile e tangibile di una società anch’essa immutabile, pur nel succedersi delle generazioni… Nel medesimo sito, angusto e infinito, costruzioni, tradizioni, attività artigianali, chiacchiere, dicerie e pettegolezzi, abitudini, preghiere, passi infiniti, ritmi millenari, richiami dei muezzin, affabilità commerciale e interminabile mercanteggiare, si susseguono ora come secoli addietro, nell’inossidabile e felpata apatia che misurerai in ore d’indolenza, litri di tè bollente, intricati percorsi nei reticoli viari, dove uomini e donne, ora come sempre, pregano nelle settanta moschee, coltivano gli orti, si incontrano negli umidi hamam in turni rigorosamente separati, e là sudano, riposano, socializzano, si lavano, conversano, trattano affari e matrimoni fra guantoni di crine, brocche d’acqua, massaggi e rudimentali docce. Come secoli addietro, i samsara fanno da riferimento e indicazione a chi si aggiri nel labirinto dei miei percorsi. La gente che popola le mie vie non è meno peculiare dell’ambiente architettonico. Incontri infatti uomini che indossano una tunica, preferibilmente bianca, una specie di turbante e la jambiah, la lama tradizionale, simbolo della virilità, sostenuta da una sfarzosa cintura intessuta di fili argentei o dorati. Incroci donne, nere presenze di cui si può notare soltanto lo sguardo, poiché gli occhi sono l’unica parte scoperta del corpo, quando non sono anch’essi velati.
Ti ritrovi a un tratto sulla strada chiamata Saila, che taglia in due l’agglomerato. Ferita netta, non rimarginabile, simbolo e allegoria delle mille ferite che mi sono state inferte nei secoli. Forma un avvallamento fra due cinte murarie ricostruite, assumendo l’aspetto di un fiume secco. Uno ouadi. E proprio come uno ouadi la strada si comporta in occasione delle piogge torrenziali che cadono in due stagioni dell’anno. La strada allora si gonfia d’acqua, fra gli alti argini, e si trasforma in un torrente che attraversa in piena i quartieri. Il traffico automobilistico ne viene impedito per qualche ora o per qualche giorno. I ponti che attraversano la Saila appaiono bassi, la gente si ferma ad ammirare lo scorrere delle acque e i ragazzi ne approfittano per tuffarsi e bagnarsi, facendosi sintesi della città ancestrale, della forza della natura e della modernità, nella quale le autovetture, che nei periodi non piovosi utilizzano la strada come una normale via di traffico, stazionano semisommerse ad attendere il passaggio della piena…
Prima o poi, transiterai in un piccolo slargo, e noterai un edificio senza finestre accanto a una piccola moschea. Qualcuno allora ti racconterà che in epoca di dominazione ottomana viveva in quella casa, allora dotata di normali finestre, una fanciulla di proverbiale e intensa bellezza. Un cavaliere ottomano passava di là di frequente, certo non per caso, e non poteva fare a meno di guardarla sospirando. Un giorno il gelosissimo padre della ragazza, furente, se ne accorse. Inviò la figlia per qualche giorno in campagna da parenti, concepì la vendetta e preparò una trappola crudele. Quando tutto fu pronto, fece rientrare la fanciulla, le impose di rimettersi bene in vista alla finestra e di invitare il cavaliere, alla sua prima apparizione, a entrare nella casa; ordine cui l’obbediente fanciulla non poteva ribellarsi. Il cavaliere, lusingato, varcò il portone, e con indosso armi e ornamenti, si accinse ad attraversare a cavallo la corte della casa, al cui opposto lato l’aspettava la ragazza. Ma proprio quando fu nel mezzo della corte, si sentì sprofondare. L’arcigno genitore, infatti, aveva fatto scavare una fossa nascosta dove il cavaliere, una volta precipitato, fu seppellito vivo con tutta la montatura, le armi, i vestiti e gli averi. Giorni dopo, gli amici e commilitoni del cavaliere, insospettiti dalla lunga e inusitata assenza, cominciarono a indagare. Più e più volte si recarono nella casa della fanciulla, ma non riuscirono mai a trovare né a supporre niente, accontentandosi gradualmente della versione secondo cui quel cavaliere aveva probabilmente avuto qualche motivo per lasciare segretamente la città. Passarono gli anni, e il padre della ragazza morì. La fanciulla, oppressa dall’orribile segreto, rivelò il misfatto del genitore. Gli antichi compagni ottomani, allora, tornarono più che mai infuriati, non solo per il delitto, ma anche per essere stati ingannati per tutto quel tempo. Rendendosi però conto che il principale colpevole era già morto, mitigarono la vendetta, posero tuttavia una condizione all’indulgenza. Avrebbero recuperato le spoglie del povero cavaliere, e se le avessero trovate prive di armi e di averi, avrebbero distrutto la casa e ucciso tutti i suoi abitanti, per punire la rapina, piuttosto che il misfatto d’onore. Se invece avessero ritrovato i beni del giovane, si sarebbero limitati a più miti interventi. Così fu. Gli ottomani recuperarono armi e averi, e risparmiarono la casa e gli abitanti. Come necessario castigo, però, e a monito di ciascuno, imposero la muratura di tutte le finestre, affinché più nessuno potesse vedere chi o che cosa vivesse o fosse in quel palazzo. Questa cupa vicenda è forse frutto di fantasia… Ma tutto congiura a definire lo spirito e l’atmosfera dei miei luoghi.
Sei stanco, ora. Siedi davanti a un caffè dove un gruppo di avventori fa a gara a offrirsi l’un l’altro la bevanda che proprio da questi luoghi raggiunse l’Occidente. È un povero sgabuzzino nei pressi di un hamam, dove uomini seminudi coprono pudicamente il corpo dalla vita in giù. Seduti sull’alto marciapiede di fronte al locale, gli avventori chiacchierano, mentre qualcuno serve la calda bevanda e offre pagnotte con l’uovo sodo. Nessuno ti fa caso, ma all’improvviso offriranno anche a te una tazza zuccherosa. Coloro che escono dall’hamam, magari coperti da accappatoi dai colori inconsueti, si incrociano con più eleganti signori che, fra l’indignato e il divertito, ne rimprovereranno a gran voce l’indecenza. Un vecchietto seduto accanto alla porta sorseggia il caffè con voluttà: sarà quello l’unico evento della lunga giornata. Un uomo, da un lato all’altro della stradina, fissa a lungo una bella ragazza europea a volto scoperto, e questa lo apostrofa in inatteso e perfetto arabo con una severità tale da indurlo a battere in ritirata verso un discreto giardino. I miei giardini… Erano lussureggianti di vegetazione e piante, un tempo, e ornati di fiori e fontane zampillanti, prima di essere via via abbandonati. Qualcuno però riprende vita. Vi si coltivano ortaggi e piante mediche, palme e arbusti floreali. Li troverai nei pressi delle moschee, e vi troverai sempre almeno una palma, l’albero cui queste genti devono il nutrimento, la frescura, l’acqua.