di Paolo Lago
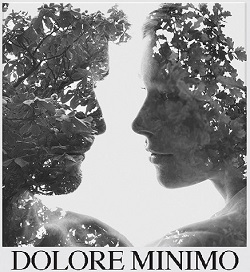 Giovanna Cristina Vivinetto, Dolore minimo, presentazione di Dacia Maraini, postfazione di Alessandro Fo, Interlinea, Novara, 2018, pp. 143, € 12,00.
Giovanna Cristina Vivinetto, Dolore minimo, presentazione di Dacia Maraini, postfazione di Alessandro Fo, Interlinea, Novara, 2018, pp. 143, € 12,00.
La poesia di Giovanna Cristina Vivinetto ci conduce, fin dai primi versi, in una dimensione mitica e, a tratti, epica, come se stessimo leggendo e ascoltando – poiché la lettura si trasforma quasi in un magico canto che ci avvolge – il racconto delle origini di un popolo e di una civiltà. La potenza mitica della poesia di Dolore minimo ci porta però all’interno di una vicenda intima e privata, trattata appunto come se fosse una materia epica, il «pacato fluire di un imperturbabile epos», come scrive Alessandro Fo nella postfazione. La forza e la semplicità della parola poetica circondano il lettore avvolgendolo di una grazia primordiale dominata da parole sincere e essenziali, parole che affondano nella mente e nel cuore come tanti dardi adamantini. Il tema trattato è dei più intimi e delicati: la progressiva trasformazione del proprio corpo, il ricordo di una metamorfosi già avvenuta la quale viene descritta nel suo farsi, nel suo magmatico mutamento: tante pagine poetiche che recano in sé il delicato ricordo di altre pagine che parlano di metamorfosi, quelle di Ovidio. Il poeta latino, infatti, con una indescrivibile grazia e delicatezza, ci riferisce di mutamenti di uomini e di dei, di corpi che cambiano, che non restano mai uguali a se stessi, all’interno di un mondo silenzioso e ovattato che riecheggia quello della corte augustea.
La parola poetica di Vivinetto, mentre canta il movimento della metamorfosi, è essa stessa soggetta a una metamorfosi continua: non è mai definita, ferma, geometricamente bloccata, ma si libra flessuosa, mobile, percorsa da un magma soffuso. La «malattia», il magico e maledetto flatus della consapevolezza della propria diversità che penetra l’anima e il corpo, si insinua nella scontata e ‘geometrica’ quotidianità, perduta nei suoi ripetitivi rituali scolpiti sullo sfondo di un torrido agosto: essa mi scoprì inadatta alla simmetria / delle proporzioni – alla retta / sempre fedele a se stessa. / Imparai così dall’imperfezione / degli alberi nel farmi ramo sottile / e spigoloso per tendere / obliquamente / alla verità della luce. Il corpo e il sé divengono imperfetti, obliqui, flessibili perché nell’imperfezione e nella diversità sono la bellezza e la grazia, nell’ordine geometrico e nel canone, invece, vuoti e scontati involucri da riempire. Mi viene in mente questa frase inserita nel film Stalker di Andrej Tarkovskij: «Che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l’uomo nasce, è debole e duttile. Quando muore, è forte e rigido. Così come l’albero: mentre cresce è tenero e flessibile. E quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell’esistenza». Lo stalker è debole, affaticato, vinto, possiede in sé le stigmate della diversità, viventi nella propria figlia paralitica; si insinua flessuoso nei meandri di territori ostili e mortali ma, forte della propria disperazione, esprime per mezzo della sua stessa debolezza la freschezza della propria esistenza.
E così, un corpo che muta, che è mutato, che è soggetto a metamorfosi, che grida la propria disperazione per una diversità che dà scandalo, là, nel mondo quotidiano e scontato, non accetta nessuna irreggimentazione in un ruolo predefinito, dettato da un vuoto ordine. Un corpo che accetta di rinascere non può che essere duttile, flessibile, continuamente attraversato da una nuova spinta alla vita: è per scongiurare la morte che si muta, che si acquistano nuove forme. La parola poetica di Giovanna Cristina Vivinetto esprime interamente la dimensione performativa di un corpo che muta e che, nella sua metamorfosi, non accetta nessun ruolo imposto dall’alto. Perché ogni ruolo è sinonimo di rigidità, di incasellamento in una griglia costruita a tavolino, disegnata dalla banalità delle convenzioni. Ed è così che la poesia si trasforma in corpo, in carne viva che subisce la ferita del taglio, del movimento che muta, che restituisce l’anima vera allo stesso corpo. La poesia, allora, restituisce in parole inaudite e segrete il mistero della metamorfosi, il dischiudersi di un dolore atavico che esce allo scoperto come le gesta di antichi eroi. La parola poetica esprime un dolore oscuro che diventa un canto cristallino, lucida presa di coscienza, magico dono che forse era stato proprio solo dell’indovino Tiresia: mutare sesso una volta nella vita.
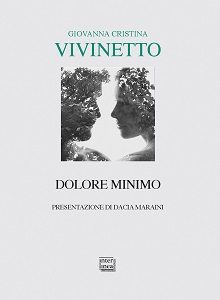 Il canto di Vivinetto esprime, in forma autobiografica, un ribelle scollarsi della carne, / una lotta fratricida tra spirito / e pelle. Un annichilimento. L’incedere poetico, infatti, alterna momenti più intimi e privati, sensazioni e immagini scaturite da un sogno o da un incubo, ad altri in cui viene lucidamente scandagliata la realtà in cui protagoniste sono le persone che circondano l’autrice: il padre, la madre, i parenti, gli amici. Tutti sorpresi, tutti in un certo senso irrigiditi di fronte alla scoperta della diversità: perché nei versi di Vivinetto è costantemente presente una lancinante barriera fra ‘io’ e gli ‘altri’, ribadita anche da due citazioni poste in esergo a due sezioni della raccolta (soprattutto una da Amelia Rosselli e una da Wislawa Szymborska, in cui il pronome «voi» è sinonimo di un invalicabile muro). Dolore minimo è l’autobiografia di un mutamento, della presa di coscienza di una diversità e del suo emergere nei vortici della carne, di un corpo perennemente presente che grida di gioia e dolore. Ogni componimento, legandosi al successivo, si prolunga in poemetto, in un poema extenso che scava nel passato e nel proprio io, con una intensità che mi ha fatto pensare a certe poesie pasoliniane, soprattutto appartenenti a Poesia in forma di rosa, in cui il poeta ripercorre all’indietro la piaga gioiosa e dolorante della propria diversità (la quale, in Pasolini, si riveste anche di connotazioni politiche e sociali).
Il canto di Vivinetto esprime, in forma autobiografica, un ribelle scollarsi della carne, / una lotta fratricida tra spirito / e pelle. Un annichilimento. L’incedere poetico, infatti, alterna momenti più intimi e privati, sensazioni e immagini scaturite da un sogno o da un incubo, ad altri in cui viene lucidamente scandagliata la realtà in cui protagoniste sono le persone che circondano l’autrice: il padre, la madre, i parenti, gli amici. Tutti sorpresi, tutti in un certo senso irrigiditi di fronte alla scoperta della diversità: perché nei versi di Vivinetto è costantemente presente una lancinante barriera fra ‘io’ e gli ‘altri’, ribadita anche da due citazioni poste in esergo a due sezioni della raccolta (soprattutto una da Amelia Rosselli e una da Wislawa Szymborska, in cui il pronome «voi» è sinonimo di un invalicabile muro). Dolore minimo è l’autobiografia di un mutamento, della presa di coscienza di una diversità e del suo emergere nei vortici della carne, di un corpo perennemente presente che grida di gioia e dolore. Ogni componimento, legandosi al successivo, si prolunga in poemetto, in un poema extenso che scava nel passato e nel proprio io, con una intensità che mi ha fatto pensare a certe poesie pasoliniane, soprattutto appartenenti a Poesia in forma di rosa, in cui il poeta ripercorre all’indietro la piaga gioiosa e dolorante della propria diversità (la quale, in Pasolini, si riveste anche di connotazioni politiche e sociali).
Il canto poetico deve farsi terra, sangue, respiro; deve tornare a una dimensione ctonia che si è irrimediabilmente perduta e che si può forse recuperare nello spazio arcaico di un bosco: Sentivo di dover ripartire / dalla terra, dai rami, da un coro / di occhi, zampe e code inavvertibili / vivi in minuscoli petti pulsanti / a cui chiedere la loro intatta voce. Una dimensione legata a antichi riti di fecondazione e rinascita, per cui la parola diviene essa stessa racconto mitico e si carica di un significato antropologico legato alle origini della vita: fecondarmi / per ridiventare minuscola / materia di un corpo universale. Ed ecco il magico, doloroso e bellissimo rituale della rinascita: di fronte agli occhi della propria madre, un figlio rinasce figlia e diviene a sua volta madre. Un figlio che è contemporaneamente figlia e madre di una nuova parte di sé, un nuovo sé che emerge, libero e liberato per continuare la vita oltre la morte. Perché accettare le convenzioni e l’ordine avrebbe voluto dire accettare la morte: perciò si rinasce per continuare a vivere e splendere della propria infinita bellezza, una diversità bellissima che dà scandalo nel banale ordine delle cose e che consegna all’esistenza tante nuove, stupende tracce di vita.
Scandito in un canto che riflette sul corpo e lo rende protagonista della propria storia più intima, con accenti che possono ricordare certe poesie di Giovanna Sicari, il ‘poema’ autobiografico di Dolore minimo riflette però anche sulla mente e sul pensiero, perché, alla fine la sessualità è tutto un groviglio da districare / nella mente: il primo e più importante passo avviene dentro di noi, prima che nell’esteriorità del corpo. Perciò è importante consolare quell’intima diversità per resistere, per opporre una resilienza contro chi vorrebbe imporre le regole di una presunta normalità: essere contro natura – a detta delle regole non scritte di un ‘ordine’ costituito – e proprio per questo resistere contro coloro che si sgolano a dirci che potevamo essere / chi non volevamo, chi non eravamo, in una protesta silenziosa che può ricordare, mutatis mutandis, quella montaliana del «ciò che non siamo, ciò che non / vogliamo», contro una progressiva ‘fascistizzazione’ della società. Eppure, questa resistenza è necessaria: perché chi va contro le assurde regole di qualsiasi tipo porta in sé il germe dell’esistenza e della vita e, come i resistenti in un periodo di dittatura, fa parte degli unici esseri innocenti. / Gli ultimi esseri viventi, noi, / trapiantati nel mondo dei morti / per sopravvivere.
Dolore minimo è perciò la lucida testimonianza poetica di una resistenza, di una rinascita e di una nuova esistenza, di uno splendere nuovo forte della sua flessuosa ‘diversità’. Nata ma non generata, la nuova figlia è venuta / al mondo con la vivida certezza / di splendere sola nella diversità, in un nuovo corpo che finalmente le appartiene, che vive e vivrà, un corpo nel quale un dolore non comune / riluce. E la poesia è il magico canto di questo corpo, della sua metamorfosi, del suo nuovo splendore.



