di Franco Pezzini
 La Danzatrice e le reliquie (puntata precedente qui)
La Danzatrice e le reliquie (puntata precedente qui)
Si è parlato della testa ghigliottinata del re, gorgoneion del terrore nei giorni della Rivoluzione, e del peso simbolico che finisce ad avere sotto la superficie del romanzo di Dumas La donna dal collier di velluto. Ma nello stesso periodo quell’immagine viene letta, dai monarchici, in ottica completamente diversa, come richiamo alla testa di san Giovanni, con tutto ciò che ne deriva in termini ideologici (il re come lui martire eccetera): e ciò finisce col ricondurre a un secondo “mostro”, pure evocato da Dumas come in filigrana, a proposito di una danza in cui qualcuno perde la testa. Si parla di Salomè: danzatrice come Arsène, e capace come lei di estorcere a deboli uomini il pegno di un fremito sessuale oppiaceo e travolgente (sul tema, cfr. qui).
Certo, Medusa è una figura mitologica mentre Salomè ha una carta di identità storica – nata attorno al 14 d.C., morta in tarda età (per l’epoca) tra il 62 e il 71; eppure la spregiudicata danzatrice che si prepara al grande Sabba dell’età simbolista può già vantare, a questo punto, uno statuto altrettanto mitico.
In effetti, della sua biografia si sa poco. Nell’ambito dell’episodio losco che le darà fama, la morte del Battista di cui richiederebbe a Erode la testa su input della madre Erodiade, i Vangeli le dedicano poche parole (Mc 6, 17-29 e Mt 14, 3-12) limitandosi a definirla «ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος», “la figlia di Erodiade”, e non citandone il nome; l’espressione è però letta da alcune antiche versioni di Marco come «la figlia di Erode, Erodiade», per cui si chiamerebbe come la madre. A riportarne il nome come Salomè è un’altra fonte antica, Giuseppe Flavio (Antichità giudaiche XVIII, 5, 4) che la vuole figlia di Erode II (Erode Filippo I) e sposa del tetrarca Filippo (Erode Filippo II), poi di Aristobulo di Calcide re dell’Armenia Minore. Dove in effetti il volto di lei spicca su qualche moneta: in fondo l’ennesima testa di questa storia. Ma qui in pratica, con notizie sulla sua prole (tre figli dal secondo marito) e un po’ di dubbi sui quali non ci soffermiamo in questa sede, si chiude il versante storico della sua vicenda.
Lasciando però il posto alle voce delle leggende, alcune piuttosto risalenti: quella per esempio della Lettera di Erode a Pilato, un apocrifo neotestamentario appartenente al cosiddetto Ciclo di Pilato (V secolo?). Lì il re – identificabile nel tetrarca Erode Antipa – riferisce che la figlia Erodiade (quindi probabilmente Salomè) sarebbe rimasta decapitata dal ghiaccio di una pozza d’acqua dov’era caduta, come in un cattivo esempio alla Pierino Porcospino: la testa
è rimasta sulla superficie del ghiaccio [come sul piatto della scena evangelica]. Ed ecco, sua madre tiene la sua testa in grembo posata sulle proprie ginocchia, e tutta la mia casa è in grande dolore […] Ti mando gli orecchini di mia figlia e il mio anello, che potrebbero essere per te un memoriale della mia morte. [Lettera, cit., 1 e 12]
 Dove ciò sia avvenuto è discusso, ma le tradizioni sull’esilio di Antipa e della partner Erodiade e la presenza della figlia in sinistre leggende pirenaiche farebbero pensare a Lugdunum Convenarum, odierna Saint-Bertrand-de-Comminges nell’Haute-Garonne a poca distanza dalla Spagna. Implausibilità storiche (e medico-legali) a parte, è però chiaro che la Francia è affascinata da questo mito. E se dei vilain non è uso conservare reliquie (chissà che ne è stato dei fantomatici orecchini spediti a Pilato), queste saranno offerte dalla letteratura.
Dove ciò sia avvenuto è discusso, ma le tradizioni sull’esilio di Antipa e della partner Erodiade e la presenza della figlia in sinistre leggende pirenaiche farebbero pensare a Lugdunum Convenarum, odierna Saint-Bertrand-de-Comminges nell’Haute-Garonne a poca distanza dalla Spagna. Implausibilità storiche (e medico-legali) a parte, è però chiaro che la Francia è affascinata da questo mito. E se dei vilain non è uso conservare reliquie (chissà che ne è stato dei fantomatici orecchini spediti a Pilato), queste saranno offerte dalla letteratura.
Ci si arriva poco per volta. Heine, nel poemetto Atta Troll, canto XIX (1841), parlando della «bella principessa di Giudea» trascinata nella dannazione della caccia selvaggia, si riferisce a un’Erodiade (forse per il nesso Diana / Herodiana delle schiere streghesche altomedioevali) che è stata intesa alternativamente come la madre e la figlia:
Ella porta sempre con sé, su quel piatto d’argento, la testa di Giovanni, e bacia, bacia quella testa con trasporto; poiché vi fu un tempo che ella amò Giovanni; la Bibbia non lo dice, ma ben viva è nel popolo la leggenda dell’amore sanguinario di Erodiade; altrimenti come spiegare quell’ardente brama? Potrebbe mai una donna desiderare la testa di un uomo che non ama? Ella forse fu cattivella con l’amato facendolo decollare, ma quando sul capo d’argento ne vide il capo mozzo, pianse disperatamente e morì impazzita per amore [cit. in Vito Levi, Richard Strauss, Studio Tesi, Pordenone 1984, p. 64.]
Ma, sull’onda della traduzione del poemetto (1847) che entusiasma Nerval, Gautier, Baudelaire, Moreau e tanti altri, arrivano le versioni francesi del tema. Così ecco Baudelaire ne I fiori del male – lirica 27, sezione Spleen et Idéal – richiamare Salomè assieme alla madre (1857); ecco Mallarmé iniziare Les Noces d’Hérodiade (1864) con cui si misurerà per trentacinque anni, senza completare l’opera; ecco Flaubert nell’Hérodias (1877) ripescare da Giuseppe Flavio e rendere celebre il nome della figlia come Salomè – e ormai tutti la chiameranno così –, in controcanto all’amorosa Sulamita del Cantico dei cantici; ecco Laforgue, Banville, Huysmans e tanti altri evocarla con affascinata attrazione. Dumas, chiudendo La donna dal collier di velluto nel 1849, può ben ricordare la versione francese del poemetto di Heine edita due anni prima: e se non può ancora immaginare gli sviluppi poetici da Baudelaire in avanti né, tanto meno, l’ossessione-Salomè tra la fine dell’Otto e i primi decenni del Novecento, sembra tra i primissimi letterati francesi di questa filiera. Dove, dicendo Dumas, in tema di storie di fantasmi si intende anche il suo consulente, complice e a tratti coautore Paul Lacroix, detto Bibliophile Jacob per l’erudizione appassionata e la leggendaria bibliofilia (1806-1884), in grado di scovare le leggende più rare e ovviamente al corrente del corpus sulla figlia di Erodiade, in una Francia dalle robuste devozioni alla memoria di san Giovanni. Dove il riferimento è a una Salomè non storica ma ormai fantasima come quella di Heine: una sorta di Sposa cadavere dall’impossibile e torbido amore, mai superato; una danzatrice notturna la cui schiera ideale è quella della caccia selvaggia; e insieme, sottilmente, un mostro.
 D’altra parte a consacrare – una sacertà nera, è ovvio – la figura della danzatrice assassina è anche tutta una lunga storia pittorica. Come Giuditta (anche se con diversi sottotesti simbolici), anche Salomè è una cefalofora, portatrice cioè di una testa mozzata; e a volte l’iconografia è la medesima anche per Erodiade madre, donde talora dubbi nell’interpretazione del soggetto. Benché la stagione più fitta di icone di Salomè sia successiva, al tempo di Dumas le immagini non mancano, dalle incisioni ai dipinti: e si può ad esempio ricordare il quadro Hérodiade di Paul Delaroche, oggi conservato al Wallraf–Richartz Museum di Colonia (1843). Vi appaiono madre e figlia con la testa di Giovanni nel cesto. Una in primo piano, a fissare lo spettatore con sguardo freddo e torbido; l’altra alle spalle perplessa e come sovrappensiero, defilata e ormai perduta nella scelta di quella sera terribile a Macheronte.
D’altra parte a consacrare – una sacertà nera, è ovvio – la figura della danzatrice assassina è anche tutta una lunga storia pittorica. Come Giuditta (anche se con diversi sottotesti simbolici), anche Salomè è una cefalofora, portatrice cioè di una testa mozzata; e a volte l’iconografia è la medesima anche per Erodiade madre, donde talora dubbi nell’interpretazione del soggetto. Benché la stagione più fitta di icone di Salomè sia successiva, al tempo di Dumas le immagini non mancano, dalle incisioni ai dipinti: e si può ad esempio ricordare il quadro Hérodiade di Paul Delaroche, oggi conservato al Wallraf–Richartz Museum di Colonia (1843). Vi appaiono madre e figlia con la testa di Giovanni nel cesto. Una in primo piano, a fissare lo spettatore con sguardo freddo e torbido; l’altra alle spalle perplessa e come sovrappensiero, defilata e ormai perduta nella scelta di quella sera terribile a Macheronte.
Come però nel dramma di Medusa, dell’eroe e dello specchio, la figura di Salomè va vista anche quale punto focale di una messa in scena più ampia. In altra sede già si è affrontato il tema delle strutture-tipo del protohorror: storie orride classiche, bibliche o devote che assai prima della nascita di un moderno genere horror offrivano emozioni simili (spesso paludate di pretesti moraleggianti) ad artisti e spettatori. Si trattava di teatri mitici consacrati da grandi numeri di narrazioni e raffigurazioni, veri e propri pacchetti sicuri per gli autori che vi ricorrevano: pensiamo alle tentazioni di sant’Antonio, con il loro esondare di demoni, oppure alla vicenda esemplare e alla fine misteriosa di Don Giovanni – o ancora, appunto, alla danza di Salomè. “Teatri” dove in scena non è solo quel particolare dramma – con connotati macabri in tal modo socialmente accettati a titillare tutto il titillabile, una vera e propria exploitation da salotto se non più da sacrestia – ma più in generale pulsioni e demoni di un’intera società. Se insomma Salomè, come Carmilla e le altre vergini funeste del romanticismo nero, è indubbiamente un mostro, si tratta dell’ennesimo mostro-fantasma che alligna in fantasie e rifrazioni di un io profondo individuale e collettivo. E infatti Dumas e il suo dotto complice Lacroix, che attingono a loro volta alla struttura-tipo, ne tornano a proporre la dialettica, sia pure in modo liberissimamente reinterpretato.
Erede dell’Olimpia hoffmanniana, delle danzatrici notturne e delle varie Spose Cadaveri, Arsène lascia emergere il profilo insieme spettrale e teratologico dell’Erodiade/Salomè confusamente traghettata dai Vangeli ad Heine. Nella prima descrizione offertane, Dumas spiega che «si indovinava nell’energia della danza e nella sicurezza del corpo la certezza di una completa bellezza e quell’ardente natura che, come quella di Messalina, può essere qualche volta stancata, ma appagata mai» (La donna, cit., p. 112): e, tanto più con quel tipo di similitudine, è evidente che le arrapatissime & arrapantissime Salomè di Moreau e di Wilde sono appena dietro l’angolo. Come nel caso di Salomè, la danza di Arsène ha qualcosa di fatale già a teatro, dove strega gli spettatori. E tanto più sconvolgente sarà il valzer di terrore e desiderio in cui coinvolge Hoffmann/Nathanael – traendo vampiricamente elasticità e forza dal suo desiderio, e da quell’oro da cui ella sembra restare dipendente anche dopo la morte.
 Ma se lo spazio di Salomé è occupato da Arsène, Hoffmann occupa come ovvio quello di Giovanni: un anti-Battista, veggente fragile e sensualmente coinvolto, nella Parigi delle carmagnole sfrenate a liberare pulsioni. Del resto al terzo capitolo de La donna, quando è ancora in Germania, lo vediamo incontrare il giovane Zacharias Werner (il futuro commediografo) che la madre un po’ squilibrata ritiene destinato a diventare il nuovo Cristo: una sorta di richiamo cifrato, attraverso la familiarità tra le madri e il rapporto di quasi parentela tra i ragazzi, a quello tra Gesù e il Battista. Per inciso, Zaccaria è il nome del padre del Battista; ma le condizioni psichiche delle due madri («sofferenti entrambe per disturbi nervosi che si conclusero con la follia», ivi, p. 45) e la stessa inversione dell’ordine legato al gioco di corrispondenze evangeliche (dove più vecchio è Giovanni, più giovane è Gesù, mentre qui il maggiore tra i due giovani è il primo, Zacharias, presunto “nuovo Cristo” e minore è il secondo, Hoffmann/Giovanni) già suggeriscono una provocatoria sovversione dei richiami. Per la conferma di una certa insistita disinvoltura di utilizzo, si veda del resto l’inizio del romanzo dove Dumas si rivolge idealmente a Marie Nodier, figlia del vecchio amico, con le parole: «Vi saluto Marie, piena di grazia, il mio spirito è con voi» (ivi, p. 5).
Ma se lo spazio di Salomé è occupato da Arsène, Hoffmann occupa come ovvio quello di Giovanni: un anti-Battista, veggente fragile e sensualmente coinvolto, nella Parigi delle carmagnole sfrenate a liberare pulsioni. Del resto al terzo capitolo de La donna, quando è ancora in Germania, lo vediamo incontrare il giovane Zacharias Werner (il futuro commediografo) che la madre un po’ squilibrata ritiene destinato a diventare il nuovo Cristo: una sorta di richiamo cifrato, attraverso la familiarità tra le madri e il rapporto di quasi parentela tra i ragazzi, a quello tra Gesù e il Battista. Per inciso, Zaccaria è il nome del padre del Battista; ma le condizioni psichiche delle due madri («sofferenti entrambe per disturbi nervosi che si conclusero con la follia», ivi, p. 45) e la stessa inversione dell’ordine legato al gioco di corrispondenze evangeliche (dove più vecchio è Giovanni, più giovane è Gesù, mentre qui il maggiore tra i due giovani è il primo, Zacharias, presunto “nuovo Cristo” e minore è il secondo, Hoffmann/Giovanni) già suggeriscono una provocatoria sovversione dei richiami. Per la conferma di una certa insistita disinvoltura di utilizzo, si veda del resto l’inizio del romanzo dove Dumas si rivolge idealmente a Marie Nodier, figlia del vecchio amico, con le parole: «Vi saluto Marie, piena di grazia, il mio spirito è con voi» (ivi, p. 5).
Ad Arsène/Salomè si affianca da un lato l’amante Danton/Erode, evocato di sfuggita in un impianto tutto sovvertito. Mentre lo spazio della partner “in carica” Erodiade (madre) finisce addirittura occupato dalla pia Antonia – simbolicamente apparentata ad Arsène attraverso (si è visto) le arti musicali. Antonia che però a sua volta, al capitolo quinto, avevamo visto fare la civetta – così Dumas – con il proprio padre, il musicista Murr (che si chiama come il gatto del romanzo satirico hoffmanniano, 1819-21): e «sapeva bene di avere sul vecchio un potere completo e nel cuore di lui un regno dove regnava sovrana» (ivi, p. 67). Anzi il vecchio, in seguito al rimprovero della figlia di occuparsi più della propria musica che di lei, si agita a improvvisare una sorta di balletto nella stanza: una scena grottesca alla Hoffmann ma anche la suggestione di una dilagante sindrome della danzatrice, che infetta anche il mondo della donna-angelo.
In apparenza Salomè è figura opposta alla Gorgone: alla femmina decapitata si contrappone la decapitatrice, erede di Giuditta e collega di Turandot. Eppure, in termini mitici, le figure dei due mostri-femmina (perché tali sono, nell’ottica del prodigio/monstrum d’orrore) finiscono col trovare robusti raccordi e sfumare l’una nell’altra: sia perché non mancano, come abbiamo visto, storie sulla decapitazione di Salomè; sia soprattutto perché a emergere sono elementi di un dramma cangiante, fusi e confusi in magmatico ribollire. La portatrice-della-testa-mozza sta ostentando idealmente la propria, icona livida che neutralizza e assoggetta i suoi voyeuristici adoratori maschi. Ed è significativo trovare tale con/fusione compiuta in un altro, citato personaggio di Dumas, Milady de I tre moschettieri: agente segreta come Giuditta la decapitatrice, muore come Medusa la decapitata. Quel che conta è l’icona della testa tagliata.
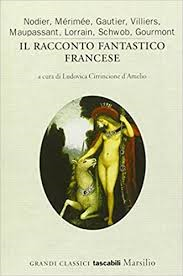 Capolavoro di originalità narrativa, la Femme rappresenta insieme un ideale precipitato dei motivi fantastici sviluppati lungo tutto l’Ottocento nella grande tradizione d’Oltralpe – fitta di donne fatali e sponsali di morte, viaggi che sprofondano il protagonista nell’Altrove o cercano invano di strapparvelo, indecidibili avventure tra patologia psichica e confini ultimi della realtà. Così a fronte dello statuto doppiamente non-morto dell’Arsène dumasiana (a voler fare solo qualche esempio suggerito dalla bella raccolta Il racconto fantastico francese, a cura di L. Cirrincione d’Amelio, Marsilio, Venezia 2005), la Venere di Ille di Prosper Mérimée (1837) è una statua dissepolta, Arria Marcella di Théophile Gautier (grande evocatore di seduttrici dall’equivoca consistenza – 1852) la polvere di un calco pompeiano, Vera di Villiers de l’Isle-Adam (1874) una morta inaccettata come tale, e la perturbante maschera di Jean Lorrain (Una di loro, 1900) il fascino di un’ombra dall’incerta sessualità: alcune venate d’inferno, altre ispiratrici di commozione, ma tutte capaci di protestare la resistenza dei sensi alle categorie di ragione e morale, conducendo il protagonista (sempre uomo) alla perplessità esistenziale e magari al precipizio psichico. Come d’altro canto gli eredi dell’Hoffmann della Femme, i turbati narratori di Maupassant e di Marcel Schwob (si pensi a L’uomo velato, 1891) non possono esorcizzare avversari impastati nelle pieghe della propria vita interiore; e l’esorcismo stesso, avverte con malinconia l’amico Nodier in Trilby (1822), rappresenta talora la sterilizzazione traumatica di una dimensione vitale.
Capolavoro di originalità narrativa, la Femme rappresenta insieme un ideale precipitato dei motivi fantastici sviluppati lungo tutto l’Ottocento nella grande tradizione d’Oltralpe – fitta di donne fatali e sponsali di morte, viaggi che sprofondano il protagonista nell’Altrove o cercano invano di strapparvelo, indecidibili avventure tra patologia psichica e confini ultimi della realtà. Così a fronte dello statuto doppiamente non-morto dell’Arsène dumasiana (a voler fare solo qualche esempio suggerito dalla bella raccolta Il racconto fantastico francese, a cura di L. Cirrincione d’Amelio, Marsilio, Venezia 2005), la Venere di Ille di Prosper Mérimée (1837) è una statua dissepolta, Arria Marcella di Théophile Gautier (grande evocatore di seduttrici dall’equivoca consistenza – 1852) la polvere di un calco pompeiano, Vera di Villiers de l’Isle-Adam (1874) una morta inaccettata come tale, e la perturbante maschera di Jean Lorrain (Una di loro, 1900) il fascino di un’ombra dall’incerta sessualità: alcune venate d’inferno, altre ispiratrici di commozione, ma tutte capaci di protestare la resistenza dei sensi alle categorie di ragione e morale, conducendo il protagonista (sempre uomo) alla perplessità esistenziale e magari al precipizio psichico. Come d’altro canto gli eredi dell’Hoffmann della Femme, i turbati narratori di Maupassant e di Marcel Schwob (si pensi a L’uomo velato, 1891) non possono esorcizzare avversari impastati nelle pieghe della propria vita interiore; e l’esorcismo stesso, avverte con malinconia l’amico Nodier in Trilby (1822), rappresenta talora la sterilizzazione traumatica di una dimensione vitale.
Spiazzante e magari pericoloso – sembra rispondere Dumas al capezzale di lui, dopo averne colto l’ultimo racconto – il fantastico è una chiave per decostruire lo storytelling offertoci e riconoscerne le strutture mitiche, con quanto di manipolatorio recano nell’immagine della società e di noi stessi: sia a fronte di maschere, reliquie ideologiche, stereotipi sessuali di tipo “antico” e che in fondo potremmo riconoscere, sia in direzione di ciò che per novità tende a sfuggire ai nostri paradigmi. Ma quella provocazione a percepire la sconcertante latitudine della realtà – perché c’è sempre qualcosa che va oltre – comporta anche una condivisione di meraviglia: una vitalità la cui forza di consolazione e di resistenza, al capezzale di Nodier come nei nostri brutti tempi, non pare poco nobile o facilmente rinunciabile.



