di Dziga Cacace
The Time Is Gone, the Song Is Over
Thought I’d Something More to Say
Time, Pink Floyd
 405 — Il pugnace Muhammad Ali the Greatest di William Klein, Francia 1974
405 — Il pugnace Muhammad Ali the Greatest di William Klein, Francia 1974
Quando ero bambino mia madre era iscritta al Club degli Editori. Non era stata una scelta granché consapevole: aveva preso tre titoli e poi aveva accettato di rimanere iscritta. O aveva dimenticato di recedere, una di quelle cose così. E ogni mese riceveva un titolo che poteva poi rifiutare. E che puntualmente rimaneva in casa.
Tra i vari titoli entrati in libreria grazie a questa modalità dove il libero arbitrio non contava più nulla e prevaleva assolutamente il caso, c’era anche Il più grande, l’umile biografia di Muhammad Ali (come da intestazione del tomo) che lessi in prima liceo per darmi un tono e che trovai fantastica. A differenza di mia madre, che penso non ne abbia letto neanche una pagina.
Da allora, io, mingherlino e con due pettorali da polletto bronchitico, ho vissuto nel mito di Alì, Cassius Clay che rifiuta il nome da schiavo e si emancipa religiosamente, politicamente e trova pure il tempo di fare una faccia di pugni così a diversi avversari. Ed è per questo che quando Pier Paolo chiama, al pomeriggio, rispondo subito sì, senza tentennamenti: allo Spazio Oberdan c’è un film che il fotografo William Klein ha dedicato al campione, quello più grande, di tutti. E noi ci andiamo, oh yeah, senza aver fatto due calcoli.
Perché il film è in originale, senza sottotitoli e dalla difficoltosa comprensione, e siccome la proiezione è gratuita, l’Oberdan è il ricettacolo di una orrenda messe di teste di cazzo. Sfaccendati oziosi come noi, studenti butterati che si danno delle arie, pensionati rimbambiti alla ricerca di un po’ di fresco: un mix atroce.
E Pier e io, in mezzo. Accerchiati.
Tutti parlano diffusamente, commentando ad alta voce, tentando improbabili traduzioni, sottolineando inoltre con risate sguaiate e teatrali la presunta partecipazione e comprensione del film. Poi, essendo il film proiettato tra le 19 e le 21, parecchi cenano in sala ed è una sinfonia di crepitanti pacchetti di carta e plastica, di boli giganteschi masticati ansimando, di patatine fatte crocchiare con voluttà a bocca aperta e di sorsate da mezzo litro con cannuccia, che danno l’effetto sonoro del lavandino stappato. Insomma: un dramma. Dietro di noi ci sono due signore che dicono almeno venti volte che “la boxe è uno sport orrendo” e “crudele”. A un certo punto sbrocco e ad alta voce chiedo a Pier Paolo: “ma se gli offro un cinema, secondo te ‘ste befane si levano dai coglioni?”. Le due rimangono silenti (e offese, perché sono stato gratuitamente maschilista, tanto per cambiare) per cinque minuti. Poi ricominciano la litania sullo sport sanguinario con rinnovata verve, rinfrancate dalla pausa imposta dalla mia sclerata.
Davanti invece abbiamo una coppia di studenti, con una lei che — giuro — ha parlato per due ore di fila; ti chiedo: ma cosa cazzo vieni al cinema a fare? Per stroncarla sul nascere, provo a zittirla sui titoli di testa. Mi guarda come se le avessi sputato nella schiena, si gira offesa e dopo due minuti riprende a parlare. A un certo punto (ero fuori dalla grazia di Dio, credo si sia capito) urlo: “50.000 lire, deve costare il biglietto!”, facendo la figura del vecchio classista intollerante che non s’è neppure reso conto del passaggio all’euro.
Silenzio agghiacciato in sala.
Dieci secondi e ricominciano tutti a parlare. Ce lo meritiamo Berlusconi, porca eva.
Il film dura due ore e presenta molti alti e bassi. Si parte in maniera geniale: le immagini (montate con concitazione) del primo match con Liston, nel 1964. Fotografia mossa e sporca, tagli improvvisi, flash bianchi e una colonna sonora composta dall’audio ambiente, da un rhythm and blues pulsante e dal suono impazzito di una locomotiva in corsa. Splendido. A questa intuizione audiovisiva, però, seguono poche altre cose veramente degna di nota. Per esempio la presentazione del team che gestiva l’allora Cassius Clay, in un bianco e nero contrastatissimo. Oppure è clamorosa la scena in cui s’indagano gli spogliatoi coi pugili che avrebbero preceduto Alì prima di una rivincita con Liston, scena dove con poche inquadrature si dice tutta la fatica del pugilato. Il resto (interviste a intellettuali, politici, vari momenti di allenamento del pugile etc.) è interessante e se non c’è un’intuizione fotografica perde valore al confronto con quel capolavoro che è Quando eravamo re. In ogni caso Alì era un genio della comunicazione e a parole non era meno veloce che sul ring. Quando parla compone un rap incazzatissimo, politico, satirico, comico: c’è tutta la voglia di rivendicare la propria forza, bellezza e intelligenza in faccia alla nazione bianca che tratta i pugili come galli da combattimento. Ma questo lo sapevamo e ne abbiamo avuto ancora una volta conferma. Film discreto, pubblico di merda. (Spazio Oberdan, Milano; 22/7/03)
 406 — L’amabilmente frivolo Sex and the City — Season 2 di AA.VV., USA 1999
406 — L’amabilmente frivolo Sex and the City — Season 2 di AA.VV., USA 1999
Ci concediamo una settimana di ozio da papponi in un villaggio a Kemer, in Turchia, rintracciato da Barbara e spendendo, come al solito, una miseria (ha come delle capacità rabdomantiche, la regazzina: trova le offerte su Televideo, lei!). Siamo in mezzo a francesi, inglesi, israeliani, libanesi e italiani e l’esperienza è ancora una volta umiliante. Gli altri, ricchi o poveri, belli o brutti, grassi o magri, maschi o femmine, laureati o caproni, al ristorante fanno la coda, gli italiani la affiancano. Su tutti prevale solitamente un ipercafone butterato, un caso antropologico che apocopa le parole alla prima sillaba e riesce ogni volta a superare tutti, senza che nessuno abbia la forza di reagire. E io mi vergogno. Quando non mi vergogno leggo Ellroy, tiro con l’arco da far schifo, partecipo al torneo di tennis e piglio un’epocale randellata da un tredicenne grasso, evito di fare bagni, dormo, mangio. Una sera capitiamo a un tavolo con quattro stronze italo-libanesi che hanno alle dita gioielli da rimettere in piedi l’economia del Burundi e mi devo trattenere dall’esporre il mio programma politico nazimaoista grazie al quale le priverei di diritti civili condannandole a un carcere iraniano.
Forse sono un po’ troppo teso, ultimamente. E non mi aiuta vedere al ritorno in Italia un blob antologico che mi mostra cosa mi son perso: Fiamma Nirenstein che accusa chiunque di antisemitismo e che forse avrebbe bisogno di una camicia di forza o il ministro Castelli che si pronuncia sulla grazia a Sofri. Un po’, quanto a competenza, come se la Arcuri decidesse gli Oscar. E poi, si può essere ministri della Repubblica e presentarsi con la camicia a maniche corte e la cravatta verde? Ma dove siamo, al circo Togni? Vabbeh: mi danno un po’ di serenità solo il matrimonio del vecchio Pitta a Bormio, dove rivedo i miei compagni di liceo e do una mazzata al mio colesterolo, e una serie tivù scacciapensieri, la seconda di Sex and the City.
Carrie Broadshaw è in crisi (la sua storia d’amore con Mr. Big si è conclusa all’ultima puntata della precedente stagione): si ritrova con le sue amiche a fare i conti con questo status di single, non si sa quanto voluto o sopportato. Carrie, Charlotte, Samantha e Miranda sono belle, intelligenti, liberate e libere. Ma tant’è, qualcosa manca sempre. Questa fase d’incertezza si consuma tra nuovi incontri e noi con loro continueremo a conoscere uomini dolcissimi o maleducati, porci o ipodotati (fisicamente e mentalmente), troppo ciarlieri a letto e fuori, vigliacchi, romantici, incorreggibili. Sicuramente insostituibili, ma con il sano beneficio del dubbio. Sex and the City è la voce orgogliosa della moderna donna borghese americana che ha diritto alla sua sessualità (sboccata, tanto quanto gli uomini) ma con l’intelligenza che agli uomini manca. La Season 2 è probabilmente meglio della prima, con più episodi — da dodici a diciotto, e sensibilmente più lunghi — e meno voglia di fare sensazione (per linguaggio e argomenti). Semmai c’è la ricerca del sentimento che si risolve più in “racconti”, piuttosto che “inchieste”. Nella prima serie lo spunto narrativo era sempre dato dalla rubrica di Carrie, adesso più dalle vicende personali delle quattro amiche e gli articoli vanno di conseguenza. I personaggi del resto sono molto affinati e credibili e il Dvd ci consente una appagante versione originale col cast che risplende per capacità interpretativa (e quando ci capita di sentire la versione doppiata, sembra che il copione venga letto). Mettiamoci regie sempre argute, montaggi inventivi e musiche azzeccate e che è pure girato in pellicola, cosa vogliamo di più? Però: perché in queste recensioni Sex and the City sí e Band of Brothers o Friends no? Boh, è andata così. Ma Band of Brothers è stato quasi un capolavoro, mentre Friends sta morendo, pace all’anima sua. (Dvd; 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12/8/03)
 407 — Il razzista La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek, Italia 2003
407 — Il razzista La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek, Italia 2003
In questa estate di piccoli trasferimenti, con Barbara che studia per l’esame da avvocato e io che cazzeggio amabilmente, finiamo per una settimana sul lago Maggiore, a Brisino. Per arrivarci giusto un’ora di macchina. Io rispetto il limite di 130 km orari e supero se va bene 4 utilitarie e un tir sfiatato. Sono invece superato a mia volta e di gran carriera da 65 autovetture, generalmente molto grosse, per l’80% tedesche. Se vietiamo l’acquisto di macchine dai crucchi capace che il numero di morti sulle autostrade crolla, vuoi vedere? Vabbeh, dovrei rilassarmi, ma l’unico cinema aperto ad agosto da Arona fino a Locarno si trova a Intra, il signorile Vip dove in passato abbiamo già visto alcune cose tremende. Tutti le altre sale sono chiuse o per ferie o per lavori, il che, in una località che ritengo turistica, è straordinario. Ad ogni modo ecco il solo spettacolo che ci viene offerto, il pluripremiato film di Ozpetek, amato da pubblico e critica. Siccome lo avevamo scientemente lasciato perdere raccontandoci la palla che avremmo potuto vederlo quest’estate, ci tocca, anche perché non possiamo vedere solo episodi di Sex and the City. E com’è ‘sto film, eh? Com’è? Beh, carino, diciamo. Curato, precisino, pulito. Non so, mi lascia un po’ interdetto perché vedo vaccatine che Ozpetek potrebbe evitare (alcuni personaggi caricaturali, la tendenza a scivolare nel lezioso) accanto a cose che invece denotano una sensibilità.
La finestra di fronte ha suscitato più entusiasmi di quelli meritati e dovrebbe essere il modello del cinema medio italiano (mentre è assurto a esempio di cinema alto). La storia è edificante, c’è il “messaggio”, ci sono gli attori e una regia. Cosa voglio di più, allora? È che mi sembra un film compiacente: la trama non ha asperità. Sono tutti buoni, adorabili, intelligenti… e anche monodimensionali, senza ambiguità. E questo non in nome di un’epica (cosa che mi fa digerire qualunque personaggio dalla psicologia nulla), anzi. E se vogliamo, questa poetica degli umili, della working class (finalmente dei personaggi che fanno mestieri normali, che si rompono il culo senza trastullarsi da copy e compagnia bella) è uno dei dati migliori del film. Ma andiamo con ordine, dài: Giovanna vive con Filippo. Sono in crisi, ma si tira avanti per i figli. Un giorno raccattano per strada un anziano (Massimo Girotti) che ha perso la via di casa e la memoria. All’inizio la presenza è ingombrante, poi Giovanna — assieme all’aiuto di un vicino di casa di cui è invaghita — scopre il passato del personaggio e gli si affeziona, apprendendone anche una lezione di vita. Il vicino è lo scultoreo Raoul Bova, diretto da non far danno. Lo spunto narrativo è ben gestito, è andando avanti che la vicenda mi gira meno bene. C’è mistero, c’è un colpo di scena, c’è affetto (questo, Ozpetek lo mette sempre: si veda l’inquadratura finale che è un atto d’amore) e c’è attenzione alla memoria (guai a perderla, in tutti i sensi). Girotti è Girotti e la Mezzogiorno non urla.
Però non so, questo film non ha la scintilla per conquistarmi del tutto. Intendiamoci, m’è quasi piaciuto, m’è passato, ma… lo dico? Lo dico! È un cazzo di film razzista, questo: non è possibile che per Ozpetek gli omosessuali siano sempre delle creature angeliche che insegnano qualcosa agli eterosessuali, invece tonti e spesso cattivi. E no! Siamo tutti uguali, caro Ferzan, anche gli omosessuali sono stronzi, falsi, stupidi, viscidi etc., se no non si uscirà mai dal ghetto, eccheccazzo. Okay, l’ho detta. Adesso, aspetto commenti intelligenti da amici gay. Ma vanno bene anche quelli stupidi, anzi.
Passando ad altro: escono grandi articoli perché — a conti fatti — per il cinema italiano è stata un’annata positiva. Ovviamente solo più dell’anno scorso, non secondo un trend particolare verificato nel tempo, ma gli analisti che si lanciano in queste disamine sono giornalisti ignoranti e sensazionalisti e non notano che quest’anno s’è fatto il risultato grazie a Vacanze sul Nilo, alla compresenza dei blockbuster di Benigni e Aldo, Giovanni e Giacomo (che hanno incassato comunque meno del previsto) e al discreto successo di nicchia di Ozpetek, Muccino e Salvatores. Più o meno la stessa formazione di tre anni fa, quando ci si era gonfiato il petto e Veltroni aveva straparlato di rivincita del cinema italiano, di ripresa, di riscossa (e chissà perché quando bisogna gonfiarsi il petto i Vanzina non fanno mai schifo, eh?). L’anno prossimo su chi dobbiamo fare affidamento? Scommettiamo che — in mancanza dei comici che hanno già dato quest’anno — si griderà di nuovo alla crisi?
E poi, un’altra cosa: queste statistiche imbecilli sono sempre corredate dalla classifica per nazioni, puntando il dito contro lo strapotere americano. Il problema non è troppi film americani, bensì troppi brutti film americani! I film italiani o europei, se sono buoni, la loro strada la trovano; al posto di magnificarli freddamente sui quotidiani, bisogna ribellarsi all’ennesimo e inutile Matrix o alle stronzate tipo Charlie’s Angels. Oppure alle chiaviche che escono nella stagione estiva, gli horror deprezzati e le commedia demenziali. È lì che dobbiamo incazzarci di brutto coi nostri distributori e con la stampa prezzolata. Ma io non posso alterarmi anche per il cinema: oggi ho ascoltato la rassegna stampa su Radio Padania Libera. Non so se tale Giulio Carnelli sia un giornalista professionista o un volenteroso collaboratore. Però non capisce ciò che legge (e lo legge a fatica, giuro, compitando le parole una a una) e gestisce un programma che sembra la parodia di un notiziario nordcoreano (qualunque commento politico contrario alla Lega è un insulto, fango, propaganda etc.). Questa tribù di coglioni governa e detta legge col 6% dei voti su scala nazionale. L’errore è la democrazia, comincio a pensare. (Cinema VIP, Intra; 8/8/03)
408 — La visione irritata di Io non ho paura di Gabriele Salvatores, Italia 2003
Altra meta dell’estate nomade: Champoluc in val d’Ayas, il mio regno da ventenne, ormai invaso da giovani schifosamente giovani. Barbara studia, io gioco a tennis, leggo, scribacchio, faccio cose. E oggi ne ho fatta una memorabile: alle 11 del mattino mi sono incamminato verso Mascognaz (45 minuti di camminata) con la ferma intenzione di conquistare poi il lago Perrin (2700 metri s.l.m.) in ardimentosa solitaria su un sentiero inusuale che non è segnato e senza alcun Bonatti o sherpa di supporto. Verso le 13 perdo la traccia e attacco un alpeggio ripidissimo, cosa che comporta un ritardo micidiale, una fatica sovrumana e un giramento di balle non indifferente. In più ho ceffato la musica in cuffia: i Grateful Dead non comunicano alcun impeto agonistico, semmai una psichedelica letargia. Poi ho sbagliato le mutande: indosso degli slip Fila con dei bordi taglienti come filo spinato. Alle 14 ritrovo il sentiero, mangio disperato un panino sotto un abete per ripararmi da qualche goccia di pioggia e riprendo la mia Via Crucis, stavolta coi Deep Purple che pompano nelle orecchie, scelta che mi dà una certa carica pedatoria. Arrivo al lago con la forza della disperazione, completamente scoglionato. Ovviamente non c’è nessuno e non ho alcuna soddisfazione ad aver raggiunto questa landa lunare sotto un cielo color piombo, ben lontana dal dolce ricordo dell’infanzia. I laghi Pinter sono a un’ora di distanza e mi dico, da vero fesso: adesso o mai più, perché attraverso queste distese desolate chissà quando ripasserò. M’incammino e la siccità ha ridotto i laghi a tre stagni fangosi. Verso le 17 comincio la discesa a valle avvertendo una vaga irritazione in zona inguinale e faccio a tempo a prendere l’ultima ovovia verso il paese, distrutto (io distrutto; ma anche Champoluc, grazie a certi piani regolatori… ma è un’altra storia). A casa scopro che ho le caviglie con delle bolle degne delle piaghe d’Egitto. L’inguine, in compenso, è color indaco per lo sfregamento e brucia come un tizzone: sono costretto a camminare a gambe larghe come Takeshi Kitano.
È con queste premesse che vado a vedere l’ultimo film di Salvatores, autore che in fondo m’è sempre stato simpatico. Stavolta si cimenta con un testo che sembra scritto appositamente per lo schermo, un racconto lungo di Ammaniti, intenso e intelligente. Il film fotografa in pieno le sensazioni del libro: l’angoscia dei bambini che scoprono il (tremendo) mondo dei grandi. La necessità di trasfigurare in fiaba la realtà, l’orrore quotidiano dell’egoismo e della cattiveria, la crudeltà innocente dei giochi, la bellezza imponente e minacciosa del paesaggio. Girato vicino a Melfi, tra fiaba horror e racconto di crescita, Io non ho paura funziona bene quanto funzionava bene il libro da cui è tratto, anche grazie ai bravi attori (bambini e adulti). Dino Abbrescia convince, come Diego Abatantuono che non abusa del consueto birignao. Gli altri sono tutti ben diretti e hanno facce che non si scordano. Belle musiche, ottima scansione del racconto (con alcune intelligenti aggiunte sul testo base), fotografia ai limiti del calligrafico: insomma, buon film. La sala minuscola di Champoluc, in cui non facevo ritorno da più di dieci anni, è abbastanza piena; fa un caldo fottuto e la proiezione è così cosà.
Ah: apprendo da Film TV che Pino Farinotti è diventato il critico cinematografico di Uno Mattina Estate. Penso che quadri tutto, infatti Farinotti pubblica un supposto dizionario, un elenco di film che correda di trama esilissima e compendia con un giudizio a stellette, senza recensione: il minimo storico dello sbattimento. Questo signore ritiene Fino alla fine del mondo un capolavoro e si vanta di aver dato all’immondo Fratello, dove sei? il massimo dei voti. Fa parte della Commissione cinema ed è forse anche grazie a lui se Fame chimica è stata girato con un budget da fame.
Io vorrei tranquillizzarmi, però. E allora accendo il televisore per spegnere il cervello. E sento che il ministro (ripeto: ministro) Giovanardi si dichiara favorevole al ritorno del nucleare e annuncia che ogni Regione si doterà di un deposito per lo stoccaggio delle scorie. Poi il ministro (ripeto: ministro) Gasparri, di fronte allo sconcerto di Al Jazeera nel vedere il governo italiano occuparsi di calcio (mettendo in fila una teoria di cazzate che non ha eguali — il governo, non Al Jazeera), riesce a commentare pubblicamente così: “Se Gheddafi figlio diventerà qualcuno sarà grazie al nostro calcio; invece Gheddafi padre passerà alla storia per essere stato il mandante dell’attentato di Lockerbie”. Sfugge ogni logica. Infine il presidente del consiglio (ripeto: presidente del consiglio) evita educatamente all’ultimo minuto l’incontro di gala all’Arena di Verona con Prodi e Schroeder (motivo ufficiale: non voleva rovinare la rappresentazione della Carmen coi fischi dell’opposizione “antidemocratica e illiberale”). Ma perché poi uno va al cinema?
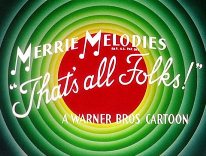 Vabbeh: rilassati, dài! Giusto, e sai che faccio io? Conto! Conto i film e produco le utilissime statistiche di fine stagione. Quest’anno ho recensito soltanto 90 film (178 due anni fa, 140 l’anno scorso: il trend è negativo! Meno 34%!). Di questi, 35 li ho visti al cinema (un buon 39%, meglio dell’anno scorso quando m’ero fermato al 26%); in Vhs ho visto 32 film (il 35 %), registrati per lo più da Tele+ (15, il 47%) e da RaiTre (8, il 25%).
Vabbeh: rilassati, dài! Giusto, e sai che faccio io? Conto! Conto i film e produco le utilissime statistiche di fine stagione. Quest’anno ho recensito soltanto 90 film (178 due anni fa, 140 l’anno scorso: il trend è negativo! Meno 34%!). Di questi, 35 li ho visti al cinema (un buon 39%, meglio dell’anno scorso quando m’ero fermato al 26%); in Vhs ho visto 32 film (il 35 %), registrati per lo più da Tele+ (15, il 47%) e da RaiTre (8, il 25%).
Grande balzo in avanti del Dvd (17 visioni, pari al 19% del totale). Passando alle nazionalità, strapotere di Hollywood con 49 film (il 54%); segue l’Italietta con 18 titoli (il 20%) e poi la Francia (8 film, il 9%). Le altre nazioni non hanno rilevanza statistica. Analizzando i dati risulta evidente che rispetto all’anno passato non ho visto meno film al cinema (35 contro 36), ma ho quasi abbandonato le Vhs (l’anno scorso erano quasi il 60%). Il dato fa pensare, eh? Forse troppa tivù? Fatta o vista?
In effetti tra Blu Notte di Lucarelli, Report, Correva l’anno, Sfide, Passepartout, Le Iene, Mai dire Domenica e Mai dire Grande Fratello, Band of Brothers, Friends, Montalbano e l’occasionale puntata imposta da Barbara di quella fetenzia fascistoide di C.S.I., tempo per il cinema ne rimaneva poco. Eh, i problemi dell’uomo moderno. (Cinema Sant’Anna, Champoluc; 21/8/03)
Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni
(Fine — 39)



