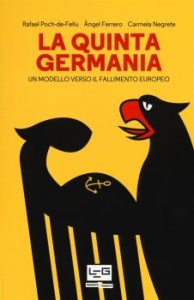di Alessandro Barile
Rafael Poch-de-Feliu, Angel Ferrero, Carmela Negrete, La quinta Germania, Leg edizioni, Gorizia 2017, pp. 244, € 22,00.
A una lettura disattenta dei particolari, questo libro edito nel 2013 in Spagna e nel 2017 in Italia – in una versione aggiornata – potrebbe apparire poca cosa. Interessante quanto retorico, andrebbe a sommarsi alla ormai vasta letteratura sulla crisi dell’europeismo. Il diavolo, notoriamente, risiede però nei dettagli. Alcune specifiche rendono questo libro prezioso: in primo luogo, gli autori sono spagnoli e scrivono per il pubblico spagnolo; in secondo luogo, il loro punto di vista non è il solito “sovranismo” – di destra o di sinistra – entro cui vengono ricondotte le posizioni critiche rispetto al processo europeista e al capitalismo tedesco, quanto un eclettico “sinistrismo” liberale. Due caratteristiche notevoli, che gettano uno sguardo obliquo sulle sorti continentali e che contribuiscono ad affinare gli strumenti della critica all’attuale modello di sviluppo euro-liberista.
La «quinta Germania» nasce dalla riunificazione nazionale del 1990, con l’annessione della DDR da parte della Germania ovest. Sul tema, rimandiamo al fondamentale Anschluss di Vladimiro Giacchè. Il recupero di sovranità territoriale e potenza economica ha trasformato l’intero processo di unificazione economica europeista. Come spiega Poch-de-Feliu nell’introduzione, «la principale novità che questa quinta Germania esibisce rispetto a quella precedente si compone di due elementi. Il primo è costituito dal suo ritorno, graduale ma deciso, a un interventismo militare»: Balcani, Afghanistan, Africa, Ucraina, Lituania, sono solo alcuni dei fronti che vedono una notevole presenza dell’esercito tedesco; «l’altro elemento è costituito da una leadership europea, dogmatica e arrogante, utilizzata come uno strumento per imporre il programma di involuzione neoliberale promosso dagli anni Settanta da parte del mondo anglosassone». La riunificazione tedesca ha prodotto un terremoto economico che ha avuto inevitabili riflessi politici: da una parte, l’economia tedesca è troppo grande rispetto ai suoi partner comunitari (25% più grande della seconda economia, quella francese); dall’altra, è troppo piccola per dominare in via esclusiva il contesto europeo (il Pil tedesco è tra il 20 e il 25% del Pil della Ue). Il risultato è «un paese troppo potente per essere un paese europeo come gli altri, ma troppo debole per pretendere di ripetere un nuovo tentativo di dominio continentale». Di qui, l’esigenza di sfruttare l’Unione europea come moltiplicatore di scala, a scapito però dei suoi partner nazionali e dei lavoratori europei (compresi, come vedremo, i suoi stessi cittadini).
La percezione comune del paesaggio economico europeo è quella di uno Stato ricco con cittadini benestanti (la Germania), che ha saputo resistere meglio di altri alla crisi economica, integrato in una pletora di altri Stati poveri o impoveriti dalla crisi. La realtà è però decisamente diversa, come spiega egregiamente questo libro, in tal senso solo l’ultimo di una serie di lavori che svelano le tare del mercato del lavoro tedesco (rimandiamo al recente Ricca Germania poveri tedeschi. Il lato oscuro del benessere, di Patricia Szarvas).
«L’economia tedesca, “il motore d’Europa”, è un motore che ha bisogno di venire alimentato costantemente con una manodopera a basso costo, che subisce condizioni lavorative sempre peggiori. Nel 2012, in Germania abbiamo assistito alla massima percentuale storica di occupazione dai tempi della riunificazione». Nel vortice della più deflagrante crisi economica dell’Occidente, in Germania si raggiungeva sostanzialmente la “piena occupazione”. Le narrazioni statistiche velano una realtà materiale alquanto differente: dal 2000 ad oggi il monte ore complessivo lavorato in Germania è rimasto identico: 58 miliardi di ore (Mauro Meggiolaro, «Il fatto quotidiano», 3 dicembre 2014). I due milioni di lavoratori in più creati nel frattempo sono il risultato di un impoverimento complessivo del mercato del lavoro: «in molti casi un posto di lavoro a tempo pieno del 2000 si è trasformato in tre mini-job o in due part-time. Ci sono più occupati ma sono occupati per meno ore, meno soldi e con minori garanzie» (Cit. Meggiolaro). In Germania circa il 25% dell’intera manodopera lavorativa, circa 9 milioni di persone, è “contrattualizzata” (le virgolette sono d’obbligo) attraverso i mini-jobs, i tirocini (praktikum), e finte partite iva, cioè lavoro autonomo alle dipendenze materiali di un solo cliente (fatto questo illegale, in Germania come in Italia). Senza contare il lavoro nero, visto che per migranti e cittadini stranieri anche europei, le garanzie dello Stato sociale, necessarie ad accedere a disoccupazione e mini-jobs, non sono (più) previste. Il risultato è quello per cui «la Germania ha smesso d’essere uno dei paesi con i salari più elevati del mondo, per diventare il campione europeo dei salari bassi». I salari reali tedeschi sono infatti costantemente diminuiti in questo decennio, a fronte di un aumento dei profitti dell’11,8%: «un tedesco su quattro guadagna meno di cinque euro all’ora. Secondo l’Ocse, in Germania un bambino ogni sei vive in relativa povertà (mentre in Olanda si tratta invece di un bambino ogni 37)». La decennale stagnazione salariale ha determinato la nota crisi della domanda interna, che non ha solo impoverito i lavoratori tedeschi, ma aumentato a dismisura le disuguaglianze di reddito avvicinando la sperequazione tedesca a quella degli Usa, una delle più elevate al mondo.
La traiettoria sociale così delineata ha portato alla formazione di un mercato del lavoro duale, che prevede una quota – sempre più esigua – di lavoratori super-garantiti, sindacalizzati e dagli alti salari, alle dirette dipendenze delle aziende madri, a fronte di una percentuale sempre crescente di lavoratori senza alcuna garanzia né salariale, né contrattuale, né sociale, alle dipendenze di aziende in subappalto che però lavorano in esclusiva per le suddette grandi aziende (processo di esternalizzazione che ha creato un’aristocrazia sempre meno operaia e una massa proletarizzata). Il problema è che la valorizzazione del capitale privato tedesco avviene esattamente grazie a questo 25% di lavoratori precarizzati su cui viene caricato il costo della competitività delle aziende tedesche. E’ infatti nei settori decisivi per il surplus tedesco che avviene l’uso smodato della “de-contrattualizzazione” e della moderazione salariale: auto e grande industria.
Perché allora la Germania sarebbe “uscita meglio” dalla crisi economica? «A partire dall’introduzione della moneta europea, l’industria tedesca più che raddoppiò le sue esportazioni (che a inizio degli anni Novanta rappresentavano il 20% del suo Prodotto Nazionale Lordo e nel 2010 il 46%)». E’ l’export che ha retto le sorti produttive della Germania, un export fondato sugli elevati livelli di competitività dati dalle riforme Hartz dei primi anni Duemila e che hanno “cinesizzato” il mercato del lavoro tedesco, desertificando la produzione industriale degli altri partner europei con cui condivide una moneta unica che mantiene ultra-competitivo il tenore degli scambi commerciali con l’estero.
I contributi presenti nel libro entrano nel cuore di questa contraddizione originaria, ma il quadro è ormai chiaro: per come sono impostate le relazioni politico-economiche europee a egemonia tedesca, «ci troviamo di fronte a una situazione senza via d’uscita, nella quale ogni serio tentativo di eliminare ciò che sta distruggendo l’Unione europea passerebbe per la negazione dell’intero sistema attuale». La soluzione proposta è «un processo ordinato di decostruzione dell’Unione europea, una soluzione più efficace per uscire dal pantano rispetto al motto “più Europa” e al federalismo autoritario. […] Il primo passo è desacralizzare l’Unione europea, farla scendere dall’altare e collocarla alla portata di una critica realista».
Perché queste conclusioni, ormai accettate e condivise da una parte del dibattito politico italiano, costituiscono uno scarto interessante rispetto a questo stesso dibattito? Come detto in apertura, le posizioni di partenza dei tre autori del presente libro non sono ovviamente di destra, ma neanche “comuniste”: tutta la prima parte del libro racchiude un duro attacco al sistema autoritario sovietico e tedesco orientale. Sono al contrario espressioni di una sinistra liberale, una sinistra che però in Italia (e sempre più “solo” in Italia) è ancora protagonista della difesa a spada tratta dell’europeismo, dell’Unione europea come unico modello di relazioni politico-economiche. Altrove, segnatamente in Spagna, l’insofferenza per l’euro-liberismo a trazione tedesca sembrerebbe essersi introdotta nelle pieghe dei ragionamenti meno “compromessi” con le posizioni ideologiche più radicali. Un libro del genere difficilmente troverebbe pubblicazione in Italia, perché ne mancherebbero gli autori. Questo libro dimostra che la critica al liberismo europeista, una critica che assuma il dato di realtà dell’irriformabilità della Ue, può tracimare dai confini del radicalismo entro cui viene forzatamente ricondotta, per farsi discorso scientifico. In Italia, evidentemente, siamo ancora lontani da un risultato simile.