di Cristina Morini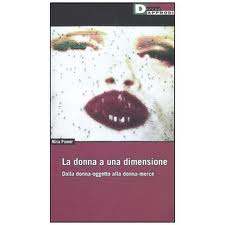
a proposito di: Nina Power, La donna a una dimensione. Dalla donna-oggetto alla donna-merce, DeriveApprodi, Roma 2011, pp. 96, € 11.00 [qui la prefazione all’edizione italiana]
Far nuovamente detonare la radicalità del pensiero e dell’agire delle donne è un compito arduo. Il femminismo ha segnato diverse generazioni in modo vivace e vitale. Ma adesso? Ha perso la forza rivoluzionaria delle origini? Di certo non gli è stato risparmiato lo strazio che è capitato ad altri ambiti (dal sindacato ai partiti politici fino ai movimenti). Il periodo attuale, con una povertà imbarazzante di argomenti ma con profonda e sottile violenza, non fa che alimentare la spirale del silenzio attraverso il potere di persuasione e di repressione dei propri complessi dispositivi di comando. Precarietà, pubblicità, giornali, televisioni, opinionisti, mercati finanziari (ed entità “metafisiche” correlate): tutto è predisposto per omologare e comprare, incanalando verso un solco prestabilito ogni dinamica conflittuale, ogni pulsione dell’anima, piegandone il verso nel senso della compatibilità, della razionalità, della misurabilità, della “normalità”. Tuttavia l’essere umano – la donna come l’uomo – non può mai avere una sola dimensione. C’è sempre un che d’insopprimibile, qualcosa che manca nel conto, che sfugge, fortunosamente, a ogni previsione.
Il libro di Nina Power, La donna a una dimensione ci dice questo in sole, densissime, 90 pagine e noi facciamo sfacciatamente il tifo per lei. Tradotto recentemente in Italia dopo la sua pubblicazione in Gran Bretagna nel 2009 [One Dimensional Woman, Zero Books], è un libro per il nuovo femminismo, fuori da ogni retorica, fuori da ogni tentazione nostalgica e identitaria. Guarda con acuto e a tratti – per chi legge – doloroso disincanto ai processi di manipolazione a cui le donne sono oggi sottoposte. L’ironia tagliente a cui l’autrice ricorre non è solo un tratto dello stile ma una probabile soluzione per prendere distanza dai nuovi mostri che ci assediano (finanza e protesi, pratica del cutting e “masturbazione come precondizione alla shopping”). L’emarginazione che le donne hanno conosciuto per secoli è stata sostituita con un’integrazione pagata al prezzo di una amara spogliazione di se stesse, deprivazione del corpo-mente attraverso l’imperativo del godimento imposto o dell’auto-oggettivazione egotica delle proprie attrattive sessuali (le tette, parti anatomiche animate da una vita loro propria “diversa da quella della proprietaria”). Uno scenario nel quale le donne devono assumere un “Io” positivo e performante, quasi fosse anch’esso un prodotto, un oggetto di consumo che si acquista senza fatica in un centro commerciale e non una concezione del sé, sfondo di pulsioni ignote, imperscrutabili, infinite. Questo femminile “estroflesso”, addomesticato, cordiale, deciso, megalomane ma disposto alla cooperazione, diventa utile al capitale per tradurre il versante umano (quella che si direbbe l’anima premoderna) nel senso della sua redditività.
Regime di viseità
 Diciamo subito quello che non troverete tra queste pagine: il libro non si sofferma sulla differenza tra movimento delle donne, lotte militanti e femminismo. Personalmente, non vedo la possibilità di operare una tale classificazione. Il femminismo è soprattutto un discorso, un discorso che ha cambiato la collocazione delle donne nello spazio-tempo della storia dell’uomo. Nina Power [a sinistra] non solo sta perfettamente all’interno di questo discorso ma sa soprattutto continuarlo, guardando oltre il “già detto”. Prova a spingere l’analisi a partire dalla lettura storicamente dominante ora, ovvero a partire da quella costruzione di una “retorica” favorevole alle donne che è il guscio vuoto che resta quando al discorso femminista viene sottratta la sostanza, ovvero ogni idea fondante di cambiamento (culturale, economico e sociale) del mondo, a partire da analisi strutturali, a partire dalla rabbia.
Diciamo subito quello che non troverete tra queste pagine: il libro non si sofferma sulla differenza tra movimento delle donne, lotte militanti e femminismo. Personalmente, non vedo la possibilità di operare una tale classificazione. Il femminismo è soprattutto un discorso, un discorso che ha cambiato la collocazione delle donne nello spazio-tempo della storia dell’uomo. Nina Power [a sinistra] non solo sta perfettamente all’interno di questo discorso ma sa soprattutto continuarlo, guardando oltre il “già detto”. Prova a spingere l’analisi a partire dalla lettura storicamente dominante ora, ovvero a partire da quella costruzione di una “retorica” favorevole alle donne che è il guscio vuoto che resta quando al discorso femminista viene sottratta la sostanza, ovvero ogni idea fondante di cambiamento (culturale, economico e sociale) del mondo, a partire da analisi strutturali, a partire dalla rabbia.
Non troverete una survey della letteratura femminista degli ultimi decenni. Il libro si concentra sulle pubblicazioni anglosassoni contemporanee di “largo consumo” per operare la decostruzione del presente proposto alle donne. Si tratta di una scelta, non di una svista. Nina Power usa lo spazio che ha per allestire una descrizione spietata e quanto mai efficace dell’unidimensionalità che il capitalismo contemporaneo ritaglia intorno alle donne, a partire dalla pubblicistica pop inglese che fa del femminismo una specie di tendenza alla moda. Un femminismo che per usare le parole dell’autrice “crede di dover lusingare il capitale per poter vendere con maggiore efficacia il proprio prodotto”.
Il titolo, spiega Power, prende spunto dall’Herbert Marcuse dell’Uomo a una dimensione, un testo nel quale si tentava di misurare l’estensione dell’ideologia contemporanea (siamo nel 1964). Un’ideologia che produce l’inganno attraverso le promesse del consumismo e della democrazia liberale. Power è diretta, non ci gira intorno: secondo lei oggi anche il femminismo si è ritagliato un ruolo tra i meccanismi di controllo applicati alle nostre vite, “rappresentando un ostacolo a una vera critica del lavoro, del sesso e della politica. Quello che ha le apparenze dell’emancipazione, nasconde un’ulteriore stretta della catena”.
Il biopotere reclama il controllo delle nostre vite, tanta più oggi che esse assumono valore grazie alla nostra naturale disposizione a cooperare. Questo avviene “con blandizie”, per dirla con Foucault. Ed ecco allora vino bianco, potere, diletti, privilegi. Basta allungare le mani, basta accettare una collaborazione che diventa integrazione e oblio. Power descrive la tragica vetrinizzazione (potremmo giustamente parlare di un regime di viseità che appartiene e viene governato dagli apparati di potere) a cui abbiamo piegato, volenti o nolenti, anche le nostre vite e i nostri corpi.
Le donne di Power sono donne apparentemente sicure e forti che si muovono sull’orizzonte del capitalismo cognitivo, nelle città occidentali. Vivono nel lavoro e di notte, si spostano in gruppo, sono curate, depilate, si dichiarano femministe dentro l’infingimento di un perenne divertimento e dentro una liberazione sessuale compulsiva, livida e meccanica collegata alla complessiva (dis)erotizzazione della società. Power parla di una “pornografia alienata”, nel senso che il sesso è diventato un lavoro come un altro, con tanto di indici intensivi di produttività. Mentre avanza l’imperativo dell’individualismo forzato per la donna-precaria, che fa di se stessa un’impresa e viene distratta dai legami sociali, si istituisce, contemporaneamente, l’imposizione del piacere, l’“obbligo del divertimento”. Entrambi restano inafferrabili: la felicità non si prescrive, anzi. Questa donna svuotata conosce l’ansia prestazionale e il potere della cioccolata sulle endorfine ma in realtà non gode davvero di niente, immersa come è in una società atomizzata in cui il narcisismo sembra essere il punto inevitabile di arrivo di ogni relazione. La cifra sentimentale di questo genere di mondo sembrano essere non la felicità o il più semplice divertimento ma, piuttosto, il rancore e l’invidia con tutto ciò che ne discende. Un triste processo che si collega da vicino a una forma di lutto del soggetto, a un’infelicità senza desiderio della quale fa parte un “non detto”, socialmente deprecabile perché deprimente: in nome della competizione all’interno della cooperazione che ha l’effetto di costringerti a consegnarti al regime di viseità; in nome di obiettivi incomprensibilmente alti che concorri tu stessa a fissarti, ti sfinisci di stanchezza, sei pervasa da continui e malinconici segnali di inadeguatezza, bevi un altro bicchiere di vino bianco per non pensarci e sorridi: the show must go on.
La rappresentanza come rappresentazione
In questo quadro, Nina Power teorizza come necessario rifiutare il laccio del potere di intercessione della “politica a misura di donna” (la rappresentanza) che continuamente ci viene propinata (le quote; le percentuali; il numero di presenze femminili nei governi). Un processo di consapevolezza che serve innanzitutto a travalicare le narrazioni dominanti e a trovare chiavi interpretative di rottura, più originali e adeguate ai problemi immensi che abbiamo di fronte. Serve a proporre alcune domande. Le donne, fedeli alla pratica femminista delle collocazioni – sapendo bene che cosa significa l’“altro” per essere esse stesse “altro”- possono avere una comprensione più profonda della realtà socio-economica contemporanea e di una politica che si performa proprio sulla violenza di un’infinita riproposizione di separazioni ed esclusioni, intese come forma di controllo? Come altrimenti intendere i vari “sistemi” applicati alle/ai migranti? E come spiegare le tante precarietà che innervano le nostre esistenze? Ma se questo è vero, allora le donne non dovrebbero, piuttosto che puntare ad avere in un qualche parlamento una qualche donna-emblema (“esca democratica”), agire uno strappo non solo rispetto al meccanismo della rappresentazione stereotipa che viene fatta di loro stesse ma anche, specularmente, a quello della rappresentanza? Sarah Palin, Condoleezza Rice e oggi Christine Lagarde non sono figure prototipiche di questi tempi e di questa infelice arte del governo? Non a caso, la crisi della politica e il desiderio di trasformazione, che si trova emarginato dal pensiero unico fondato sull’impero del mercato finanziario e sull’ipotesi di una mancanza di capacità di autonomia dei soggetti, prende forma, nonostante le tecnocrazie, nelle piazze di Barcellona e di Zuccotti Park come nella rivolta ottobrina di Roma.
Addentrarci tra i distinguo i pregi e i limiti di queste insorgenze non è oggetto di questo articolo. Esse sono tuttavia utili a esemplificare il già citato, fatidico, “scarto”. Utili a ricordarci, sempre e comunque, che la pretesa del capitale di dare un’unica misura e un’unica dimensione alle donne, come agli uomini, è impossibile.
La femminilizzazione del lavoro
 Più o meno stesso periodo in cui Power ha scritto questo testo, provavo a ragionare sul concetto di femminilizzazione del lavoro. Anche per questo motivo sento una particolare affinità con le tesi dell’autrice, che riprendono l’idea “la femminilizzazione del lavoro” traducendola in “lavorizzazione delle donne perché queste ultime — dice Power — sono oggi innanzitutto assegnate al ruolo di lavoratrici e secondariamente a quello di madri o con una posizione identitaria indipendente dalla produzione economica” (p. 34).
Più o meno stesso periodo in cui Power ha scritto questo testo, provavo a ragionare sul concetto di femminilizzazione del lavoro. Anche per questo motivo sento una particolare affinità con le tesi dell’autrice, che riprendono l’idea “la femminilizzazione del lavoro” traducendola in “lavorizzazione delle donne perché queste ultime — dice Power — sono oggi innanzitutto assegnate al ruolo di lavoratrici e secondariamente a quello di madri o con una posizione identitaria indipendente dalla produzione economica” (p. 34).
Siamo insomma, come ho già scritto, più che mai un bacino strategico e siamo soprattutto all’interno di un paradigma di accumulazione che non sa che farsene dell’identità di coloro che lavorano se non in termini di immediata spendibilità/fruibilità/estrazione di plusvalore dalla vite complessivamente intese, a partire da “certe doti del carattere” (Paolo Virno) più marcatamente femminili.
In questo quadro, sono anche io dell’idea che la potenza della tensione trasformativa del femminismo, pietra su cui si fonda il movimento delle donne di sempre, oggi possa rischiare di venir amputata dalla dimensione unilaterale del capitalismo cognitivo. Il femminismo rischia di imporsi da sé i suoi stessi vincoli, chiudendosi in un identitarismo compensatorio che si accontenta di un logo riconoscibile, improvvisamente di richiamo e di moda. Dietro il brand di questo femminismo sparisce la lotta, sparisce il conflitto. Non si fa disordine, si è composte e dignitose, si scrivono articoli altrettanto composti – e appelli — si reclamano posti, si valutano le opportunità che si schiudono per noi “ragazze”. Questo tipo di femminismo fa fatica a rispondere davvero alle problematiche reali (precarietà; assenza di futuro; mancanza di scelta; difficoltà a leggere il proprio desiderio) delle nuove generazioni di donne. Paradossalmente proprio quando la questione della differenza, lungi dal risultare superata, finisce per attraversare la società e l’esistente. Proprio quando la differenza innerva di sé, ibridandolo, l’intero contesto storico, sociale ed economico, fuori da ogni idea, sempre più astratta, di “natura” e dentro invece le questioni concrete del lavoro, delle nuove tecnologie e della rete, del simbolico spinto dai media. Proprio quando le istituzioni di femminilità e mascolinità, da sempre messe in discussione dalle donne, si mescolano con variabili cruciali come razza, classe, etnia.
Mentre il riformismo contemporaneo “salva-mercati” svela completamente il proprio aspetto illusorio e la sua violenta forza reazionaria, i cosiddetti “soggetti deboli” (donne, migranti, transgender) dovrebbero smettere di guardare al “diritto positivo” come all’unica ancora di salvezza possibile per cercare il proprio riscatto. Trovandolo, invece, dentro forme dinamiche di riapertura molteplice delle lotte, proponendo modelli di sviluppo alternativi basati sul comune, cercando strade al di fuori del solo linguaggio della produzione e del denaro. Possono indicare nuovi e più soddisfacenti modi di “stare nel mondo”: «La filosofia femminista contemporanea ha un più ampio spettro di applicazioni di quanto non abbia avuto nel passato. Ha oggi una portata universalistica, se non un’aspirazione universalistica» (Rosi Braidotti, Trasposizioni, Luca Sassella Editore, Roma 2008, pag. 29).
Tra lavoro produttivo e famiglia, il comune
La donna non ha una sola dimensione perché non è statica nel tempo e nella storia, nello scorrere degli anni e delle generazioni, nelle differenze di nazionalità e culture. Il ragionamento ci porterebbe, con tutta evidenza, a dover discutere della natura del soggetto e ad approfondire come esso sia “costruito”, quale sia la natura della conoscenza prodotta dal soggetto, e quale posizione possa reclamare a partire dalla sua specifica collocazione sociale. Questo effettivamente è il tema che fa da sfondo a questo libro, come altre riflessioni di questo tipo, oggi.
L’odierna radice materiale dell’ideologia finisce per imporci nuovi cambiamenti di specie. La femminilizzazione del lavoro, la continua necessità di promuoversi, la precarietà, il dimostrarci continuamente disponibili al lavoro che impatti hanno sul soggetto? L’imperativo produttivista contemporaneo come influenza, diversamente, la donna e l’uomo? Power cita David Harvey e si domanda: «Qual è l’effetto della circolazione del capitale variabile (l’estrazione della forza lavoro e del plus-valore) sui corpi (le persone e le soggettività) di coloro che ne vengono attraversati?» (p. 35).
Non è privo di effetti per le donne, che esse si trovino, in questa fase della storia a rappresentare l’emblema del mondo del lavoro nel suo complesso. Non è privo di effetti il fatto che la riproduzione sociale, insieme alla conoscenza, rappresentino il cuore dell’accumulazione della fase presente.
Andare per il mondo, ci aveva spiegato Virginie Despentes in King Kong Theorie [trad.. it. King Kong Girl, Einaudi, Torino 2007], poteva essere pericoloso. Ciò non toglie che, come lei, volevamo farlo e lo abbiamo fatto. Nel frattempo questo è diventato un mondo in cui l’azienda che produce un noto aperitivo offre un ingaggio a un maschio – precario, studente, operaio non importa – purché bello (povero e di bell’aspetto, come nelle fiabe). Diverrà testimonial per la pubblicità di quel prodotto e bacerà alcune top model. Smetterà così di essere precario, operaio o studente, guadagnando molti soldi.
Il mondo può essere un luogo dove ubriacarsi fino a non reggersi in piedi, specie in questo periodo di crisi economica, dove per fare carriera (o mantenere un posto di lavoro) le donne devono trasformarsi dalle dolci reginette del privato (ieri), in personalità aggressive e convinte di concorrere, altrimenti non c’è salvezza. Si tratta quindi di imparare (oggi) anche la cattiveria per giocare la partita che il capitalismo contemporaneo generosamente ci propone.
Oppure si tratta di provare (domani) a reinventarci l’esistenza, una sorte diversa. Così, alla fine, Nina Power, senza essere in grado di indicare soluzioni definitive tuttavia individua nella possibilità di sperimentare forme di vita sociale e collettiva differenti una possibile alternativa. «Non forme di comunitarismo o una confraternita ritirata dal mondo ma di un modo per ristabilire un nesso tra sesso e politica. Che è appunto il legame che il capitalismo deve occultare se vuole occultare il fatto di essere in realtà fondato sull’ordinamento e la regolazione della riproduzione. In questo senso, la famiglia è per l’appunto un problema di relazione tra sesso e politica proprio come il fatto di dover sbarcare sul mercato del lavoro e di dover restare sufficientemente in forma per vendere otto ore al giorno la propria forza lavoro» (p. 81).
In sostanza, il controllo sul corpo delle donne e sulla riproduzione sociale – anche ora che le stesse sono uscite dallo spazio privato (la casa, la famiglia) per entrare completamente nello spazio pubblico (lavoro produttivo) assumendo con ciò visibilità e finalmente retribuzione – e il rapporto privato-pubblico continuano a costituire un nodo irrisolto della società capitalistica patriarcale. La famiglia è allora una cellula “separata politicamente dal resto del mondo” e tuttavia ne rappresenta l’organismo fondante, costitutivo, quella che riproduce i modelli ideologici (socio-economici) imperanti. Ecco un compito per il futuro di un femminismo non brandizzato: l’immaginazione di questi nuovi, inediti, modelli sociali dentro l’orizzonte del comune, alternativi alla triade stato, mercato, famiglia.
Se il femminismo è filosofia della vita e se la vita oggi tende a diventare merce, il femminismo deve continuare a promuovere, per forza, una vita diversa.



