di Franco Pezzini
(da L’indice dei libri del mese, ottobre 2011, n. 10)
Da qualche tempo una certa attenzione per la letteratura minore ha permesso l’emergere anche in traduzione italiana — specie per piccoli editori alla ricerca di chicche, e complice ovviamente lo scadere del copyright — di testi del tutto dimenticati. Testi che tuttavia avevano talora goduto di tale successo di pubblico, e non solo il più popolare, da concedere agli autori un posto non ignobile nella storia culturale del proprio tempo; e di particolare interesse risultano le prove a firma femminile, espressive di percorsi spesso eccentrici rispetto ai coevi canoni letterari.
Nelle librerie nostrane è per esempio apparso l’originalissimo — nonostante il titolo — Il sangue del vampiro (The Blood of the Vampire, 1897, per i tipi Castelvecchi, Roma 2010, pagg. 336, trad dall’inglese di Alberto Frigo, Introduzione di Barbara Baraldi, euro 18,00) della romanziera, drammaturga, cantante e attrice Florence Marryat (1833-1899), con una produzione di tutto rispetto per quantità e qualità letteraria, e in altri paesi già oggetto di ampia riscoperta: l’irrompere in un algido sottomondo vittoriano della sensuale giamaicana Harriet Brandt, portatrice di una strana condanna ad attingere energie altrui, segna il deflagrare d’una crisi più vasta tra infermità, incomprensioni e tragedie.
con una produzione di tutto rispetto per quantità e qualità letteraria, e in altri paesi già oggetto di ampia riscoperta: l’irrompere in un algido sottomondo vittoriano della sensuale giamaicana Harriet Brandt, portatrice di una strana condanna ad attingere energie altrui, segna il deflagrare d’una crisi più vasta tra infermità, incomprensioni e tragedie.
Anche più emblematico dello scarto tra celebrità passata e successivo oblio è poi Vendetta! (Vendetta — The Story of One Forgotten, 1886, Gargoyle, Roma 2011, trad. dall’inglese di Monica Meloni, Postfazione di Carlo Pagetti, pagg. 345, euro 15,00) di quella Marie Corelli — o meglio Isabella Mary Mills (1855-1924) — dei cui vendutissimi romanzi la regina Vittoria dichiarava di attendere con ansia l’uscita. Un’autrice il cui successo corre fino alla prima guerra mondiale, sostenuto da un’intelligente amministrazione d’immagine: a partire dalla bubbola d’esser figlia di un conte italiano, laddove il padre era un giornalista scozzese e la madre probabilmente la governante, ex-operaia di Londra.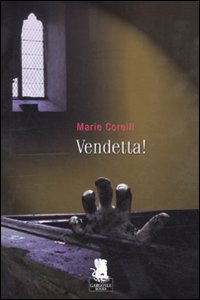 Ma proprio il gioco di un’identità fittizia ritorna con abbondanza nel tessuto dei bestsellers corelliani — sull’onda del resto di quel continuo ritorno del tema dell’identità che tra Otto e Novecento trionfa nella grande letteratura, ma imbeve anche tutta una produzione minore e popolarissima in una pirotecnia di mascheramenti e dubbi, sospetti perturbanti e drammatiche agnizioni. Per esempio in Innocent, Her Fancy and His Fact, 1914, Corelli narra di una figlia illegittima che come lei diverrà famosa romanziera, venerata dal pubblico ma spregiata dalla critica (merita rammentare lo stroncante giudizio sulla Nostra a firma di Joseph Conrad, 1898). E sul tema gioca anche Vendetta!, esempio dell’eccellente salute goduta nell’Inghilterra tra i due secoli dal feuilleton all’Invernizio, con qualche spruzzata di gotico e tanto onesto mestiere — al punto da rendere godibile un simile melodramma ancora al pubblico odierno.
Ma proprio il gioco di un’identità fittizia ritorna con abbondanza nel tessuto dei bestsellers corelliani — sull’onda del resto di quel continuo ritorno del tema dell’identità che tra Otto e Novecento trionfa nella grande letteratura, ma imbeve anche tutta una produzione minore e popolarissima in una pirotecnia di mascheramenti e dubbi, sospetti perturbanti e drammatiche agnizioni. Per esempio in Innocent, Her Fancy and His Fact, 1914, Corelli narra di una figlia illegittima che come lei diverrà famosa romanziera, venerata dal pubblico ma spregiata dalla critica (merita rammentare lo stroncante giudizio sulla Nostra a firma di Joseph Conrad, 1898). E sul tema gioca anche Vendetta!, esempio dell’eccellente salute goduta nell’Inghilterra tra i due secoli dal feuilleton all’Invernizio, con qualche spruzzata di gotico e tanto onesto mestiere — al punto da rendere godibile un simile melodramma ancora al pubblico odierno.
Lo sfondo è un’Italia che, nonostante le malizie professionali dell’Autrice e il gusto colorito per l’esotico, si rivela farlocca quanto quella del gotico di un secolo prima: un’Italia dove il teatro delle passioni può conoscere gli eccessi più allegri — possibilità interdetta sull’educato sfondo britannico — ma permette a Corelli di lanciare continue frecciate al proprio mondo. Il conte napoletano Fabio Romani, dato per morto nel corso dell’epidemia di colera 1884, si risveglia nella bara e nel corso della fortunosa liberazione trova nella cripta un tesoro, nascosto dai briganti; salvo scoprire anche, al pregustato ritorno a casa, che l’amatissima moglie Nina e il più caro amico lo tradivano da tempo, e ora simulando disperazione si apprestano a godersi la sua dipartita. Da cui la vendetta del titolo, consumata da Fabio col fingersi tal conte Cesare Oliva, insinuarsi tra i due e distruggerli: e l’improbabile macchinosità del tutto, l’odiosa spregiudicatezza di Nina (persino verso la figlia bambina, in toni da profumi e balocchi) e la verbosità monomaniaca del narratore Fabio riescono a divertire il lettore senza fargli prendere troppo sul serio gli aspetti amari della vicenda. Il fatto è che il soave ingenuotto che non vedeva alcunchè di equivoco nelle frequentazioni tra la sensuale Nina e l’amico Guido — ma trattava sua moglie, sospettiamo, come un bel soprammobile —, non sa far tesoro neppure della nuova drammatica esperienza, e resta ripiegato su se stesso e le sue corte vedute. Così, virando semplicemente su tinte più livide la propria semplicistica visione del mondo, si abbandona a una dispendiosa e teatrale rivalsa senza curarsi realmente di salvare la figlia — salvo un po’ di scontato teatrino sentimentale — e tantomeno di maturare qualunque autocritica. Quasi metaforiche, dunque, le lenti scure con cui caratterizza il fasullo conte Oliva, a immagine di una debolezza di vedute che fa transitare dalla più beata ingenuità a un odio altrettanto tetragono. Del resto, anche posseduto dalle Erinni, il Nostro continua a sdilinquirsi con assoluto candore su altri fronti. Emblematica per esempio la descrizione sul passaggio del re nella Napoli colpita dal colera: la commozione tracimante di Fabio sulla nobiltà paterna del “monarca impavido, Umberto d’Italia, l’uomo che i suoi sudditi erano felici di onorare”, risente ovviamente del clima emotivo d’epoca e in esso va collocata — ma è in fondo del tutto omologa a quella votata da Fabio in precedenza, in modo altrettanto acritico, ai fedelissimi moglie ed amico. Continue invece le lamentose pontificazioni del Nostro contro le donne del suo ambiente: un tema speso dall’Autrice in chiave di critica sociale un po’ ruspante (la diversa attitudine alla fedeltà nelle classi popolari — da cui Corelli viene — rispetto al cinico bel mondo) ma che finisce col confermare il ritratto di un immaturo, accidiosamente incapace di costruire qualcosa con una donna. D’altra parte Corelli, nel mettere in scena tale Montecristo in sedicesimo, ha la malizia di affidargli tutta la narrazione — da cui pesanti sospetti di tendenziosità non solo nella coloritura dei fatti, ma radicalmente nella loro comprensione — e lo presenta senza equivoci come uno sconfitto: privo però dell’alone maledetto del Vendicatore di Dumas, e caratterialmente non dotato della profondità per cogliere la vertigine d’una qualsiasi dannazione. Al di là insomma del talk show sull’affettata odiosità dei fedifraghi che spinge il lettore a prendere le sue parti (e godersi spudoratamente come andrà a finire), Fabio/Cesare non si guadagna troppa fiducia: restando, a onore di Madame Corelli e della sua capacità di cogliere i giorni in arrivo, un antieroe molto più adatto del titanico Montecristo al corto respiro dei giorni nostri.
Altri drammi dell’identità emergono però in una seconda opera a firma femminile recentemente riproposta: un’opera dimenticata, stavolta, non per scarsa notorietà odierna dell’Autrice — nientemeno che l’americana Louisa May Alcott (1832-1888) — ma perché facente parte di quella sua produzione nera, tra gotico e thriller, riemersa solo a metà del XX secolo.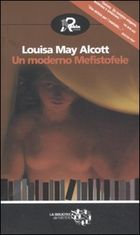 Una produzione edita con lo pseudonimo di A.M. Barnard o in forma decisamente anonima, come questo Un moderno Mefistofele (A Modern Mephistopheles, 1877) talora attribuito a Julian Hawthorne, e proposto oggi per i tipi Robin (La biblioteca del mistero, trad. dall’inglese di Lorena Paladino-Morgante, Roma 2010, euro 14,00, pagg. 235) insieme a un paio d’altre opere alcottiane di analogo tono: un thriller dell’anima elegante e tortuoso, stupefacentemente torbido per chi rammenti solo il ciclo di Piccole donne (le cui letture impoverite in scorciate edizioni “per l’infanzia” non rendono però giustizia alla statura dell’Autrice). In scena sono le dinamiche drammatiche tra un quartetto di personaggi male assortiti: a partire dal bellissimo giovane Felix Canaris, con brucianti ambizioni di letterato, salvato dal suicidio al primo capitolo per far da compagno/servo e allietare esteticamente (ammiccamento omosessuale compreso) l’equivoco salvatore. Questi però, il ricco, cerebrale e sarcastico Jasper Helwyze, moderno Mefistofele del titolo, garantisce fama artistica agli scritti di Felix, che dunque si presta al gioco — e solo poco a poco comprende la gabbia d’oro in cui è stato chiuso. Sorta di Roderick Usher più malizioso e maneggione, il malaticcio Jasper è in effetti irriducibile a una banalizzazione come vilain: algido e coltissimo seduttore d’anime, manipolatore degli altri fino all’utilizzo di ipnosi e psicofarmaci, persino nelle incresciose propensioni da voyeur interiore mostra tratti di paradossale candore, e svela inattese sensibilità. C’è poi l’angelica Gladys, una piccola donna — appunto — dalla volontà d’acciaio, incarnazione ideale di quella “Dichiarazione dei Sentimenti” sui diritti femminili tanto ammirata dall’Autrice: portata a nozze senza amore da Felix per il solito patto faustiano, sarà tuttavia in grado di farlo perdutamente innamorare — anzi non solo lui, ma persino il mefistofelico e smarrito Jasper. E c’è infine la più matura Olivia, in ostaggio dell’amore per Jasper che ha tradito in passato finendone alla mercè: da lui avvilita a sedurre Felix per i soliti giochini di dominio interiore, si dimosterà capace di riscattarsi fattivamente a fianco degli amici sofferenti… Indubbiamente il contesto è morboso, e sottolineato da uno stile torpido e claustrofobico — come del resto un po’ tutta la storia precipita tra i chiusi muri della magione di Jasper, una casa Usher quasi immagine del suo cervello, e pronta a un crollo di carne e sangue. Eppure si tratta di una storia “morale”, con le rigidità ideali che possiamo prevedere, ma di non banale sviluppo. Il belloccio Felix è uno smidollato tutto lamenti e capricci, travolto dalla sua spocchia: perché diventi digeribile dovremo vederlo sconvolto, a biascicare a Gladys la vera origine dello scritto che gli ha offerto la fama, nella solita dialettica di identità mascherate, scambiate e confuse. Gladys poi, vero panzer della virtù circonfusa di un candore naturale, non può che trascorrere rapidamente per questo mondo verso una morte precoce e il Cielo ricercato, lasciando devastati i due uomini: una figura intensa, coraggiosa e dolente, mai stereotipata nel bozzetto dell’insipida donna-angelo, ma troppo perfetta perché il lettore provi il desiderio di bere anche solo un tè con lei. Più attraenti i personaggi più maturi e complessi: e se l’ex-pantera Olivia riesce a recuperare una dignità senza affettazioni moraleggianti, una certa simpatia viene anche al marpione Jasper. Che scontando colpe e ateismo in un tragico finale crepuscolo, assume nel suo corpo paralizzato tutta la claustrofobia dell’ultima avventura, tutto il lancinante desiderio — l’identità, ancora — d’essere un altro, e amato come lui.
Una produzione edita con lo pseudonimo di A.M. Barnard o in forma decisamente anonima, come questo Un moderno Mefistofele (A Modern Mephistopheles, 1877) talora attribuito a Julian Hawthorne, e proposto oggi per i tipi Robin (La biblioteca del mistero, trad. dall’inglese di Lorena Paladino-Morgante, Roma 2010, euro 14,00, pagg. 235) insieme a un paio d’altre opere alcottiane di analogo tono: un thriller dell’anima elegante e tortuoso, stupefacentemente torbido per chi rammenti solo il ciclo di Piccole donne (le cui letture impoverite in scorciate edizioni “per l’infanzia” non rendono però giustizia alla statura dell’Autrice). In scena sono le dinamiche drammatiche tra un quartetto di personaggi male assortiti: a partire dal bellissimo giovane Felix Canaris, con brucianti ambizioni di letterato, salvato dal suicidio al primo capitolo per far da compagno/servo e allietare esteticamente (ammiccamento omosessuale compreso) l’equivoco salvatore. Questi però, il ricco, cerebrale e sarcastico Jasper Helwyze, moderno Mefistofele del titolo, garantisce fama artistica agli scritti di Felix, che dunque si presta al gioco — e solo poco a poco comprende la gabbia d’oro in cui è stato chiuso. Sorta di Roderick Usher più malizioso e maneggione, il malaticcio Jasper è in effetti irriducibile a una banalizzazione come vilain: algido e coltissimo seduttore d’anime, manipolatore degli altri fino all’utilizzo di ipnosi e psicofarmaci, persino nelle incresciose propensioni da voyeur interiore mostra tratti di paradossale candore, e svela inattese sensibilità. C’è poi l’angelica Gladys, una piccola donna — appunto — dalla volontà d’acciaio, incarnazione ideale di quella “Dichiarazione dei Sentimenti” sui diritti femminili tanto ammirata dall’Autrice: portata a nozze senza amore da Felix per il solito patto faustiano, sarà tuttavia in grado di farlo perdutamente innamorare — anzi non solo lui, ma persino il mefistofelico e smarrito Jasper. E c’è infine la più matura Olivia, in ostaggio dell’amore per Jasper che ha tradito in passato finendone alla mercè: da lui avvilita a sedurre Felix per i soliti giochini di dominio interiore, si dimosterà capace di riscattarsi fattivamente a fianco degli amici sofferenti… Indubbiamente il contesto è morboso, e sottolineato da uno stile torpido e claustrofobico — come del resto un po’ tutta la storia precipita tra i chiusi muri della magione di Jasper, una casa Usher quasi immagine del suo cervello, e pronta a un crollo di carne e sangue. Eppure si tratta di una storia “morale”, con le rigidità ideali che possiamo prevedere, ma di non banale sviluppo. Il belloccio Felix è uno smidollato tutto lamenti e capricci, travolto dalla sua spocchia: perché diventi digeribile dovremo vederlo sconvolto, a biascicare a Gladys la vera origine dello scritto che gli ha offerto la fama, nella solita dialettica di identità mascherate, scambiate e confuse. Gladys poi, vero panzer della virtù circonfusa di un candore naturale, non può che trascorrere rapidamente per questo mondo verso una morte precoce e il Cielo ricercato, lasciando devastati i due uomini: una figura intensa, coraggiosa e dolente, mai stereotipata nel bozzetto dell’insipida donna-angelo, ma troppo perfetta perché il lettore provi il desiderio di bere anche solo un tè con lei. Più attraenti i personaggi più maturi e complessi: e se l’ex-pantera Olivia riesce a recuperare una dignità senza affettazioni moraleggianti, una certa simpatia viene anche al marpione Jasper. Che scontando colpe e ateismo in un tragico finale crepuscolo, assume nel suo corpo paralizzato tutta la claustrofobia dell’ultima avventura, tutto il lancinante desiderio — l’identità, ancora — d’essere un altro, e amato come lui.



