di Gioacchino Toni
 Michael Taussig, La bellezza e la bestia. Il fascino perverso della chirurgia estetica, Meltemi, Milano, 2017, pp. 241, € 18,00
Michael Taussig, La bellezza e la bestia. Il fascino perverso della chirurgia estetica, Meltemi, Milano, 2017, pp. 241, € 18,00
Nel 2012 The University of Chicago Press ha pubblicato il saggio The Beauty and the Beast di Michael Taussig, antropologo che, come ricorda Franco La Cecla nella Prefazione all’edizione italiana, gode di buona fama in ambito anglo-americano ed ispano-americano e decisamente di minor fortuna tra gli antropologi francesi ed italiani che lo accusano di scarsa accademicità. Il volume, che da poco è stato tradotto da Emanuele Fabiano e dato alle stampe in Italia dall’editore Meltemi, esamina i tentativi di trasformare il corpo attraverso la chirurgia estetica sia per accrescere la bellezza che per mascherare l’identità.
Autore di opere come The Devil and Commodity. Fetishism in South America (1980), Shamanism, Colonialism, and the Wild Man (1987), Cocaina. Per un’antropologia della polvere bianca (2007), The Corn Wolf (2015), Taussig, in La bellezza e la bestia, stabilisce un interessante collegamento tra la violenza dilagante in Colombia e l’industria della bellezza. A partire dall’analisi di interventi chirurgici che si sono trasformati in veri e propri disastri, l’autore ragiona sulla bellezza del corpo femminile e il consumo, collocando la chirurgia estetica, da lui chiamata “chirurgia cosmica”, tra la dépense di George Bataille e le riflessioni di Max Horkheimer e Theodor Adorno sul dominio della natura.
«La bellezza e la bestia pone la questione della bellezza in relazione alla violenza, si interroga sul perché in Colombia così tanti racconti sulla chirurgia estetica – che qui chiamo “chirurgia cosmica” – si dilettino con la morte o con la sfigurazione del paziente. Nel mondo che oggi ci circonda non è in gioco solo la coesistenza di glamour e terrore, ma la loro sinergia» (p. 19). Le riflessioni si sviluppano a partire dal “caso colombiano” perché, secondo lo studioso, proprio in questo paese il legame tra bellezza e violenza risulta più appariscente ma il ragionamento è da considerarsi estendibile a livello generale.
Siamo sicuri che le interminabili immagini e il fragore della polizia con le maschere antigas, i giubbotti antiproiettile, le mitragliatrici, le tenute antisommossa nero brillante, gli elicotteri, le luci intermittenti, le sirene, i gas lacrimogeni e i cavalli, non stiano lì a testimoniare qualcosa che va oltre la scelta estetica e che potremmo definire “pratico” o “utilitaristico”? Dopotutto, esiste qualcosa di “pratico” che non incorpori un’estetica? A mio avviso, questo ruota intorno al narcolook ispirato nelle giovani donne che appartengono, o vorrebbero appartenere, a narcotrafficanti favolosamente ricchi e godere del loro stile di vita fuori dal comune. La loro imago – tette di silicone, culi giganti, magrezza da liposuzione – ha innescato non solo il boom della moda e dell’abbellimento, assorbendo le fantasie e le energie di uomini e donne ma, in termini più generali, parla del corpo come di un emblema e un veicolo, di una forma d’essere che ha rimpiazzato il lavoro e la disciplina in favore dello stile, della trasgressione e dell’eccesso erotizzato. Questa stessa estetica ora si estende al mondo, fino a includere la guerra, le torture, la mutilazione e la frenesia della nuova economia capitalistica, alla ricerca di respiro in quello che si chiama, fin troppo familiarmente, “consumo” (p. 20).
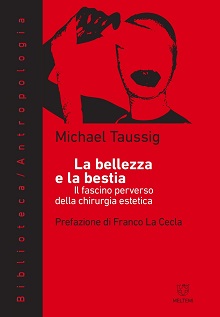 Taussig si interroga circa la possibilità che sia proprio l’estetica ad innescare il meccanismo della vita e coglie nella tendenza moderna di ridurre tutto a un mezzo per un fine le cause che hanno portato a renderci insensibili di fronte alla forza dell’estetica che scorre nel quotidiano ben al di fuori dei musei e delle gallerie in cui è stata costretta: «i racconti delle baraccopoli agroindustriali della Colombia che ho in mente sono emissioni del lato oscuro della bellezza, racconti di sventura che incontrano una cupa soddisfazione nei tentativi di abbellimento finiti tragicamente» (p. 29). Attraverso questi racconti veniamo catapultati in ingrandimenti del seno che si risolvono in infezioni e mastectomie, in interventi oculari volti ad abbellire lo sguardo che portano all’incapacità di chiudere gli occhi, a lifting al volto che lo trasformano mostruosamente, ad innalzamenti o ingrossamenti del sedere che lo vedono poi lentamente scivolare lungo le gambe ecc.
Taussig si interroga circa la possibilità che sia proprio l’estetica ad innescare il meccanismo della vita e coglie nella tendenza moderna di ridurre tutto a un mezzo per un fine le cause che hanno portato a renderci insensibili di fronte alla forza dell’estetica che scorre nel quotidiano ben al di fuori dei musei e delle gallerie in cui è stata costretta: «i racconti delle baraccopoli agroindustriali della Colombia che ho in mente sono emissioni del lato oscuro della bellezza, racconti di sventura che incontrano una cupa soddisfazione nei tentativi di abbellimento finiti tragicamente» (p. 29). Attraverso questi racconti veniamo catapultati in ingrandimenti del seno che si risolvono in infezioni e mastectomie, in interventi oculari volti ad abbellire lo sguardo che portano all’incapacità di chiudere gli occhi, a lifting al volto che lo trasformano mostruosamente, ad innalzamenti o ingrossamenti del sedere che lo vedono poi lentamente scivolare lungo le gambe ecc.
In passato il capitalismo manifestava «rapporti inquieti con la spesa folle e il lusso, dal momento che sopprimeva la parte più selvaggia della nostra natura in nome di una mentalità utilitaristica e parsimoniosa» (p. 61). L’imperativo era risparmiare per investire, non spendere. La classe lavoratrice, ed ancor più il lumpenproletariat, mancavano di quell’etica del risparmio propria della classe media. «Questi Grandi Spendaccioni e Sperperatori, incapaci di moderazione, che bevevano, giocavano, andavano a puttane e compravano non appena avevano un centesimo o due in tasca, se avevano le tasche, occuparono l’immaginario occidentale fino alla fine della Seconda guerra mondiale, quando spendere (ovvero “consumare”) diventò qualcosa di meravigliosamente buono e nobilitante, un’aspirazione civilizzatrice simile a una nuova religione» (pp. 61-62).
A partire dalla seconda metà del Novecento il capitalismo sembra barcamenarsi tra il tentativo di imporre una cultura del consumo ed il voler limitare questa cultura «ai soli membri responsabili e meritevoli della società, che lavorano onestamente in onesti posti di lavoro e non succhiano dalla tetta del welfare state, riservato invece al salvataggio dei super-ricchi» (p. 62). Il grande dilemma pare però essersi risolto velocemente. «Quanto intrecciate e comiche siano diventate queste distinzioni oggi è reso ancor più evidente dal crescente deficit degli Stati Uniti e dall’impossibilità di ridurlo senza diminuire i consumi, con il rischio che questo ostacoli la capacità del consumatore di mettere di nuovo in marcia l’economia, attraverso l’uso di ciò che gli esperti chiamano “consumer muscle”. Questa eloquente espressione ci segnala come la rivoluzione sia ora completa. Il consumo è divenuto produzione, o almeno “muscolare”, l’ultimo sospiro dell’etica protestante è incapace di comprendere la grandiosità della spesa fine a se stessa, che è in realtà ciò che sta conducendo al disastro, tanto sui campi di battaglia delle guerre degli Stati Uniti ispirati dalla dépense quanto nei centri commerciali o su eBay» (pp. 62-63).
A partire da tali riflessioni, Taussig si chiede cosa sia allora oggigiorno il “consumatore”.
questa nuova creatura post-Seconda guerra mondiale implica un essere ancora più antico, anzi primordiale, che sembra essere già esistito nel profondo dell’immaginario della società, come i personaggi che l’infaticabile cronista dei poveri di Londra, Henry Mayhew, creò a partire dai vagabondi della metà del XIX secolo. Personaggi che, egli pensava, si sarebbero potuti trovare quasi ovunque e in qualsiasi tempo […] Non c’è da sorprendersi che le chiamasse “le tribù erranti”. Avevano mandibole e zigomi pronunciati con teste piccole; una gran massa muscolare che toglieva sangue al cervello; un linguaggio segreto, cuze-cut o slang; disdegnavano il lavoro regolare e continuo; amavano erbe e radici stupefacenti e liquori intossicanti; erano insensibili al dolore; avevano un amore sfrenato per i giochi d’azzardo e le danze libidinose; traevano piacere dalla vista delle sofferenze delle creature sensibili e delizia dallo sport e la guerra; erano assetati di vendetta; possedevano un concetto vago di proprietà; le donne erano lascive e avevano un incerto senso della religione. Questa lista, a mio modo di vedere, vale più o meno anche per gli aristocratici – la ripugnanza per il lavoro, la passione per il liquore e, ovviamente, l’amore smodato per le scommesse, gli sport e la guerra – tutte testimonianze del dispendio che Bataille chiama dépense. Il primitivo e l’aristocratico sono intimamente legati in quanto sono entrambi conoscitori della dépense, la grande arte dello sperpero (pp. 63-64).
 Sulla base di tali riflessioni Taussig giunge alla questione centrale della sua riflessione: l’avvenuto slittamento dal lavoro alla moda, dall’utilità allo stile. Marx sostiene che con il capitalismo moderno la produzione diviene un obiettivo dell’uomo, invertendo così il modello precedente in cui era l’uomo ad essere l’obiettivo della produzione. Secondo Taussig Marx ha ragione circa l’alienazione, «che fa dell’uomo una cifra in una equazione di profitto-efficienza, tuttavia mancava di una teoria del “consumo”, e la sua idea di “uomo” rimanda forzatamente a un’astrazione incapace di contemplare gli aspetti più selvaggi di tale alienazione. L’uomo è ora davvero “lo scopo della produzione”, anche se non si tratta dell’uomo che aveva in mente Marx» (pp. 67-68).
Sulla base di tali riflessioni Taussig giunge alla questione centrale della sua riflessione: l’avvenuto slittamento dal lavoro alla moda, dall’utilità allo stile. Marx sostiene che con il capitalismo moderno la produzione diviene un obiettivo dell’uomo, invertendo così il modello precedente in cui era l’uomo ad essere l’obiettivo della produzione. Secondo Taussig Marx ha ragione circa l’alienazione, «che fa dell’uomo una cifra in una equazione di profitto-efficienza, tuttavia mancava di una teoria del “consumo”, e la sua idea di “uomo” rimanda forzatamente a un’astrazione incapace di contemplare gli aspetti più selvaggi di tale alienazione. L’uomo è ora davvero “lo scopo della produzione”, anche se non si tratta dell’uomo che aveva in mente Marx» (pp. 67-68).
Da tempo i ceti più agiati amano copiare o riprendere la moda dei ceti più bassi e le aziende produttrici di merci non mancano di affidarsi a studi sistematici al fine di mettere a profitto tale tendenza. Negli Stati uniti “L Report” presenta ogni semestre un’indagine accurata delle tendenze di moda tra gli adolescenti del ghetto. Secondo le autrici dell’indagine periodica, i consumatori contemporanei, a prescindere dall’età o dal reddito, come mai prima ambiscono ad avere stile e prestigio. Facendo riferimento ad uno speciale su “L Report” pubblicato da Malcom Gladwell nel 1997 sulle pagine del “New Yorker”, Taussig nota che tale «infiltrazione della moda riguarda solo i ragazzi e non le ragazze del “ghetto”», dunque si chiede se il «fantasma della virilità maschile (sesso e crimine)» non sia per caso intrinseco a tale genere di infiltrazione.
Nelle undici pagine patinate che Gladwell scrive sul cool, pubblicate ad uso del gruppo demografico decisamente non-cool di coloro che leggono il “New Yorker” (si parla tanto di diffusione dal basso, quando poi sono le saghe di John Updike sulle periferie bianche di classe media a connotare la rivista), non compare neppure un accenno – non uno – a una ragazza. Fatta eccezione, ovviamente, per le due donne bionde del Connecticut – alle quali sembra che le cose stiano andando molto bene – , che si immergono nel ghetto per vedere che ne è dello stile, permettendo poi a qualcun altro di copiarlo in fabbriche schiaviste disseminate in tutto il mondo prima di far uscire il catalogo semestrale successivo, che nel 1997 costava ventimila dollari. Se le ragazze compaiono è solo perché i ragazzi se ne approprino, come quando seguiamo Gladwell mentre accompagna una caccia-tendenze nel Bronx […] La donna si avvicina a un giovane membro di una banda e gli dà un paio di scarpe nuove, delle Reebok DMX RXT pensate per ragazze, che il ragazzo adora (p. 70-71).
A corredo dell’articolo-reportage “New Yorker” include un’illustrazione a tutta pagina che mostra la suola della scarpa sprigionare una vera e propria esplosione di colori. Non è difficile intravedere in questa immagine una metafora visiva del meccanismo della moda che deriva dal basso, dalle periferie più degradate; è dalle suole che scaturisce il cool.
Siamo a una nuova resa dei conti, più virtuale che reale, anche se la vecchia realtà, quella del corpo umano che combina il reale con il superreale, continua a persistere mentre la chirurgia cosmica offre una via di salvezza, collegando la carne reale all’immagine reale, la spesa compulsiva alla virtualità. Chiamarla spesa compulsiva non ne coglie il senso […] Il carattere favolistico che riscontro in questo importante cambio nel capitalismo mondiale ha a che vedere con la seduzione degli oggetti inanimati: le scarpe di polvere di diamante, le scarpe da ginnastica Reebok DMX RXT. I nomi la dicono lunga – diamanti e polvere di diamanti a fianco del ruggito da motosega delle scarpe DMX RXT e dell’aspro digrignamento consonantico prodotto da nomi come Reebok, che si svuotano nella vacuità di questo spazio incantato fatto di tutto e di niente. La seduzione esercitata da questo spazio è ciò che giace nel cuore del sempre più frenetico consumo del mondo, e al centro di questo cuore si trovano alcuni degli oggetti più seducenti di tutti – il volto e il corpo umano – che convivono con quella magia dell’apparire che noi chiamiamo cool, pompata fuori dalle periferie degradate. Esiste solo una cosa più seducente della bellezza, ed è la capacità di trasformarsi in bellezza (p. 76)
La seduzione del volto e del corpo umano. Eccoci arrivati al cuore di La bellezza e la bestia. E da qui inizia il viaggio tra le mostruosità della chirurgia estetica, tra infezioni ed effetti collaterali, tra trasformazioni, se non azzeramenti, dell’identità e mutilazioni inferte con violenza inaudita sui corpi altrui come raccontato, ad esempio, nel Capitolo decimo, “Bellezza e mutilazione”, ove viene ricostruita brevemente la storia della mutilazione del corpo (vivo o morto) in Colombia a partire dagli anni Quaranta del Novecento, «quando non era infrequente che i membri di partiti politici opposti – Liberali e Conservatori – lavorassero abilmente gli uni sugli altri con machete e coltello» (p. 111). Un’orgia di sangue fatta di squarci sotto alla mandibola per estrarre la lingua, tagli sul corpo per portarlo alla morte per lento dissanguamento, stupri, mutilazioni genitali, estrazioni di feti dall’utero della madre e via dicendo. «Trent’anni dopo, l’estetica della mutilazione creativa riapparve nella chirurgia praticata dai gruppi paramilitari colombiani, alcuni dei quali, secondo quanto viene riportato, realizzavano veri e propri corsi di mutilazione, che fungevano contemporaneamente anche da iniziazione» (p. 112). Tanta creatività applicata al machete ed al coltello segnala come anche la mutilazione corporale abbia una propria estetica.
Oppure, ancora, colpisce quanto raccontato nel Capitolo settimo, “Sorrisi griffati”, ove le riflessioni dello studioso prendono il via da un articolo intitolato “I chirurghi dei bassifondi”, pubblicato da “El Tiempo” nel 2009 in concomitanza con la cattura del narcotrafficante Chupeta, famoso anche per i tanti interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto. L’articolo del quotidiano riporta alcune storie riguardanti un dentista di Bogotà che si occupa di conferire un nuovo sorriso ai suoi clienti paramilitari ed a partire da tali racconti Taussig riflette circa il ricorso al termine “disegnare” utilizzato dai chirurghi e dai dentisti estetici. Non “fare”, ma “disegnare”, come per i “jeans griffati”. Il linguaggio sembra tradire come il volto ed il corpo non siano poi considerati così diversi dalle altre merci su cui intervengono i creativi nel tentativo di conferire valori aggiunti.
 Questi interventi di chirurgia estetica, o cosmica, come preferisce definirla l’autore, hanno certamente a che fare con le antiche pratiche magiche fondate sulla mimesi e la fisiognomica, come il mascheramento, la pittura del volto e del corpo dedicate alle divinità o attuate confidando di venire a far parte dell’Olimpo. Il viaggio proposto da Taussig, nel suo condurci lungo percorsi in cui si intrecciano bellezza e violenza, non può che lasciare il lettore scosso. È percorrendo questo reticolo catastrofico e maledetto, ove il volto ed il corpo si fanno merce, consumo-produzione, che Taussig giunge alla conclusione che l’uomo è davvero diventato “lo scopo della produzione”, ma, come detto, non si tratta dell’uomo che aveva in mente Marx.
Questi interventi di chirurgia estetica, o cosmica, come preferisce definirla l’autore, hanno certamente a che fare con le antiche pratiche magiche fondate sulla mimesi e la fisiognomica, come il mascheramento, la pittura del volto e del corpo dedicate alle divinità o attuate confidando di venire a far parte dell’Olimpo. Il viaggio proposto da Taussig, nel suo condurci lungo percorsi in cui si intrecciano bellezza e violenza, non può che lasciare il lettore scosso. È percorrendo questo reticolo catastrofico e maledetto, ove il volto ed il corpo si fanno merce, consumo-produzione, che Taussig giunge alla conclusione che l’uomo è davvero diventato “lo scopo della produzione”, ma, come detto, non si tratta dell’uomo che aveva in mente Marx.
Taussig è sicuramente un antropologo non convenzionale, criticato da diversi studiosi per una conduzione dei suoi studi ritenuta un po’ troppo creativa. Nella preziosa Prefazione al volume scrive di lui Franco La Cecla che la sua lettura della storia coloniale rovescia spesso le letture più banali di ispirazione marxista e terzomondista. «Lo fa usando a piene mani l’approccio di Walter Benjamin alla storia e applicandovi gli strumenti della “invidia mimetica” di René Girard. Di Benjamin, Taussig riprende la fortissima intuizione di una lettura teologica del mito […] Per i sottoproletari che lavorano nelle miniere e nelle piantagioni delle colonie ispaniche del Centro e Sudamerica, il lavoro cui sono forzati in cambio di un misero salario è qualcosa che li lega al “diavolo”. Perché non ha nulla dei connotati del lavoro indio, che è fatto per la comunità e per il benessere. Questo è un lavoro dove ci si lega alla demonicità per essere irretiti nella fantasmagoria delle merci che il salario può insegnare a desiderare. Rovesciando l’ottica coloniale che vede nell’indio l’incarnazione del paganesimo e quindi del Diavolo, gli indios stessi se ne impossessano leggendo nella loro alienazione a causa del colonialismo proprio una presenza diabolica» (p. 10). Da qui prende il via un particolare gioco di specchi in cui colonizzatori e colonizzati ribaltano costantemente la situazione riprendendosi l’un l’altro.
Tornando a La bellezza e la bestia, ed ai rapporti tra estetica e potere, non resta che lasciare la chiusura alle parole dello stesso Taussig: «È perfettamente legittimo chiedersi quanto, in queste storie, ci sia di vero e quanto sia fantasia, a patto che se ne accetti l’intollerabile fusione, ragione in più per essere coscienti di ciò che tutti sapevamo e che però non sapevamo di sapere – che per i duri e per lo Stato l’estetica è tanto cruciale quanto lo è per l’aumento del seno, lo stiramento del volto o la magrezza flessuosa ottenuta con la liposuzione» (pp. 19-20).



