di Franco Pezzini
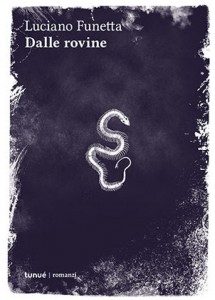 L’apologo del serpente, del giardino, della prova/tentazione di un personaggio maschile e di una controparte femminile dai connotati ambigui o piuttosto cangianti ha probabilmente radici protostoriche e affiora in miti diversi, a monte di quella celeberrima trascrizione biblica a sua volta indefinitamente assunta a modello. Un teatro mitico talmente radicato nel nostro immaginario che il ritrovarne gli elementi – tanto più se spesi con efficacia – in una narrazione moderna muove qualcosa in noi come macchina per pensare, evoca risonanze dal profondo, e fa reagire i mitemi in tutta la latitudine delle possibilità.
L’apologo del serpente, del giardino, della prova/tentazione di un personaggio maschile e di una controparte femminile dai connotati ambigui o piuttosto cangianti ha probabilmente radici protostoriche e affiora in miti diversi, a monte di quella celeberrima trascrizione biblica a sua volta indefinitamente assunta a modello. Un teatro mitico talmente radicato nel nostro immaginario che il ritrovarne gli elementi – tanto più se spesi con efficacia – in una narrazione moderna muove qualcosa in noi come macchina per pensare, evoca risonanze dal profondo, e fa reagire i mitemi in tutta la latitudine delle possibilità.
Come accade avvicinando un libro splendido e tremendo – i due aggettivi, da usarsi con cautela, sono qui necessari – uscito tempo fa per i tipi Tunué, ‘Dalle rovine’ di Luciano Funetta (pp. 184, euro 9,90, Latina 2015). Splendido per la violenza visionaria con cui pone sul piatto una serie di temi-chiave del nostro mondo postmoderno, dalla pulsione a tutto guardare e rendere oggetto di spettacolo, alla seduzione dell’estremo (in scena è un certo tipo di pornografia, senza compiacimenti ma anche senza moralismi), al precipitare – realmente tragico – delle identità in oggetti, al senso di chiusura che vediamo trionfare su tutto un orizzonte attorno a noi; e tremendo, senza sconti, per gli stessi motivi. Leggere ‘Dalle rovine’ (candidato al LXX Premio Strega, dunque con tutti i connotati socialmente riconosciuti dell’ottima letteratura, ma che a distanza di due anni sembra importante richiamare) è realmente una discesa nel serpente-labirinto che conduce al regno dei morti che abbiamo dentro, con la forza ambigua e dirompente del mito.
Un’opera dove tutto parla: a partire dal nome di quella città di Fortezza – la città idealmente dei muri, il post-Castello d’Otranto di un orrore che riconosciamo, anche se di primo acchito sembra aperta, apertissima – che sembra ipostatizzare tutte le chiusure dei personaggi. A partire dal protagonista autoconfinato in una casa piena di gabbie di topi e serpenti, l’Adamo Rivera; e via via attraverso la prigionia nei rituali video dove amoreggia coi diletti ofidi, nel circo asfittico di un certo sottomondo in cui immediatamente quel video spopola, in progetti filmici che si fanno incubi, nelle esperienze stesse entro una villa claustrofobica sempre più luogo di morte e di soffocamento in cui tutto precipita (c’è chi ne fugge, chi addirittura vi si toglie il fiato per impiccagione) e in prospettiva nella morte-prigionia snuff. Dove il tentativo/tentazione di aprire – la visione oltre i limiti di ciò che si può vedere, la vita oltre i limiti dello sperimentabile – porta a un ripiegarsi e chiudersi sempre più necrotico e necrofilo. Ma (appunto) senza moralismi, e in termini asciutti per bandire dall’apologo ogni facile e morboso compiacimento, che sperderebbe il valore della tragedia: un risultato di impressionante controllo narrativo.
Quell’alloggio semivuoto tra teche di serpenti, e poi soprattutto la villa tra gli alberi – autentico anti-Eden dai connotati mitici, grande e labirintico di stanze – in cui vive il produttore-demiurgo Jack Birmania, che crea per Rivera un nuovo mondo-materia attraverso la gnosi del cinema, sono i primi due spazi dell’anti-creazione in cui si consuma la tragedia; e il terzo è la casa del Divisore Alexandre Tapia, trickster e cattiva coscienza del vecchio produttore, sua ombra e trait d’union con le manifestazioni del Male nella storia. Il frutto dell’Albero qui è un copione maledetto (Dalle rovine, appunto), destinato a dar conoscenza dell’inconoscibile e la tristezza che ne deriva; e a precipitare tutti verso la morte che da un certo punto dilaga pandemicamente.
Quanto alla donna dell’apologo mitico, di primo acchito sembra avere poco spazio in questa storia voyeuristicamente maschile, di Adamo-Rivera alle prese con impotenti e senescenti demiurghi, serpenti fallici e Divisori: mentre a ben vedere le figure femminili ci sono ma caratterizzate dalla fuga e dall’assenza, Eve fragili, latitanti o morte, vagamente perturbanti ma incapaci di schiacciare la testa al serpente.
Esclusa la risposta moralistica, la tristezza montante va a braccetto – altra grande caratteristica di questa scrittura – con la capacità di farci provare empatia verso la piccolezza, le malinconie, le solitudini dei vecchi demiurghi e del mondo appannato che fa loro corte, angeli decaduti e amori spezzati: un mondo che scopriamo meno innocente di quanto avremmo sperato, segnato in ultimo dal Male nella sua dimensione più aggressiva e antiumana, e tale tuttavia che vorremmo salvarli. Il paradosso e la genialità della trascrizione di questo mito nero sta forse anche in una dolente e autentica nostalgia dell’umanità.
Se in scena è ovviamente e in modo diretto la seduzione scopica di un certo nesso piacere-mercato-violenza nel mondo del nuovo millennio, con tutto quanto comporta su una società e un sistema malati, non sembra però incongruo cogliere dal romanzo anche echi più indiretti. A evocare, come già accennato, un ampio ventaglio di provocazioni, e in particolare le sirene di un certo mercimonio disumanizzante: gestioni di immagini e corpi dove il virtuale conosce implicazioni materialissime, e i sogni – di chi ovviamente ha la poltrona – rivelano di non essere mai neutri. Come nella pornografia di tanti teatrini legati al mondo del lavoro (vogliamo chiamarla pornergia?), e buon Primo maggio dalla Notte di Valpurga.
Verissimo che la sorte di un romanzo, nel nostro tempo senza memoria, rischia di giocarsi nelle prime settimane dall’uscita; ma la sovrabbondanza dell’offerta – in buona percentuale dimenticabile – non può e non deve far perdere di vista testi che parlano davvero. E il cui narrare dalle rovine ci dice molto del mondo in cui viviamo e di quelli cui virtualmente ci stiamo dirigendo.






