E’ tutto da stabilire il primato che viene a oggi attribuito a David Foster Wallace, nelle patrie lettere statunitensi. Non che DFW non sia un grandissimo scrittore – è comunque da passare attraverso il filtro del tempo ed è necessario osservare la disposizione dei residui magici di foglie aruspicine che rimarranno in fondo alla tazza vuota. Brillantezza, capacità di intravvedere legami tra oggetti e soggetti distantissimi, edificazione di gnoseologie narrative – chi potrebbe negare a Foster Wallace il ruolo di autentico narratore di avanguardia? La risposta c’è e non è un nessuno: è William T. Vollmann. Se messi accanto sul piano dell’intelligenza ciclopica, dell’acribia assoluta, della capacità di sguardo morale e amorale, di scultura del memorabile, Vollmann risulta assai meno prediletto di DFW eppure probabilmente destinato a compiere quanto all’autore dell’infinita beffa non è riuscito: dare a noi la nostra epica occidentale, mentre l’occidente si folgora nel suo tramonto. Europe Central (Strade Blu Mondadori, straordinaria traduzione di Gianni Pannofino, 25 euro per 1080 pagine) è questa epica apparentemente storica, fondamentalisticamente storica – è ciò che Le benevole di Littell non è riuscito a essere: il libro mondo del Novecento europeo, il testo universo, che vortica in ogni cantone dell’occidente, intravvedendo il gorgo del male ovunque e ovunque il riscatto del bene.
 E’ una babele di storie legate a doppio filo, a cui si dovrebbe obiettare che la tesi di fondo è sbagliata, la prassi storiografica è immorale: sembrerebbe, infatti, che Vollmann si sia appoggiato a quella indegnità che è l’equivalenza tra totalitarismo hitleriano e staliniano, il pezzo forte della carriera dello storico Ernst Nolte. Vollmann infatti, in Europe Central, racconta il secondo conflitto mondiale e il periodo immediatamente successivo, e lo fa incarnandosi nella visuale tedesca alternatamente a quella sovietica. Sembrerebbe dunque un’algebra para-revisionista, ma non lo è. Troppo profonda la sapienza (e la sapienzialità) dell’autore americano, per ignorare che l’equipollenza tra Stalin e Hitler è un’aberrazione inaccettabile – poiché Hitler fece di ben peggio che Stalin, senza metterci sul piano allucinante della conta dei milioni di morti per mano dell’uno o per mano dell’altro. La differenza è storica e metafisica. La pianificazione della messa in mora di una parte dell’umanità (il popolo ebraico) come anticipazione della messa a morte graduale e scientifica di tutta l’umanità è una cifra che è del solo Hitler, non c’è in Stalin; senza dire che l’esito delle tempeste di acciaio che sono state fatte abbattere sull’Europa e sui territori sovietici dal nazismo sancisce un verdetto discutibile quanto si vuole, ma effettivo per lo scrivente: e cioè la vittoria postuma di Hitler, che si sovrappone a volte e a volte coincide con l’evanescenza dello stalinismo sul lungo periodo. Mentre Hitler è attuale, è il presente, Stalin è un arnese dimenticato nella soffitta della storia. Il che non leva un grammo alla responsabilità gravissima e criminale e criminogena del “caro leader” georgiano. Tuttavia la differenza è centrale ed è, a conti fatti, l’autentico perno su cui ruota questa narrazione inauditamente polifonica, titanicamente protesa a una coralità impossibile e mitologica che è la tragedia allestita in Europe Central da William Vollmann.
E’ una babele di storie legate a doppio filo, a cui si dovrebbe obiettare che la tesi di fondo è sbagliata, la prassi storiografica è immorale: sembrerebbe, infatti, che Vollmann si sia appoggiato a quella indegnità che è l’equivalenza tra totalitarismo hitleriano e staliniano, il pezzo forte della carriera dello storico Ernst Nolte. Vollmann infatti, in Europe Central, racconta il secondo conflitto mondiale e il periodo immediatamente successivo, e lo fa incarnandosi nella visuale tedesca alternatamente a quella sovietica. Sembrerebbe dunque un’algebra para-revisionista, ma non lo è. Troppo profonda la sapienza (e la sapienzialità) dell’autore americano, per ignorare che l’equipollenza tra Stalin e Hitler è un’aberrazione inaccettabile – poiché Hitler fece di ben peggio che Stalin, senza metterci sul piano allucinante della conta dei milioni di morti per mano dell’uno o per mano dell’altro. La differenza è storica e metafisica. La pianificazione della messa in mora di una parte dell’umanità (il popolo ebraico) come anticipazione della messa a morte graduale e scientifica di tutta l’umanità è una cifra che è del solo Hitler, non c’è in Stalin; senza dire che l’esito delle tempeste di acciaio che sono state fatte abbattere sull’Europa e sui territori sovietici dal nazismo sancisce un verdetto discutibile quanto si vuole, ma effettivo per lo scrivente: e cioè la vittoria postuma di Hitler, che si sovrappone a volte e a volte coincide con l’evanescenza dello stalinismo sul lungo periodo. Mentre Hitler è attuale, è il presente, Stalin è un arnese dimenticato nella soffitta della storia. Il che non leva un grammo alla responsabilità gravissima e criminale e criminogena del “caro leader” georgiano. Tuttavia la differenza è centrale ed è, a conti fatti, l’autentico perno su cui ruota questa narrazione inauditamente polifonica, titanicamente protesa a una coralità impossibile e mitologica che è la tragedia allestita in Europe Central da William Vollmann.
Da pagina 164 a pagina 180, questo genio neorinascimentale (ma anche neogreco e neobabilonese e tutti i neo più epici della storia della letteratura universale) compie ciò che nessuno è riuscito a compiere: narra Hitler. La narrazione di Hitler è difficile, al punto che se ne hanno pochissimi esempi – il romanzo latita a fronte dello sbaglio a cui induce la rappresentazione del Führer. Spiegarlo, renderlo umano, renderlo disumano, farne leggenda, abbassarlo a figurina polverosa, dichiararlo perdente, essere asettici nei suoi confronti: come si vede, tra alcune opzioni di narrazione possibile, ciascuna risulta immorale, eticamente scorretta, sbagliata drammaturgicamente. Ciò semplicemente perché Hitler non è un personaggio. Vollmann coglie proprio questa gigantesca falla, che non si dimostra affatto una chance narrativa: vede il buco bianco Hitler e lo attraversa, facendolo chiudere dall’interno. Questo capitolo di poche pagine, Il sonnambulo, è un’opera nell’opera, è il centro della Centrale Europa narrata con sforzo omerico. In nemmeno venti pagine Vollmann compie un gesto impressionante, che a mio parere non ha pari nella storia della narrativa contemporanea occidentale. Vengono narrate, per brevi metope, alcune diseguali gesta del sonnambulo e della realtà da lui innescata. Il sonnambulo: è scritto così, semplicemente in minuscolo, non nominato se non con questa qualifica che lo mette in contatto con l’umanità, ma anche lo separa dall’umanità, lui che vorrebbe separare l’umanità da se stessa. Non si è mai visto infatti un sonnambulo che lo sia per tutta la sua vicenda esistenziale. In sedici pagine Vollmann esaurisce l’avventura tragica in cui Hitler trascina il mondo, la sua grottesca e quasi ineffata seminagione di male – e ciò senza mitizzare Hitler nemmeno in una frase. Chi scrive ha affrontato di persona, con mezzi di intelletto e vocazione artistica assai inferiori a quelli di Vollmann, il problema della narrazione di Hitler e assicura che quanto è stato realizzato in Europe Central ha dell’incredibile, del sovraumano: e cioè dell’umanissmo. Qui l’arte non sutura affatto la ferita, ma è mimetica dello svuotamento a cui Hitler deve essere sottoposto affinché gli sia impedita ogni vittoria postuma. Ecco un esempio della prosa e della visione e del trattamento che Vollmann riserva a Hitler per svuotarlo trattenendo tutto quanto è stato, in modo che non continui a essere:
“Il sonnambulo, nel suo cappotto grigio chiaro (i nostri ricordi di lui si sono fatti così grigi e sgranati) anela a essere un altro Gunnar. Non è forse un apripista anche lui? Non è forse stato abile a incantare tutti i serpenti fino a quel momento? E la sua Germania sarà Gúthrun. La Germania deve morire feroce, mettendo a fuoco ogni cosa…”
Il sonnambulo sogna cosa? La realtà. Tanto che riesce a muoversi in essa, quasi fosse sveglio, agilmente, non urta, incede. Incide nella realtà e sulla realtà, essendone di fatto separato per un fatto di percezione – per un fatto coscienziale che lo separa dalla veglia e dall’umano. Lo separa sì, ma chi si azzarderebbe a dire che un sonnambulo non appartiene all’umanità?
Basterebbe questo capitolo a se stante, così preciso, così chirurgico, così umile e geniale, a fare di Europe Central un capolavoro. Sarebbe sufficiente, è sicuramente necessario – ma Europe Central è tutt’altro. Questo “romanzo di romanzi” è una scena immane, una piattaforma continentale dove si ergono figure gigantesche, protagonisti di storie e vicende che amplificano le possibilità della storia e aumentano la realtà, rendono testimonianza dell’onnipotenzialità del fato e del lavoro umano – l’umano, questo roditore della storia. Tutto ciò avviene grazie a una centrifuga di nozioni, ricordi, aneddoti, immagini che fa di Vollmann un uomo metatemporale: sembra che costui abbia davvero vissuto per anni e in Germania e in Unione Sovietica e in altre zone dell’Europa, poiché cita con nonchalance i film e le canzonette e le più assurde banalità che significano un tempo. Nonè plausibile immaginare (e lo si comprende dalle imperdibili note a fine volume) quanto l’autore abbia studiato per fondersi immersivamente con la materia storica di cui tratta. E si trattasse soltanto di questo: ma non si tratta di questo soltanto. E’ devastante il procedere visionario, per scatti immaginali e linguistici continui, che il traduttore italiano Gianni Pannofino (qui talmente eccelso da apparire ai limiti della medianità) rende in maniera travolgente, estenuante nel vortice centripeto che è di fatto quell‘Europa ed è anche l’epica di Vollmann. Si stagliano, in un teatro più vasto del continente eurasiatico (la narrazione sconfigge ogni geografia, per estensione e profondità e apici), si ergono inarrivabili figure leggendarie: il generale Von Paulus e Mitja Shostakovich, il regista di regime Karmen e il generale Vlasov, la poetessa Achmatova e l’artista tedesca e comunista Kollwitz, mentre si alternano a sporgersi verso la platea Göring e Goebbels e Stalin in persona e Lenin con la sua ferita e le sue due donne, e invenzioni miracolose di personaggi finzionali ma poderosamente immortali nel pantheon della narrativa contemporanea – un tecnico radiofonico tedesco in campo di battaglia, una spia doppiogiochista nella Berlino spaccata in due, carristi e soldati che entrano in modalità arcade nelle nostre menti, sparando le loro allucinazioni con mitragliate di parole immaginifiche e potenti. Corre, lungo questa narrazione che sembra davvero l’Iliade europea del Novecento, il filo sottile e sempre in vista di Elena di Troia: che in questo caso si chiama ancora Elena, solo che ha un cognome, ed è l’amante di Shostakovich e la coniuge di Karmen, la donna inafferrabile, la rifiutata che rifiuta, la punitrice che commmina la pena, la Parca che è la Musa, il per sempre che è qui e ora: Elena Konstantinovskaja, ovvero il compimento definitivo del portato romantico che affliggeva la letteratura del nostro tempo. Io, da scrittore di modesta caratura (e non lo dico per posa), mi domando come potrò mai, in vita, delineare un personaggio femminile che possa anche solo reggere un pallido confronto con questo assedio all’inassediabile femminino che Vollmann ha creato come se fosse sorto ex nihilo, intervenendo nella storia ma proveniente da altri universi. Elena Konstantinovskaja è la Anna Karenina del nostro tempo. E del resto si può dire che Vollmann è il Tolstoj della nostra epoca. La sua prosa febbrile, storica o di invenzione, avvolgente o travolgente, filosofica o emetica, fantasmatica o lucidamente delirante, capace di giocare a nascondino con ogni emblema e a qualunque latitudine dell’umano regno su questo pianeta – questo miracolo che grazia il nostro tempo di un’apparizione totalmente umanistica: è la presenza inesausta dell’opera d’arte a dispetto dei pessimisti, dei minimalisti del malaugurio, degli stilisti che hanno in testa un canone assurdissimo e tutto nazionale e accentuativo, dei giornalisti che ambiscono a fare gli scrittori e degli scrittori che in realtà fanno i giornalisti.
Vollmann va alle radici di questo tempo, che può essere finale e/o può risultare iniziale. Il canto ambiguo, intimo e politico, descrittivo ed evocativo – questo portento che la fantasia febbrile di Vollmann è riuscita a creare, come se si trattasse di una bolla spaziotemporale e di una zona autonoma in cui sperimentare dolore ed estasi: è il libro d’ore di inizio millennio, che affianca altre tre, quattro scritture fondamentali in questa congiuntura e sparse sul pianeta, tra le quali Vollmann costituisce la possibilità che ciò che una volta fu un immaginario imperiale (l’americano) fuoriesca dall’impero, torni al Vecchio Continente e restituisca il regalo fatto alle Nuove Indie: la scoperta di una terra incognita, cioè la Centrale Europa da cui ha irradiato tutto l’occidente.
Sarei disposto a rimborsarvi di persona, se il libro, una volta esauritolo, vi avesse deluso. Ma siamo tra umanisti, in quanto leggenti, e poi io son povero, come forse anche voi: non in ispirito, ma nelle sostanze. E nonostante ciò lancio un appello accoratissimo: leggete questo libro/esperienza, leggete questo grappolo di universi, piegatevi al ringraziamento e non al culto di William T. Vollmann, lo scrittore più potente della mia generazione a livello globale.
Tutto quanto ho qui scritto è così insufficiente a descrivere questa babele letteraria, è così lontano dal rendere l’idea del flusso potentissimo che è pronto a investire il lettore, che sento la necessità di porgervi le mie scuse per l’inadeguatezza. Davvero: questa volta non trovo le parole.



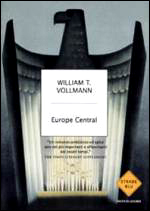 di
di 