di Valerio Cuccaroni
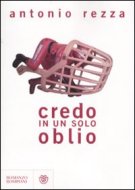 Antonio Rezza, Credo in un solo oblio, Bompiani, 2007, pp. 144, € 14,00.
Antonio Rezza, Credo in un solo oblio, Bompiani, 2007, pp. 144, € 14,00.
Credo in un solo oblio è una boccata di ossigeno per chi nella lettura non cerca evasione, ma un’esperienza di metamorfosi e conoscenza, da cui si esce con le pupille lucidate. Non che si riesca a respirare molto, scorrendo queste pagine asfittiche: si sta piuttosto in apnea e, se non lo si era già, si rischia di diventare claustrofobici.
La storia è quella di uomo che dice di aver avuto una figlia, di nome Maria, da lui tanto amata che ha deciso di tenerne nascosta l’esistenza, sfruttando cinicamente la morte della moglie, uccisa dal parto: «Quando la madre perì dissi ai più cari che aveva perso la bambina».
Ma la sua gelosia è talmente ossessiva, che diventa sospettoso anche di se stesso e per preservarla dal proprio sguardo, decide di rinchiuderla nel pensiero, come Zeus con Atena, ma al contrario: «La presi con le braccia, me la ficcai a forza nella fronte e la nascosi tra le pieghe immacolate della mente per dedicare a lei solo l’idea».
Credo in un solo oblio è un’opera che si inserisce nel raro e prezioso filone degli antiromanzi, dal Codice di Perelà di Palazzeschi a Comiche di Celati e Salto mortale di Malerba, i cui protagonisti sono tutti personaggi da manicomio, anormali, antitetici.
Ecco cosa dice di sé l’Io narrante protagonista di Credo in un solo oblio, dopo aver raccontato l’episodio della figlia: «Di fronte a tal problema quel che faccio importa poco: non lavoro, non ho rapporti sociali, mi sveglio ogni giorno e cado in balia di una deriva implacabile che mi condurrà all’infermità mentale. Esco al mattino e cammino dovunque. E la sera non torno. Scorrazzo anche di notte con il vento che si fa soffio nel mio petto. E certe volte stento a capir chi sono. E mi è caro veder dove conduce il turbamento».
A questo punto inizia un’avventura surrealista che occuperà tutto il resto dell’opera: il nostro (a)eroe va a farsi una foto, senza motivo apparente; non riuscendo a rilassarsi, il fotografo gli dice di sgomberare la mente, così egli tira fuori dalla testa la figlia, sorride, ma non riesce a stare fermo — si muove. Uscirà dallo studio fotografico «intontito con tre instantanee dove non ci sono», con la sensazione che gli manchi qualcosa (la figlia) ed è così che gli spunta un fiore in testa. Come se nulla fosse, va a farsi la carta di identità: l’impiegato, «ricurvo sulle carte», non lo guarda, quindi non lo nota e senza vederlo accetta le sue foto. Circolando con un documento falso, viene arrestato e trascinato in una camionetta con due pregiudicati: uno dei due, quando il nostro (a)eroe gli chiede «Come mai non sono quel sei?», sorride e tira fuori dalla tasca la sua carta di identità: «con mio stupore, ci sono io nella sua foto. Solo io». Ogni foto che vedrà d’ora in poi conterrà la sua immagine. Uscito dal carcere, per evitare un altro posto di blocco, si nasconde nella foto della carta di identità. Sarà il primo di innumerevoli ingressi, a cui corrispondono altrettante uscite, in un mondo popolato di ombre (un Ade contemporaneo).
Non è un caso che l’opera inizi così: come ogni romanzo moderno che si rispetti, Credo in un solo oblio è un’indagine sulla identità, come già Don Chisciotte, sempre in bilico fra conscio e inconscio, fra apparenza-ribalta e realtà-retroscena, fra vita e morte.
L’Io narrante, come ogni Io moderno, è un Io scisso (quando anche la sua ombra lo abbandonerà per unirsi alle altre, confesserà: «la cosa che più mi stordisce è avvertire una scissione dentro di me»), dunque doppio, e sempre dislocato: la discesa nel mondo della foto è una discesa nell’Inconscio, nel lago di Narciso, laddove le identità si confondono e dominano gli istinti di morte (in un gioco perverso di scambi fra vita e immagini, il protagonista ucciderà tutti gli uomini, al solo scopo di fare ordine, cioè di assegnare a ogni tomba la foto del morto corrispondente) e gli istinti libidici (a un certo punto si accoppierà con un’ombra, che partorirà un mostro, l’ombra di un bambino già vecchio).
Specie nelle descrizioni corporali («quella capocchia arroccata sopra un collo che appollaia sulle spalle che s’aggrappano all’addome che accovaccia sul suo culo tramutato in doppia chiappa cadauna abbarbicata sulla coscia che s’impala sullo stinco affossato sopra un piede che nonostante sia insaccato sulla carne maledetta lascia a terra a pena l’orma. Il problema è sempre quello: pesiamo troppo poco per bucare il terreno e seppellirci vivi»), questo «pasticcio allucinato» ricorda da vicino il cinema di Jan vankmajer, cineasta praghese che il suo più noto connazionale Milos Forman ha definito «la somma di Walt Disney e Luis Buñuel».
Se proprio si deve fare un appunto a quest’opera, così densa, piena di interrogativi e sollecitazioni, è l’abuso della parola cazzo: non in quanto corrispettivo gergale del pene, ché risponderebbe alla tendenza espressionista di Rezza, ma in quanto iteriezione, intercalare, perché in questo caso più adatto ai romanzi giovanilistici che allo stile mai banale dell’autore. Per fortuna che Rezza ha saputo ironizzare anche su questo suo tic: «Dio non ci capisco un cazzo più».



