Salamanca 1486. Cristoforo Colombo, davanti al Real Consejo, «presenta la hipótesis de que es posible “buscar el Levante por el Poniente”», suscitando lo scandalo dei dotti. Non solo non esiste alcuna possibilità di raggiungere il Cipango, ma la stessa grande navigazione è un assurdo: a fronte delle misure di Eratostene (peraltro sottovalutate da Colombo) non esistono più i grandi navigatori di un tempo. La navigazione è possibile solo all’interno del conosciuto, ogni mappa essendo già stata disegnata dai cartografi accademici. Colombo parte lo stesso, e torna con evidenze empiriche che dimostrano che la navigazione dalle Canarie al Cipango è fattibile.
I dotti reagiscono con livore. Alcuni rifiutano persino di discuterne – «¡es una tontería!», dichiarano sdegnati. Altri meditano, e dopo ampie consultazioni stabiliscono una linea di condotta: «América existe, es verdad, pero es malo que exista»; la sua scoperta non rappresenta «alguna novedad» rispetto a quanto già si sapeva. E comunque, se a dettare le rotte non sono più i cartografi ufficiali, ma personaggi come questo Cristóbal Cólon, «¿donde iremos a parar?». Così, sintetizzando, Milo Temesvar raccontava, nel suo classico (anche se mai tradotto) The Pathmos Sellers la situazione culturale del suo tempo [1]. Solo del suo tempo?
 Italia, 2008. Alcuni scrittori, al di fuori dei salotti accademici, tentano una diversa navigazione. Provano a tracciare una rotta che colleghi alcune opere della narrativa italiana dell’ultimo decennio: cercano l’allegoritmo della narrativa italiana contemporanea. È una proposta. Con un lessico d’altri tempi, la si chiamerebbe inchiesta e conricerca: termini che sfuggono ai dotti se-dicenti critici marxisti, di quelli che, cantava il poeta, Marx l’hanno letto nei libri di famiglia. Nel “realismo” e nell’ “epica” vengono identificati gli anelli deboli della catena da far saltare, e in Gomorra (libro o film, o entrambi) l’oggetto narrativo su cui esercitare accorti distinguo.
Italia, 2008. Alcuni scrittori, al di fuori dei salotti accademici, tentano una diversa navigazione. Provano a tracciare una rotta che colleghi alcune opere della narrativa italiana dell’ultimo decennio: cercano l’allegoritmo della narrativa italiana contemporanea. È una proposta. Con un lessico d’altri tempi, la si chiamerebbe inchiesta e conricerca: termini che sfuggono ai dotti se-dicenti critici marxisti, di quelli che, cantava il poeta, Marx l’hanno letto nei libri di famiglia. Nel “realismo” e nell’ “epica” vengono identificati gli anelli deboli della catena da far saltare, e in Gomorra (libro o film, o entrambi) l’oggetto narrativo su cui esercitare accorti distinguo.
Tormentato dai dubbi, Andrea Cortellessa osserva, con l’acume che gli è proprio: « Se però qualcosa in comune c’è fra “realismo” ed “epica” è che sono connotati attribuiti alla narrativa soprattutto nel secolo del realismo senza “nei” e dell’epica borghese di Hegel. Tutto questo new non sarà un ritorno al buon vecchio Ottocento? E non sa ancora di postmoderno questo tentativo di aggirare la modernità?» [2].
A garantirgli sonni tranquilli interviene Romano Luperini: «Un semplice restauro di forme desuete sarebbe solo un artificio rassicurante: di quelli che da sempre richiede l’industria culturale. Se parliamo di “ritorno alla realtà” è perché si affacciano nuove realtà che non possono essere rappresentate con strumenti legati a momenti storici così diversi dal nostro».
Degno di nota è che il gesto stilistico di Cortellessa e Luperini anticipi l’esplicita rivendicazione di un approccio “neo-realistico” da parte di Giancarlo De Cataldo e Massimo Carlotto [3]. E poiché di neorealismo si parla, sarà bene specificare che «un film come Gomorra, del resto, non ha nulla della carica volontaristicamente ideologica, e della struttura di racconto talora semplificata, di tanto neorealismo».
 Cortellessa è un curioso individuo, con strani riflessi condizionati: legge “Dio” e gli scatta il frame mnemonico “Provvidenza manzoniana” [4], legge “epica” e gli scatta il frame “Estetica di Hegel”. Sembra che il “buon vecchio Ottocento” gli sfugga dal subconscio non appena l’ego razionale si assopisce e non riesce a censurare quei piccoli segreti sporchi che ciascuno di noi cerca di nascondere a se stesso. E così — atto mancato o falso movimento? — dimentica che il termine “epica” connota la narrativa anche ai tempi, tutt’altro che buoni e vecchi, di un certo Walter Benjamin, che sul teatro epico di Brecht ha scritto un saggio [5] nel quale sono già teorizzati alcuni dei caratteri che oggi emergono nel romanzo e nel cinema del NIE.
Cortellessa è un curioso individuo, con strani riflessi condizionati: legge “Dio” e gli scatta il frame mnemonico “Provvidenza manzoniana” [4], legge “epica” e gli scatta il frame “Estetica di Hegel”. Sembra che il “buon vecchio Ottocento” gli sfugga dal subconscio non appena l’ego razionale si assopisce e non riesce a censurare quei piccoli segreti sporchi che ciascuno di noi cerca di nascondere a se stesso. E così — atto mancato o falso movimento? — dimentica che il termine “epica” connota la narrativa anche ai tempi, tutt’altro che buoni e vecchi, di un certo Walter Benjamin, che sul teatro epico di Brecht ha scritto un saggio [5] nel quale sono già teorizzati alcuni dei caratteri che oggi emergono nel romanzo e nel cinema del NIE.
Benjamin fa questo effetto: se l’hai letto per davvero, ti spunta fuori anche se non te ne accorgi; se l’hai sleggiucchiato solo per poterne parlare in società, non lo riconosci in chi cerca di pensare (non a Benjamin, ma) come Benjamin. La presa di posizione di un lettore collettivo co-interessato, la dilatazione epica degli eventi storici, il carattere anti-tragico agevolato dalla narrazione di lungo periodo, lo stupore in luogo dell’immedesimazione e la rappresentazione di situazioni (ciò che Brecht chiamava “straniamento”), l’attenzione al gesto, il ruolo attivo dello spettatore sono tanti piccoli concetti che Benjamin e Bertolt Brecht hanno messo in salvo nello zainetto delle cose da portare nel Terzo Millennio: uno zainetto che, assieme a quello di Calvino, i narratori italiani hanno trovato e aperto. Ed hanno cominciato ad usare quegli strumenti.
Epperò, ammonisce Luperini, «ogni generazione deve trovare le forme in cui dire la propria realtà: non quella di sessant’anni fa!» Il NIE è nuovo realismo, cioè neorealismo, e il neorealismo è storia, è — riproposto oggi – «vuota convenzione». E Gomorra di Matteo Garrone, incalza Cortellessa, «convince soprattutto per la netta soluzione di continuità con la tradizione del realismo».
Sarà… però qualcosa non mi torna. Più di qualcosa, a dire il vero. Da autore di opere “neo-epiche” col duplice vizio di prendere le parole sul serio e di sospettare sempre di loro, ho provato a prendere sul serio l’accusa di neorealismo [6]. Risfogliandomi, ça va sans dire, i due capitoli di Gilles Deleuze sul cinema neorealista, [7] che dicono sulla letteratura neorealista molto più di qualunque schematizzazione critico-letteraria.
Che cos’è il neorealismo? Qualcosa di più dell’impasto di populismo, miseria e melò, della «bella Lucia Bosé in veste da contadinella nei campi della ciociaria» e delle «cosce oniriche» di Silvana Mangano, ma senza una sana coscienza di classe marxiana descritto da Natalia Aspesi [8].
Il neorealismo ha a che fare — sostiene Deleuze — con una nuova forma di realtà dispersiva, ellittica, errabonda, che opera per blocchi, con legami deliberatamente deboli ed eventi fluttuanti: «il reale non è più rappresentato o riprodotto, ma “mostrato”. Invece di mostrare un reale già decifrato, il neorealismo mostrava un reale ancora da decifrare, ambiguo; è il motivo per cui il piano-sequenza tende a rappresentare il montaggio di rappresentazioni». È il motivo per cui, per mostrare con un esempio come criteri formali si rovescino in elementi contenutistici, la corsa di Anna Magnani in Roma città aperta dietro il camion nazista è arte [clicca sull’immagine per vederla], il suo remake di Martina Stella dietro la macchina di Stefano Accorsi in L’ultimo bacio no.
Di più: il neorealismo ha espresso, prima della Nouvelle Vague e del cinema americano del dopoguerra, gli elementi di svolta che rovesciano la crisi del cinema basato sull’immagine-azione nel cinema dell’immagine-movimento. Si tratta di cinque caratteristiche fondamentali, la cui presenza nel neorealismo dà ragione della potenza di essere insita in questa forma cinematografica, e legittima l’uso del termine “neorealismo” per designare una forma narrativa (filmica o letteraria) che risponda a queste caratteristiche, indipendentemente dalle forme e i mezzi che adotta.
1. Situazione dispersiva.
La nuova immagine cinematografica non rinvia a una situazione sintetizzata o compiuta, ma a un insieme di personaggi legati da interferenze deboli, che possono mutare statuto e diventare da secondari principali, o viceversa. Deleuze indica il cinema di Robert Altman, e in particolare Nashville, come punto di arrivo di questa immagine: non ha avuto il tempo di aggiungere Short Cuts (America oggi), e con lui i racconti di Raymond Carver, che ancora qualcuno si ostina a considerare minimalista. Il punto di partenza è, com’è ovvio, la rappresentazione urbana dell’Italia di Rossellini e De Sica durante e dopo la guerra.
2. Relazioni volutamente deboli.
In luogo di un universo in cui gli eventi si prolungano l’uno nell’altro e gli spazi sono saldamente raccordati, la nuova immagine fa della forma ellittica non un modo di raccontare, ma la sostanza stessa del racconto: «i concatenamenti, i raccordi e i legami sono deliberatamente deboli. Il caso diventa il solo filo conduttore». Quintet di Altman e Taxi Driver di Martin Scorsese portano negli anni Settanta quella potenza dell’accidentale esplorata da Visconti in Ossessione.
3. Uso della forma-passeggiata.
La camminata continua, l’andata-e-ritorno, il bisogno interiore o esteriore di una fuga. L’attraversamento dell’America in Easy Rider o di Roma in Ladri di biciclette, la fuga in A bout de souffle: e come non pensare, anticipando l’argomentazione, a quella moderna Anabasi che è l’intero ciclo russo di Mario Rigoni Stern (ma anche La storia di Tönle)?
4. Uso dei clichés.
«Ci si chiede cosa permette di mantenere un carattere d’insieme in questo mondo senza totalità né relazioni. La risposta è semplice: ciò che costituisce l’insieme sono i cliché […], gli stereotipi correnti di un’epoca o di un momento, slogan sonori e visivi che Dos Passos chiama “attualità”». Il cliché è veicolo d’una proiezione dell’interiorità sul mondo, e dell’interiorizzazione soggettiva di una condizione sociale. C’è tutto un mondo di criteri formali dietro le facce sconosciute degli attori non-professionisti di De Sica, ma anche dietro la scelta di attori comici e cantanti (Totò, Franchi e Ingrassia, Modugno) in Pasolini (Che cosa sono le nuvole?) [9]: un mondo che fa propria l’idea (di origine romantica) di una sola identica miseria, interiore ed esteriore. E della possibilità di esprimere l’una attraverso l’altra, e viceversa.
5. Denuncia di un complotto.
In un mondo caotico e attraversato da relazioni instabili, la circolazione dei cliché dall’interno all’esterno, dal fuori al dentro prende la forma di un “grande complotto” acentrico: non un’organizzazione che «rimanderebbe a luoghi distinti ed azioni assegnabili attraverso le quali si individuano i criminali», ma a «un potere occulto che si confonde con i suoi effetti, i suoi mezzi». Come La conversazione di Francis Ford Coppola; o come i due romanzi-emblema del NIE: Q e Romanzo criminale. Le radici neorealistiche di questo ambiente sono ad esempio presenti nella rappresentazione tanto delle reti partigiane quanto delle milizie nazi-fasciste in Beppe Fenoglio, o nell’assente presenza dei combattenti russi nel Sergente nella neve. Notevole che Deleuze, nel derivare questo tratto dal neorealismo, lo ponga in esplicita opposizione col cinema nero del realismo americano: quel noir che critici come La Porta e Berardinelli continuano a credere in atto nei romanzi che recensiscono, fermandosi alla quarta di copertina, come “romanzi di genere” dai quali trasparirebbe un desiderio di internazionalismo – «gli scrittori italiani non vogliono essere scrittori italiani» [10].
 Guardando alla luce di questi tratti Gomorra di Garrone non è difficile riconoscervi all’opera, oltre a buona parte dei tratti caratterizzanti il NIE (come hanno dimostrato Gervasini e De Cataldo), tutte e cinque queste categorie. Certo, attraverso nuove forme espressive e nuovi strumenti, come l’uso della camera a mano: un mezzo le cui potenzialità, dopo Lars von Trier (e Soderbergh), sono oggi all’acme. Un mezzo che è stato ideato per primo da Antonioni, per il piano-sequenza finale di Professione: reporter che portava a perfezione quel movimento di macchina interno-esterno che è stato una delle cifre stilistiche dell’epica di John Ford. Michelangelo Antonioni: il regista che ha portato a un punto di non-ritorno (come il suo corrispondente Rothko nella pittura) il valore relativo, se non l’indiscernibilità, tra la dimensione esteriore e quella interiore, all’interno della situazione filmica, «come se il reale e l’immaginario si rincorressero l’un l’altro, si riflettessero l’uno nell’altro attorno a un punto d’indiscernibilità». E dunque di cinema neorealista si tratta, sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista estetico-formale. Con buona pace delle risibili critiche a Saviano ieri [11], e a Paolo Sorrentino oggi, sull’aver “sporcato” la ricostruzione realistica con inserzioni di fantasia.
Guardando alla luce di questi tratti Gomorra di Garrone non è difficile riconoscervi all’opera, oltre a buona parte dei tratti caratterizzanti il NIE (come hanno dimostrato Gervasini e De Cataldo), tutte e cinque queste categorie. Certo, attraverso nuove forme espressive e nuovi strumenti, come l’uso della camera a mano: un mezzo le cui potenzialità, dopo Lars von Trier (e Soderbergh), sono oggi all’acme. Un mezzo che è stato ideato per primo da Antonioni, per il piano-sequenza finale di Professione: reporter che portava a perfezione quel movimento di macchina interno-esterno che è stato una delle cifre stilistiche dell’epica di John Ford. Michelangelo Antonioni: il regista che ha portato a un punto di non-ritorno (come il suo corrispondente Rothko nella pittura) il valore relativo, se non l’indiscernibilità, tra la dimensione esteriore e quella interiore, all’interno della situazione filmica, «come se il reale e l’immaginario si rincorressero l’un l’altro, si riflettessero l’uno nell’altro attorno a un punto d’indiscernibilità». E dunque di cinema neorealista si tratta, sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista estetico-formale. Con buona pace delle risibili critiche a Saviano ieri [11], e a Paolo Sorrentino oggi, sull’aver “sporcato” la ricostruzione realistica con inserzioni di fantasia.
Bene: se adesso apro un paio di testi esemplari del neorealismo letterario italiano, trovo sin dagli incipit le caratteristiche che Deleuze rinviene nel cinema, e alle quali attribuisce il titolo di neorealismo. E che oggi ritrovo nella narrativa che cerchiamo di leggere come New Italian Epic.
Le prime pagine di Cronaca di poveri amanti (1947) di Vasco Pratolini mostrano in atto quelle caratteristiche neorealistiche sopra elencate. Quel prendere per mano il lettore e portarlo all’interno di una scena creata scomponendo la “realtà” e ricomponendola per gesti, oggetti, suoni il cui unico legame è una semplice successione temporale; quel piano-sequenza nel quale si prepara già l’inserzione di elementi lessicali fiorentini; quel punto di vista spiazzante, che è ora il canto del gallo, ora la ronda della polizia, ora il gesto del superstizioso fattore: il microcosmo di via del Corno disomogeneo, granulare, dalle relazioni ora dense ora ambigue o flebili è già tutto qui, prima ancora che compaia quel basco comunista che ha permesso a tanta critica distratta di sminuire come ideologico il neorealismo di Pratolini. Ed è già pronta la peculiare mimesi linguistica dello scrittore fiorentino, che si muove in una lingua “maggiore” (il toscano) trattandola come una lingua dialettale, cioè minore: un toscano in divenire, sul punto di transitare dal gergo all’italiano.
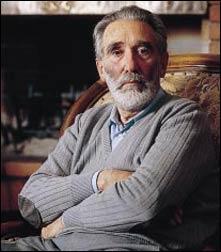 Diversamente da Pratolini, Mario Rigoni Stern (mi sia permesso di dire: fino a pochi giorni fa il più grande scrittore italiano vivente) usa i dialetti come cliché linguistici. Il reggimento alpino in Russia è una piccola babele nella quale l’italiano si ricompone a posteriori come lingua media (media anche tra un lessico medio-ordinario e un lessico ricercato-tradizionale): e c’è voluto Marco Paolini per renderne tutte le sfumature [clicca sull’immagine per vedere un estratto]. Ho già detto come il topos dell’Anabasi ridiventi attuale nel ciclo russo. Ma anche in un piccolo gioiello narrativo come il racconto In un villaggio sepolto nella Balka [12] – una piccola anabasi privata [13] – è introdotto, eccentricamente, da un mulinare di neve che scandisce, nella sua ingovernabilità, un tempo del ritorno e delle pause lento come il tempo scandito da una candela (quella di una poesia di Boris Pasternak, alla quale s’è ispirato Rigoni Stern). E in questa sospesa lentezza tutto è già preparato per l’inatteso rovesciamento delle relazioni tra il soldato italiano Marco e il vecchio russo, in questo mulinare della neve che avvolge tutto e ricostruisce nella tormenta un mondo unificato dal silenzio, un orizzonte nel quale il tempo sospeso sarà ricomposto collegando eventi lontanissimi nello spazio e nel tempo, attraverso una semplice frase: «Mi, Marco, son to pare».
Diversamente da Pratolini, Mario Rigoni Stern (mi sia permesso di dire: fino a pochi giorni fa il più grande scrittore italiano vivente) usa i dialetti come cliché linguistici. Il reggimento alpino in Russia è una piccola babele nella quale l’italiano si ricompone a posteriori come lingua media (media anche tra un lessico medio-ordinario e un lessico ricercato-tradizionale): e c’è voluto Marco Paolini per renderne tutte le sfumature [clicca sull’immagine per vedere un estratto]. Ho già detto come il topos dell’Anabasi ridiventi attuale nel ciclo russo. Ma anche in un piccolo gioiello narrativo come il racconto In un villaggio sepolto nella Balka [12] – una piccola anabasi privata [13] – è introdotto, eccentricamente, da un mulinare di neve che scandisce, nella sua ingovernabilità, un tempo del ritorno e delle pause lento come il tempo scandito da una candela (quella di una poesia di Boris Pasternak, alla quale s’è ispirato Rigoni Stern). E in questa sospesa lentezza tutto è già preparato per l’inatteso rovesciamento delle relazioni tra il soldato italiano Marco e il vecchio russo, in questo mulinare della neve che avvolge tutto e ricostruisce nella tormenta un mondo unificato dal silenzio, un orizzonte nel quale il tempo sospeso sarà ricomposto collegando eventi lontanissimi nello spazio e nel tempo, attraverso una semplice frase: «Mi, Marco, son to pare».
 In cosa sono neorealisti e al tempo stesso epici Pratolini [a sinistra] e Rigoni Stern? Nella narrazione di un reale che non “sta là fuori”, che viene scomposto e ricomposto a partire da elementi che pure esistono — nulla appare invano, nel neorealismo. Nella composizione e scomposizione delle relazioni; nel continuo passare da una dimensione interiore, sentimentale o della memoria, ad una dimensione esteriore, storica. In una accurata mimesi linguistica che nasconde sotto il tappeto della lingua apparentemente media i propri giochi linguistici. E in cosa il NIE è neorealista? Nell’assunzione etica di un reale che non è mai “naturale” né “naturalistico”; nel versare la complessità narrativa in un’attitudine popolare; nel gioco tra caso e necessità; nel proporre, sottotraccia, una lingua in divenire, correlativo oggettivo di un’identità in divenire.
In cosa sono neorealisti e al tempo stesso epici Pratolini [a sinistra] e Rigoni Stern? Nella narrazione di un reale che non “sta là fuori”, che viene scomposto e ricomposto a partire da elementi che pure esistono — nulla appare invano, nel neorealismo. Nella composizione e scomposizione delle relazioni; nel continuo passare da una dimensione interiore, sentimentale o della memoria, ad una dimensione esteriore, storica. In una accurata mimesi linguistica che nasconde sotto il tappeto della lingua apparentemente media i propri giochi linguistici. E in cosa il NIE è neorealista? Nell’assunzione etica di un reale che non è mai “naturale” né “naturalistico”; nel versare la complessità narrativa in un’attitudine popolare; nel gioco tra caso e necessità; nel proporre, sottotraccia, una lingua in divenire, correlativo oggettivo di un’identità in divenire.
Restiamo su quest’ultimo punto (e pazienza se la mimesi linguistica del NIE viene negata da certa critica: hanno da fare i critici, mica possono leggere tutti i libri di cui parlano!). Nel NIE compaiono spesso figure della marginalità, della devianza, dell’universo migrante. Come i proletari fiorentini di Pratolini, come gli alpini di Russia e i montanari della piana d’Asiago di Rigoni Stern, il NIE mette in vibrazione il mondo dal punto di vista degli ultimi. La precarizzazione è la cifra esistenziale di molta parte del NIE: sul piano del contenuto. Intendiamoci, conoscere Edward Said (e possibilmente non solo lui, nella più che ventennale produzione degli studi postcoloniali) è oggi quasi imprescindibile: ma alcuni autori del NIE i migranti li conoscono non solo per averne letto, ma per averci lottato assieme, per trovarseli accanto sui luoghi di lavoro, nelle strade delle periferie: e si vede, nei loro romanzi.
Sul piano dell’espressione, il NIE opera, sia rispetto ai generi che rispetto alla lingua, secondo quello che Naoki Sakai, uno dei più interessanti studiosi postcoloniali, chiama vivere in traduzione [14]. All’interno dell’apparente lingua media (ciò che Sakai chiama «indirizzo linguistico omolinguale») in cui i diversi idioletti del mondo sono forzatamente tradotti (così come il capitale traduce nel codice del valore di scambio ogni diversità e ogni differenza), gli autori del NIE cercano di far vibrare cliché linguistici, dialetti, slang, gerghi. La critica accademica vi vede solo “sfondamenti” nel linguaggio della televisione e dei media, laddove si tentano esperimenti di traduzione eterolinguistica della lingua comune, si prova a passare dall’Uno ai molti, dalla lingua del potere a quello delle moltitudini delle periferie, delle fabbriche, dei barconi. Di dar voce a quel gigantesco Pequod che è l’Italia.
Per far questo, e per riconoscerlo, nulla di più alieno da noi della riproposizione — questa sì, reazionaria e regressiva — dell’intellettuale separato, a parte, relegato, ai margini: il narratore è migrante e clandestino perché siamo tutti migranti e clandestini.
Solo: alcuni lo sanno, altri no.
Hic Rodhus, hic salta.
NOTE
1. Milo Temesvar, The Pathmos Sellers, Rutgers-Newark, N.J., Seven Types Press, 1961. A scanso di equivoci, sarà bene precisare che quella di Temesvar è una metafora. Il dibattito di Salamanca non verteva, con buona pace di qualche sprovveduta critica, sul fatto che la terra fosse tonda anziché piatta, ma sulla effettiva distanza del Giappone rispetto alle Canarie secondo i divergenti calcoli di Eratostene e Posidonio.
2. Andrea Cortellessa, Scrittori con i piedi per terra. Dialogo sul neo-neorealismo dopo il trionfo di “Gomorra” a Cannes, “La Stampa”, 30 maggio 2008 [qui]
3. Giancarlo De Cataldo, Raccontare l’Italia senza paura di sporcarsi le mani, “Repubblica”, 8 giugno 2008; Massimo Carlotto, Legalità d’evasione, “il Manifesto”, 13 giugno 2008 [qui].
4. Andrea Cortellessa, Ammaniti, l’ovvio dei popoli, “La Stampa, 20 novembre 2006 [qui]
5. Walter Benjamin, Che cos’è il teatro epico? , in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1966, pp. 125-135.
6. Termine che per altro avevo proposto di adottare quasi cinque anni fa [qui]
7. Gilles Deleuze, La crise de l’image-action, in Cinéma 1. L’image-mouvement, Minuit, Paris, 1983, pp. 266-290; Au-delà de l’image-mouvement, in Cinéma 2. L’image-temps, Minuit, Paris, 1985, pp. 7-37. Le citazioni che seguono sono tradotte da questi due testi.
8. Natalia Aspesi, Quel bianco e nero populista e un po’ melò non è mai stato la voce del dissenso, “Repubblica”, 8 giugno 2008.
10. Alfonso Berardinelli, in Francesco Borgonovo, La rinascita dell’epica? «È soltanto autopromozione», “Libero”, 1 giugno 2008.
11. Filippo La Porta, in Francesco Borgonovo, «Cari scrittori, non raccontate balle», “Libero”, 4 gennaio 2008.
12. In Storie dell’altipiano, Meridiano Mondadori, Milano, 2003, pp. 837-853.
13. Diremo, col “trotzkista patafisico” Cordelli, (Destra eccentrica, “Corriere della sera”, 4 giugno 2008) che anche Rigoni Stern regredisce nella destra eccentrica col suo far scivolare i valori comuni nel fatto individuale? O seppelliremo il critico con una sonora risata?
14. Vedi la mia recensione a Sandro Mezzadra, La condizione postcoloniale qui.





