di Armando Lancellotti
 Come sanno tutti coloro che si occupano e si interessano dell’argomento trattato dal libro di Simone Belladonna – Gas in Etiopia. I crimini rimossi dell’Italia coloniale, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2015, l’ultimo e più recente lavoro uscito sulla questione – solo nel 1996 il generale Domenico Corcione, Ministro della difesa dell’allora governo Dini, ammise l’uso di gas e di aggressivi chimici da parte delle truppe italiane impiegate nella guerra d’Etiopia del 1935/’36. A sessant’anni esatti da quei tragici e criminosi fatti, le autorità e le istituzioni italiane, seppur in modo troppo blando e tardivo rispetto alla gravità dell’accaduto, prendevano una decisione di fatto non più differibile, visti i cospicui risultati raccolti nel frattempo dalla ricerca storica nonostante i numerosi ostacoli incontrati e, spesso, da quelle stesse istituzioni frapposti, e abbandonavano, quindi, quell’imbarazzante atteggiamento omertoso che aveva contribuito in modo decisivo a censurare e ad allontanare dall’orizzonte della memoria collettiva italiana i crimini coloniali ed in particolare quelli commessi in A.O.I. (Africa Orientale Italiana). Ben tre interpellanze parlamentari e il lungo ed aspro, nonché noto, confronto polemico, consumatosi a mezzo stampa, tra Angelo Del Boca e Indro Montanelli avevano finalmente acceso e puntato i riflettori di una parte almeno dell’opinione pubblica sul passato coloniale italiano, su pagine di “storia patria” in buona sostanza sconosciute o quasi a molti italiani. Il successore alla Difesa di Domenico Corcione, cioè Beniamino Andreatta, ministro del primo governo Prodi, si trovò ad affrontare nel 1997 lo scandalo dei crimini commessi dai soldati italiani in Somalia durante la missione ONU nota come Restore Hope, a cui l’Italia partecipò con un impiego di uomini, denominato Missione Ibis, inferiore solo a quello statunitense e con cui non si lasciò sfuggire l’occasione né di rimettere piede in una sua ex colonia del Corno d’Africa, né di macchiarsi di violenze e crimini contro civili, come già accaduto in epoca fascista.
Come sanno tutti coloro che si occupano e si interessano dell’argomento trattato dal libro di Simone Belladonna – Gas in Etiopia. I crimini rimossi dell’Italia coloniale, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2015, l’ultimo e più recente lavoro uscito sulla questione – solo nel 1996 il generale Domenico Corcione, Ministro della difesa dell’allora governo Dini, ammise l’uso di gas e di aggressivi chimici da parte delle truppe italiane impiegate nella guerra d’Etiopia del 1935/’36. A sessant’anni esatti da quei tragici e criminosi fatti, le autorità e le istituzioni italiane, seppur in modo troppo blando e tardivo rispetto alla gravità dell’accaduto, prendevano una decisione di fatto non più differibile, visti i cospicui risultati raccolti nel frattempo dalla ricerca storica nonostante i numerosi ostacoli incontrati e, spesso, da quelle stesse istituzioni frapposti, e abbandonavano, quindi, quell’imbarazzante atteggiamento omertoso che aveva contribuito in modo decisivo a censurare e ad allontanare dall’orizzonte della memoria collettiva italiana i crimini coloniali ed in particolare quelli commessi in A.O.I. (Africa Orientale Italiana). Ben tre interpellanze parlamentari e il lungo ed aspro, nonché noto, confronto polemico, consumatosi a mezzo stampa, tra Angelo Del Boca e Indro Montanelli avevano finalmente acceso e puntato i riflettori di una parte almeno dell’opinione pubblica sul passato coloniale italiano, su pagine di “storia patria” in buona sostanza sconosciute o quasi a molti italiani. Il successore alla Difesa di Domenico Corcione, cioè Beniamino Andreatta, ministro del primo governo Prodi, si trovò ad affrontare nel 1997 lo scandalo dei crimini commessi dai soldati italiani in Somalia durante la missione ONU nota come Restore Hope, a cui l’Italia partecipò con un impiego di uomini, denominato Missione Ibis, inferiore solo a quello statunitense e con cui non si lasciò sfuggire l’occasione né di rimettere piede in una sua ex colonia del Corno d’Africa, né di macchiarsi di violenze e crimini contro civili, come già accaduto in epoca fascista.
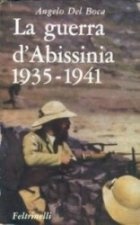 Si potrebbe pertanto supporre che a partire da queste vicende della metà dagli anni ’90, ricostruite ed analizzate nel dettaglio anche da Simone Belladonna nel suo libro, sia andato via via aumentando l’interesse per l’imperialismo italiano e soprattutto per gli aspetti peggiori e criminali di esso (o “più criminali”, si potrebbe dire, essendo un’aggressione coloniale già in quanto tale definibile, oggi, come un crimine contro l’umanità, se si applica l’art.7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1998) e che all’infaticabile e meritorio lavoro di ricerca storica di Angelo Del Boca innanzi tutto, che già a metà degli anni ’60 faceva uscire il suo primo libro sulla guerra d’Abissinia, e di Giorgio Rochat in secondo luogo, si siano aggiunti gli sforzi di altri storici e ricercatori. Ed in parte è quanto è accaduto, poiché al maggior africanista italiano e all’esperto studioso di storia militare sopra citati si sono affiancati, sia prima sia dopo le ammissioni governative del 1996, altri storici che con i loro lavori hanno di molto ampliato ed arricchito, per quantità e qualità, la conoscenza sia della guerra d’Etiopia e dell’uso di gas e armi chimiche in particolare, sia, più in generale, di altre pagine cupe della nostra storia recente: l’imperialismo italiano nel suo complesso e i crimini dalle nostre truppe commessi non solo in Abissinia, ma anche in Libia, oppure nei Balcani durante il secondo conflitto mondiale; i campi di internamento per civili su suolo italiano o nelle zone di occupazione militare, ecc. Per citarne alcuni, con la consapevolezza di, involontariamente, dimenticarne altri, si possono ricordare i lavori di: A. Aruffo, L. Borgomaneri, D. Bidussa, A. Burgio, I. Campbell, S. Capogreco, M. Dominioni, F. Focardi, N. Labanca, G. Oliva, D. Rodogno, E. Salerno ed anche S. Belladonna, il cui libro da poco dato alle stampe costituisce l’occasione per la stesura di queste riflessioni.
Si potrebbe pertanto supporre che a partire da queste vicende della metà dagli anni ’90, ricostruite ed analizzate nel dettaglio anche da Simone Belladonna nel suo libro, sia andato via via aumentando l’interesse per l’imperialismo italiano e soprattutto per gli aspetti peggiori e criminali di esso (o “più criminali”, si potrebbe dire, essendo un’aggressione coloniale già in quanto tale definibile, oggi, come un crimine contro l’umanità, se si applica l’art.7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1998) e che all’infaticabile e meritorio lavoro di ricerca storica di Angelo Del Boca innanzi tutto, che già a metà degli anni ’60 faceva uscire il suo primo libro sulla guerra d’Abissinia, e di Giorgio Rochat in secondo luogo, si siano aggiunti gli sforzi di altri storici e ricercatori. Ed in parte è quanto è accaduto, poiché al maggior africanista italiano e all’esperto studioso di storia militare sopra citati si sono affiancati, sia prima sia dopo le ammissioni governative del 1996, altri storici che con i loro lavori hanno di molto ampliato ed arricchito, per quantità e qualità, la conoscenza sia della guerra d’Etiopia e dell’uso di gas e armi chimiche in particolare, sia, più in generale, di altre pagine cupe della nostra storia recente: l’imperialismo italiano nel suo complesso e i crimini dalle nostre truppe commessi non solo in Abissinia, ma anche in Libia, oppure nei Balcani durante il secondo conflitto mondiale; i campi di internamento per civili su suolo italiano o nelle zone di occupazione militare, ecc. Per citarne alcuni, con la consapevolezza di, involontariamente, dimenticarne altri, si possono ricordare i lavori di: A. Aruffo, L. Borgomaneri, D. Bidussa, A. Burgio, I. Campbell, S. Capogreco, M. Dominioni, F. Focardi, N. Labanca, G. Oliva, D. Rodogno, E. Salerno ed anche S. Belladonna, il cui libro da poco dato alle stampe costituisce l’occasione per la stesura di queste riflessioni.
 Ma se dall’ambito ristretto degli addetti ai lavori, degli storici e dei lettori interessati al passato coloniale italiano otto-novecentesco ci spostiamo in direzione dell’opinione pubblica, da intendersi in questo caso come consapevolezza e conoscenza diffuse dell’imperialismo italiano, delle sue guerre e delle sue politiche di repressione e occupazione, allora lo scenario cambia bruscamente e si delinea un quadro di sostanziale ignoranza, formatasi nel corso degli ultimi settant’anni che ci separano dalla fine della seconda guerra mondiale e dalla perdita dell’impero; insipienza che va addirittura oltre l’amnesia o il ricordo sfocato e impreciso di un passato che inevitabilmente si allontana sempre più, perché consiste in una sostanziale non conoscenza di quel passato, cioè di un pezzo della nostra storia lungo una sessantina d’anni, quelli che separano l’Italia di Depretis da quella di Mussolini e del secondo conflitto mondiale, in quanto fu a partire dagli anni ’80 del XIX secolo fino alla guerra d’Etiopia e conseguente proclamazione dell’impero del 1935/’36 che l’Italia interpretò a più riprese una politica imperialistica di conquista coloniale dell’agognato “posto al sole” in terra d’Africa.
Ma se dall’ambito ristretto degli addetti ai lavori, degli storici e dei lettori interessati al passato coloniale italiano otto-novecentesco ci spostiamo in direzione dell’opinione pubblica, da intendersi in questo caso come consapevolezza e conoscenza diffuse dell’imperialismo italiano, delle sue guerre e delle sue politiche di repressione e occupazione, allora lo scenario cambia bruscamente e si delinea un quadro di sostanziale ignoranza, formatasi nel corso degli ultimi settant’anni che ci separano dalla fine della seconda guerra mondiale e dalla perdita dell’impero; insipienza che va addirittura oltre l’amnesia o il ricordo sfocato e impreciso di un passato che inevitabilmente si allontana sempre più, perché consiste in una sostanziale non conoscenza di quel passato, cioè di un pezzo della nostra storia lungo una sessantina d’anni, quelli che separano l’Italia di Depretis da quella di Mussolini e del secondo conflitto mondiale, in quanto fu a partire dagli anni ’80 del XIX secolo fino alla guerra d’Etiopia e conseguente proclamazione dell’impero del 1935/’36 che l’Italia interpretò a più riprese una politica imperialistica di conquista coloniale dell’agognato “posto al sole” in terra d’Africa.
E non si trattò, come la vulgata più diffusa vorrebbe, di un colonialismo minore, più proclamato che praticato, ovvero, addirittura, bonario e benevolo, nonché – come ogni colonialismo occidentale ha sempre preteso di essere – civilizzatore. Per ambizioni e finalità, non ebbe molto da invidiare a quello di altre potenze europee del tempo e il suo carattere “tardivo” fu motivato dall’altrettanto tarda unificazione nazionale, un po’ come accadde all’imperialismo tedesco, bismarckiano prima e guglielmino poi. Prese le mosse, la conquista italiana di un “posto al sole”, negli anni ’80 dell’Ottocento e conobbe un momento apicale con la guerra italo-turca per la Libia del 1911/’12 e, quindi, nella sua fase “liberale” e non ancora fascista, si sviluppò negli stessi decenni in cui, per fare qualche esempio, la Francia si impossessò di Tunisia, Indocina, Marocco e l’Inghilterra prese il controllo di Suez e dell’Egitto, tasselli essenziali e strategici dei rispettivi imperi. Certamente i risultati italiani furono di ben minore portata, ma questo lo si dovette soprattutto a rapporti di forza nello scacchiere internazionale ed africano nei quali l’Italia era la parte debole, non certo alle intenzioni dei governi italiani, della classe dirigente liberale e dei settori del mondo economico coinvolti, soprattutto dai tempi di Crispi in poi. Per farsi largo tra le potenze del tempo, l’Italia intraprese due grandi guerre coloniali, che aggiunsero ulteriori elementi di criticità ai già incrinati e logori rapporti dei rispettivi scenari internazionali, che, pochi anni dopo l’una e l’altra guerra italiana, avrebbero condotto ai due conflitti mondiali: si tratta della già citata guerra di Libia e, ovviamente, di quella d’Etiopia. Ma il numero delle guerre potrebbe raddoppiare se si considera che tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, l’Italia – già fascista – fu impegnata nella riconquista di Tripolitania e Cirenaica e che quella del 1935/’36 fu, in realtà, la seconda guerra per l’Abissinia, preceduta da quella crispina, conclusasi con la disfatta di Adua del 1896, che costò più vittime di tutte le guerre risorgimentali messe assieme. La mussoliniana aggressione dell’impero etiope, poi, fu realizzata con un dispiegamento di uomini, mezzi, forze mai visto prima in una guerra africana o coloniale, tanto che, come ricorda Belladonna (S. Belladonna, cit, p.19) sulla scorta delle analisi di G. Rochat, si deve parlare di una guerra “nazionale”, non solo coloniale. «Guerra coloniale voleva dire un corpo di spedizione piccolo con molte truppe africane, obiettivi limitati e tempi lunghi, poca pubblicità e scarso coinvolgimento dell’opinione pubblica (come la riconquista della Libia). Mandare centinaia di migliaia di soldati invece voleva dire toccare direttamente tutti gli ambienti: ogni rione, ogni parrocchia, ogni villaggio avrebbe avuto i suoi “ragazzi di leva”. Voleva dire mobilitare la grande macchina propagandistica del regime, tutti i giornali, le scuole, i parroci, le industrie. Appunto una guerra “nazionale” […]» (G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Einaudi, Torino, 2005, pp.25-26).
E pertanto non solo per aspirazioni ed obiettivi politici o per mezzi ed uomini impiegati quello italiano non fu un colonialismo “minore”, ma anche per coinvolgimento, via propagandistica, dell’opinione pubblica e dell’intero paese. Se il caso etiope, sopra ricordato da Rochat, è il più evidente, poiché architettato e messo in opera dalla macchina della propaganda di un regime totalitario, per sua natura avvezzo al modellamento coercitivo del pensare collettivo e pubblico, non meno importante fu il caso della sbornia nazional-colonialistica degli anni attorno alla guerra di Libia, che forgiò i capisaldi dell’ideologia nazionalistica che poi traslò nell’interventismo del 1914/’15, e di seguito nel fascismo e che ripropose, sostanzialmente immutate, le sue parole d’ordine anche nel 1935/’36.
Sulla scorta di queste, seppur sbrigative, considerazioni, verrebbe da chiedersi perché allora quello italiano sia dagli italiani stessi considerato un colonialismo di rango inferiore e magari un po’ “straccione” o perché, peggio ancora, esso sia così poco ricordato e conosciuto.
Se poi si apre il capitolo dei crimini coloniali italiani le cose peggiorano ulteriormente e una spessa coltre di nubi sopraggiunge ed avvolgendoli nasconde i fatti più incresciosi e i comportamenti più violenti e criminali di cui si sono rese responsabili le forze armate italiane nelle colonie. E’ come se un fitto ed impenetrabile muro di nebbia impedisse alla coscienza collettiva degli italiani di vedere il proprio passato e le permettesse di vivere pacificata nella serena ignoranza della propria storia rimossa. A tal proposito basta gettare uno sguardo all’editoria scolastica, per rendersi conto come dei crimini di guerra italiani, dei gas in Etiopia, e prima ancora dei campi di concentramento libici in cui fu deportato il 50% della popolazione della Cirenaica, della brutale repressione contro la resistenza prima libica poi abissina, dei campi di internamento nei Balcani aggrediti e occupati insieme all’alleato nazista, ecc quasi non ci sia traccia. Pochi i manuali di storia che dedicano più di qualche riga o paragrafo a questi argomenti e quasi mai entrando nelle questioni con sufficiente profondità di prospettiva e accuratezza di analisi.
 E le cose non migliorano se passiamo dalla manualistica scolastica ad altri mezzi e prodotti culturali e di informazione: giornali, televisione, produzione documentaristica e cinematografica.
E le cose non migliorano se passiamo dalla manualistica scolastica ad altri mezzi e prodotti culturali e di informazione: giornali, televisione, produzione documentaristica e cinematografica.
E allora gli studenti e gli italiani in generale conoscono qualcosa – sempre troppo poco, certo, ma comunque qualcosa – di Marzabotto e delle Fosse Ardeatine, ma ignorano per lo più la strage di Debrà Libanòs, in cui la furia di fascisti e soldati italiani si scatenò in una rappresaglia che fu una vera e propria mattanza, per punire l’attentato del 19 febbraio 1937 contro il generale Graziani, viceré di Etiopia dopo il rientro di Badoglio a Roma a guerra conclusa: prima venne la popolazione civile di Addis Abeba, che subì un pogrom squadrista che durò tre giorni; poi i notabili dell’etnia amhara, fucilati o deportati nei campi di concentramento, in particolare a Nocra in Eritrea e a Danane in Somalia; poi i cantastorie e gli indovini, accusati di propagare notizie anti italiane di villaggio in villaggio, che vennero arrestati e uccisi ed infine i monaci, i docenti di teologia, gli studenti del convento copto di Debrà Libanòs, considerato il centro nevralgico della resistenza abissina ed anche il luogo in cui gli attentatori fuggiaschi avrebbero trovato rifugio ed aiuto. [Per i fatti di Debrà Libanòs si veda, tra gli altri, A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2005]
Se ci limitiamo anche solo all’episodio culminante del monastero, il numero delle vittime va da un minimo di 1400 circa a un massimo di 2000 circa, eliminate secondo modalità e logiche che non presentano sostanziali differenze da quelle delle cosiddette “eliminazioni caotiche” degli Einsatzkommandos nazisti sul fronte orientale e contro gli ebrei sovietici, o da quelle delle rappresaglie stragiste dagli stessi tedeschi utilizzate per reprimere la resistenza partigiana nell’Europa occupata ed anche in Italia. Questa la sequenza delle fasi principali dello sterminio: controllo militare del luogo, rastrellamento e concentramento delle vittime, trasporto con camion delle stesse in un luogo prescelto per l’esecuzione di massa, la piana di Laga Wolde non lontana dal monastero, uccisione tramite fucilazione e ammassamento dei cadaveri in fosse comuni. E non solo il modus operandi, ma anche la logica e le finalità che mossero i fascisti e i soldati italiani in Etiopia non differivano da quelle che avrebbero mosso i nazisti qualche anno dopo: repressione vendicativa della popolazione civile rea di collaborazione con i resistenti, rottura dei collegamenti tra partigiani e civili, governo e controllo del territorio tramite il terrore, dimostrazione di forza brutale.
E ancora, risulta difficile rilevare essenziali differenze tra gli ordini impartiti, tra gli altri, dal colonnello Herbert Kappler alle Fosse Ardeatine e le decisioni prese dal governatore del Regno del Montenegro, generale Alessandro Pirzio Biroli, che nel giugno del 1943, come rappresaglia per l’uccisione presso Podgorica da parte dei partigiani di 9 italiani del 383° reggimento di fanteria, fece fucilare 180 ostaggi, secondo una proporzione di 1 a 20, il doppio di quella applicata a Roma dopo l’attentato di via Rasella del 23 marzo1944. Ma di queste “Fosse Ardeatine jugoslave”, che ci vedono coinvolti in qualità di carnefici e non di vittime, non c’è memoria. [Per la repressione italiana della resistenza partigiana in Jugoslavia si vedano, tra gli altri: A. Del Boca, Italiani, brava gente?, cit; G. Oliva, “Si ammazza troppo poco”. I crimini di guerra italiani 1940-43, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2006; D. Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Bollati Boringhieri, Torino, 2003]
E, per aggiungere un altro ed ultimo esempio tra i tanti possibili di questa sperequazione della memoria storica, è grosso modo noto a tutti gli italiani, anche grazie alla ricca ed ottima produzione cinematografica americana, l’uso massiccio da parte statunitense di defoglianti durante la guerra del Vietnam, ma pochi in Italia sanno che una trentina di anni prima il Regio Esercito italiano avvelenò la popolazione, gli animali e la vegetazione dell’Etiopia con tonnellate di ordigni caricati con iprite o arsina.
 Ma quali sono allora le cause e i motivi di questa sperequazione della memoria, come poco sopra è stata definita, che porta la coscienza collettiva di un popolo, quello italiano, a conoscere e commemorare, come è doveroso e fondamentale, i crimini di guerra subiti, ma ad allontanare dal piano del proprio orizzonte visivo quelli compiuti?
Ma quali sono allora le cause e i motivi di questa sperequazione della memoria, come poco sopra è stata definita, che porta la coscienza collettiva di un popolo, quello italiano, a conoscere e commemorare, come è doveroso e fondamentale, i crimini di guerra subiti, ma ad allontanare dal piano del proprio orizzonte visivo quelli compiuti?
Che cosa, dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi, ha impedito e continua ad impedirci di impostare un rapporto con il nostro passato recente che sulla base di una verità storica seriamente ricostruita permetta di fare di quel passato stesso, per quanto scomodo o spiacevole possa essere, un tassello, un mattone per costruire un’identità storica collettiva consapevole e critica?
La ricerca storica procede nel suo lavoro di scavo e di ricostruzione, di indagine, di spiegazione e comprensione, ma non riesce a fare breccia nella coscienza collettiva, non è capace di sedimentarsi in essa perché si scontra con l’ostruzionismo pervicace di un mito collettivo, di una leggenda a cui, consciamente o inconsciamente, teniamo più che ad ogni altra immagine di noi stessi: la leggenda del “buon italiano”, degli “italiani, brava gente”. [Si vedano a tal riguardo, tra gli altri, A. Del Boca, Italiani, brava gente?, cit.; S. Capogreco, I campi del Duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Einaudi, Torino, 2004]
Si tratta di una rappresentazione collettiva ampiamente auto assolutoria e rassicurante secondo la quale l’italiano – per indole, carattere o storia – non sarebbe capace di atti efferati, di crudeltà e crimini e, pertanto, anche in tempo di guerra, sarebbe mite, bonario e tollerante, sempre ben disposto anche nei confronti del nemico, se non addirittura sentimentale e comunque sempre umano. Uno stereotipo in piena regola, costruito su misura come un abito sartoriale, tagliato e cucito da mani esperte per le migliori occasioni e per le foto in posa.
Un’autorappresentazione fantasiosa, tanto deformata quanto a sua volta deformante – di cui in seguito verranno indicate per sommi capi genesi e ragioni – che dal dopoguerra è andata progressivamente radicandosi, innervandosi per divenire infine contenuto e forma essenziali dell’immagine che il popolo italiano tende a proporre di se stesso.
Da simili premesse, quali conseguenze? Numerose e tutte venefiche, in quanto travisano la realtà e producono, nell’ordine, falsità, oblio ed ignoranza. E pertanto il colonialismo italiano sarebbe stato un “colonialismo umanitario”, che costruiva ponti, pozzi e strade, quasi più missionario che conquistatore, che esportava – non violava – civiltà. Proprio come vuole il più inattaccabile degli stereotipi a supporto dell’ideologia imperialistica, quello della missione civilizzatrice, del “fardello dell’uomo bianco”, che nelle sue varianti ha resistito, e resiste, ben oltre l’età storica del colonialismo. Sullo sfondo di una visione così edulcorata della presenza italiana in Africa non c’è posto per crimini, violenze o stragi, che risultano conseguentemente minimizzati, quando non totalmente rimossi. E il paradigma di pensiero si sposta facilmente dall’Africa all’Europa, ai Balcani o al fronte russo, dove, ancora una volta i crimini compiuti vengono dimenticati o addirittura – è il caso dell’ARMIR – responsabilità e ruoli vengono capovolti e i soldati italiani da “invasori” diventano “vittime”. [Si veda a tal proposito Th. Schlemmer, Invasori, non vittime. La campagna italiana di Russia 1941-1943, Laterza, Roma-Bari, 2009]
Storture e travisamenti diventano riduzionismo e sfiorano il negazionismo quando si tocca la delicata questione del razzismo, che non riguarderebbe, se non limitatamente e in forme sempre blande, l’indole italiana, senza che di questa edulcorata lettura del fenomeno si possano trovare riscontri, dati e fatti comprovanti e a fronte, invece, delle Leggi razziali e antisemite del ’38 e dei provvedimenti legislativi segregazionisti e razzisti introdotti in A.O.I nel 1936 e 1937, che non solo mostrano come l’atteggiamento degli italiani in Etiopia fosse tutt’altro che fraterno e benevolo nei confronti della popolazione africana, ma anche dimostrano, scavalcando e confutando facilmente le interpretazioni minimaliste del razzismo italiano che immancabilmente lo vorrebbero spiegare come diretta emanazione e imposizione di Berlino su Roma, che esso conobbe invece una genesi e sviluppi propri e complessivamente autonomi dall’antisemitismo tedesco e collocabili per l’appunto in terra africana. [Si consulti E. Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2003]
E allora anche il ricorso ai campi di concentramento non rientrerebbe nelle modalità propriamente italiane di esercitare il potere, reprimere e combattere i nemici, nonostante la costruzione di campi, per condizioni di internamento terribili, in Libia prima ancora che sul territorio nazionale o nelle zone di occupazione in Jugoslavia. Il lager diventa quindi una esclusiva dei nazisti, che, per bilanciamento complementare del mito del “buon italiano”, assurgono a mito negativo, quello del “tedesco malvagio”, per indole o per tratto etnico-nazionale. [Si consultino, tra gli altri, E. Collotti, L. Klinkhammer, Il fascismo e l’Italia in guerra, Ediesse, Roma, 1996; F. Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano, Laterza, Roma-Bari, 2013]
 Di fronte ad un così ben articolato armamentario di distorsioni e banalizzazioni storiche, i tentativi non tanto di fare luce sui crimini coloniali italiani, da questo punto di vista un cospicuo lavoro è già stato e continua ad essere svolto, ma piuttosto quelli di divulgare i risultati della ricerca, affinché possano divenire parte essenziale di una autocoscienza storica nazionale consapevole e critica, sembrano quasi sempre destinati alla sconfitta. Tale è la resistenza opposta dal meccanismo di rimozione censoria del “buon italiano”. Ovviamente quello italiano non è l’unico caso di memoria storica collettiva di problematica incubazione e di distorta e gravemente parziale formazione: ne sono un esempio le memorie conflittuali che in Spagna si confrontano davanti al passato franchista e ai crimini dai nazionalisti compiuti, e poi negati, durante la guerra civile ed immediatamente dopo, in un paese in cui la fine del regime si è associata alla continuità istituzionale per mezzo della monarchia. Ma il confronto più significativo va fatto con la Germania, che, pur avendo dovuto fare i conti subito dopo la fine della guerra con il macigno dell’allora recente passato nazista e dei suoi crimini contro l’umanità, aveva mantenuto e coltivato per decenni un proprio mito, anch’esso auto assolutorio e rassicurante, quello del “blasone immacolato” della Wehrmacht. A partire dall’immediato dopoguerra era stata ripetutamente proposta la teoria secondo cui l’esercito si sarebbe comportato onorevolmente e sarebbe uscito “pulito” dal secondo conflitto mondiale e, soprattutto, dal nazismo. Esso non avrebbe fatto altro che adempiere al proprio dovere e non si sarebbe sostanzialmente macchiato di crimini o di atrocità, che, pertanto, sarebbero stati compiuti solo da SS e Waffen-SS, dalla Gestapo e dal partito. In questo modo un’istituzione forte dello stato – l’esercito – e il grosso della popolazione tedesca coscritta e inviata sui fronti a combattere erano privi di colpe particolari e venivano sottratti al sospetto di aver commesso atti efferati, mentre l’esclusiva dell’orrore veniva attribuita al regime, al partito e ai corpi di polizia da esso dipendenti. [Tra gli altri, si consultino F. Andrae, La Wehrmacht in Italia. La guerra delle forze armate tedesche contro la popolazione civile 1943-1945, Editori Riuniti, Roma, 1997; L. Klinkhammer, Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili (1943-44), Donzelli editore, Roma, 1997]
Di fronte ad un così ben articolato armamentario di distorsioni e banalizzazioni storiche, i tentativi non tanto di fare luce sui crimini coloniali italiani, da questo punto di vista un cospicuo lavoro è già stato e continua ad essere svolto, ma piuttosto quelli di divulgare i risultati della ricerca, affinché possano divenire parte essenziale di una autocoscienza storica nazionale consapevole e critica, sembrano quasi sempre destinati alla sconfitta. Tale è la resistenza opposta dal meccanismo di rimozione censoria del “buon italiano”. Ovviamente quello italiano non è l’unico caso di memoria storica collettiva di problematica incubazione e di distorta e gravemente parziale formazione: ne sono un esempio le memorie conflittuali che in Spagna si confrontano davanti al passato franchista e ai crimini dai nazionalisti compiuti, e poi negati, durante la guerra civile ed immediatamente dopo, in un paese in cui la fine del regime si è associata alla continuità istituzionale per mezzo della monarchia. Ma il confronto più significativo va fatto con la Germania, che, pur avendo dovuto fare i conti subito dopo la fine della guerra con il macigno dell’allora recente passato nazista e dei suoi crimini contro l’umanità, aveva mantenuto e coltivato per decenni un proprio mito, anch’esso auto assolutorio e rassicurante, quello del “blasone immacolato” della Wehrmacht. A partire dall’immediato dopoguerra era stata ripetutamente proposta la teoria secondo cui l’esercito si sarebbe comportato onorevolmente e sarebbe uscito “pulito” dal secondo conflitto mondiale e, soprattutto, dal nazismo. Esso non avrebbe fatto altro che adempiere al proprio dovere e non si sarebbe sostanzialmente macchiato di crimini o di atrocità, che, pertanto, sarebbero stati compiuti solo da SS e Waffen-SS, dalla Gestapo e dal partito. In questo modo un’istituzione forte dello stato – l’esercito – e il grosso della popolazione tedesca coscritta e inviata sui fronti a combattere erano privi di colpe particolari e venivano sottratti al sospetto di aver commesso atti efferati, mentre l’esclusiva dell’orrore veniva attribuita al regime, al partito e ai corpi di polizia da esso dipendenti. [Tra gli altri, si consultino F. Andrae, La Wehrmacht in Italia. La guerra delle forze armate tedesche contro la popolazione civile 1943-1945, Editori Riuniti, Roma, 1997; L. Klinkhammer, Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili (1943-44), Donzelli editore, Roma, 1997]
Fu una mostra sui crimini della Wehrmacht organizzata dal Hamburger Institut für Sozialforschung tra il 1995 e il 1999 (Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 – Guerra di sterminio. Crimini della Wehrmacht dal 1941 al 1944) e poi dal 2001 al 2004 (Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944 – I crimini della Wehrmacht. Le dimensioni della guerra di sterminio 1941-1944) a creare scompiglio e a mettere in discussione l’assunto di fondo della leggenda del “buon soldato tedesco”. La prima mostra attraversò 33 città in Germania ed Austria per un totale di 800.000 visitatori e la seconda fu portata in 11 città tedesche, a Vienna e in Lussemburgo e raccolse 420.000 visitatori. [Sito ufficiale della mostra]
Le dimensioni e il successo di pubblico della Wehrmachtsausstellung e il dibattito e le polemiche che ne scaturirono evidenziano come fosse difficile per molti tedeschi misurarsi con un’immagine di sé diversa da quella fino a quel momento coltivata, come fosse impegnativo dover rinunciare all’idea di un esercito complessivamente estraneo alle inumane pratiche del regime e del partito e dover ampliare considerevolmente l’area del coinvolgimento attivo nei crimini del nazionalsocialismo fino a farvi rientrare, appunto, l’esercito nel suo complesso. Coinvolgimento generalizzato del popolo, dello stato, dell’intera società, degli apparati economici nella costruzione e realizzazione del regime e nelle sue imprese, dalla guerra alla Shoah, che la ricerca storica aveva già ampiamente appurato e dimostrato, sempre più abbandonando letture “hitleriste” e, dagli anni Settanta in poi, virando verso approcci di tipo strutturalista, ma nell’opinione pubblica il mito della “Wehrmacht pulita” aveva resistito ben più a lungo.
Anche in Italia, il mito degli “italiani, brava gente” trovò terreno fertile in cui attecchire nell’immediato dopoguerra, perché lo vollero un po’ tutti. Agli ex fascisti, che intendevano a tutti i costi evitare di dover rendere conto dei crimini compiuti, risultava utile far passare l’immagine buonista del soldato italiano, che, associata alle censure capillari operate dal regime negli anni precedenti su argomenti quali, per esempio, i gas in Etiopia di cui ovviamente non c’era traccia nella cospicua memorialistica coloniale, gettava fumo negli occhi e contribuiva ad avvalorare il teorema innocentista ed auto assolutorio. Tutto questo però, si badi bene, al costo di un tanto paradossale quanto totale capovolgimento dell’immagine dell’Uomo Nuovo fascista che il regime aveva teorizzato, propagandato e costruito per vent’anni. Di quell’idealtipo fascista l’esempio più fulgido era stato proprio Rodolfo Graziani, il “macellaio degli arabi” – secondo la definizione che ne avevano dato i libici – non certo l’immagine auto denigratoria e derisoria confezionata ad hoc di un soldato italiano forse un po’ bislacco e pasticcione, magari non efficiente come altri nel combattere, ma che compensa tali deficienze marziali con cameratismo, umanità e compassione anche verso il nemico.
Ma interessava anche al maggior partito di governo, la Democrazia cristiana, che si proponeva di conseguire il fine della riconciliazione popolare, della armonizzazione nazionale, attraverso un rapporto col recente passato che privilegiasse più la continuità che la rottura ed evitando l’epurazione della classe dirigente e militare precedente. A tal fine era quanto mai utile costruire una rappresentazione “vittimistica”, quindi assolutoria, di un popolo italiano interamente e sostanzialmente buono, che aveva subito e non voluto o condiviso il fascismo, corpo estraneo o parentesi malata, per dirla con Croce, nella storia del paese.
Ma anche ai partiti della sinistra e in particolare al Partito comunista la favola del buon italiano tornava comoda. Attraverso di essa era possibile sottolineare ed amplificare i meriti dell’Italia partigiana e di quella forza politica che più delle altre antifasciste l’aveva combattuta, il Pci appunto, contrapponendo un popolo buono ad un regime feroce. Si poteva impostare l’equazione, politicamente legittimante lo stesso partito, tra Resistenza e popolo italiano, il cui risultato sarebbe stato quello di un partito comunista parte integrante della nazione e forza politica nazionale, anche a costo di rinunciare alla necessaria epurazione e alla doverosa punizione dei maggiorenti e dei criminali del precedente regime. Il tutto culminò, come è noto, nell’amnistia da Togliatti stesso voluta per il conseguimento – per dirla con le parole del segretario del Pci – “della riconciliazione e della pacificazione di tutti i buoni italiani”.
E diedero il loro contributo a questa mitopoiesi postbellica anche gli Alleati, per i quali l’Italia, paese strategico e confinante con la “cortina di ferro” e da governarsi più in continuità con il passato che attraverso traumatiche rotture, era così importante da meritare un trattamento diverso da quello dei suoi alleati del Patto Tripartito, con i quali aveva scatenato e combattuto la seconda guerra mondiale e così non vennero mai istruite una “Norimberga italiana” o una “Tokio italiana”. I criminali di guerra richiesti dalla Jugoslavia, dalla Grecia o dalle ex colonie africane non furono mai consegnati e le pene inflitte da tribunali italiani furono poche, lievi e incommensurabilmente inadeguate ai crimini perpetrati.
Ma se tutto questo spiega il passato, perché ancora oggi, quando ci separano dalla guerra di Etiopia ottant’anni esatti, quando le ragioni del dopoguerra sono ormai soltanto analisi storica, parlare dei gas in Abissinia e di altre atrocità continua a suscitare come automatica reazione la riproposizione della formula magica del “buon italiano”?
Possibile che quelle motivazioni, così strettamente legate al periodo fascista e coloniale, alla sua fine e alla problematica costruzione di una nuova identità nazionale, in un paese prima aggressore e poi aggredito, prima nemico degli Alleati poi in parte cobelligerante, spaccato in due territorialmente e politicamente, attraversato dalla lotta partigiana e dalla guerra civile, tessera fondamentale nel nuovo mosaico europeo della guerra fredda, ecc, possibile – ci si chiedeva – che ancora oggi mantengano un senso?
O dobbiamo forse, più semplicemente, rassegnarci ad ammettere che, al di là di tutte le considerazioni di ordine storico e politico sopra abbozzate ed indipendentemente da esse, a noi italiani piacciono questi panni? Ci sentiamo bene in essi? Ci rassicura l’immagine un po’ da commedia e un po’ da tragedia di un italiano sempre succube degli eventi della Grande Storia che lo sovrastano, ma capace anche di ricostruirsi un proprio piccolo mondo privato, nella famiglia, nel borgo o quartiere, con gli amici o i commilitoni, dove è in grado di conservare e coltivare quel lato umano che lo caratterizzerebbe comunque e sempre e che gli consente, quando poi dalla Grande Storia è chiamato alla guerra, di combattere con onore, ma mai con brutalità e talvolta di fraternizzare pure col nemico e di fare all’amore con le donne dei paesi invasi, mai, ovviamente, di violentarle?
Qualunque sia la spiegazione, è certo che tale falsa e sciocca, menzognera e meschina autorappresentazione collettiva è così radicata in noi che riemerge ad ogni occasione buona e contribuisce, oggi come in passato, a mantenere umido e pronto il terreno per la semina dei più nefasti revisionismi e giustificazionismi, atti a riabilitare un passato vergognoso attraverso il potente fertilizzante dell’ignoranza della storia.
_________________________________________________
Immagini, in ordine dall’alto al basso:
– manifesto della R.S.I, Vogliamo essere comandati dai negri? Giammai! Italia, 1944
– copertina di A. Del Boca, La guerra d’Abissinia 1935-41, Feltrinelli, Milano, I edizione, 1965.
– copertina di S. Belladonna, Gas in Etiopia. I crimini rimossi dell’Italia coloniale, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2015
– Gruppo di militari italiani intorno a una bomba C.500.T caricata a iprite
– cartolina coloniale, Armamenti, 1935-‘36
– La raccolta dei cadaveri della rappresaglia fascista, Addis Abeba, febbraio 1937



