di Anarcoreta
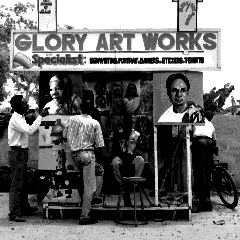 [Qui la prima parte del racconto]
[Qui la prima parte del racconto]
Quando arriviamo io e Gideon, gli occhi di tutti si voltano verso di noi. Un saluto e Gideon inizia a trattare con quello che la “maria” la vende. Io vengo invece apostrofato da un uomo con la camicia rosa. Le sue pupille sono rosse fuoco, ha fumato, e in abbondanza. Dice che gli devo dare soldi. Chiedo perché. Perché lui ha il potere lì. Intanto la transazione per cui siamo venuti si è completata nel giro di poche battute. Il venditore chiede How many? Gideon mi guarda. Chiedo quanto costa. Arrivano cinque strisce di carta marrone di piccole dimensioni. Le riconosco.
La maria da queste parti si vende in due modi, o in grandi fogli grezzi contenenti rametti non lavorati, oppure in queste strisce di carta — che ora avevo davanti ai miei occhi – dalle dimensioni di una canna grande, già sminuzzata, pulita da semi e stecchi, e pronta per l’uso. Pago. La mia attenzione torna sull’uomo con la camicia rosa che insiste per avere almeno uno dei cinque pacchettini. Mi infastisce la sua arroganza. Prendo uno degli involucri e lo do in mano ad un ragazzo che non aveva aperto bocca, I don’t like powerful people (Non mi piacciono i potenti). Non mi guardo indietro. “Rizla”, offre il venditore porgendomi cinque cartine, ne prendo una sola e ci muoviamo.
Il prezzo — per i curiosi, i pedanti, gli amanti dei particolari, insomma per quei lettori, che magari non sono neanche prevalenti, ma ritengono importante questa informazione, anche perché questo racconto e ogni suo particolare è tutto vero, insomma il prezzo è stato 2 a pacchettino (Gideon ha corretto gentilmente il venditore che uscendo il tutto ne aveva chiesti 5 per ciascuno) per un totale — come potrebbe calcolare un alunno delle classi intermedie delle elementari a cui le insegnanti sono solite dare esercizi di questo genere – di 10.
Ho aperto una parentesi in cui ho piazzato un accenno che — a questo punto — merita un ulteriore parentesi e un ulteriore approfondimento, e il lettore non sia disturbato da questo gioco di scatole cinesi che potrebbe distogliere l’attenzione dalla trama principale, non sia disturbato perché con questa, le parentesi — per ora — si chiudono e perché in un racconto le vie secondarie possono essere importanti quanto il tracciato principale. Il fascino di una storia è nel percorso — per come si allineano fatti e parole — e non è mica nell’ansia che prende il lettore per sapere come andrà a finire. Ho detto e ribadisco che ciò che trovate scritto, è tutto vero. Cosa voglio dire? Che non sto fabbricando niente; anche se ho una pessima memoria, sono appena passate un paio di ore tra ciò che è scritto e il mio scrivere questi primi appunti, che saranno seguiti fedelmente nelle correzioni e ampliamenti che sono venuti nei giorni a seguire. A volte, mi sembra, che la realtà offra spunti sufficienti di riflessione per raccontare che cosa ci è successo. Passando dalla mente. Cercando di riproporre, di rappresentare i flussi di sensazioni che ci scorrono addosso anche nel corso di un semplice pomeriggio, di qualche ora. I racconti spesso sono frutto di immaginazione, questo invece è uno scorcio di realtà.
La luce è ormai quella del tramonto avanzato. Mentre piscio su un arbusto guardo la linea dell’orizzonte dove il blu intenso delle nuvole si scurisce fino ad assumere — con la complicità di una luminosità ormai evasiva e diffusa — tonalità grigie. In lontananza, noto delle linee verticali — appena oblique – sottilissime che tagliano le nuvole togliendo la nettezza, la definizione nei contorni, come se ciò che avessi di fronte non fosse la realtà ma la sua rappresentazione in forma di acquarello. Look, the rain is coming (Guarda, arriva la pioggia) dico a Gideon. Guarda sfuggente, It is like that when the night is coming (E’ così quando arriva il buio).
Troviamo un angolino, poco distante da dove erano avvenuti incontri e transazioni. Ci mettiamo a sedere e decidiamo di assaggiare l’acquisto mentre si conversa. Abbiamo chiacchierato poco e quella sembra una buona occasione. Ha ventun anni, si definisce a tourist friend; lo conoscono in campus; lui si muove con i turisti; lo posso trovare quando voglio lì dove ci siamo incontrati, basta chiedere a chiunque; tutti lo conoscono. Sposto la discussione sulle piante che crescono e quelle che non crescono in Europa. Riprende lui, se fossi qui più a lungo, gli piacerebbe muoversi con me. Una chiaccherata piacevole, anche se non intima. Inizia a rullare lui ma poi sonda la mia competenza e a una risposta moderatamente affermativa, mi passa il tutto e questa è l’occasione per dire anche due parole — ma proprio due – sul filtrino ritenuto opzionale da queste parti.
Intanto si alza il vento – un sintomo chiaro che la pioggia sta arrivando — e i fiammiferi sono tre. Sono tre perché erano cinque quando me li ha datti il tassista la sera prima e ho fumato due sigarette in quel lasso di tempo. Il primo lo accendo io: la fiammella si spegne prima che lui possa avvicinarci la canna. Il secondo fiammifero lo accende Gideon: mi piazzo davanti per parare il vento, lui si accoscia e piega le due mani per proteggere il tenue fuoco dalla brezza; si spegne anche il secondo. Accende immediatamente anche il terzo e con questo riesce ad alimentare una fragile combustione. Per assicurarsi che non si spenga, aspira e sputa fumo, aspira e sputa, aspira e sputa con vigore mentre la canna si arrossa in cima, rassicurando me e lui. Iniziamo ad appropriarci di un abbondante purino d’erba.
A questo punto comincia un’altra storia che inizia con Gideon che si accanisce sulla canna per garantire l’accensione e quindi il consumo. Mentre faccio i primi tiri e sento salire l’effetto, pensavo che per quanto possa soffermarmi a narrare le mie sensazioni, queste le può comprendere con maggiore empatia chi pratica l’uso di sostanze che alterano il normale scorrere della sensibilità e percezione. Non nego che ci possano essere persone in grado di intuire il sentire — certo diversificato ma comunque simile — caratteristico dello stato di ebbrezza chimica di questo genere: sto cercando di dire che l’esperienza diretta rende più pienamente consapevole ai consumatori certe dimensioni. L’effetto della canna è immediato e potente: le parole si accavallano, perdono una direzione precisa, faccio difficoltà a capire esattamente cosa Gideon mi stia dicendo. La luce oramai è tenue. La canna si spegne nelle mie dita quando manca ancora metà. Sono pronto ad andarmene e glielo dico.
Sono seduto su un sasso girato verso Gideon, dietro di me passa un ramo dello stradino. In quel mentre transita, proprio di lì, l’uomo dalla camicia rosa, accompagnato da una persona che lo sovrasta di una testa. Si accorgono della nostra presenza e si fanno avanti. Prima con aria minacciosa chiedono il permit, il permesso per stare lì nel ghetto a fumare. Gli dico che è lo stesso che hanno anche loro. Gli occhi rossi dell’uomo con la camicia rosa si illuminano, il tono di voce sale e la distanza tra me e lui si riduce. Vuole soldi e non sembra essere intenzionato a spostarsi fino a quando gli vengono concessi. L’uomo con la camicia rosa insiste nel chiedere qualcosa in modo che sarei potuto venire lì — senza problemi — quando volevo. Spiego che io, nel ghetto, non ci avrei probabilmente più messo piede, anche se i fatti della vita sono notoriamente imprevedibili, perché avevo programmi che mi portavano ad allontanarmi dall’università, dal ghetto e anche da loro. La spiegazione evidentemente non è convincente e cerca di aggirare il punto imprescindibile, cioè che per una ragione o per l’altra, potevo trovare quella che più mi compiaceva, volevano che fossero ceduti dei soldi; volevano, uso il plurale, perché l’uomo con la camicia rosa era spalleggiato — silenziosamente ma senza riserve – da quello più alto, che gli sta dietro ma che durante la conversazione si muove intorno a lui e ad un certo punto mi si para — più che davanti, visto che ero seduto — sopra.
Che sia chiaro a tutti che l’assenza di un nome proprio con tanto di cognome e titolo e magari anche un accenno alla genealogia familiare — non è dovuto ad una mancanza di rispetto e che gli appellativi sia dell’uomo con la camicia rosa che di quello più alto non vogliono essere denigratori ma sono dovuti al fatto che così mi sono rimasti impressi nella mente, e altre designazioni dovrei inventarle, e — come già detto – qui di inventato non c’è niente; casomai di inesattezze e discrepanze rispetto ad una versione completa che potrebbe aver girato un videoamatore — ammesso che il filmato meritasse l’ultimo aggettivo scritto – ci sono solo le intermittenze della memoria. Quello che manca — il nome di alcuni protagonisti di questa storia — non inficia ciò che è successo, ovvero che ci troviamo tutti nella situazione appena descritta, di difficile risoluzione, che sembra sospesa lì nel tempo, immobile, se non fosse per la luce sempre più scarsa che segnala l’inesorabile e irreversibile scorrere dei momenti.
Oltre che il tempo scorrono, velocemente, anche i miei pensieri. Posso interpretare la richiesta di soldi come una minaccia — se non avessi pagato, gli umori si sarebbero potuti infiammare, sarebbe forse salito il fastidio e il nervosismo in un contesto in cui nessuno dei quattro presenti all’incontro aveva il massimo controllo delle sue capacità psico-fisiche. Cerco di orientarmi, chiedo specificazioni. L’appello a something from your heart, qualcosa dal mio cuore, che risponde ad una domanda di quantificazione del loro desiderio, sembra indicare che non c’era in quel momento una minaccia bensì una richiesta di ridistribuzione volontaria. Ora, questa è una richiesta frequente fatta soprattutto, ma non esclusivamente, al bianco — legittimata da una sproporzione nelle risorse a disposizione che produce continui imbarazzi a chi, come me, sente che, non tanto i soldi, ma la loro distribuzione disuguale sono un problema. Questa sensazione di ingiustizia nell’accesso alle agognate banconote si grida meglio stando dalla parte di chi ha meno, e questo risulta più facile in Italia; diventa imbarazzante sentire l’ingiustizia stando dalla parte di chi ha in tasca e nella borsa, in cui ricordiamolo, c’era il portatile, di un valore che probabilmente — in una volta sola — nessuno degli altri tre presenti ha mai visto, e se ha visto, ha visto in mani altrui. Insomma, dal mio cuore non veniva lo stimolo di mettere mano al portafoglio mentre nella mia testa si accavallavano vari pensieri che mi bloccavano lì. La domanda dell’uomo con la camicia rosa poteva essere un’occasione per ridistribuire ma — e qui si aprono riflessioni che mi hanno accompagnato a lungo nelle mie permanenze africane — che senso hanno regali fatti sotto esplicita richiesta — presentati addirittura come l’acquisto di un permesso, con accenni a modalità di stampo mafioso? Guardandola in un’ottica diversa, la cessione di soldi su richiesta può essere vista come quella che siamo abituati a classificare come carità o elemosina — in cui il contatto tra le due persone si limita ad un atto gratificante per entrambi — per chi da nel dubbio innalzamento morale, per chi riceve nella concreta soluzione di qualche necessità o piacere immediato – ma che, proprio limitandosi a quella transazione, in qualche modo rafforza due ruoli incommensurabili, due persone distanti, due vite che, non riuscendo a conoscersi, risolvono il loro rapporto con i soldi, che notoriamente di per sé — mezzo anonimo per eccellenza — non generano scambio, non mettono in gioco le persone. Rimane inoltre aperta la questione del perché quelli che per qualche ragione entrano in contatto con i bianchi – come guide, amici, simpatizzanti o semplicemente procacciatori di maria – debbano avere il privilegio di estorcere loro qualcosina e debbano invece essere escluse le persone più discrete, meno espansive, meno intraprendenti o magari dotate di maggiore dignità e amor proprio. Quando pongo la questione del perché proprio a lui devo dare qualcosa, l’uomo con la camicia rosa risponde in modo sensatamente pratico che però non risolve il mio problema morale: As we are here… (in quanto noi siamo qui). Infine, per chi crede che i soldi vadano distribuiti con maggiore equità, la cessione di soldi ai singoli inibisce o rimane comunque inefficace rispetto allo scopo ultimo, che — ricordiamolo – è quello di diffondere il potere al punto che ciascuno — e i gruppi nella loro organizzazione egualitaria — possano bandire i privilegi, sperperi e lussi ed imporre una distribuzione realmente equa dei beni — risultante da un bilanciamento tra necessità e sforzo e non su rendite, cariche, sfruttamento – e quindi garantire il libero sviluppo delle potenzialità di ognuna e di ognuno. Per tutte queste ragioni, “dal mio cuore” non usciva nulla.
[Continua]



