di Sandro Moiso
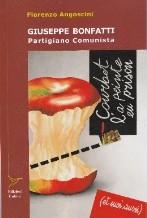 Fiorenzo Angoscini, Giuseppe Bonfatti. Partigiano Comunista, Edizioni Colibrì 2015, pp. 176, € 12,00
Fiorenzo Angoscini, Giuseppe Bonfatti. Partigiano Comunista, Edizioni Colibrì 2015, pp. 176, € 12,00
La forma di produzione capitalistica, su cui si fondano i valori dominanti dell’attuale società, dà per scontato uno scorrimento lineare e progressivo del tempo in cui tutti gli avvenimenti e i differenti ambienti sociali sembrano convivere in una sincronia meccanica precisa ed incontrovertibile.
Al massimo, chi non si adatta, anche quando si tratta di interi gruppi sociali, è considerato fuori tempo, sorpassato, inadeguato, superato, sconfitto oppure semplicemente residuo di un passato destinato ormai a scomparire.
Il tempo implacabile degli orologi, meccanici, al quarzo o atomici, scandisce il tempo del capitale e delle scienze applicate senza alcun riguardo per i tempi della specie e degli individui che la compongono. Che in passato hanno misurato il tempo con le lune, con il sole, con le stagioni, con gli eventi piccoli e grandi che hanno scandito le vite de dei singoli esseri umani, dei clan, delle famiglie, delle tribù e delle classi sociali.
Tempi che non rispondono soltanto agli orologi, alle clessidre o alle meridiane, ma soprattutto alle emozioni, ai ricordi, alla memoria e alle sensazioni provate in determinate occasioni e che, spesso, si prolungano ben oltre l’accadimento in sé. Una percezione soggettiva del tempo che si amplifica in particolare là dove la memoria delle lotte di classe e delle guerre civili, che le hanno spesso accompagnate, non è ancora stata del tutto rimossa e cancellata e che, talvolta, sopravvive più nella testimonianza dei singoli individui che non nelle istituzioni, culturali o politiche, formalmente addette alla ricostruzione degli avvenimenti storici.
L’affermazione della percezione soggettiva del tempo sembra, così, affermarsi maggiormente nella narrazione delle microstorie, spesso affidate all’oralità, più che alla storia documentaria in cui, come negli orrendi percorsi scolastici, la storia viene scandita in ere, età, secoli e decenni; adatti, soprattutto, a definire ciò che è avvenuto e che, nel frattempo, si è allontanato in maniera irreparabile da noi. Qualcosa che, simile ad un vecchio maglione in un cassetto, può essere abbandonato, dopo averne fatto tutti gli usi leciti o illeciti possibili, alla critica definitiva dei tarli.
Ma se un libro, una tesi ufficiale o un’interpretazione superata del passato oggettivo e pertanto “storico” possono essere rimossi in questo modo, altrettanto non può avvenire là dove una ben più sanguinosa memoria continua a sopravvivere nella mente e nei corpi di coloro che hanno provato e, magari, continuano a provare sulla propria pelle la realtà dello sfruttamento, della repressione, della sconfitta e del tradimento delle lotte passate. Sempre soltanto sopita, nonostante gli infiniti sortilegi invocati dagli assistenti stregoni del potere.
Così accade che nelle classi rimanga depositata, anche in singoli individui, una sorta di mentalità o memoria collettiva inconscia. Una sorta di palinsesto, dove anche ciò che è stato socialmente e ufficialmente rimosso, con la soppressione e la repressione, perfino fisica e più violenta, in qualche modo ritorna. Chiamare tutto ciò ricordo è troppo poco e anche memoria non basta a definirlo. E’, piuttosto, una specie di sedimento in parte biologico e in parte culturale o, meglio, politico.
Proprio da uno di questi sedimenti, originatosi nel contesto della guerra civile italiana tra il settembre del ’43 e l’aprile del ’45, prende spunto l’interessante libro di Fiorenzo Angoscini, giornalista e militante bresciano. Ed è una vicenda che non ha, pur nella sua linearità e semplicità, nulla da invidiare ai migliori film di Sergio Leone. Una vicenda in cui il passato si ricongiunge al presente in nome di un futuro non ancora realizzato, ma da cui si attende pur sempre un benefico ed egualitario cambiamento.
Giuseppe Bonfatti, ex-partigiano classe 1924, dopo decenni passati a lavorare in Brasile, torna nel 1990 in Italia. Nella mattina di giovedì 8 novembre dello stesso anno, a Viadana in provincia di Mantova, uccide a colpi di gravina1 Giuseppe Oppici, ex-fascista locale. Per Bonfatti è un atto dovuto. Cosa che rivendicherà ancora durante il processo tenutosi presso il Tribunale di Brescia e da cui uscirà con una condanna, in primo grado, a 24 anni di carcere.
La storia, in sé, è piuttosto nota anche in rete. Ciò che fa però l’autore, che all’epoca ebbe modo di conoscere ed intervistare l’ex-partigiano, è allargare lo sguardo a tutti gli avvenimenti grandi e piccoli che stavano alla base di una siffatta e disperata scelta e, soprattutto, riavviare un discorso di classe su una guerra, quella partigiana, che troppo frettolosamente è stata relegata a mera “guerra di liberazione nazionale” o, peggio ancora, a “secondo Risorgimento”, privandola così di quella connotazione classista che era stata alla base della sua diffusione tra vasti settori operai e contadini della Pianura Padana.
Diffusione e condivisione di ideali che, anche se non sempre finì col promuovere significative vittorie sul piano militare, certo indicava una tendenza alla rivolta, se non alla vera e propria rivoluzione sociale, che un ventennio di repressione statale, monarchica e fascista, non era riuscito a cancellare. Anzi, fa bene l’autore a sottolineare, riprendendo le parole di personaggi, tra gli altri, del calibro di Ferruccio Parri e Carlo Galante Garrone oppure di Cesare Bermani, come la guerra civile in Italia non fosse mai cessata a partire dal Biennio Rosso.2 Al massimo era stata continuata per diversi anni sul territorio nazionale da una sola delle parti in causa, quella fascista, mentre l’altra non aveva mai cessato di battersi ovunque avesse avuto modo di farlo. Come l’esperienza della guerra civile spagnola ci ricorda ancora.
Nel fare ciò, l’autore non solo ricostruisce alcuni episodi salienti e/o minori della lotta di classe armata nelle province di Mantova, Cremona, Parma e Reggio Emilia (come ad esempio la tragica vicenda dei fratelli Cervi), ma ristabilisce anche la verità storica e sociale sulle radici di quelle esecuzioni messe in atto nel dopoguerra in quello che il revisionismo storico ha definito “triangolo della morte” o “triangolo rosso”. Revisionismo di Pansa e associati che,3 purtroppo, può affondare ancora una volta le sue “ragioni” proprio nell’azione e nelle parole dei leader del partito che più di ogni altro volle accollarsi il merito della battaglia anti-fascista: il Partito Comunista Italiano.
E’ infatti interessantissima la parte del testo che ricostruisce la delusione dei partigiani di fronte alle scelte operate da Togliatti quando, da ministro guardasigilli del primo governo d’unità nazionale successivo alla fine del conflitto, tese la mano agli ex-fascisti attraverso un’amnistia che di fatto impedì una vera epurazione dello stato italiano e delle sue strutture di sicurezza e di ordine pubblico dagli elementi compromessi col passato regime, mentre con l’altra dava di fatto inizio alla persecuzione dell’ala più intransigente del movimento partigiano.
Il provvedimento fu emanato il 22 giugno 1946, poco più di un anno dopo la fine della guerra e del regime. Pochi mesi dopo, nell’autunno dello stesso anno, Togliatti attaccò frontalmente l’operato di quei partigiani che, non volendo piegarsi alle decisioni e ai compromessi del partito e del suo leader, anche attraverso il rapimento e l’uccisione di ex-funzionari fascisti e dirigenti aziendali compromessi con le deportazioni di operai italiani in Germania, avevano continuato la lotta di classe anti-fascista, prima in un intervento pubblico presso il Teatro Municipale di Reggio Emilia (24 settembre) e poi, il giorno successivo 25 settembre, in una conferenza di organizzazione a porte chiuse presso la federazione comunista di Reggio Emilia.
Come afferma Angoscini nelle sue ben documentate pagine, il punto era uno solo: garantire la transizione democratica, interrompere tutte le attività che la ostacolavano, accreditare il Partito Comunista, nazionale e regionale, come partecipe sincero e corretto della cruciale fase storica, emarginando gli indisciplinati (irriducibili e incompatibili). Iniziando a indicarli come provocatori al soldo di chissà chi: “La realtà è che i delitti che oggi macchiano alcune zone emiliane sono senza dubbio dovuti ad elementi squilibrati e sbandati, non legati a nessun partito politico, ma dietro di essi è molto verosimile che si trovi la mano e l’intenzione di chi si serve del delitto politico”.4
L’unico neo del testo, ampiamente compensato dalla mole di dati e dalla ricchissima bibliografia che lo accompagnano, sta forse nella semplicità con cui l’autore, sposando in altra parte del libro, forse un po’ troppo, la tesi dell’effettiva grandezza di Stalin e della sua volontà di realizzare una rivoluzione su scala internazionale, denuncia la doppiezza di Togliatti senza cogliere in essa la malattia d’origine dello stalinismo tutto e delle sue conseguenze sul movimento operaio, dai processi di Mosca fino agli accordi di Yalta. Avvenimenti ed accordi che definivano il perimetro entro cui Togliatti, nemico di ogni autonomia di classe come tutto il PCI dei decenni successivi, si muoveva in maniera pienamente cosciente.
La stessa finzione della doppia anima del Partito, quella istituzionale e quella rivoluzionaria, costituiva infatti la trappola in cui gli irriducibili furono “presi” e disarmati. Soprattutto quando, dopo l’attentato a Togliatti del luglio 1948, la mobilitazione, accompagnata da simboliche azioni armate, di operai e militanti comunisti ebbe come successiva conseguenza soltanto la consegna allo Stato italiano della gran parte delle armi, leggere e pesanti, rimaste nelle mani degli ex-partigiani e gappisti.
Un aspetto qui tralasciato, ma sicuramente interessante come ipotesi di ricerca, sarebbe stato proprio quello di vedere come il mito “Stalin”, destinato in qualche modo a mantenere il controllo della forza lavoro ed impedirne un’eccessiva insubordinazione sia in Russia che nel resto del mondo ad opera dei partiti bolscevizzati, sarebbe stato rovesciato nel suo contrario ed utilizzato dai protagonisti di un’insopprimibile lotta di classe, che, una volta liberata, o per scelta o per necessità, si sarebbe appropriata di tutti gli strumenti disponibili. Anche di quelli apparentemente meno adatti per la sua espressione. E che avrebbero finito, a loro volta, col rivoltarsi contro la stessa, imbrigliandola in azioni destinate a riportarla alla sconfitta.
In fin dei conti, la storia di Giuseppe Bonfanti parte anche da lì. Partigiano, stalinista come rivendicava ancora negli anni novanta, la cui casa di famiglia era stata data alle fiamme e distrutta da una squadraccia repubblichina dopo un fallito attentato ad un gerarca locale; in seguito incarcerato e trasferito in un campo di concentramento da cui riuscì ad evadere per riprendere la lotta e costretto, nel dopoguerra, ad emigrare in Brasile per trovar lavoro; senza aver mai dimenticato che, alla fine, gli “sconfitti” fascisti erano stati quelli che avevano, di fatto, ereditato il ruolo di conduttori dello Stato repubblicano. Mentre i partigiani, gli irriducibili, come lui e moltissimi altri, avevano dovuto ritornare al lavoro salariato e alla dipendenza dal capitale, quando addirittura non avevano dovuto emigrare per sfuggire al carcere ed alla prigione.
Ed è quello il passato che non passa. Che non passerà mai finché vivrà una società basata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e sull’accumulazione di capitale. Finché esisterà una società divisa in classi, in cui la maggioranza delle donne e degli uomini dovrà ancora sottostare alla dittatura dei pochi che detengono i mezzi di produzione, le leve del potere e le armi del terrore statale e della repressione. Anche là dove si finge l’esistenza di una democrazia parlamentare o della libertà d’espressione (purché non sia di insegnamento per la lotta).5
E’ lì che il tempo si è fermato. Altro che trascorso o andato avanti. Finché vivrà un Partito della Nazione (che di quel partito togliattiano è ancora erede, se non nella forma almeno nei compiti), finché vivranno i “finti” compromessi del Nazareno (che prolungano nel tempo la formula dell’unità nazionale nell’interesse del capitale e del comando sulla manodopera), finché continuerà il tentativo di rimuovere ciò che non si può rimuovere ovvero la contraddizione tra capitale e lavoro e tra sfruttati e sfruttatori, il nostro tempo sarà sempre quello di Giuseppe Bonfatti.
Che, come afferma giustamente Fiorenzo Angoscini, non fu il carnefice, ma la vittima:
“Vittima, perché costretto a subire vent’anni di dittatura fascista.
Vittima, perché ha patito lo squadrismo, responsabile dell’incendio e conseguente distruzione della sua casa.
Vittima, perché incarcerato e, poi, rinchiuso in un campo di concentramento.
Vittima, perché nonostante possa essere annoverato tra la schiera dei «vincitori», ha dovuto emigrare in un paese lontano per poter svolgere un’attività lavorativa.
Vittima, perché ha dovuto patire per quarant’anni la condizione di esule.
Vittima, perché nessun giudice o tribunale ha perseguito i suoi aguzzini” (pag. 18)6
 Così, fino a quando non avremo potuto sputare sulle tombe di coloro che hanno già perso una volta e non avremo relegato il capitale all’oblio e al ruolo di semplice ricordo di uno dei peggiori incubi che abbiano travagliato la specie umana, ogni volta che sentiremo nominare Giuseppe Bonfatti, Partigiano Comunista, risponderemo: “Presente!”
Così, fino a quando non avremo potuto sputare sulle tombe di coloro che hanno già perso una volta e non avremo relegato il capitale all’oblio e al ruolo di semplice ricordo di uno dei peggiori incubi che abbiano travagliato la specie umana, ogni volta che sentiremo nominare Giuseppe Bonfatti, Partigiano Comunista, risponderemo: “Presente!”
Si confronti su tale tema anche Fabio Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo 1918-1921, UTET 2009
Senza contare l’attuale revanscismo delle foibe che mira a cancellare con un colpo di spugna i crimini dell’occupazione italiana dell’ex-Jugoslavia durante il secondo conflitto mondiale
Chiarissimo in proposito Erri De Luca, La parola contraria, Feltrinelli 2015
Sarebbe qui, forse, possibile ipotizzare, sulla base anche delle considerazioni svolte sulla violenza da Jan Assmann, nel suo saggio Non avrai altro Dio (il Mulino 2007), la permanenza di una logica sacrificale, intesa come ricerca di una comunicazione, nella violenza esercitata da Bonfatti e in genere nelle varie forme proletarie di insorgenza, molto diversa dalla violenza della verità, e quindi negatrice e distruttrice tout court dell’altro e delle sue ragioni, esercitata dallo Stato o dalle istituzioni che contribuiscono a riprodurlo (eserciti, partiti, movimenti religiosi monoteistici). Ma questo discorso porterebbe lontano dal tema principale qui trattato.







