Speciale a cura di Wu Ming
 E’ un’estate di siccità dell’anima, che si porta via i nostri fratelli maggiori, uno in fila all’altro, come scoiattoli ghermiti da un rapace. Dopo Piermario Ciani e Roberto Bozzetti (aka DJ Pappa Rodriguez), ieri sera la notizia che ti spegne la voce e ti fa balbettare al telefono.
E’ un’estate di siccità dell’anima, che si porta via i nostri fratelli maggiori, uno in fila all’altro, come scoiattoli ghermiti da un rapace. Dopo Piermario Ciani e Roberto Bozzetti (aka DJ Pappa Rodriguez), ieri sera la notizia che ti spegne la voce e ti fa balbettare al telefono.
E’ morto a soli 51 anni Valerio Marchi, sociologo, storico dei movimenti giovanili, militante antifascista, skinhead, ultrà della Roma, libraio e scrittore.
All’improvviso, molti fenomeni (il fascismo da curva, le sottoculture giovanili, il rock della destra radicale ecc.) diventano opachi, meno leggibili. Rimane sguarnita una postazione critica importante, e tutti quanti ne sconteremo le conseguenze. Il mix incarnato da Valerio (credibilità accademica + culo in strada, strumentazione scientifica + passione viscerale) è sempre più difficile da “shakerare”, in un Paese impoverito dalla “fuga dei cervelli”, dove imperversa il radicalismo da salotto ed è egemone l’arricciata di naso di fronte alle manifestazioni della cultura popular.
Questa morte avrà un impatto devastante sulla cultura italiana, che purtroppo – in tutt’altre faccende affaccendata – se ne accorgerà tra chissà quanto.
Abbiamo confezionato un piccolo tributo, uno speciale, per far conoscere un po’ del lavoro di Valerio anche a chi non ne ha mai sentito parlare.
Mandiamo un abbraccio rude e un po’ maldestro, da orsi affettuosi, alla famiglia di Valerio, agli innumerevoli amici e a tutti i compagni da via dei Volsci a Polignano. [WM1, 24 luglio 2006]
1. L’articolo de “Il Manifesto”, 23 luglio 2006
2. Una presenza solida e costante – di Wu Ming 5
3. Introduzione a La sindrome di Andy Capp: cultura di strada e conflitto giovanile – di Valerio Marchi [2003]
4. Estratto da Il Derby del bambino morto: violenza e ordine pubblico nel calcio – di Valerio Marchi [2005]
5. Una videointervista a Valerio Marchi sulla destra radicale in Europa
Da “Il Manifesto” di domenica 23 luglio 2006:
ADDIO A VALERIO MARCHI, UNO STORICO MILITANTE
Bari. Valerio Marchi era uno storico, sarebbe stato un grande professore ma la sua università era la strada, la “nostra” strada. Via dei Volsci a San Lorenzo, Roma. Aveva militato nell’autonomia operaia e ne andava fiero, poi aveva aperto la libreria, sul marciapiede opposto a quello di Radio onda rossa e delle vecchie sedi che oggi ospitano lo spazio sociale “32”. La sua libreria era (e resta) uno spazio aperto, frequentato dai compagni, dagli skin, dagli ultras e da gente ancora meno “presentabile”.
Valerio un libro non sapeva venderlo senza raccontarti una storia, senza fare mille domande per capire cosa cercassi veramente, senza darti un consiglio. Che lo volessi o no. “Ma no, pija quell’altro che è mejo…”. E sopratutto scriveva. Saggi sullo stragismo e sull’estrema destra, sulle culture e le sottoculture giovanili: La morte in piazza. Vent’anni di processi sulla strage di Brescia (Grafo), La sindrome di Andy Capp. Cultura di strada e conflitto giovanile (Nda press), SMV: stile maschio violento. I demoni di fine millennio (Costa & Nolan), Nazirock – Pop music e destra radicale (Castelvecchi). In questi giorni stava scrivendo una nuova “storia del teppismo”, più ampia di quello pubblicato qualche anno fa. Chissa se ha scritto a sufficienza per poterla pubblicare anche se l’autore non c’è più.
Valerio Marchi è morto a cinquant’anni, di infarto, a Polignano a mare, splendido paese arroccato sulla riviera a sud di Bari nel quale aveva scelto di vivere con la moglie Anna e aveva aperto una nuova libreria,”Lacapagira” l’ha chiamata.
Giovedì ero lì con lui per un dibattito con gli ultras delle Puglie, baresi, fasanesi, monopolitani, ragazzi che ti riconciliano con il calcio. Insieme abbiamo presentato il suo studio (edito da DeriveApprodi) su violenza e ordine pubblico nel calcio che prende le mosse (e il titolo) da una vicenda paradigmatica: il derby del bambino morto, la stracittadina romana interrotta dagli ultras con la notizia dell’uccisione di un bambino da parte della polizia, una notte di fuoco e di follia che ci ha insegnato moltissimo. Valerio ci ha insegnato molto altro. (A.Man)
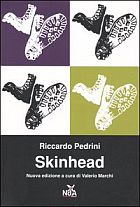 Riccardo Pedrini, Skinhead, nuova edizione a cura di Valerio Marchi, NDA Press, Rimini 2004 |
UNA PRESENZA SOLIDA E COSTANTE
di Wu Ming 5 (Riccardo Pedrini)
Estate, proprio come ora. L’immagine è quella di una corsa forsennata per le strade e i quartieri della capitale, due skinhead su una vecchia moto inglese, e il mondo scorre, si apre. Il mondo, cioè la città, è finalmente benigno e percorribile perché noi abbiamo deciso di non subire più, perché abbiamo deciso di alzare la testa e gridare forte. Scorrono strade, piazze, case popolari, quartieri di ricchi. Incrociamo mille volti, noi andiamo verso San Lorenzo.
L’immagine è il baricentro emotivo della mia vita, viene dalla pancia, e riguarda un uomo che non c’è più.
Ero abituato a considerare Valerio Marchi una presenza costante, solida. Gli attribuivo la perennità che si attribuisce a genitori e fratelli maggiori quando si è piccoli. Valerio Marchi ci sarebbe sempre stato, la sua passione per la vita e la sua incredibile energia avrebbero continuato a mandare luce. Lo spazio che occupava era grande. Ora guardi in quello spazio e ti prende la vertigine, un buco nero, denso, non ne vedi il fondo.
Il lutto è grave, non ti puoi nascondere dietro frasi di circostanza e razionalizzazioni.
Questo è vero dal punto di vista umano e politico, per me e per innumerevoli compagni, e questo è il caso in cui davvero non puoi distinguere tra l’una e l’altra cosa. Umano e Politico, cioè il fatto concreto di essere così, di essere in un certo modo, di aver attraversato il proprio tempo con una precisa, lucida traiettoria, lasciando così tanto dietro di te in termini umani e intellettuali.
In questa tragedia è importante ricordare Valerio Marchi in tutta la statura intellettuale che ha saputo raggiungere. Valerio Marchi viveva la strada. Ne capiva i codici in maniera istintiva, originaria. Valerio Marchi capiva nella carne e nel corpo il dolore della periferia, la durezza della condizione di inurbato e subalterno, e capiva nella carne e nel corpo la potenza ricchissima della spinta alla ribellione, l’efficacia dello stile, che è capace di redimere in misura profonda. Valerio Marchi è stato in grado di elaborare tutto questo in un’opera di straordinaria importanza, che ha pochi paragoni nel mondo per lucidità, portata innovativa e profondità di dottrina. Questo disgraziato paese perde una voce insostituibile. I suoi compagni perdono un amico, un pezzo della propria materia vivente.
Il mio primo libro vide la luce perché Valerio seppe credere nel progetto fino in fondo. Gli devo l’omaggio più profondo per questo e per molte altre cose che taccio.
Spero che un giorno il gioco delle molecole e degli elementi porti alla vita un altro Valerio Marchi, anche se nessuno della presente generazione vedrà quel momento. Uomini come Valerio sono rari, sempre di più. Qui, resta duro e lacerante il dolore di chi rimane.
[Nota il saggio-testimonianza Skinhead. Lo stile della strada uscì nel 1997 presso l’editore Castelvecchi, con introduzione di Valerio Marchi. Nel 2004 il libro è stato riedito da NDA Press, a cura di Valerio e con una sua prefazione.]
 Valerio Marchi, La sindrome di Andy Capp. Cultura di strada e conflitto giovanile, Nda, 2003 |
PREFAZIONE A LA SINDROME DI ANDY CAPP
di Valerio Marchi
Clicca qui per leggere il testo in pdf.
[…] Nella terminologia utilizzata rispetto alle “questioni giovanili” affiora perpetuo un senso di allarme, una carica fobica che sembra manifestarsi in una vera e propria sindrome paranoide collettiva, definita “sindrome di Andy Capp”, in cui ogni giovane assume le allarmanti sembianze di Andy Capp, protagonista assoluto delle famose strip dell’inglese Reg Smythe. Tale fumetto inscena una vivida ed immediata descrizione di un determinato stile di vita, di una sfera comportamentale che trova in Andy Capp il proprio più straordinario interprete: aggressivo, ubriacone, maschilista, sciovinista, sfaticato, qualunquista, tendenzialmente xenofobo, cosmicamente alieno da ogni forma di acculturazione, Andy antropomorfizza lo stereotipo della “bestia sottoproletaria”, riesce a rappresentare il modello del giovane marginale: disoccupazione cronica, senso del territorio, penuria economica, aggressività fisica e sessuale.
Questa “sindrome”, riferita alle classi dominanti e più in generale al ceto medio, si manifesta come stato di paranoia collettiva indotto dal combinarsi di cinque condizioni: per attivarla, la turbolenza giovanile deve svilupparsi in un periodo segnato da diffusi stati di incertezza sul proprio presente e futuro, di generalizzato rancore, che sfociano nella ricerca di capri espiatori. La seconda condizione essenziale al suo sviluppo è la presenza di un sistema di comunicazione in grado di catalizzare e riamplificare gli stati d’ansia collettiva. La turbolenza giovanile, come terza condizione, deve inoltre tendere a tracimare oltre quei quartieri e quelle porzioni di territorio consuetudinariamente assegnate alla sfera d’influenza del “giovane marginale e turbolento” e parzialmente sottratte a quelle dell’autorità costituita.
Inoltre, l’allarme giovani deve avere tra i propri interpreti, per amplificare la propria portata di sciagura nazionale, non soltanto le consuete “belve del ghetto”, quei sottoproletari che la cultura dominante vuole violenti per antonomasia, ma ragazzi di ogni ceto e condizione sociale, a sottolineare il progressivo allargamento dell’ “emergenza”. Infine, come quinta e ultima condizione, deve possibilmente esprimere valenze tali da rendere le manifestazioni di turbolenza giovanile del tutto estranee al proprio modello culturale. […]
 Valerio Marchi, Il derby del bambino morto. Violenza e ordine pubblico nel calcio, Derive Approdi, Roma 2005 |
ESTRATTO DA IL DERBY DEL BAMBINO MORTO
di Valerio Marchi
Assistere al derby da casa, davanti al televisore, induce in chi frequenta o ha frequentato con passione una curva un sottile senso di colpa. Non essere lì a sgolarsi, a sventolare bandiere, a partecipare alle coreografie, a dannarsi e a soffrire insieme alla squadra ti fa sentire inutile, un misero tesserino del vasto e anomico popolo di Sky Tv. Questo vale non soltanto per il derby romano, ma per tutte le tifoserie e per tutti i match dei nostri campionati e coppe. La dimensione televisiva ti priva di quel senso di protagonismo che soltanto lo stadio, e in particolare la curva, ti regala. Te ne stai lì, davanti allo schermo, a trepidare inutilmente. Gli echi delle tue urla sono destinati a spegnersi nella stanza, senza unirsi a quelli altre decine di migliaia di voci che a pochi o a centinaia di chilometri di distanza galvanizzano i propri ragazzi e annichiliscono gli avversari. Il peso della colpa è tale da spingere molti ai pietosi palliativi delle visioni di gruppo – nei pub, nei ristoranti, sul maxischermo in piazza – attraverso cui esorcizzare il rimorso in un tripudio di anacronistici e inutili atteggiamenti curvaroli: le bandiere, le sciarpe e le maglie coi colori sociali, l’incitamento a gola spiegata, addirittura i cori e gli slogan. La verità è che, ovunque si sia, davanti al televisore si soffre due volte: per quel che avviene in campo – o meglio per quel che la regia televisiva decide di farti vedere – e per quel sentirti un vile, un traditore, un disertore. Perché le partite guardate in televisione non contano, non fanno classifica. Questo libro nasce dallo stato d’animo con cui ho seguito dalla televisione l’incontro Lazio-Roma del 21 marzo 2004, appunto «il derby del bambino morto». Il mio ultimo abbonamento in Sud risale ormai al lontano 1996-97. Da allora le volte che sono andato all’Olimpico si contano sulla punta delle dita (ricordo un Roma-Milan soprattutto per un ininterrotto tormentone di circa 40 minuti contro il portiere Rossi, il primo e doveroso Roma-Liverpool, poco altro). Così, anche domenica 21 marzo placo l’ansia da televisore innervandomi ai cellulari di chi invece c’è. Mi giungono notizie che contrastano con la presunta tranquillità con cui Sky parlerà del pre-partita. Gli amici mi raccontano di un paio di contatti con i cuginetti, ma soprattutto delle cariche che si allargano dalla Sud fino a ponte Duca d’Aosta, dei pericolosi caroselli motorizzati e della «cattiveria genovese» della guardia di finanza. L’ultima telefonata è prima delle 20: le notizie non sono buone, gli scontri si sono spostati nell’antistadio della Sud e sembrano crescere d’intensità, il fumo dei lacrimogeni già invade parti della curva. Attendo impaziente fino alle 20,24, quando il monoscopio di Sky lascia finalmente il posto alle telecronaca, per saperne di più: i saluti, le prime banalità retoriche, le formazioni, le coreografie, l’ingresso in campo delle squadre. Sugli incidenti, niente. Solo un accenno minimizzante ai «soliti, piccoli tafferugli», gli stessi termini che utilizzerà il questore di Roma, Nicola Cavaliere, a partita già interrotta. Inizia il gioco e le poche inquadrature della curva mi suggeriscono che non tutto procede per il meglio, il movimento convulso intorno ai boccaporti mi fa temere che sta avvenendo qualcosa di brutto a ridosso della curva, ma dalla telecronaca nulla traspare. Segue l’intervallo e, alla ripresa del gioco, i commentatori di Sky non possono infine non notare e riferire la scomparsa degli striscioni prima in Sud e successivamente in Nord, in Tevere, in parte della Monte Mario. Né possono ignorare i cori contro le forze di polizia e per la sospensione della partita, sempre più alti e sempre più condivisi dall’intero stadio. Provo a richiamare i soliti amici ma i cellulari non hanno campo, un gigantesco ingorgo telefonico blocca ogni possibilità di comunicazione con l’Olimpico. Vorrei infilarmi in un paio di scarpe e correre lì a fare una qualsiasi cosa di una qualsiasi natura, nemmeno io so bene cosa, ma quel po’ di razionalità ancora in funzione mi inchioda davanti al televisore. La prima reazione all’intero spettacolo è di pura arroganza intellettuale: come ho già scritto non serve mica aver letto i saggi di Jan Harold Brunvand o di Cesare Bermani per riconoscere la natura della voce sulla morte del bambino. Sin dagli inizi, e ancor più nei fatti successivi, si manifestano in forme evidenti le caratteristiche dei boatos, delle voci incontrollate che si diffondono oralmente – una sorta di telegrafo senza fili – e che nella storia hanno abbondantemente manifestato le proprie potenzialità persuasorie. L’idea originaria del libro nasce dunque dalla «fortuna» di poter trattare un così eclatante caso di boato sviluppatosi in un contesto socialmente e strutturalmente chiuso e in un lasso di tempo particolarmente ristretto. I carichi di ansia sociale, l’assegnazione del ruolo di capro espiatorio, le valenze che in questi casi assumono i tentativi di smentita, la distorsione degli avvenimenti anche oltre ogni evidenza: «il derby del bambino morto» si presentava, fin dal titolo, come una storia degna delle leggende metropolitane raccolte, tra gli altri, anche da questi due grandi etno-antropologi. La seconda reazione è stata di consapevolezza: quel che stava avvenendo – ed è avvenuto in seguito – attorno alla vicenda del derby interrotto, dalle cronache falsificate del pre-partita alle strategie di piazza dopo la sospensione, dalle accuse di complotto alla successiva ondata repressiva, dimostrava come l’intera vicenda travalicasse i confini del Grande raccordo anulare per porsi come risultato esemplare delle politiche di ordine pubblico perseguite negli stadi in questi ultimi trenta anni e, più in generale, della crisi generale del sistema-calcio. La terza e ultima reazione è stata infine di fierezza: la presa di posizione del pubblico – “non si gioca di fronte alla morte” – mi è sembrata e continua a sembrarmi l’ennesima conferma di come nelle curve e nelle altre gradinate risieda l’ormai unica componente del sistema-calcio ancora dotata di senso etico e morale. Quel che sentivo condannare in ogni forma e tipologia mi sembrava – e mi sembra tuttora – la prima risposta valida ed efficace alle consuete litanie dello “show must go on” e dei “motivi di ordine pubblico” che impongono di giocare a ogni costo. La valanga di fango che istituzioni e mass media stavano gettando sugli ultras e, in cerchi concentrici, sul popolo di curva e su quello dell’intero Olimpico, considerati e definiti nel peggiore dei casi come degli untori e nel migliore come dei poveri creduloni, mi offendeva come credo offenda chiunque abbia messo piede in un stadio di calcio. Mi sono tornate in mente tutte le occasioni in cui non si sarebbe dovuto giocare e invece niente, avanti tutta per le consuete e radicate ragioni, e il libro che avevo in mente ha così assunto toni e accenti che pur mantenendo la dovuta e auspicabile “scientificità” riuscissero anche a rendere giustizia a tutti coloro che quella sera hanno reclamato la sospensione del gioco, compresi i tre ragazzi che con innocente inconsapevolezza hanno voluto a ogni costo comunicare i sentimenti della curva ai propri idoli. Ci sarà un processo, meritano di essere assolti. Ma intanto, in questa nostra “era del daspo”, pagheranno il loro gesto con una lunga rinuncia allo stadio.
VIDEOINTERVISTA A VALERIO MARCHI SULLE TRASFORMAZIONI
DELLA DESTRA RADICALE IN EUROPA
Dal sito Ngvision, video di 37 minuti. Valerio Marchi, intervistato l’11 luglio 2005 all’interno sua libreria, racconta le trasformazioni della destra radicale in europa, le nuove forme legate alle culture giovanili e alla musica: il punkrock e il movimento oi! l’Italia degli anni ’90, Base Autonoma, Meridiano Zero e Forza Nuova etc.



