di Sandro Moiso
L’ultima fatica cinematografica dei fratelli Coen, Inside Llewyn Davis1 , non appartiene certamente alle opere più importanti dei due autori americani, ma riesce comunque a trasmettere l’immagine e le contraddizioni di un’epoca e di un ambiente che hanno segnato in maniera significativa l’evoluzione della musica americana moderna. L’epoca è quella compresa tra i primi anni cinquanta e la seconda metà degli anni sessanta del secolo appena trascorso, mentre l’ambiente è quello dei musicisti del folk revival del Greenwich Village di New York.
Al centro delle vicende, che si sviluppano nell’arco di pochi giorni, si staglia la figura di Llewyn Davis, musicista e cantante folk di origine irlandese, spiantato, costantemente indeciso tra il proseguire una poco significativa carriera artistica oppure riprendere il mare come membro dell’ equipaggio di qualche nave mercantile. Un proletario della cultura, insomma, costantemente a caccia di un impiego sia sotto forma di ingaggio in qualche locale oppure sotto quella di un nuovo e migliore contratto discografico oppure, ancora, a bordo di una nave destinata a solcare i mari del mondo.
Proletario nelle origini e nell’attitudine, comunista per scelta, come rivela in un momento del film, e disperato intrattenitore di pubblici distratti nei café newyorchesi oltre che sfigatissimo tombeur de femmes. Un personaggio spesso antipatico, scomodo come quasi sempre sono i protagonisti della cinematografia dei Coen, ma dotato di una sua intrinseca coerenza. Soprattutto nel rifiutare tutto ciò che potrebbe limitarne la libertà espressiva e di movimento.
Tra un viaggio a Chicago, in compagnia di un musicista jazz sarcastico e tossicomane (interpretato dal solito bravissimo John Goodman), e svariate incursioni, a caccia di qualche dollaro, in una casa discografica legata alla musica tradizionale (in cui è facile individuare la Folkways Records di Moses Asch) ed incapace di promuovere adeguatamente i giovani artisti, il personaggio interpretato da Oscar Isaac corre contro tempi ed eventi che sembrano costantemente sfuggirgli di mano.
Anzi, che sembrano proprio prendersi gioco di lui. Troppo in anticipo sul rinnovamento del folk, che avverrà poi con altri nomi ed altri musicisti, ma allo stesso tempo troppo in ritardo con il suo gusto per una musica prodotta quasi artigianalmente. In tempi di musica ed artisti prodotti, poi, industrialmente. E in cui una critica troppo sincera e tutt’altro che allusiva può essere ripagata con una gran scarica di pugni da parte di un marito adirato e violento.
Tempi in cui il suicidio poteva costituire la “soluzione del problema”, l’estrema risorsa contro la sconfitta e la delusione. Così la figura dell’amico suicida, presa a prestito dai tanti folksinger che decisero così di troncare la loro vita negli anni sessanta (Peter La Farge, Phil Ochs, Paul Clayton) accompagna le vicende del protagonista, che sembra, in più di un momento, pensare alla stessa soluzione per sfuggire ai suoi fantasmi, alla delusione artistica e alle difficoltà economiche.

Ritagliato sulla figura di Dave Van Ronk, colui che fu descritto come il sindaco del Greenwich Village o, almeno, di quelle vie dedicate ai locali dove si suonava musica folk ( MacDougal Street e Bleecker Street) e dallo stesso Dylan come “il re e il signore indiscusso” di quella zona di Manhattan che gravitava intorno a Washington Square, il film ne ripercorre, sintetizzandoli, alcuni momenti topici della carriera. Avvicinandoli nel tempo e dando loro quel tocco di tristezza e di dramma che spesso fa sì che le commedie di Joel ed Ethan Coen lascino quasi sempre in bocca al pubblico il sapore amaro della sconfitta personale e dell’errore inevitabile.
E proprio questo sapore amaro accompagnato, però, da un’abbondante dose di ironia e di cinismo avvicina i fratelli Coen allo spirito dell’autentico Van Ronk e, forse, anche al sano materialismo privo di fronzoli e di orpelli inutili che ne hanno sempre caratterizzato sia le scelte musicali che di vita. Come ben dimostra la sua autobiografia recentemente pubblicata in Italia da Rizzoli2 .
Ancora un libro
“Io sono un marxista e un materialista” (pag.367). Da questa netta affermazione, probabilmente inaspettata per la gran parte di coloro che si interessano alla musica americana, occorre iniziare per comprendere il senso della ricerca musicale di Dave Van Ronk, spentosi nel 2002 all’età di sessantasei anni, e del giudizio che egli dava della società e dell’ambiente musicale in cui e con cui si trovò a vivere e convivere.
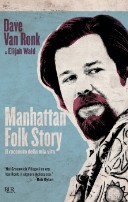 La cifra politica, infatti, segna tutta la sua esperienza, fin dagli anni cinquanta. Ripercorrere attraverso la sua penna, e quella dell’amico Elijah Wald che ha dovuto completarne la biografia dopo la sua dipartita, gli anni che vanno dai tempi del senatore McCarthy a quelli della Nuova Sinistra degli anni sessanta e anche oltre, significa entrare in una sorta di caleidoscopio di sigle ed intenzioni che potranno sorprendere molti lettori.
La cifra politica, infatti, segna tutta la sua esperienza, fin dagli anni cinquanta. Ripercorrere attraverso la sua penna, e quella dell’amico Elijah Wald che ha dovuto completarne la biografia dopo la sua dipartita, gli anni che vanno dai tempi del senatore McCarthy a quelli della Nuova Sinistra degli anni sessanta e anche oltre, significa entrare in una sorta di caleidoscopio di sigle ed intenzioni che potranno sorprendere molti lettori.
Van Ronk ci guida attraverso le sue esperienze prima nel movimento anarchico, poi tra i rimasugli degli Industrial Workers of the World fino alla sua adesione al trotzkismo e al comunismo di sinistra, senza mai interrompere il suo più totale rifiuto di ogni forma di stalinismo. E dei prodotti culturali che ne derivavano. Il tutto, però, condotto con animo, allo stesso tempo, cinico e gentile; completamente privo di qualsiasi retorica partitocratica o intellettualistica.
Così come cantava, parlava questo perfetto esempio di newyorchese nato a Brooklyn nel 1936 e morto nella stessa città. Basti qui riportare un episodio, per capirne lo sguardo e l’esperienza che ebbe modo di farsi in un ambiente in cui la memoria delle rivoluzioni europee dei primi decenni del XX secolo erano ancora molto vivaci. “Un bavarese di nome Franz, che aveva fatto parte del movimento sindacale in Germania, mi raccontò di essere stato a Monaco al tempo dell’assalto al parlamento. Qualcuno gridava «Compagni! Dobbiamo mantenere l’ordine rivoluzionario. Non calpestate le aiuole». E tutti questi tizi, armati di fucile e quant’altro, si tolsero dall’erba e si misero in fila sui vialetti lastricati. Nel frattempo, all’altra estremità del vialetto, li attendevano le mitragliatrici. Franz si accorse di cosa stava accadendo, mollò il fucile e si incamminò nella direzione opposta. Andò fino ad Amburgo, salì su una nave e venne in America. Ma da quella esperienza, diceva, la classe operaia tedesca si era ritagliata un posto speciale nel suo cuore…” (pag. 75)
La prima vera scoperta della tradizione musicale folcloristica americana avvenne infatti negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, durante la Grande Depressione. Soprattutto nell’ambiente degli immigrati e del Partito Comunista Americano. “Il Partito comunista ebbe un ruolo chiave nella nascita di questo movimento musicale; (Woody) Guthrie per un po’ tenne persino una rubrica tutta sua sul «Daily Worker» (il quotidiano del partito). Ma dall’altro creava non pochi e trascurabili problemi. Tanto per cominciare c’erano i vari avvicendamenti negli incarichi politici, per cui i membri degli Almanac Singers si ritrovavano a cantare un pezzo antimilitarista come Plow Under o altri contro l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale durante il patto Molotov-Ribbentrop per poi gettare tutto dalla finestra per intonare canti patriottici militaristici inneggianti alla guerra quando la Germania invase l’Unione Sovietica” (pag. 68).
Questa esperienza, soprattutto quella degli Almanac Singers, avrebbe fortemente segnato la generazione di folksinger precedente quella di Van Ronk e di Dylan. E fu questa la linea di demarcazione che divise per anni dal nuovo movimento folk un personaggio come Pete Seeger. Che era ritenuto da tutti quei giovani musicisti un autentico padre putativo, ma che tardò a riconoscerli come suoi legittimi eredi, anche quando negli anni sessanta gli stessi presero le sue difese per permettergli di rientrare nel mondo della radiodiffusione e della televisione americana, da cui era ancora escluso come ai tempi di Joseph McCarthy.
Ma quello che avvenne nei locali e nelle strade del Greenwich, intorno a quella Washington Square che divenne un po’ la palestra all’aria aperta per un’intera generazione di folksinger, nel periodo narrato da Van Ronk fu ancora qualcosa di diverso e di più radicale, dal punto di vista musicale.
La prima riscoperta della tradizione orale e musicale americana aveva privilegiato le tradizioni dei lavoratori e le canzoni di lotta. Spesso questo aveva mantenuto invariata la separazione tra musica bianca e nera. I neri come Leadbelly e Josh White erano ben accetti principalmente quando attraverso i canali culturali del partito comunista prestavano la loro voce alla tradizione musicale bianca e, possibilmente, impegnata.
 I giovani “bianchi” del Greenwich, però, scelsero un altro approccio. Magari con scarse attitudini musicali, ma con tanta voglia di cambiare decisero che tutto il patrimonio della musica popolare americana andava salvaguardato. Se da un lato era quindi possibile risalire alle origini inglesi ed irlandesi di quella musica, dall’altra il blues e il jazz ne facevano anche indiscutibilmente parte. Così, mentre Bob Dylan costruiva il suo primo, vero successo, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, sull’aria della vecchia ballata inglese “Lord Randall”, altri iniziarono ad andare a cercare i grandi esecutori di blues ascoltati sui vecchi dischi a 78 giri per portarli a suonare nei locali dove si suonava musica folk.
I giovani “bianchi” del Greenwich, però, scelsero un altro approccio. Magari con scarse attitudini musicali, ma con tanta voglia di cambiare decisero che tutto il patrimonio della musica popolare americana andava salvaguardato. Se da un lato era quindi possibile risalire alle origini inglesi ed irlandesi di quella musica, dall’altra il blues e il jazz ne facevano anche indiscutibilmente parte. Così, mentre Bob Dylan costruiva il suo primo, vero successo, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, sull’aria della vecchia ballata inglese “Lord Randall”, altri iniziarono ad andare a cercare i grandi esecutori di blues ascoltati sui vecchi dischi a 78 giri per portarli a suonare nei locali dove si suonava musica folk.
E anche se i primi ad avere successo furono dei gruppi bianchissimi come il Kingston Trio, tutto ciò aprì la strada alla riscoperta del blues in tutte le sue forme da un lato e alla nuova canzone cantautoriale dall’altro. Così mentre vecchi bluesman come Mississippi John Hurt, Skip James, Gary Davis e Lightnin’ Hopkins, solo per citarne alcuni, iniziavano a calcare le scene del Gaslight, dall’altra nuovi personaggi come Joni Mitchell, Leonard Cohen , Phil Ochs iniziavano a diventare le star del circuito folk.
Dave attraversò tutto il periodo e ne attraversò tutte le tendenze: dalla riscoperta del jazz tradizionale al folk anglo-irlandese, passando per le jug band e le canzoni composte da Kurt Weil e Bertolt Brecht fino a Woody Guthrie e al blues, in cui fu particolarmente favorito dalla sua voce.
“E quel brontolio profondo nella mia voce? Amico mio, sono asmatico. Più il tempo è brutto, più la mia voce è rauca e rasposa. E’ fantastico. Nasconde tutti i difetti” (pag. 231) ebbe modo di rispondere ad un giornalista che lo intervistava.
Anche se per Van Ronk “fu senza dubbio il successo di Bobby (Dylan) a mettere in moto il cambiamento. Fino ad allora il movimento folk era ancora molto legato alla tradizione, tanto che gli autori a volte spacciavano le proprie composizioni per pezzi tradizionali. Per certi versi, quindi, la cosa più importante fatta da Bobby non fu scrivere le canzoni, quanto dimostrare che era possibile scriverle” (pag. 341).
Innamorato delle belle canzoni, che spesso per lui non coincidevano con quelle impegnate o politiche, il nostro interprete dalla voce spesso cavernosa quanto quella di Tom Waits, non si preoccupò mai di avere un futuro come autore, ma si preoccupò sempre della qualità dell’esecuzione e del mantenere la propria personalità. Come quei bluesman neri cui riservò sempre la più grande ammirazione. “Il mondo che aveva generato quelle personalità non esiste più da parecchio tempo. Già all’epoca i musicisti più anziani sembravano spesso emissari di un’era mitica e ormai svanita […] (Ma) in fondo si trattava di uomini e donne adulti, e sapevano benissimo chi erano. E quella era una delle caratteristiche più importanti della loro musica, che la ragione stessa per la quale erano diventati famosi: suonavano e cantavano come persone che sapevano chi erano. Non era gente facile da impressionare. Non importa poi molto se sei un bracciante del Texas o un laureato di Harvard: se non sai chi sei, sei perso, a prescindere da dove finisci. Se invece lo sai, non ci sono problemi” (pp. 332 – 333).
“Quando si trattava di musica politicamente impegnata, il mio sguardo si faceva altrettanto critico anche rispetto ciò che veniva scritto intorno a me. Avevo l’impressione che nessuno si fosse mai lasciato convincere di essere nel torto semplicemente ascoltando una canzone; in sostanza, quando scrivi una canzone di argomento politico, stai predicando a un coro di convertiti. Ovvio però che al coro servono canzoni e poi, quando un gruppo si ritrova a cantare insieme, i suoi membri diventano più solidali gli uni con gli altri […] ho sempre pensato che la politica è politica e la musica è musica. Brecht era stalinista, ma le sue migliori canzoni non sono staliniste.[…] E parlando di Paxton, Ochs o Dylan, le loro canzoni mi piacevano quando erano ben scritte, indipendentemente da ciò che dicevano, mentre quando non erano ben scritte non mi interessavano” (pag. 346)
 In queste, e in molte altre osservazioni, sta la bellezza di una testimonianza quasi unica sulla musica folk americana e sull’ambiente politico e culturale che l’ha prodotta.
In queste, e in molte altre osservazioni, sta la bellezza di una testimonianza quasi unica sulla musica folk americana e sull’ambiente politico e culturale che l’ha prodotta.
Alcune indicazioni di carattere discografico
Nonostante lo scarso successo commerciale, la discografia di Dave Van Ronk è piuttosto estesa e disseminata tra varie case discografiche (Folkways, Prestige, Verve Forecast, Polydor, Philo solo per citarne alcune), anche se di difficile reperibilità essendo ormai quasi tutta fuori catalogo. Per iniziare a farsi un’idea dello stile e del genere musicale vale forse la pena di ascoltare la colonna sonora del film dei Coen, prodotta e arrangiata dal solito, autorevole e bravissimo T-Bone Burnette, per poi passare a qualche antologia ancora reperibile come: Down in Washington Square, The Smithsonian Folkways Collection, Smithsonian Folkways 2013 oppure la classica raccolta Inside Dave Van Ronk, che dovrebbe ancora essere reperibile in edizione Prestige, o, ancora, i suoi ultimi dischi per la Philo come il bellissimo Sunday Street, ristampato nel 1999 dalla Rounder Records. Buon Ascolto… e buona lettura!




