di Marilù Oliva
Aurelio Grimaldi, Malaspina, Elliot, Roma 2013, pp. 306, € 18,50
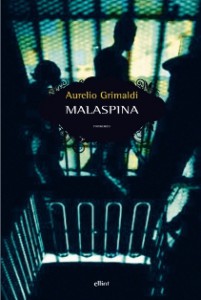 Aurelio Grimaldi ha scritto diversi libri – ricorderete Mery per sempre, del 1987 – e ha diretto vari film, tra cui La ribelle (con Penelope Cruz), Le buttane, la triade dedicata a Pasolini: Nerolio, Rosa Funzeca e Un mondo d’amore. Cito inoltre la trilogia del 2004 dedicata ad Aldo Moro e una pellicola erotica in costume, L’educazione sentimentale di Eugénie, del 2005 ma ambientato nel XVIII secolo, i cui riferimenti sono De Sade e il Decameron di Pasolini.
Aurelio Grimaldi ha scritto diversi libri – ricorderete Mery per sempre, del 1987 – e ha diretto vari film, tra cui La ribelle (con Penelope Cruz), Le buttane, la triade dedicata a Pasolini: Nerolio, Rosa Funzeca e Un mondo d’amore. Cito inoltre la trilogia del 2004 dedicata ad Aldo Moro e una pellicola erotica in costume, L’educazione sentimentale di Eugénie, del 2005 ma ambientato nel XVIII secolo, i cui riferimenti sono De Sade e il Decameron di Pasolini.
Ma torniamo ai suoi libri. Se a proposito di Mery per sempre e Ragazzi fuori si è parlato di dittico – per entrambi Dino Risi ha realizzato un film –, Malaspina, da poco uscito per Elliot, segna in qualche modo la chiusura del cerchio, perché epicentro è ancora il carcere minorile di Malaspina, in acronimo C.R.M.M., lo stesso in cui annaspavano e sopravvivevano alcuni personaggi di Mery per sempre – che ne è una versione minima –, a partire dal travestito eponimo. In quella fatiscente struttura, nella Palermo degli anni Ottanta – la città dei duecento omicidi l’anno, con il sindaco DC Martellucci che non nominava mai la parola “mafia” – il protagonista, Aurelio, un maestro ventiquattrenne che ha vissuto quattro lustri in Lombardia, ottiene l’incarico per una docenza in quarta elementare. Ha l’aspetto di un ragazzo, abbigliamento casual e – anagraficamente parlando – non è poi così lontano dai minori che si trova in classe, adolescenti dai tredici anni in su. È elettrizzato, all’inizio, per quella che ritiene una missione, anche se a poco a poco il suo entusiasmo deve fare i conti con i muri di gomma in cui rimbalza: le abitudini malsane, il clima invivibile, la rassegnazione dei detenuti alle soverchierie, l’omertà alla mafia e l’ottusa obbedienza alla stessa, le gerarchie insidiose da cui nessuno è esentato: direttore, agenti, educatori. Chi è lì rinchiuso si porta dietro solo storie tristi, scolarizzazioni disastrose, povertà, disagi sociali, famiglie la cui cifra comunicativa sono le percosse, delinquenza precoce. Il crimine è stato indossato come muta di sopravvivenza e non è raro che dallo spaccio di droga si sia passati al consumo e al furto.
Il nostro protagonista è armato di buona volontà e di speranza, talvolta sbaglia, talvolta ci prende, tenta comunque di avvalersi della potenza della persuasione e conta sulle finalità educative del suo ruolo, proponendo un modello alternativo di libertà di pensiero, uguaglianza, democrazia e diritti, anche attraverso proposte didattiche inusuali – che gli varranno l’ostilità di colleghi ed educatori –, prendendo iniziative concrete contro la mafia, come quando cerca di scalfirne la carica di tabù. E si spinge anche oltre: denuncia le violenze degli agenti contro alcuni allievi e non teme di condividere in pubblico le dichiarazioni scritte dai suoi ragazzi. Ma gli ostacoli da superare sono tanti, dai più titanici ai più ovvi, quali la totale mancanza di senso etico e civile, l’abitudine a fregare il prossimo e un maschilismo che ha radici ataviche:
«La classe si surriscaldò: ‘a fimmina non deve lavorare perché metterebbe subito le corna al marito, deve starsene a casa, non deve avere amici perché per amico ci basta il marito; appena una sorella o una figlia diventano “signorine” non devono più andare a scuola perché c’è il pericolo che sbaglino. E tutto l’angusto repertorio del caso.[…]
La verginità era giusta perché “il piacere è nel marito che la rompe” (Franco); la moglie non doveva avere amici perché “ci rumpu i iammi” (Gaetano); il maschio invece poteva avere tutte la amiche che voleva, “così ficchiamo” (in molti” e “io ‘u fazzu sulu pi sfiziu” (in moltissimi). Se la moglie avesse tradito il marito sarebbe stata uccisa a coltellate, lei e il suo amante, e i loro corpi gettati in mezzo alla strada perché tutti vedessero e capissero; il marito, invece, poteva avere tutte le amanti che voleva, “perché ‘u masculu è cacciaturi” (Ignazio)»
Quest’esperienza pedagogica però non piace ai superiori, tanto che tutti premono perché il docente non venga confermato l’anno successivo:
 evidentemente i suoi metodi formativi stanno irritando qualcuno e l’ostruzionismo che riceve ne è segnale significativo. La passione di Aurelio viene scambiata per irresponsabilità e ansia da protagonismo, in realtà mancano i presupposti per un concorde metodo didattico coi colleghi, dato che essi non credono nelle possibilità rieducative del carcere e nel recupero: in sostanza tutto quello per cui il giovane maestro si è speso. Lui confida nell’articolo 27 della Costituzione, mentre gli operatori che lo affiancano vivono la prigione solo come momento repressivo, esausti: «La colpa era tutta dell’istituzione carceraria; in galera non si può far niente se non gestire alla meno peggio il quotidiano. Questo il postulato». Pochi sfuggono a tale logica, come dimostra il comportamento degli agenti di custodia:
evidentemente i suoi metodi formativi stanno irritando qualcuno e l’ostruzionismo che riceve ne è segnale significativo. La passione di Aurelio viene scambiata per irresponsabilità e ansia da protagonismo, in realtà mancano i presupposti per un concorde metodo didattico coi colleghi, dato che essi non credono nelle possibilità rieducative del carcere e nel recupero: in sostanza tutto quello per cui il giovane maestro si è speso. Lui confida nell’articolo 27 della Costituzione, mentre gli operatori che lo affiancano vivono la prigione solo come momento repressivo, esausti: «La colpa era tutta dell’istituzione carceraria; in galera non si può far niente se non gestire alla meno peggio il quotidiano. Questo il postulato». Pochi sfuggono a tale logica, come dimostra il comportamento degli agenti di custodia:
«Ormai non mi sorprendevo più del loro atteggiamento ostile, degli sguardi bassi, dei ritardi consapevoli con cui mi consegnavano le chiavi dell’aula, facendo finta di non vedermi e lasciandomi impalato finché non perdevo la pazienza e andavo nel loro corridoio a reclamarla: e quelli trovavano la faccia di scusarsi dicendo di non avermi scorto».
Una storia indimenticabile, tanto più sapendo che è vera, scritta con precisione e sentimento, storia che, involontariamente, è un po’ metafora della nostra Italia, del suo stato di abbandono, dello scarso senso civico, della cura del particolare, del dilagare di furberie e mani che si allungano per strappare un po’ di potere. Anche nel libro, infatti, «ormai era tutto chiaro; perché li dentro, a Malaspina, ogni settore operativo era un compartimento stagno, un clan, una camarilla».



