di Roberta Cospito
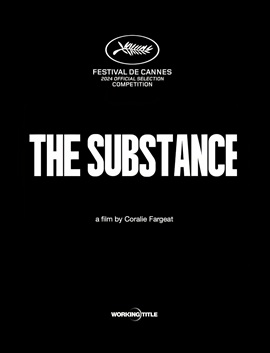 Di The Substance, film di Coralie Fargeat – regista francese apprezzata in passato per il suo Revenge (2017), in cui raccontava la vendetta di una donna stuprata –, se ne sta parlando molto e con commenti piuttosto divergenti.
Di The Substance, film di Coralie Fargeat – regista francese apprezzata in passato per il suo Revenge (2017), in cui raccontava la vendetta di una donna stuprata –, se ne sta parlando molto e con commenti piuttosto divergenti.
In effetti, è un film piuttosto particolare per cui questa varietà di opinioni non mi stupisce affatto; sinceramente, anch’io non ho capito bene in quale percentuale mi sia piaciuto, ma sta di fatto che il film è senza dubbio interessante.
Approdato nella sale italiane tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, il film ruota attorno all’assunzione di una “sostanza” reperita sul mercato nero da parte dell’attrice cinquantenne Elisabeth Sparkle (fisico e volto sono di Demi Moore), ormai in declino e relegata a fare lezioni di aerobica per la televisione, nonostante in passato sia stata premiata anche con un Oscar.
L’imperativo dello show business è però impietoso e, così, lo spiacevole produttore del programma – Harvey, stesso nome di battesimo di Weinstein, il tristemente noto produttore cinematografico statunitense –, con le fattezze dell’attore statunitense Dennis Quaid, decide che ormai Elisabeth ha fatto il suo tempo ed è ora che lasci il campo a una sostituta più avvenente.
L’essere licenziata proprio nel giorno del suo cinquantesimo compleanno perché non ha più lo splendore della gioventù – curiosamente il suo cognome, Sparkle, in inglese significa scintillare –, fa precipitare la diva nella depressione più totale per cui, di fronte alla possibilità di ritornare ai fasti del passato, cede rapidamente alla tentazione d’inocularsi una sostanza che le darà la possibilità di creare – in pratica, partorire non dal grembo ma dalla schiena – una versione migliore di se stessa, dove per migliore in questo caso s’intende più giovane e bella.
Le regole del procedimento sono poche, semplici e ben spiegate: il siero è inoculabile una sola volta e le due donne, la “diva matrice” e la “diva altra sé”, dovranno alternarsi ogni sette giorni, l’una andando in una specie di letargo mentre l’altra resterà libera di agire: Elisabeth potrà così rivivere per interposta persona un’altra giovinezza con tutti i suoi benefici, percependo nello stato “vegetativo” tutto quello che l’altra – interpretata da Margaret Qualley, battezzata Sue – vivrà direttamente.
L’esperimento pare funzionare. Sue riesce a essere la protagonista dello spettacolo che prima era condotto da Elisabeth riscuotendo un successo strepitoso ed entrando rapidamente in un vortice di impegni, conoscenze, opportunità, ormai precluse all’altra che si ritroverà, invece, ad affrontare settimane di solitudine e inattività a cui non era abituata.
Ben presto, a Sue il tempo a sua disposizione non basta più e – contravvenendo alla regola dell’alternanza e dimenticando l’imperativo che le viene fornito insieme al kit di (ri)generazione di tenere ben presente il fatto che l’identità è una sola, seppur in qualche modo sdoppiata – decide di non lasciare più possibilità di vita all’altra innescando, così, un meccanismo di devastazione del corpo (matrice) di Elisabeth da cui pare impossibile ritornare indietro.
Ogni momento rubato alla vita dell’altra crea a questa un terribile invecchiamento del corpo, un po’ come succede ne Il ritratto di Dorian Gray per cui Dorian venderà la sua anima per garantirsi che sarà un’immagine dipinta e non il proprio corpo a invecchiare.
L’aspetto più rilevante e apprezzabile del film è la denuncia che fa la regista: è evidente la critica allo show business, al mondo degli affari che alimenta quello dello spettacolo. per cui bisogna massimizzare i guadagni e buttare via ciò che viene considerato obsoleto, persone incluse; un mondo in cui bisogna vincere a ogni costo e pazienza se si lasciano dei feriti sul campo.
L’altra forte critica è nei confronti di una società in cui la mercificazione del corpo delle donne è all’ordine del giorno, decisa a farci credere che l’esteriorità, la bellezza, sia l’unico obiettivo che valga la pena perseguire nella vita.
La regista, con decise inquadrature sul corpo giovane e sodo di Sue, stringendo l’occhio della telecamera su glutei, cosce, seni e labbra, restituisce alla perfezione lo sguardo che alcuni uomini posano senza il minimo rispetto sui corpi femminili ignorando (o facendo finta di ignorare) quanto sia offensivo e doloroso per chi li riceve. Ma assieme si sviluppa una critica anche nei confronti di chi non riesce ad accettare i segni che il passare del tempo lascia inevitabilmente sul nostro corpo, segni che dovremmo imparare, se non proprio ad apprezzare, almeno ad accettare con serenità, lasciando che la natura segua il suo corso.
 A un certo punto del film Elisabeth incontra un suo vecchio compagno di scuola che, incantato dal suo aspetto – stiamo parlando di Demi Moore, una bellezza decisamente fuori del comune –, riesce a vincere la timidezza lasciandole il suo numero di cellulare; in un primo momento, lei lo liquida velocemente, ma quando i morsi della solitudine iniziano a farla sanguinare decide di telefonargli e accettare un suo invito a cena. La sera stabilita si prepara con cura e, con il suo attillato vestito rosso, si appresta a uscire, ma il suo sguardo si posa sull’immagine di Sue ritratta in un enorme poster visibile dalla finestra del suo appartamento e, a quel punto, corre in bagno ad aggiustarsi il trucco, i capelli, una, due, tre volte, finché alla fine rinuncerà a uscire non considerandosi nemmeno abbastanza bella da poter farsi vedere dal suo ex compagno di scuola, un uomo che definirlo ordinario è un complimento, o da eventuali avventori del ristorante dove i due si sarebbero incontrati.
A un certo punto del film Elisabeth incontra un suo vecchio compagno di scuola che, incantato dal suo aspetto – stiamo parlando di Demi Moore, una bellezza decisamente fuori del comune –, riesce a vincere la timidezza lasciandole il suo numero di cellulare; in un primo momento, lei lo liquida velocemente, ma quando i morsi della solitudine iniziano a farla sanguinare decide di telefonargli e accettare un suo invito a cena. La sera stabilita si prepara con cura e, con il suo attillato vestito rosso, si appresta a uscire, ma il suo sguardo si posa sull’immagine di Sue ritratta in un enorme poster visibile dalla finestra del suo appartamento e, a quel punto, corre in bagno ad aggiustarsi il trucco, i capelli, una, due, tre volte, finché alla fine rinuncerà a uscire non considerandosi nemmeno abbastanza bella da poter farsi vedere dal suo ex compagno di scuola, un uomo che definirlo ordinario è un complimento, o da eventuali avventori del ristorante dove i due si sarebbero incontrati.
Chi come me in quel momento faceva il tifo per lei, una donna che finalmente avrebbe potuto ricevere i complimenti cui era stata abituata e di cui aveva un bisogno disperato per ricominciare a sentirsi viva, resta delusa dalla sua scelta di non uscire ma, d’altra parte, quando una persona è abituata a essere osannata, idolatrata, ammirata quotidianamente la vita “normale” è dura da gestire, l’equilibrio con se stessi difficile da raggiungere.
La maturità, il vissuto da cui Elisabeth dovrebbe o potrebbe ricevere forza, non riesce a evitarle l’arenarsi in poltrona davanti alla televisione; fa riflettere il fatto che, nonostante i tanti soldi guadagnati in una vita da prima donna, le varie frequentazioni con altre celebrità, i riconoscimenti di vario tipo (addirittura la stella sulla Hollywood Walk of Fame) non resti traccia né di felicità né di rapporti umani su cui poter contare.
The Substance mi ha lasciata perplessa per qualche momento eccessivamente didascalico come, per esempio, il sottolineare più volte e da subito l’unicità delle due versioni femminili – peraltro, ponendo lo spettatore in uno stato di allerta per cui si può immaginare che sarà proprio questo l’aspetto che creerà problemi nella gestione della sostanza – e qualche esagerazione di troppo; per esempio, molti hanno ritenuto eccessivo il finale in cui viene versato sangue a ettolitri – scene, in effetti, molto splatter che però possono essere giustificate dal voler farci riflettere sulla mostruosità della bellezza a ogni costo – ma, personalmente, ho trovato più fastidioso il fatto che Sue riesca a ricavare dal suo bagno una sorta di sgabuzzino non visibile all’esterno, con l’abilità di una carpentiera d’esperienza quando, invece, si sta parlando di una star della tv che nulla c’entra con fiamme ossidriche e martelli.
 Durante la visione del finale, mentre le immagini del corpo in disfacimento di Elisabeth riempivano il grande schermo, continuavo a pensare al saggio di Jude Ellison Sady Doyle Il mostruoso femminile edito da Tlon, un’opera che indaga – analizzando miti, letteratura e anche cinema horror – la primordiale paura che il patriarcato nutre da sempre nei confronti delle donne: “La donna è sempre stata un mostro. La mostruosità femminile si insinua in ogni mito, dal più noto al meno conosciuto: sirene carnivore, Furie che con artigli affilati come rasoi dilaniano uomini, leanan sídhe che incantano mortali per poi prosciugarne l’anima. Queste figure – di una bellezza letale o di una bruttezza intollerabile, subdole o traboccanti di furore animale – rappresentano tutto ciò che gli uomini trovano minaccioso nelle donne: bellezza, intelligenza, rabbia e ambizione. Nel mito cristiano, a essere donna è l’apocalisse. Nella Bibbia, infatti, si profetizza che la fine dei tempi sarà dominata da una regina lussuriosa con in mano un calice d’oro «colmo delle abominazioni e delle impurità della sua prostituzione”.
Durante la visione del finale, mentre le immagini del corpo in disfacimento di Elisabeth riempivano il grande schermo, continuavo a pensare al saggio di Jude Ellison Sady Doyle Il mostruoso femminile edito da Tlon, un’opera che indaga – analizzando miti, letteratura e anche cinema horror – la primordiale paura che il patriarcato nutre da sempre nei confronti delle donne: “La donna è sempre stata un mostro. La mostruosità femminile si insinua in ogni mito, dal più noto al meno conosciuto: sirene carnivore, Furie che con artigli affilati come rasoi dilaniano uomini, leanan sídhe che incantano mortali per poi prosciugarne l’anima. Queste figure – di una bellezza letale o di una bruttezza intollerabile, subdole o traboccanti di furore animale – rappresentano tutto ciò che gli uomini trovano minaccioso nelle donne: bellezza, intelligenza, rabbia e ambizione. Nel mito cristiano, a essere donna è l’apocalisse. Nella Bibbia, infatti, si profetizza che la fine dei tempi sarà dominata da una regina lussuriosa con in mano un calice d’oro «colmo delle abominazioni e delle impurità della sua prostituzione”.
Mi piace chiudere così, con la letteratura, a mio avviso sempre poco citata quando si scrive di cinema, benché nelle numerose recensioni a The Substance abbondino, anche giustamente, gli accostamenti con film quali The elephant man di David Lynch, Shining di Kubrick, Crash di David Cronenberg, Titane di Julia Ducournau, La morte ti fa bella di Robert Zemeckis, Alien di Ridley Scott, Carrie. Lo sguardo di Satana di Brian De Palma e molti altri ancora.



