di Gioacchino Toni
 A proposito della raccolta di saggi di Richard Hofstadter, La repubblica dei fucili. L’America come cultura delle armi e altri saggi (Luiss University Press, 2024), di cui ci si è occupati relativamente alla diffusione della violenza e delle armi negli Stati Uniti su “Carmilla”, vale la pena soffermarsi anche sui testi più datati presenti nel volume. Per quanto le riflessioni espresse dallo storico americano contenute in La rivolta pseudo-conservatrice vadano contestualizzate al momento in cui le scrive, a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, non mancano di essere di una qualche utilità ancora oggi al fine di comprendere meglio le radici che hanno condotto ad un immaginario politico americano in cui l’universo liberal sembra aver totalmente perso la sua spinta al cambiamento.
A proposito della raccolta di saggi di Richard Hofstadter, La repubblica dei fucili. L’America come cultura delle armi e altri saggi (Luiss University Press, 2024), di cui ci si è occupati relativamente alla diffusione della violenza e delle armi negli Stati Uniti su “Carmilla”, vale la pena soffermarsi anche sui testi più datati presenti nel volume. Per quanto le riflessioni espresse dallo storico americano contenute in La rivolta pseudo-conservatrice vadano contestualizzate al momento in cui le scrive, a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, non mancano di essere di una qualche utilità ancora oggi al fine di comprendere meglio le radici che hanno condotto ad un immaginario politico americano in cui l’universo liberal sembra aver totalmente perso la sua spinta al cambiamento.
Se negli anni Trenta «la forza dinamica della politica americana era il dissenso liberal», che si proponeva di «riformare le ingiustizie del nostro sistema sociale ed economico e cambiare il modo di fare le cose», negli anni Cinquanta «la vita politica non trae più il suo dinamismo dai liberal […] che hanno inconsapevolmente assunto la psicologia di chi li ha preceduti»; molti dei soggetti marginali a cui si rivolgeva il New Deal hanno nel frattempo trovato una collocazione stabile nella società tanto da indurli ad un certo “conservatorismo”. «I vecchi liberal», negli anni Cinquanta, scrive Hofstadter, «non auspicano certo qualche nuovo ambizioso programma, ma si limitano a difendere quanto possibile i traguardi già raggiunti e la libertà di espressione» (p. 62).
Secondo lo storico, le nuove forme di dissenso non solo non possono dirsi radicali, ma nemmeno del tutto conservatrici: a differenza del passato, queste presentano una richiesta continua di conformismo, tanto che si potrebbe parlare di «pseudo-conservatorismo». A palesarsi è infatti una forma di evidente «insoddisfazione per la vita americana, le sue tradizioni e le sue istituzioni»; sono lontane dal moderatismo incline al compromesso del conservatorismo classico esprimendo infatti «un odio profondo, seppure inconsapevole, per la nostra società e le sue dinamiche» (p. 63).
«Lo pseudo-conservatore», scrive Hofstadter, «crede di vivere in un mondo dove qualcuno lo spia, sta tramando contro di lui, lo sta tradendo e lo porterà alla rovina, crede che le sue libertà siano state invase in modo arbitrario e intollerabile. È contrario a quasi tutte le novità degli ultimi vent’anni di politica americana» (p. 65). Questa figura non sopporta la burocrazia così come la partecipazione del proprio Paese ad organismi sovranazionali, come l’Onu, detesta avere a che fare con altre nazioni e soprattutto rifiuta di doverle aiutare economicamente e militarmente, percepisce la debolezza degli Stati Uniti, che vede in balia di azioni eversive provenienti da ogni dove, ed imputa ogni fallimento internazionale ad un tradimento. «L’ostilità latente e diffusa verso le istituzioni americane prende la forma di una valanga di proposte per stravolgere i corpus delle nostre leggi fondamentali» (p. 66).
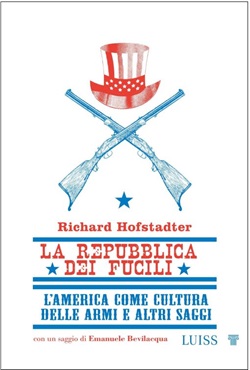 Secondo lo storico si è di fronte a qualcosa di profondamente diverso dal vecchio ultra-conservatorismo isolazionista; questo fenomeno di pseudo-conservatorismo deriverebbe direttamente dalla «vita americana, eterogenea e senza radici, e soprattutto [dal] modo caratteristico con il quale gli americani da sempre ambiscono a uno status e a un’identità stabile» (p. 71). Un universo, quello americano, che negli anni Sessanta fa sempre più fatica a rapportarsi con quel melting pot celebrato dallo storytelling ufficiale, che non vede più funzionare la mobilità sociale e occupazionale, ormai ridotte a ricordi del passato.
Secondo lo storico si è di fronte a qualcosa di profondamente diverso dal vecchio ultra-conservatorismo isolazionista; questo fenomeno di pseudo-conservatorismo deriverebbe direttamente dalla «vita americana, eterogenea e senza radici, e soprattutto [dal] modo caratteristico con il quale gli americani da sempre ambiscono a uno status e a un’identità stabile» (p. 71). Un universo, quello americano, che negli anni Sessanta fa sempre più fatica a rapportarsi con quel melting pot celebrato dallo storytelling ufficiale, che non vede più funzionare la mobilità sociale e occupazionale, ormai ridotte a ricordi del passato.
Oltre ad essere un’arena in cui si confrontano interessi materiali contrastanti dei diversi gruppi sociali, la politica è anche luogo in cui vengono proiettate «le aspirazioni e le frustrazioni relative allo status; luogo in cui si intersecano temi politici, di interessi, e problemi individuali, di status, in cui questi ultimi tendono ad avere la meglio. Se nei momenti di depressione e malcontento economico il dissenso tende ad incanalarsi in richieste di riforme concrete, nei momenti di maggior prosperità, quando sono le questioni di status ad avere il sopravvento, il dissenso assume la forma della lamentela priva di proposta concreta, di rivalsa, rancore e ricerca di capri espiatori. «Le preoccupazioni di status accomunano paradossalmente due tipi di persone che giungono da direzioni opposte. Il primo tipo è quello degli anglosassoni di antica tradizione, protestanti, il secondo quello delle famiglie d’immigrati, soprattutto di discendenza tedesca e irlandese, spesso cattoliche» (pp. 74-75). I primi guardano allo pseudo-conservatorismo nel momento in cui sentono di perdere privilegi di casta, i secondi quando li guadagnano. Se molti liberal tendono a vedere nel dissenso pseudo-conservatore una minaccia alle libertà in direzione totalitaria, Hofstadter si dice restio a bollarlo come puramente fascista o totalitario.
Con Pseudo-conservatorismo revisited. Un post-scriptum dei primi anni Sessanta, lo storico americano torna su quanto scritto a metà del decennio precedente soprattutto per apportare alcune modifiche a proposito del concetto di politica di status.
Alla metà degli anni Cinquanta appartiene lo scritto Il mito dell’allegro possidente dedicato alla trasformazione del piccolo agricoltore proprietario della terra che lavora in imprenditore. Hofstadter ricostruisce le discrepanze tra la figura del reale piccolo proprietario terriero al lavoro nei campi e la narrazione che di esso è stata a lungo fatta negli Stati Uniti, che ha continuato a presentarlo come esempio di lavoratore industrioso, indipendente, autosufficiente e dotato di spirito egalitario anche quando, ormai, questo si era trasformato in imprenditore commerciale. Paradossalmente, spiega lo studioso, più lo yeoman ai allontanava da un’attività incline all’autosufficienza in favore di un’agricoltura imprenditoriale, più cresceva una narrazione incline alla nostalgia per il passato rurale, probabilmente in ossequio alla presunta innocenza delle origini.
Lo yeoman, proprietario di una piccola fattoria conduzione famigliare, incarnava la «persona semplice, onesta, sana, indipendente e felice [che] viveva in comunione con una natura benevola» (p. 99), vera e propria base di una società virtuosa, figura secolare e al tempo stesso religiosa, in quanto espressione del lavoro della terra creata da Dio. Un mito, quello agreste, non nato in seno al popolo, bensì come concetto letterario ideato dalle classi più agiate che lo avevano derivato dalla cultura inglese dalla seconda metà del Settecento, che a partire dal secolo successivo si sarebbe diffuso nell’immaginario popolare statunitense. La Rivoluzione americana avrebbe poi contribuito a fare dello yeoman una sorta di simbolo della nuova nazione. Nel guardare alla città, questa figura vi scorgeva una sorta di alieno ed ostile «coacervo di strozzini, dandy, damerini e aristocratici pieni di idee europee» (p. 105) che lo trattava da bifolco.
Se nel corso del periodo coloniale, fino all’Ottocento inoltrato, ancora era ravvisabile una certa corrispondenza tra lo yeoman reale e la narrazione che di esso veniva fatta, con lo spostamento verso le praterie e la possibilità di introdurre macchinari nel lavoro nei campi, il contadino inizia ad abbandonare forme di autosufficienza per occuparsi della “coltura da reddito” modificando non solo la vita quotidiana ma anche l’immaginario.
Si sviluppò così una società agricola che a differenza di quella dello yeoman non si sentiva legata alla terra, ma al valore della terra. Il vero frutto della società rurale americana, sviluppatasi su praterie e pianure, non era lo yeoman o il tranquillo abitante del villaggio, ma uno stressato piccolo affarista di campagna che lavorava sodo, si trasferiva fin troppo spesso, giocava d’azzardo con la propria terra, e si faceva strada con le sue forze. […] Divenne un uomo d’affari molto prima di cominciare a considerarsi tale (p. 111).
Con la fine dell’Ottocento questa figura, per quanto ancora attiva direttamente sui suoi possedimenti terrieri, iniziò a guardare ai propri dipendenti, aumentati decisamente di numero, con il medesimo sospetto con cui guardava ai lavoratori di città, soprattutto se sindacalizzati, come un tempo guardava ai “damerini e aristocratici”. A spazzare definitivamente via il vecchio yeoman saranno però soprattutto i mezzi di comunicazione novecenteschi – dai trasporti ai mass media radiofonici, cinematografici e televisivi – con il loro affievolire sempre più le differenze tra il mondo rurale e quello cittadino.



