di Franco Pezzini
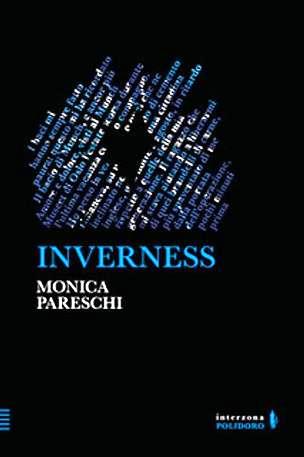 Monica Pareschi, Inverness, pp. 174, € 15, Polidoro, Napoli 2024.
Monica Pareschi, Inverness, pp. 174, € 15, Polidoro, Napoli 2024.
Traduttrice eccellente e attivissima, Monica Pareschi è anche un’elegante e sorprendente narratrice. Sorprendente non nel senso relativo che un lettore non possa attendersi un esito alto da chi quotidianamente ingaggia al suo livello un corpo a corpo con la parola (è autrice del resto del bel romanzo È di vetro quest’aria, Italic Pequod, 2014, e di pregevoli racconti apparsi su varie testate); ma in senso assoluto, per l’impatto di narrazioni che – non sembri un’affermazione naïf, non è affatto scontato – continuano a sollecitare ancora a libro chiuso. E si può essere grati al direttore Orazio Labbate, per averlo inserito della collana Interzona.
Iniziamo col dire che questi racconti elegantissimi, godibilissimi e dunque capaci (altra dote non scontata) di farsi divorare, presentano varia metratura, dai molto brevi ad alcuni di ampio respiro, sia pure con un senso del ritmo e un equilibrio dosatissimi, come l’“Inverness” che chiude la raccolta. E partiamo dalla definizione di quarta di copertina:
Una raccolta di racconti spietata che si dipana a mo’ di lunga narrazione fondata su una deliziosa crudeltà sentimentale.
Un’opera fondata sui sentimenti più nascosti, sulle piccolezze mostruose, vitree, che tutti noi coviamo mentre amiamo e mentre odiamo. Una costellazione di racconti che divaricano l’anima piano piano, come cristalli Swarovski. In queste storie c’è, nell’incontro con l’altro, una paura antica: incontri sbagliati e mancati, incontri fatali. Baci velenosi. Bambine dai difetti repellenti. Addii freddi e intollerabili, ricambiati in parte e scambiati per eterne maledizioni. Il confine sottile tra il vedersi davvero e l’inorridire […].
Il che già dice qualcosa di fondamentale: sono racconti crudeli. Ma con la marcia in più, rispetto a certa scipita crudeltà splatter che si limita ad affettare i corpi, di raccontare con straordinaria misura e piglio autenticamente letterario reazioni che ci inabitano tutti, tagliando come un bisturi sulla carne viva della nostra interiorità. Tagliando a base di conati cerebrali, tentazioni e tanti irrisolti: qualcosa che seziona il nostro modo di porci rispetto agli altri, di guardarli, di sfiorarli, in particolare nelle dinamiche dei sentimenti.
Dunque crudeltà: basti pensare alla spaventosa vita di campagna di “Primo amore”, ai corteggiatori/gabbiani manipolatori di varie storie, al gioco al massacro di “Troppo amore uccide”, alla brutalità infelice di Gheri in “Mors tua vita mea”, alla repellente Mariangela di “Un bacio, ancora” con la sua sozza e inattesa iniziazione della protagonista, alla troppo disinvolta e privilegiata P. di “Inverness”. Una crudeltà che colpisce i più fragili – quelli archiviati dalla vita a opere di brave famiglie, o i socialmente nell’angolo – ma anche persone in fondo realizzate, e tuttavia insidiate per dinamiche di potere, sessuale in primo luogo.
Eppure, come accennato, un altro elemento torna a serpeggiare come un filo grigio, forte in queste storie. La dimensione cioè di conati, tentazioni e irrisolti: infatti ricorrente, ed elemento connotante la raccolta, è il tema della sospensione. Una sospensione sfiorata, in atti che vengono consumati in anestesia o alla fine come in un cono d’ombra, ne “I baci di Munch o la perfezione dell’amore”: dove il focus resta sul prodromo all’amplesso, quasi in virtuale sospensione di quanto segua. Atti che invece non vengono consumati, pur proiettando tutta la loro potenza allusiva o decomponendosi nell’onirico, come in “Primo amore”, in “Fiori” (“Non è successo niente”) e “Troppo amore uccide” – dove a sospendersi sono intere relazioni. O ancora nella scena chiave di “Mors tua vita mea” (“In fondo, a ben pensarci, non è successo niente”), e nella tentata predazione seduttoria, vorace e alla fine grottesca, di “I gabbiani”. Poi ci sono mete che non vengono raggiunte (l’Inverness del racconto è quasi un controcanto dell’Itaca di Kavafis, non solo nell’esito ma nella simbolica qui fallimentare del viaggio); e baci – di nuovo – che restano sbavature impossibili da cancellare nella vana attesa di pacificarsi in qualche modo, come appunto in “Un bacio, ancora”. E in tutte queste storie, esplicita o virtuale ma incalzante, quella sospensione della vita che è l’invecchiare e trascorrere verso la morte.
I maschietti in scena sono in gran parte sordidi, immaturi, viriloidi di mezza tacca; le donne spesso raffrenate da ombre divoranti, compulsioni sociali, perplessità radicali o malattie. Le coppie sembrano fatte per non funzionare, esaurirsi in una sessualità tutta eventuale – e spesso sospesa – e tanta solitudine. Le amicizie non mostrano la pietas sperata, le complicità fanno acqua o si esauriscono in teatrini sovraccitati che rivelano liaisons malamente velate. Né si può attribuire il quadro amaro solo alla stagione fascistoide in cui siamo a mollo: alcune storie proiettano nel passato, forse i tempi permettono solo di evocarle come emblematiche, anche se evidentemente non si tratta di studi sociologici. Al netto d’altronde di un’amarezza generale – e a tratti di una maliziosa ironia – la raccolta è troppo sottile nelle sue analisi interiori, troppo pungente, elegante e (usiamo pure il termine, che non svilisce) troppo divertente per risolvere personaggi e bozzetti in stereotipi.
Significativa la scena della ragazza il cui zaino viene perquisito da corrucciati e superficiali poliziotti: le mani sporche, la rabbia e l’ironia che l’operazione suscita nelle battute di lei, il rapporto fallimentare tra i sessi, i pregiudizi verso il non allineato, la forzatura a tirar fuori il proprio intimo… e quella parallela con l’intimo psicologico e fisico insidiato per tutta la raccolta in rapporti sentimentali sghembi, estorsivi, voraci – come vede nel bacio, “prodromo crudele del banchetto amoroso”, la voce narrante di “I baci di Munch o la perfezione dell’amore”. Un racconto felicemente in testa alla raccolta: il Munch del Grido e del Vampiro (cioè l’Amore e dolore qui citato), nonché dello struggente Il bacio (pure ovviamente menzionato), dove le carni degli amanti sembrano fondersi in un impasto cereo più inquietante che romantico, appare una sorta di patrono della malinconia crepuscolare e iperborea di questi testi. Dove una speranza ormai archiviata e un dolore sordo trascinato lasciano nondimeno emergere come un palpito di sguardo il tremolio fragile di una bellezza: “[…] due cose insieme come sempre, e non sa come tenere entrambe, il dolore e la bellezza della sua vita”.
Ma in un contesto di solidarietà fallite la sospensione si fa spesso separazione, scelta di solitudine. La netta freddezza evocata dal nome Inverness cui punta una ragazza dalla vita repressa (“è un nome pieno di sole e di luce ghiacciata, azzurra. Un nome che contiene l’inverno”) è in fondo la freddezza di quella solitudine invernale che alla fine incontra (“Poi proseguiamo, divise, negli anni”), come qui tanti altri personaggi. Dio ci guardi dalle preghiere esaudite, diceva santa Teresa.



