di Marco Sommariva
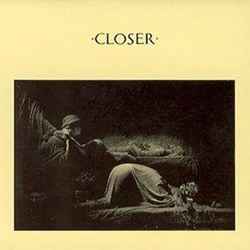 Quando, nell’estate del 1980, misi sul piatto del giradischi Closer, il secondo album in studio dei Joy Division, mia madre mi chiese se potevo ascoltarlo con le cuffie invece che dagli altoparlanti dell’impianto stereo così che a lei, indaffarata in cucina, non arrivasse neppure una nota di quel disco. Negli anni precedenti aveva apprezzato qualsiasi vinile entrasse in casa, da Bruce Springsteen a Jackson Browne a Edoardo Bennato, da Patti Smith alla Premiata Forneria Marconi ai Pink Floyd, da Bob Marley a Eugenio Finardi ai Genesis alla colonna sonora del film Jesus Christ Superstar, e stiamo parlando di una donna credente che da ragazza, trent’anni prima, ascoltava Nilla Pizzi e Achille Togliani. In quegli anni arrivò a chiedermi come mai non avevo ancora acceso il giradischi e, persino, se potevo mettere un long playing piuttosto che un altro, ma coi Joy Division alzò subito bandiera bianca, disse proprio: “Non riesco ad ascoltare queste canzoni: sono tristi”.
Quando, nell’estate del 1980, misi sul piatto del giradischi Closer, il secondo album in studio dei Joy Division, mia madre mi chiese se potevo ascoltarlo con le cuffie invece che dagli altoparlanti dell’impianto stereo così che a lei, indaffarata in cucina, non arrivasse neppure una nota di quel disco. Negli anni precedenti aveva apprezzato qualsiasi vinile entrasse in casa, da Bruce Springsteen a Jackson Browne a Edoardo Bennato, da Patti Smith alla Premiata Forneria Marconi ai Pink Floyd, da Bob Marley a Eugenio Finardi ai Genesis alla colonna sonora del film Jesus Christ Superstar, e stiamo parlando di una donna credente che da ragazza, trent’anni prima, ascoltava Nilla Pizzi e Achille Togliani. In quegli anni arrivò a chiedermi come mai non avevo ancora acceso il giradischi e, persino, se potevo mettere un long playing piuttosto che un altro, ma coi Joy Division alzò subito bandiera bianca, disse proprio: “Non riesco ad ascoltare queste canzoni: sono tristi”.
Dopo più di quarant’anni ascolto ancora i Joy Division e vi garantisco che, al momento, non ho ancora preso in considerazione l’idea di ammazzare nessuno; scrivo così perché, poco dopo la tragedia di Paderno Dugnano, ho letto su Il Messaggero che il ragazzo che ha ucciso fratello e genitori, fra le altre cose, avrebbe detto: “Ascoltavo tanta musica triste. Soprattutto i Beatles. Sentivo in continuazione una loro canzone, The Long and Winding Road”, frase che ho sentito riportata anche in più di un programma televisivo. Come spesso accade, di fronte a certi drammi s’inizia a costruire castelli sul niente o poco più: “L’interrogatorio di R. non è solo la ricostruzione della dinamica del triplice omicidio, ma un viaggio nella mente del diciassettenne: il suo immaginario, i suoi pensieri, cosa abbia trasformato un ragazzo studioso e sportivo in un triplice omicida. E agli inquirenti racconta di quel brano che parla di una lunga e tortuosa strada fatta di solitudine, la stessa che stava percorrendo.”
Qualche corto circuito mentale mi riporta ai tempi in cui se ne scrivevano di tutti i colori sui fumetti di Dylan Dog, comprese considerazioni dove si affermava che i ragazzi che leggevano certi episodi del personaggio creato da Tiziano Sclavi, rischiavano di rimanere avvolti da una sensazione di impotenza di fronte a un mondo fatto di orrori, di violenza e sopraffazione, e che per loro era facile cadere nella trappola del pessimismo, che nelle pagine dell’Indagatore dell’incubo non si comprendeva dove finiva l’ironia e dove cominciava l’intenzione seria di proporre ai lettori un approccio con il mondo dell’occultismo e che alla fine, ridendo e scherzando, i ragazzi sembravano avvicinarsi a certi pericolosi argomenti e, soprattutto le menti più fragili, finivano davvero per interessarsi al satanismo, e così dallo scherzo si rischiava di passare alla pratica reale. E via cantando.
E chissà mai che, per difendere i nostri ragazzi, prima o poi non si arrivi a una proposta di legge in cui si chieda di vietare musica, fumetti e, perché no, cinema, teatri e quant’altro, magari sulla base dell’esperienza afghana che dimostra gli ottimi risultati raccolti dai talebani da iniziative quali bruciare strumenti musicali, perché – come l’ascolto della musica e il ballo, vietati pure questi – sono in grado di corrompere i giovani.
Sulla tragedia di Paderno Dugnano, lo scorso 3 settembre ho letto sul quotidiano Avvenire un interessante articolo di Nicoletta Martinelli Il pezzo inizia con un’affermazione di Simone Feder, psicologo presso la Casa del Giovane a Pavia, il quale ricorda che in Italia, sino al 1986, i canarini erano usati nelle miniere per segnalare la presenza di gas tossici che, se respirati, avrebbero ucciso i minatori; per i lavoratori, gli uccellini in questione erano sia un allarme visivo quando morivano, sia un allarme uditivo quando smettevano di cantare. Lo psicologo ricorda quanto sopra per dire che, oggi, i nostri canarini sono gli adolescenti, ma che il problema non va cercato nella morte del canarino, fuor di metafora nei gesti estremi in cui vediamo coinvolti i ragazzi, ma nell’aria che è tossica e, quindi, nella società.
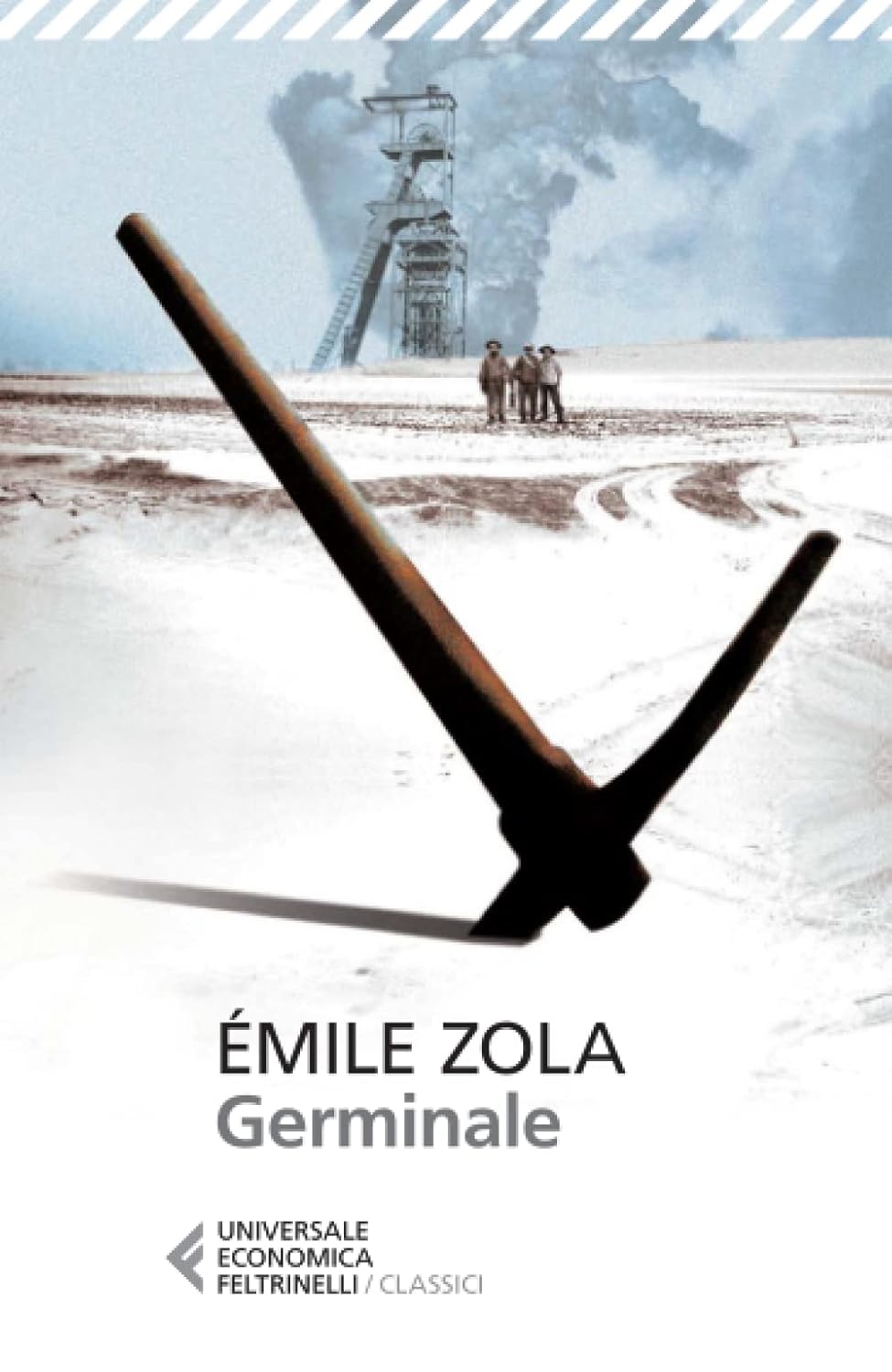 Probabilmente, è stato questo richiamo alle miniere a farmi tornare in mente certi passaggi del Germinal di Emile Zola, che sembrano adattarsi a una disgrazia, apparentemente, molto distante dalle vicende narrate dallo scrittore francese, nel romanzo del 1885.
Probabilmente, è stato questo richiamo alle miniere a farmi tornare in mente certi passaggi del Germinal di Emile Zola, che sembrano adattarsi a una disgrazia, apparentemente, molto distante dalle vicende narrate dallo scrittore francese, nel romanzo del 1885.
L’articolo della Martinelli prosegue citando Caetano Veloso che cantava Da vicino nessuno è normale – frase che, se non erro, è stata attribuita anche a Franco Basaglia –, facendo notare che il cantautore brasiliano è smentito dal diciassettenne di Paderno Dugnano il quale, pur avendo ucciso genitori e fratellino, è sempre stato ritenuto normale anche da vicino, se si dà credito alle descrizioni che amici e parenti fanno del ragazzo; amici e parenti tra i quali, come pare abbia confessato agli inquirenti, il ragazzo si sentiva un “corpo estraneo”, “oppresso”. Dato che sembra che queste sensazioni non siano nate il giorno della strage ma prima, mi è venuta in mente questa frase di Germinal: “…non era una vita possibile quella d’aspettare inerti delle cose che si sarebbero realizzate forse fra cento anni.”
E quando lo psicologo Feder spiega che il disagio di un ragazzo può essere invisibile, spesso celato e gestito dal giovane con una sofferenza dentro le mura, privata, silenziosa, mi viene in mente che questo celare potrebbe essere il necessario angolo di menzogna citato da Zola: “Quando si vive come bestie, a capo chino, è pur necessario un angolo di menzogna, dove uno si diverta a regalarsi quelle cose che non potrà mai possedere.”
Nel pezzo di Avvenire leggo anche che, nel caso in oggetto, la premeditazione ha convissuto con l’agito impulsivo; pescando ancora da Germinal, a mio modesto parere potrebbero aver fatto la loro parte anche il coraggio, magari frutto della certezza di essere nel giusto “quando si è dalla parte della ragione si sa essere anche coraggiosi” e la casualità “spesso non si fa il male solo perché mancano le occasioni”.
L’articolo sposta, poi, il discorso sui genitori ponendo la domanda, come spesso si fa in queste situazioni, dov’erano e cosa facevano mentre i loro figli sbarellavano, ricordando che quando un adolescente lancia una sfida deve esserci un adulto pronto ad accoglierla, ma che ci manca la capacità o la voglia di aiutare i giovani a gestire anche le frustrazioni e che, di fronte alla fatica dell’essere genitori, si passa la responsabilità agli specialisti. E così, quando leggo su Il Fatto Quotidiano che lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, interpellato da Il Messaggero, provando ad analizzare i motivi e le circostanze che possono favorire il quadro di un delitto di questo genere, afferma che “Non c’è una regola. Ed è avvenuto perché non parliamo più. Abbiamo scambiato i soldi con le parole. Una volta si parlava e non c’erano soldi”, ripenso a un passaggio di Germinal in cui “la folla” citata richiama alla mia mente il ragazzo diciassettenne: “…erano il suo vestito di seta, il suo mantello di pelliccia, perfino la piuma bianca del suo cappellino, che esasperavano la folla. Era profumata, aveva un orologio, la pelle fine, da fannullona, che non aveva mai toccato il carbone.”
E quando leggo che il mondo giovanile ha rotto gli argini e la comunità educante è ancora in cerca di un modo per assistere, accompagnare e intervenire sulle fragilità e le vulnerabilità dei giovani, rivedo questi due passaggi del buon’Émile: “Quel che mi dà fastidio sono i vili che guardano senza far niente, mentre noi rischiamo la nostra vita” e “il piacere di vivere se ne va quando se n’è andata la speranza…”
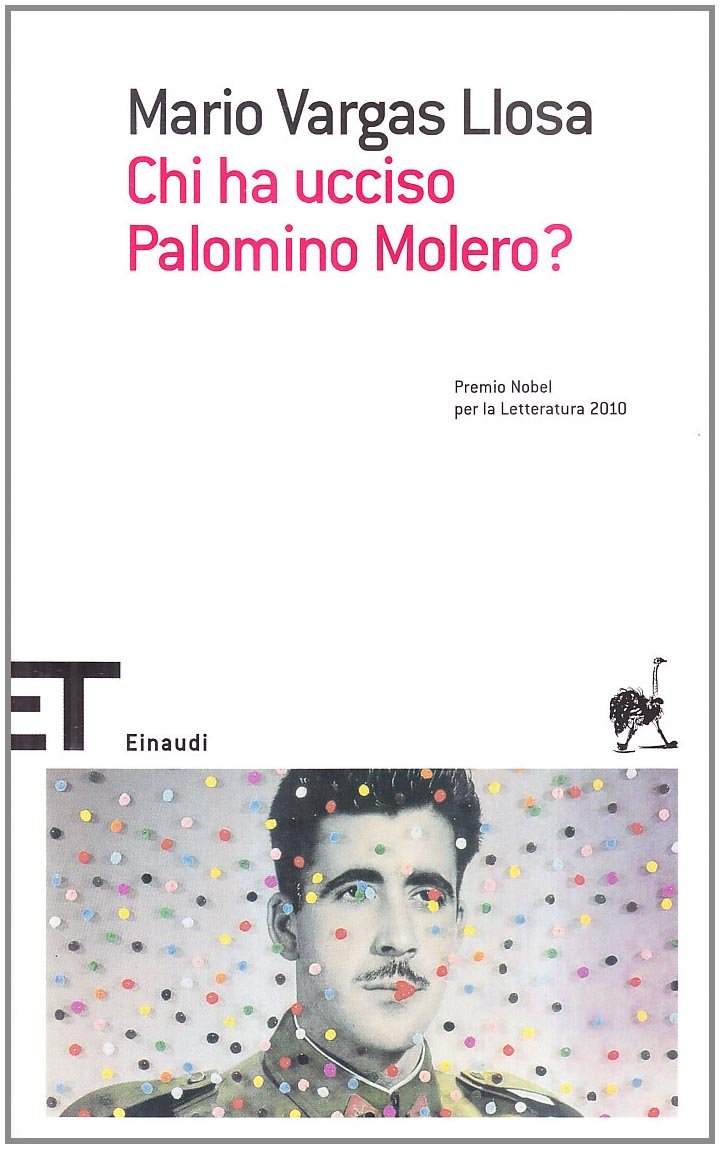 Leggo anche che il malessere che descrive R. che ha ucciso la famiglia, è lo stesso di molti altri ragazzi ed è l’incapacità di saper dare il nome alle cose, di saper definire con parole, concetti, idee e immagini quello che si sta provando, un’incapacità di analisi che diventa un malessere insuperabile perché non saper descrivere un problema ha come conseguenza non saper chiedere aiuto per risolverlo. È a questo punto che mi viene in mente un romanzo di Mario Vargas Llosa, Chi ha ucciso Palomino Molero?, dove un personaggio, facendo riferimento alla figlia, dice: “Per portare Alicita a New York ho venduto la casa dei miei genitori. Ho dato fondo a tutti i miei risparmi. Ho persino impegnato la mia pensione di vecchiaia. Negli Stati Uniti guariscono tutte le malattie del mondo, fanno ogni sorta di miracoli scientifici. Non è quanto dicono tutti? Be’, se è così, qualsiasi sacrificio è giustificato. Salvare quella bambina. E salvare anche me. Non l’hanno guarita. Ma, almeno, hanno scoperto cos’aveva. Delusions. Non guarirà mai perché non se ne guarisce. Aumenta, semmai. Prolifera col tempo, come un cancro finché la causa è lì, a provocarlo.” Parlando di parole utili a identificare i problemi ma che purtroppo spesso non si trovano, penso al divario sempre più ampio che quotidianamente riscontro tra le parole che vengono pronunciate e il pensiero che si aveva intenzione di esprimere, distanza che rende ormai approssimativa ogni tipo di comunicazione, anche la più semplice.
Leggo anche che il malessere che descrive R. che ha ucciso la famiglia, è lo stesso di molti altri ragazzi ed è l’incapacità di saper dare il nome alle cose, di saper definire con parole, concetti, idee e immagini quello che si sta provando, un’incapacità di analisi che diventa un malessere insuperabile perché non saper descrivere un problema ha come conseguenza non saper chiedere aiuto per risolverlo. È a questo punto che mi viene in mente un romanzo di Mario Vargas Llosa, Chi ha ucciso Palomino Molero?, dove un personaggio, facendo riferimento alla figlia, dice: “Per portare Alicita a New York ho venduto la casa dei miei genitori. Ho dato fondo a tutti i miei risparmi. Ho persino impegnato la mia pensione di vecchiaia. Negli Stati Uniti guariscono tutte le malattie del mondo, fanno ogni sorta di miracoli scientifici. Non è quanto dicono tutti? Be’, se è così, qualsiasi sacrificio è giustificato. Salvare quella bambina. E salvare anche me. Non l’hanno guarita. Ma, almeno, hanno scoperto cos’aveva. Delusions. Non guarirà mai perché non se ne guarisce. Aumenta, semmai. Prolifera col tempo, come un cancro finché la causa è lì, a provocarlo.” Parlando di parole utili a identificare i problemi ma che purtroppo spesso non si trovano, penso al divario sempre più ampio che quotidianamente riscontro tra le parole che vengono pronunciate e il pensiero che si aveva intenzione di esprimere, distanza che rende ormai approssimativa ogni tipo di comunicazione, anche la più semplice.
Ungaretti scriveva nell’Allegria di naufragi: “Si sa che tra le parole e ciò che si vuol dire c’è sempre un divario enorme, anche quando magari sembri piccolissimo… Dirò dunque che cercavo l’approssimazione meno imprecisa, la riduzione di quanto possibile di quel divario ineliminabile che c’è tra le cose da dire e il modo di dirle.”
Credo, però, sia venuto il momento di chiedersi se, per caso, questa mancanza di parole non sia frutto di un lavorio iniziato diverso tempo fa che voleva proprio ottenere questo, zittirci, silenziarci perché non ci si lamentasse, non si protestasse; sintetizzava Umberto Galimberti in un’intervista: “Se hai poche parole non puoi avere tanti pensieri, perché i pensieri sono proporzionali alle parole che possiedi: io non posso pensare qualcosa di cui non ho la parola. Quando ho poche parole, penso poco.”
A questo punto, mi verrebbe da ipotizzare questo… il Sistema per difendersi dagli attacchi e garantirsi la sopravvivenza, fa in modo di ridurre il più possibile il numero di parole a disposizione delle persone che governa, queste accettano di buon grado il tutto perché, in fondo, mica vengono tolti loro i social o i campionati di calcio e, così, mentre ci si rende conto di non conoscere più parole a sufficienza per contestare chi ci usa, i nostri figli si uccidono o ci ammazzano perché ammutoliti da quello stesso Sistema contro cui non siamo più capaci di lottare.
Il Giacomo Leopardi che, se non cambieremo strada, un giorno verrà vietato nelle scuole perché non politically correct, nello Zibaldone scriveva: “Un’idea senza parola o modo di esprimerla, ci sfugge, o ci erra nel pensiero come indefinita o mal nota a noi medesimi che l’abbiamo concepita. Colla parola prende corpo, e quasi forma visibile, e sensibile, e circoscritta.”
Anche il linguista Tullio De Mauro ci aveva avvertito che la distruzione del linguaggio è la premessa a ogni futura distruzione eppure, nonostante i numerosi ammonimenti, leggevo in questi giorni su Rolling Stone che sempre più artisti si autocensurano come, per esempio, Patti Smith che ha tolto il brano Rock ‘n’ Roll Nigger – galeotto fu il nigger, ergo negro – da tutte le edizioni in streaming del suo album Easter del 1978.
Eppure, tutto ciò che oggi ci fa vergognare del nostro passato ha generato in noi degli anticorpi utili per non commettere errori simili: sarà mica proprio qui, nel desiderio di cancellare le nostre vergogne l’origine dei nostri problemi?



