di Franco Pezzini
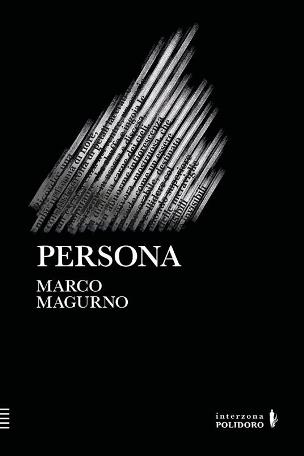 Marco Magurno, Persona, pp. 350, € 18, Polidoro “Interzona”, Napoli 2024.
Marco Magurno, Persona, pp. 350, € 18, Polidoro “Interzona”, Napoli 2024.
Attraverso le immagini il mondo finisce e comincia di nuovo.
“Ventidue lettere fondamentali. Egli le estrasse, le sbozzò, le soppesò, le alternò e diede forma per mezzo loro all’intera creazione, e a tutto quanto dovesse in seguito generarsi”, afferma il Sepher Yetzirah: in sostanza tutta la realtà sarebbe fatta di lettere. Gli Oracoli Caldaici ammoniscono a non cambiare mai i nomi barbari, cioè quelle stringhe alfabetiche di significato non riconoscibile, che nondimeno interagirebbero potentemente con la realtà, e vanno usate senza alterazioni. “Siamo simboli e viviamo in essi” affermava Emerson – e forse non solo simboli, ma segni. Cammino e lascio un’impronta: quelle impressioni nella sabbia sono io? La mia voce registrata su nastro: sono io? La mia immagine video, mentre mi muovo e parlo: di nuovo, è la mia persona? Lo sarebbe un mio ologramma?
Queste proiezioni sono fantasmi (assoggettati alla schiavitù della ripetizione – ma quante volte siamo noi a ripeterci?), che in qualche modo restano di noi: forme elettriche di sopravvivenza alla morte, presentate da un Bardo elettrico.
Se la morte decompone, l’immagine ricompone.
Mentre l’involucro di carne del simile imputridisce, il suo simulacro, l’altro corpo, incorruttibile, può liberarsi al giogo del mondo e continuare a vivere in immagine.
Ma il nostro stesso dileguarci dal mondo – spettro/fantasma o spettro/luce, con tutte le frequenze avvertibili o meno – rimanda a una significazione: l’ingresso nel mondo ci proietta irreversibilmente nella dimensione dei segni.
Tali scarne considerazioni possono preparare la presentazione dell’originalissimo, vertiginoso Persona per Polidoro “Interzona”, di Marco Magurno – già narratore di esplosioni della realtà con Diorama, il Saggiatore, 2016 –, ideale oracolo caldaico delle nostre infinite proiezioni in segni, dalla risacca di tempi diversi. Spiega in un’intervista, di cui mi pare interessante offrire alcuni stralci:
Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con le immagini, sia per diletto che per lavoro.
Mi occupo da quasi trent’anni di immagine e design grafico nel Web, nella pubblicità e nella comunicazione […].
A un certo punto, quindi, mi sono chiesto non più il come ma il perché delle immagini: per quale motivo su uno schermo o su un foglio, su una tela o su una parete di una grotta ci fosse qualcosa al posto di niente. E per quale motivo questo qualcosa fosse la replica, il monumento alla presenza di qualcos’altro, il suo fantasma.
Avevo già tentato di indagare la realtà in quanto fantasma nel mio precedente Diorama uscito per il Saggiatore. Era, Diorama, un libro costruito su giustapposizioni di immagini, analogie e frizioni, nel quale avevo mischiato il registro ironico – forse troppo post-moderno! – con un registro più tragico (che costituiva fisicamente la parte centrale, in bianco e nero, di un volume coloratissimo).
Questa parte oscura, ectoplasmatica, l’ho sempre considerata come un cuore nero da far collassare. Tanto più che, nel corso degli anni, ho sviluppato una avversione crescente all’ironia post-moderna – pur senza perdere il buon umore e l’ironia vera, sia chiaro! Ma sentivo che quell’approccio non era più sufficiente e che occorresse andare più nel profondo.
Persona, in latino, è la maschera teatrale, dall’etrusco phersu (“Se ho recitato bene, applauditemi” eccetera), e in seguito attraverso una lunga elaborazione teologica se ne maturerà un’accezione più profonda e metafisica – fino alle tre Persone trinitarie, alla persona diaboli eccetera –, e una serie di significati più consueti qui elencati in una nota iniziale. Ma persona è anche un nodo di interessi e diritti giuridicamente rilevanti, dunque di nuovo un coagulo di potenzialità e di segni legati a una vicenda comunitaria umana.
All’inizio piccole cose: un nome, un indirizzo, un appuntamento di lavoro.
E poi tornare indietro perché si è dimenticati a casa anche la fonte di ogni informazione, accedere a email, messaggi, mappe, telefonare e scusarsi, rimandare, correre in bagno e sciacquarsi la faccia con l’acqua volutamente gelida evitando il doppio nello specchio. Poi a seguire: dimenticare il luogo del parcheggio, una documentazione imprescindibile, un nome, un altro nome, smarrire il nome delle persone come si fa con un ombrello, un paio di guanti, un oggetto minimo.
È così che ho iniziato a dimenticare.
Ho pensato che il mondo stesse sparendo poco a poco.
Magurno offre il caso di un protagonista, appunto Persona, per antonomasia, consumato da progressiva amnesia e che dunque cerca di riunire tasselli per salvaguardare una propria identità: ma intorno, è il pianeta a conoscere una parallela crisi (“Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi […]”,“il tempo si è fatto breve; […] passa infatti la figura di questo mondo!”). E l’unico modo per raccontare questa crisi duplice o piuttosto incrociata è la chiave transmediale, col risultato di una fucina ergodica di immagini fotografiche e stringhe da codice html, narrazioni ellittiche (con pagine bellissime, poetiche, ricche di riflessione sapienziale), frantumi di fiabe, di chat e di questionari, sessioni di videogioco, tavole di fumetto e poema, “rotte parole”, citazioni ed eclissi, solarizzazioni e inabissamenti nell’ombra. Le narrazioni vi si frantumano come in una risacca onirica. Persino i caratteri si deformano, s’increspano, sdrucciolano nell’invisibile…
<Ricordo> lo scorrere del tempo. Quello apparente, frazionato e atomico del secondo: la percezione delle transizioni tra i livelli iperfini dell’atomo di Cesio-133 che riposa nel suo zero Kelvin: una misura assoluta.
Ricordo lo spettro temporale elaborato dagli antichi induisti, ai cui due margini opposti le unità sono così estreme da risultare incomprensibili e apparentemente inutili in termini pratici.
Ricordo il kala, che i maestri fanno corrispondere a un intervallo di 44 secondi; ricordo il paramanu, della lunghezza di circa un diciassettesimo di secondo; il mahamanvantara, corrispondente a 311.040 miliardi di anni.
Con il kala si misura il battito cardiaco umano, con il paramanu il battito delle ali di un colibrì, con il mahamanvantara il battito delle galassie.
Preceduto da citazioni di Morselli (Dissipatio H.G.) e Kafka (Aforismi di Zürau), l’itinerario prende l’avvio, opportunamente, da un’invocazione che apre il tutto al rituale. Seguono Imago mortis (“È insaziabile, l’occhio che guarda […] Ti sia concessa così la grazia: e doppo il morire vivere anchora”) sul rapporto-chiave tra visione e immagini, ombra e riflesso, camera oscura e luce, conversione dell’ordine in dati numerici; Cominciamento, che vede il racconto personale diventare racconto di specie; Terra, “Dove il pianeta vivente respira di tremore”. E finalmente, in Persona, l’identità con questo nome, “tra i frammenti della memoria, esperisce la propria dimenticanza”, con una progressiva erosione che sembra far sparire progressivamente l’intero mondo. Da cui Bardo, “Dove, tra i residui elettrici, avviene il viaggio oltremondano di Persona” e come nell’antica Persia o in riti ancora più antichi il corpo è affidato agli avvoltoi e poi allo spaccacorpo per la frantumazione delle ossa e la macinazione con latte e farina. Di nuovo singole unità minime, frammenti in quel tessuto della realtà di cui l’autore insegue qui il retro, l’ordito, il viluppo di fili. A ciò segue, come nel Bardo tibetano, l’annuncio dell’incontro con deità, alcune regole da osservare e dialoghi ritualizzati per una ruminazione interiore.
Un’ars moriendi appresa per disincanto, la nostra, da praticare nella posa.
La nostra semenza è già un’orda di ectoplasmi impressi sui display.
“Scegli dunque la rinascita e ascolta qualche storia che ti allieti nell’intanto”: per cui segue Fabula, “Dove alcune fole vengono narrate e altrettante vengono taciute”, a narrare di Macchine madri (e della preghiera da loro insegnata in grazia del Cloud: “Sacra memoria salvaci dalla dimenticanza, facci presenza, presenza infinita”), captcha, una città fatta tutta di rumore, una persona blu con “due bestie d’affezione: un pappagallo stocastico di nome Artificio e una quintessenza di polvere” (la fiaba è deliziosa, a tratti esilarante), una stella degenere, e la sequenza lorem ipsum. Tutto si chiude con In exitu, “Dove tutto ha fine e un nuovo cominciamento” – e non avrebbe senso spoilerare – e Opera, con le tavole finali. Di nuovo l’autore:
L’immagine mi è dunque apparsa come il nostro talismano contro la morte: il modo che la nostra specie ha escogitato per continuare a esistere, se non più in sostanza quantomeno in figura. Quella stessa morte che, nel presente assoluto dell’oggi, tendiamo a scansare se non proprio a negare. E intorno alla quale non abbiamo, a differenza di tempi e sensibilità altre antiche, elaborato un’ars moriendi o un libro dei morti.
Ma forse il nostro libro dei morti, ho pensato, è proprio la Rete, quel “colosso ultimo e terminale che abbiamo eretto un po’ per ricordare e un po’ per ridere”, in cui trasferiamo, attimo dopo attimo, duplicandola in figura, tutta la nostra esperienza.
Da qui l’idea del Libro elettrico dei morti, sovrapposto a uno dei testi che mi ossessiona da tempo: il Bardo Thodol, il Libro dei morti tibetano.
Nel rito tibetano il defunto, o il moribondo, viene accompagnato nel passaggio finale dalla lettura a voce alta di preghiere, precise istruzioni che lo guidano nel percorso.
La preghiera del Phowa è letteralmente “il trasferimento della coscienza”, una sorta di “mind uploading” pre-tecnologico.
Mentre i testi del Bardo Thodol guidano la coscienza nell’attraversamento del Regno intermedio, dove essa intraprende una lotta con le proprie proiezioni interiori, le divinità benefiche e malefiche, cercando di resistere e porre fine al ciclo delle reincarnazioni o, quantomeno, di ottenere una buona rinascita.
[…]
La tecnologia ci risparmia la fatica, ma non il dolore; ci consegna a un presente assoluto ma ci sottrae l’attenzione.
E a suo modo Persona è un libro sul dolore, che è la prima nobile verità del buddismo, e un libro sull’attenzione, che è sigillo di vera presenza e ratto costante d’ogni demone.
In questo continuum fantasmatico, che ci vede e prevede immersi e salvati, è un libro di spettri: è quindi lo spettro di un libro.
È fatto di parole e di immagini: le immagini di una vita fatta di immagini.
Un ultimo appunto sui testi: ho tentato di lavorare su una parola che fosse ultradensa, con un maggior peso specifico possibile. E ho tolto, tolto molto…
Certo il risultato è un romanzo molto particolare che richiede un approccio non superficiale, e non si esaurisce in uno sperimentalismo fine a se stesso. Anzi, inserito nella collana “Interzona” diretta da Orazio Labbate, ne costituisce una sorta di sviluppo conseguente, il seguito di una riflessione incalzante portata avanti tra distopia e Libri dei morti per esempio da Michele Neri ed Enrico Sibilla in forme diverse ma vertiginosamente coerenti. Qualcosa che sfida il senso del nostro finire – della persona, della storia, qui della Terra come la conosciamo – a suggerire possibili gnosi e chiavi di sopravvivenza, di rilettura dell’identità e ruminazione su un senso di esperienze anche molto quotidiane.
Ora posso vedere il mondo degli spiriti, dirà un indigeno delle isole Figi a chi gli mostra uno specchio.
Un’esperienza di lettura e visione di raro fascino, una grande macchina per pensare.






