di Francisco Soriano
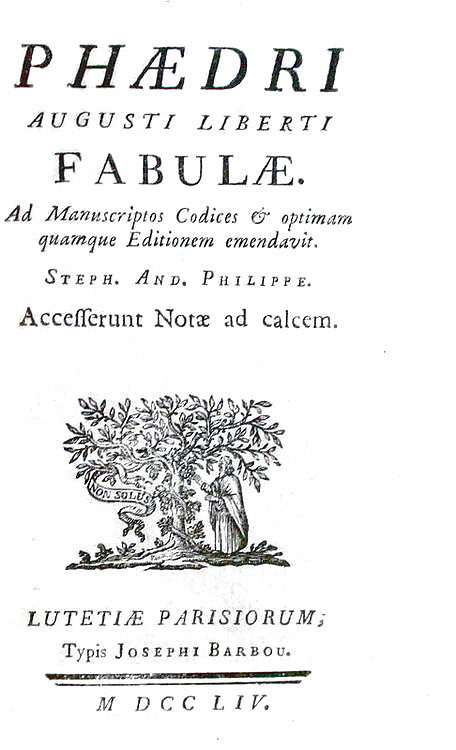 La pedagogia dei programmi ministeriali della scuola primaria molto spesso propone nei libri di testo di italiano favole e racconti mitologici, con riferimenti al mondo classico e, in generale, ai nostri valori fondanti ben radicati nel pensiero filosofico, letterario e tragico della Grecia antica e di Roma. Uno dei racconti ricorrenti nella favolistica riservata ai bambini è la storia della «cicala e la formica» tramandataci dai testi di Esopo, che arricchisce la dinamica del dialogo fra i due insetti di elementi morali e comportamentali.
La pedagogia dei programmi ministeriali della scuola primaria molto spesso propone nei libri di testo di italiano favole e racconti mitologici, con riferimenti al mondo classico e, in generale, ai nostri valori fondanti ben radicati nel pensiero filosofico, letterario e tragico della Grecia antica e di Roma. Uno dei racconti ricorrenti nella favolistica riservata ai bambini è la storia della «cicala e la formica» tramandataci dai testi di Esopo, che arricchisce la dinamica del dialogo fra i due insetti di elementi morali e comportamentali.
Nulla di male nel seguire la logica di questo immenso scrittore di favole se non, per la malcapitata cicala, di passare alla storia come nullafacente, pigra canterina di un domani senza futuro e senza gloria. Ben altro onore per la laboriosa formica, instancabile e organizzata fino al rischio della propria vita, nell’intenzione di preservare per sé e per la comunità una sicurezza pratica reale. Nessun problema, si direbbe, se il tutto viene interpretato nell’ottica di esercitare nella coscienza dei piccoli educandi l’idea di un «fare» collettivo che consenta a tutti una vita migliore piena di prosperità e in pacifica comunità. Questo compito pedagogico è assolutamente perseguito e anche consolidato, ma…
Capita di leggere il mito delle cicale di un altro glorioso narratore quale fu Socrate, il quale sembra interpretare diversamente, utilizzando un «registro» ideologicamente opposto a quello di Esopo, il «fare» delle «inutili» cicale. Socrate dice: «Tempo ne abbiamo, a quanto pare. E poi mi sembra che in questa calura soffocante le cicale, cantando sopra la nostra testa e discorrendo tra loro, guardino anche noi. Se dunque vedessero che anche noi due, come fanno i più a mezzogiorno, non discorriamo, ma sonnecchiamo e ci lasciamo incantare da loro per pigrizia della mente, giustamente ci deriderebbero, considerandoci degli schiavi venuti da loro per dormire in questo luogo di sosta come delle pecore che passano il pomeriggio presso la fonte; se invece ci vedranno discorrere e navigare accanto a loro come alle Sirene senza essere ammaliati, forse, prese da ammirazione, ci daranno quel dono che per concessione degli dèi possono dare agli uomini»*.
Il primo elemento importante di questo testo appare già dalla parola «tempo», e dalla sua funzione in riferimento alla scelta del proprio vissuto quotidiano. Il tempo oggi si restringe, domina la nostra vita, scandisce i battiti del nostro cuore, dei nostri impegni e del nostro lavoro: il nostro tempo è spesso «irrespirabile». Bisognerà prima o poi riappropriarsene. Chi di noi è in grado di dire «tempo ne abbiamo»? Forse siamo ancora in grado di «discorrere e navigare» accanto alle cicale come alle Sirene senza essere ammaliati?
Ma la profondità di questo dialogo attrae il lettore che non si arresta a un mero dato costitutivo dell’intera dinamica raccontata come possibilità di una condizione tipica degli uomini, bensì pone una domanda rivelatrice, una eccezione, una dimensione altra, un modello esistenziale alternativo al quotidiano scandito dal dovere del «fare» ad ogni costo. Il «fare» di cui discorre Socrate è chiaramente quello della poesia, che lo contiene pienamente nel suo stesso etimo e significato originario. Incalza Fedro: «E qual è questo dono che hanno? A quanto pare, non l’ho mai sentito». Lapidaria la risposta di Socrate che ci rende instabili, dubbiosi, come il genio «greco» che più di tutti ha saputo indagare e attraversare lo spirito dell’Umanità di ogni tempo con la sua maieutica, il «metodo» per eccellenza che stimola la ricerca della verità e non definisce a priori: «Non si addice davvero a un uomo amante delle Muse non averne mai sentito parlare. Si dice che un tempo le cicale erano uomini, di quelli vissuti prima che nascessero le Muse; quando poi nacquero le Muse e comparve il canto, alcuni di loro restarono così colpiti dal piacere che cantando non si curarono più di cibo e bevanda e senza accorgersene morirono. Da loro in seguito ebbe origine la stirpe delle cicale, che ricevette dalle Muse questo dono, di non aver bisogno di nutrimento fin dalla nascita, ma di cominciare subito a cantare senza cibo né bevanda fino alla morte, e di andare quindi dalle Muse a riferire chi tra gli uomini di quaggiù le onora, e quale di esse onora. A Tersicore riferiscono di quelli che l’hanno onorata nei cori, rendendoli a lei più graditi, a Erato di chi l’ha onorata nei carmi d’amore, e così per le altre, secondo l’onore che ha ciascuna. A Calliope, la più anziana, e a Urania, che viene dopo di lei, riferiscono di quelli che trascorrono la vita nella filosofia e onorano la loro musica, poiché esse, avendo cura del cielo e dei discorsi divini e umani, emettono tra tutte le Muse la voce più bella. Per molte ragioni, quindi, a mezzogiorno bisogna parlare e non dormire».
Dunque la narrazione mitologica, ancora una volta, dell’origine delle cicale commuove: in realtà esse appartengono al nostro essere umani, prima dell’arrivo delle Muse e del loro canto che in osmosi alla poesia compiono il gesto strabiliante dell’amore e dell’amicizia, narrano in versi sentimenti, felicità e dolori degli uomini. La poesia come parola, dialogo, canto e soprattutto «fare». I due racconti non si contrappongono, bensì ci indicano forse parallelamente strade diverse. Il testo di Socrate non esalta l’accidia e la contemplazione fine a se stessa, al contrario ci invoglia a un «fare» che si addica al nostro essere umani, alla comparsa della poesia come tratto sublimante della nostra stessa essenza umana. Forse ci invita a consacrare parte delle nostre giornate al tempo lento, alla cura della propria anima, all’esaltazione di un amore, di un’amicizia, una grazia, un atto di bontà che altrimenti andrebbero diluiti fino a scomparire nel vorticoso gioco del produrre, competere, comprare, vendere, mercificare in ogni dove e ad ogni costo.
È proprio vero che a mezzogiorno bisogna parlare e non dormire!
* Da Fedro, 258e-259d, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2014, p. 566.



