di Franco Pezzini
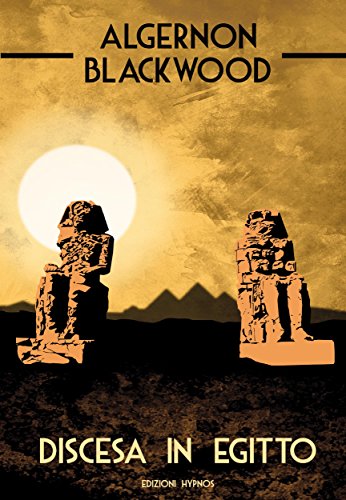 Algernon Blackwood, Discesa in Egitto, ed. orig. 1914, trad. dall’inglese di Elena Furlan, pp. 87, € 8,90, Hypnos, Milano 2017.
Algernon Blackwood, Discesa in Egitto, ed. orig. 1914, trad. dall’inglese di Elena Furlan, pp. 87, € 8,90, Hypnos, Milano 2017.
“Eppure, con mio sollievo, l’aspetto più volgare di questa malia egiziana lo lasciava indifferente: rimaneva impassibile di fronte ai misteri banali; non raccontava storie di mummie, non faceva neppure accenno agli aspetti più comuni del sovrannaturale. Non c’era gioco in lui. L’influenza era seria e vitale”.
Fin dall’epoca delle Weird (o meglio Weyward) Sisters del Macbeth con le loro profezie destinate ad autoavverarsi, il weird – da wierd, non a caso dall’inglese antico wyrd, “fato, destino”, cfr. norreno urðr, “fato, una delle tre Norne” – riflette il linguaggio congruo a un rapporto critico, “fantastico” con il tempo e tra tempi diversi. Un linguaggio dei paradossi – consequenziali, sì, ma spiazzanti – che ne originano a livello storico (l’uso dei tempi diversi sparigliati nei romanzi weird di Valerio Evangelisti è emblematico) e insieme il linguaggio dei paradossi di un fantastico interiore, con la risacca che conosciamo in noi. Non tanto o necessariamente il futuro, dunque, con tutta la sua santabarbara di attese e distopie come evocate nella fantascienza, ma il rimbalzare straniante, magari beffardo, di passato, presente e futuro nella provocatorietà dei nessi causali.
Ecco spiegato, al di là di una comodità nomenclatoria di volta in volta meditata o modaiola per un linguaggio che pare fin troppo miscellaneo, il rapporto radicale del genere strano – come il weird è stato definito – con i vari filoni del fantastico, linguaggio moderno dell’identità (personali e collettive) e delle sue crisi di crescita o di orrida necrosi: a partire dalle crisi del nostro essere nel tempo, del nostro essere tempo. Qualcosa di emblematico nel testo che qui si presenta.
Parlando di Algernon Blackwood (1869-1951), è uso citare Lovecraft, a proposito e a sproposito. HPL critica il collega inglese senza peli sulla lingua con il suo solito linguaggio acidulo, pure ammirandone genuinamente il genio e con lodi convinte. Mentre Blackwood gli rimprovera la mancanza di quello “spiritual terror” che rende convincente l’evocazione dei mondi sottili e dei loro abissi in quanto oggetto di serie convinzioni personali. In soldoni: Blackwood alle vertigini dell’occulto crede; Lovecraft no, anche se crede a ciò che esse rendono con linguaggio mitico, metaforico, letterario. I suoi richiami all’occulto costituiscono un geniale pulsante narrativo – congruo per assurdità visionaria – funzionale a evocare la vertiginosa piccolezza dell’uomo in un cosmo o piuttosto caos cieco e idiota, irriducibile ai corti orizzonti di un’antropologia ottimistica. Ovvio che i due non possano capirsi a fondo.
Comunque HPL inquadra così la raccolta blackwoodiana Incredible Adventures per Macmillan, 1914:
vi sono alcuni fra i più bei racconti mai scritti dall’autore, che portano la fantasia verso riti barbari su colline avvolte nella notte, verso aspetti segreti e terribili che si nascondono dietro scene apparentemente innocue e verso sotterranei impensabili e misteriosi sotto le sabbie e le piramidi d’Egitto: il tutto con una sottigliezza e delicatezza che convincono laddove una penna più rozza o più leggera si limiterebbe a far divertire. Certi racconti non sono neppure delle storie, o quasi, ma piuttosto studi su impressioni inafferrabili e brani di sogni ricordati a metà. La trama è dovunque trascurabile, e il clima di suspense domina incontrastato [L’orrore soprannaturale nella letteratura].
Come al solito, HPL celebra o censura secondo i propri gusti: e anche questo bilancio elogiativo sulla raccolta che contiene la novella – nel senso anglosassone – Discesa in Egitto (A Descent Into Egypt) risente del limite: vero che la relativa trama può apparire esile, ma non è trascurabile e proprio dei meccanismi weird offre un’illuminante testimonianza.
Il narrante (anonimo) ritrova in Egitto un amico, George Isley, il cui profilo inquieto non è mai stato compreso dalla società circostante: adesso si occupa di archeologia. Ma quando il narrante scrive, Isley non c’è più, non esiste più, e non nel senso che sia morto: la persona rimasta in vita – e socialmente apprezzata – ha perso tutta la sua dimensione interiore, come l’avesse abbandonata per andare altrove, e ne è rimasto un guscio brillante e vuoto. Qui Blackwood sembra assimilare la lezione di Henry James e dei fantasmi modulari, interiori ma con impatti provocatori e a volte sarcastici sulle dinamiche sociali: e il testo, per chi lo legga cercando il weird a effetto e una trama a forti tinte, può rischiare di deludere. Laddove è invece proprio in questa sottigliezza la sua forza. L’autore lo sa bene: “L’incredibile avventura era vera, letteralmente, ma, essendo spirituale, non può essere narrata come un romanzo poliziesco”, per dire una storia di genere nel senso più naïf. Per non parlare dello stile elegante, letterario che l’autore riesce a sostenere (assecondato qui dalla bella traduzione di Elena Furlan) – una delle caratteristiche del resto della sua scrittura, e che lo fa spiccare su tanti altri nomi anche molto buoni del genere.
Il narrante e Isley si ritrovano in effetti in una sorta di non-luogo, o di scena teatrale in bianco e nero, un albergo – molto simile a quello del capolavoro The Mummy di Karl Freund, 1932 – in cui in pratica resteremo per tutto il tempo anche se a un certo punto vi si apriranno idealmente pareti e soffitti come appunto a teatro, in una vertigine esteriore emblematica di quella interiore a cui è votato tutto il testo. Il narrante è “arrivato con un organo malato che lo specialista aveva promesso sarebbe guarito nell’aria straordinaria di Helouan” (luogo celebre per lo stabilimento termale, una piccola città oggi assorbita nella caotica periferia del Cairo), e ci sono anche altri invalidi. L’albergo – oltretutto cosmopolita – è del resto la situazione per antonomasia di una temporaneità convalescente, aperta in questo caso al deserto come un avamposto sull’ignoto e insieme sull’inconscio: il narrante si rende presto conto che le avventure archeologiche di Isley l’hanno mutato a fondo, imprevedibilmente. Fino a suscitargli una compassione empatica per l’amico che cerca in lui qualche tipo di sostegno.
Il fatto è che, spiega Isley, i turisti e gli stessi archeologi colgono solo barlumi di un abisso. E incalza affermando che
mentre la maggior parte dei paesi dà, altri prendono. L’Egitto ti cambia. Nessuno può vivere qui e rimanere esattamente ciò che era prima […] Prima ti toglie qualcosa […] ma alla fine prende te. Nulla viene a sostituire ciò che è perso. Si è stati prosciugati.
Perché l’Egitto attrae nel Passato (scriviamolo pure con la lettera maiuscola, capiremo poi perché), e il narrante coglie in Isley una sorta di lotta interiore e un disperato bisogno di salvezza da qualcosa che gli preme addosso, come un’affascinata tentazione. In Isley manca ormai qualcosa che anni prima era presente, quasi risucchiato, e a un tratto il narrante capisce: su Isley sta calando una notte interiore, il Presente lotta con il Passato ma lui ha ormai perso la speranza di non venir cambiato sotto quell’impatto. L’Egitto morto è in realtà minacciosamente vivo: i due anni di Isley nella Valle dei Re sono stati troppo, ma ora ha “un piccolo progetto qui vicino dall’altra parte del Nilo”, in direzione di Saqqara e del cimitero di Menfi. In effetti Isley – osserva il narrante nel dialogo – non è solo un repertoriatore di nudi fatti, “Senti l’antico Egitto e lo riveli. Hai sempre avuto questa facoltà divinatoria… misteriosa, ho sempre pensato”: qualcosa che coglie dimensioni diverse e più profonde.
E in effetti una “terza presenza”, una specie di Convitato di pietra, sembra essersi ormai silenziosamente unita al loro tavolo. “Era enorme e oscuro; era anche guardingo. L’Egitto arrivò librandosi, fluttuando accanto a noi”. Non c’è bisogno di mostri, e neppure di quelle mummie che garantiranno alla terra del Nilo una lunga presenza sugli schermi popolari: quel che arriva, mostruoso, è l’abisso del passato. A irretire chi si fermi e sia sensibile – non i turisti distratti, e neppure gli archeologi pragmatici – con quel “potere centrale che si nasconde dietro l’incanto superficiale che la gente chiama ‘la magia dell’Egitto’” e alligna sottoterra. Non si può neppure parlare di rimosso, ma piuttosto di velato e inaccessibile se non a chi l’Egitto sceglie di manifestarsi, per divorarlo.
Nessuna sorpresa dunque che qualcosa opponga resistenza alle scoperte più importanti, quasi offendendosi al loro disvelamento (mentre qui non c’è spazio per storie di vendette da tombe violate, “erano per menti superstiziose o bambini; le divinità che reclamavano la sua anima erano di un altro ordine di grandezza”): a impedire l’emersione dal passato di una quantità di informazioni…
In effetti il povero Isley, come rimpicciolito e con l’identità sprofondata, ribatte all’amico che è lui “ad avere capacità divinatoria, non io”. E c’è qualcosa, intuisce il Nostro, che Isley vorrebbe confessare, ma gli viene appunto bloccato da quella volontà esterna e tirannica.
Non avrebbe senso pensare di riassumere nei singoli passaggi questa storia bellissima di emozioni visionarie, e possiamo limitarci a qualche rilievo invitando senz’altro alla lettura: i due amici si attribuiscono a vicenda una sorta di sensibilità medianica, scoprono una solidarietà empatica e consolatoria… ma in pratica si tratta della stessa identità narrante, scissa come nella migliore tradizione del fantastico – si pensi solo a “L’uomo della folla” di Poe –, e nuovamente modulare solo per agevolare la narrazione in chiave funzionale a una messa a fuoco sia interna (Isley) che esterna (il narrante). L’anima trascinata nel passato è quella di Isley, ma il gioco di specchi riguarda lo stesso narrante; e del resto oltre al Terzo minacciosamente emerso, a un certo punto – visto che “il Presente scivolava via in maniera bizzarra” –, a completare il tavolo interviene un quarto, nuovamente in coppia/rifrazione speculare con Isley.
Mentre sul bordo del deserto un passato monumentale e mostruoso esonda nelle sensazioni del narrante come l’arcidemone di una Tebaide antoniana, arriva infatti a un certo punto l’ex-socio di Isley, l’ambiguo egittologo Moleson, con cui ha condotto scavi punteggiati da strani esperimenti… e alla fine interrotti per i citati “ostacoli” posti dal Passato. Autore del singolare saggio Una moderna ricostruzione dell’adorazione del Sole nell’antico Egitto, Moleson li raggiunge all’albergo e – nonostante una prima impressione gradevole – presto si rivela il cattivo genio di Isley o un suo alter ego ormai schiavo del Passato. “[…] irresponsabile, in un certo senso insincero, quasi senza cuore”, quest’uomo dal fisico di mummia potrebbe capitalizzare certe voci su Aleister Crowley giunte a Blackwood nell’ambito dei comuni giri ex-Golden Dawn, senza esserne di fatto un ritratto: l’amore per la vita brillante, la lode dell’eccesso, la morale che “non era senz’altro quella di oggi”, le speculazioni esoteriche, l’incarnazione di divinità egizie, lo spazio lasciato a una realtà divorante pagana, il riferimento stesso al Bulaq Museum set della più famosa avventura egiziana di Crowley, la notazione che Moleson verrà “annoverato tra gli energici e allucinati entusiasti che danno vita a nuove religioni, ottengono notorietà, una manciata di seguaci isterici e poi… l’oblio” permettono di ipotizzare almeno qualche nesso al racconto in fase genetica.
Per evitare spoiler, non si racconta come evolve questa vicenda di predazione da parte del Passato, che vede a un tratto Moleson e Isley compenetrarsi (con un salto allucinatorio da organico a inorganico che ci fa ormai pensare a Le venti giornate di Torino) in due statue colossali, non a caso gemelle – dunque in rifrazione ideale – dall’enorme pregnanza simbolica. Sono quei Colossi di Memnone che da immagini di Amenhotep III, mutilate dal conquistatore persiano Cambise, verranno riletti come in rapporto al mitico Memnone della guerra di Troia: dal Colosso di destra all’alba emergevano curiosi rumori, che possiamo identificare come causati dal riscaldamento solare della pietra (e cesseranno per motivi probabilmente strutturali dal III sec. d.C.), ma per gli antichi restituivano il saluto di Memnone alla madre Eos, l’aurora. In realtà quel canto che echeggia e diventa emblematico di una dimensione ipnotico-musicale del Passato – il tema è qui ben sviluppato, con pagine straordinarie –, è anche quello di un genere letterario circondato di equivoci e suggestioni. Il Passato che straborda, censura, carpisce e possiede è in fondo un tassello di tutta quella dinamica degli impatti del tempo sopra l’identità e la Storia che nel weird costituisce uno degli elementi chiave: il non-luogo dove un testimone dall’identità variamente fratta (il narrante, Isley, Moleson…) conosce non solo l’attacco di un passato vampiresco, non solo la metamorfosi attraverso un rito e un animarsi di forme antiche – come in tanto horror – ma uno svuotamento sociale che lo restituisce diverso alla realtà attraverso il tema di una disturbante Nascita al Passato. Per lui come per tutti quelli che ne hanno seguito i passi, mentre la Storia emerge solo in quanto permessa da quel passato fascinoso e mortifero.
Non c’è trama? Dipende cosa intendiamo per tale. Ma poche storie son strane e fatali (due termini con cui si potrebbe tradurre weird) quanto quelle dove i tempi cambiano di posto e la nascita avviene al Passato, evertendo nessi causali collettivi e personali. Per cantare invano, come da un volto sfigurato di pietra, al sorgere del giorno nel deserto.



