di Paolo Lago
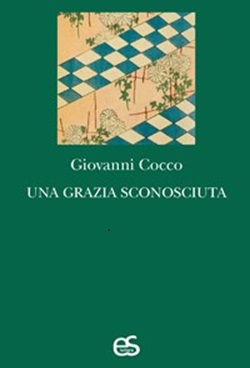 Giovanni Cocco, Una grazia sconosciuta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 204, euro 15,00.
Giovanni Cocco, Una grazia sconosciuta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 204, euro 15,00.
È una forma ibrida fra biografia, autobiografia, romanzo, saggio di critica cinematografica Una grazia sconosciuta, il libro che Giovanni Cocco dedica alla vita e all’opera di Jean Vigo. Si tratta di uno scritto polimorfo che, proprio in virtù del suo habitus ibrido, non definito, esercita un fascino particolare sul lettore. Lo stesso oggetto libro, a vedersi, non sembra essere legato in nessun modo alla figura di Vigo (che non viene nominato nel titolo), nella sua elegante veste verdolina con una riproduzione di un’opera dell’artista giapponese Furuya Korin. Incontrarci Vigo, e scoprirlo gradatamente, sarà una ulteriore affascinante sorpresa. Le vicende ambientate nei primi anni Trenta, che vedono Vigo alle prese con la realizzazione dei suoi film, si riflettono come in uno specchio nella contemporaneità, nelle vicende successe negli ultimi anni. A loro volta, i luoghi e le vicende contemporanee si riflettono in quelle a cavallo fra anni Venti e Trenta. Il focus narrativo si concentra soprattutto su Nizza, Parigi e i suoi dintorni, luoghi dove Vigo ha vissuto e ha girato i suoi film. Ad esempio, il libro si apre con un prologo in cui l’autore ricorda l’attentato del 14 luglio del 2016 che provocò ottantasei morti e trecento feriti sul lungomare di Nizza. Su quello stesso lungomare, ottantasette anni prima, il giovane regista anarchico Jean Vigo iniziava le riprese del suo primo cortometraggio, À propos de Nice (1929), in una Francia che di lì a non molti anni avrebbe conosciuto gli orrori della seconda guerra mondiale. Il gioco di rispecchiamenti e di intrecci investe anche la biografia di Vigo e l’autobiografia di Cocco: lo scrittore, infatti, attua una continua rifrazione delle proprie vicende personali e familiari in quelle di Vigo, e viceversa. Quasi senza soluzione di continuità si passa dalle situazioni personali dell’autore a quelle di Vigo, fino al momento in cui Costanza, la compagna dello scrittore, gli chiede, riferendosi al regista: “Intendi dire che si sentiva oppresso come quando mi parli del tuo lavoro?”. Ma c’è di più: le rifrazioni non riguardano soltanto le vicende biografiche del regista a cavallo fra anni Venti e Trenta del Novecento e dello scrittore a cavallo fra anni Dieci e Venti del nuovo millennio. Il tutto sembra poi rinfrangersi nella finzione cinematografica messa in scena da Vigo: ad esempio, il non sempre facile rapporto di coppia fra Jean e Lydou, la sua compagna, si riflette in quello fra Giovanni e Costanza ed anche in quello fra Jean e Juliette, che il regista ci racconta in L’Atalante (1934). Le storie e le vicende si intersecano, si aggrovigliano per poi sdipanarsi all’interno di una scrittura che avvolge ed attrae. Insomma, con Una grazia sconosciuta non ci troviamo davvero davanti ad un oggetto letterario convenzionale e scontato.
 Per introdurci dentro la realizzazione del primo corto di Vigo, il già ricordato À propos de Nice, Cocco utilizza la strategia della forma elenco: una serie di parole e di frasi che evocano le immagini del film e che si succedono senza un ordine apparente, davvero, con una grazia tutta surrealista. La parola scritta tende quindi a mimare l’immagine, le sequenze del film che mostrano Nizza sotto vari aspetti, dai luoghi più eleganti a quelli più popolari (di gran lunga più amati dal regista). Vigo (del quale è stato tratteggiato un ottimo profilo qui su “Carmilla”), figlio dell’anarchico Miguel Almereyda (pseudonimo di Eugéne Bonavenure de Vigo), morto nella prigione di Fresnes, è un regista libero e ribelle, che ha lottato duramente contro i meccanismi della nascente industria cinematografica che già allora imponevano condizioni ciniche e spietate. Vigo ha sempre seguito il suo istinto e la sua vocazione contro le crudeli “logiche di mercato” che avrebbero voluto farlo essere ed agire secondo il loro diktat anche se, in alcuni momenti, ha dovuto comunque piegarsi ad esse per poter realizzare materialmente le proprie opere. Nel finale del libro, Cocco, dopo una visita alla tomba del regista, ci racconta di aver ritrovato una nuova capacità di guardare al futuro proprio grazie a ciò che gli ha insegnato Jean Vigo: “Jean Vigo mi aveva insegnato che era possibile vivere in un modo diverso, e amare ogni singolo istante della vita per ciò che era: un regalo inaspettato, una fortuna, una maledizione; e che era possibile accettare qualunque sorte, a patto di avere il coraggio di seguire il proprio istinto e la propria vocazione; senza sconti, a qualunque prezzo, con passione, qualunque fosse il risultato”.
Per introdurci dentro la realizzazione del primo corto di Vigo, il già ricordato À propos de Nice, Cocco utilizza la strategia della forma elenco: una serie di parole e di frasi che evocano le immagini del film e che si succedono senza un ordine apparente, davvero, con una grazia tutta surrealista. La parola scritta tende quindi a mimare l’immagine, le sequenze del film che mostrano Nizza sotto vari aspetti, dai luoghi più eleganti a quelli più popolari (di gran lunga più amati dal regista). Vigo (del quale è stato tratteggiato un ottimo profilo qui su “Carmilla”), figlio dell’anarchico Miguel Almereyda (pseudonimo di Eugéne Bonavenure de Vigo), morto nella prigione di Fresnes, è un regista libero e ribelle, che ha lottato duramente contro i meccanismi della nascente industria cinematografica che già allora imponevano condizioni ciniche e spietate. Vigo ha sempre seguito il suo istinto e la sua vocazione contro le crudeli “logiche di mercato” che avrebbero voluto farlo essere ed agire secondo il loro diktat anche se, in alcuni momenti, ha dovuto comunque piegarsi ad esse per poter realizzare materialmente le proprie opere. Nel finale del libro, Cocco, dopo una visita alla tomba del regista, ci racconta di aver ritrovato una nuova capacità di guardare al futuro proprio grazie a ciò che gli ha insegnato Jean Vigo: “Jean Vigo mi aveva insegnato che era possibile vivere in un modo diverso, e amare ogni singolo istante della vita per ciò che era: un regalo inaspettato, una fortuna, una maledizione; e che era possibile accettare qualunque sorte, a patto di avere il coraggio di seguire il proprio istinto e la propria vocazione; senza sconti, a qualunque prezzo, con passione, qualunque fosse il risultato”.
 Dopo un capitolo dedicato ad un altro corto di Vigo, Taris, roi de l’eau (1931), sul campione di nuoto Jean Taris, uno dei primi film in cui incontriamo riprese subacquee, lo sguardo di Cocco si focalizza su Zéro de conduite (1933), un film che racconta la rivolta degli studenti di un collegio contro le autorità scolastiche. Come osserva l’autore, con quest’opera il regista intendeva offrire “una visione del mondo precisa: quella dell’infanzia oltraggiata che, di fronte alla solitudine e alla sofferenza, prima si ribella, nella straordinaria scena della battaglia dei cuscini, per poi sforzarsi di ricavare un posto al sole, quando i ragazzini si impossessano del collegio e mettono alla berlina i carcerieri”. Anche in questo caso si può intravedere una rifrazione delle vicende personali dell’autore relativamente al suo lavoro di insegnante di scuola media: a un certo punto lo scrittore racconta della sua esperienza di insegnamento in una nuova scuola, nella quale non si è trovato bene: “La ferrea disciplina e il clima di quella scuola mi terrorizzavano”. Forse si tratta di un istituto epigono di quello in cui si svolge la vicenda raccontata da Vigo, fra grotteschi, crudeli e ambigui istitutori e uno, invece, dalle qualità umane, Huguet, che viene prontamente allontanato. Quattro studenti, puniti con lo “zero in condotta”, capeggeranno una rivolta durante la festa della scuola, issando sul tetto della scuola una bandiera con un teschio (al posto della bandiera francese) trasformandosi così quasi in pirati durante un’incursione. Pirati che però assomigliano di più all’immagine ‘romantica’ e immaginaria (poco corrispondente alla realtà) che abbiamo di essi: liberi e anarchici guerrieri che lottano contro tutte le ingiustizie. Oltre alla denuncia sociale, nel film è molto presente anche una dimensione magica, onirica e poetica: un aspetto che – rileva Cocco – non è stato colto dai contemporanei ma è stato riscoperto nel dopoguerra e, successivamente, soprattutto grazie ai teorici e ai registi della Nouvelle Vague (basti pensare solo ai Quattrocento colpi – 1959 – di François Truffaut, che deve non poco al cinema di Vigo). I ragazzi si ribellano all’autorità gretta e meschina di un’istituzione rigida e antiquata che però – come possiamo evincere dalle notazioni dello scrittore – sembra sopravvivere ancora adesso nelle plaghe delle varie riforme della scuola.
Dopo un capitolo dedicato ad un altro corto di Vigo, Taris, roi de l’eau (1931), sul campione di nuoto Jean Taris, uno dei primi film in cui incontriamo riprese subacquee, lo sguardo di Cocco si focalizza su Zéro de conduite (1933), un film che racconta la rivolta degli studenti di un collegio contro le autorità scolastiche. Come osserva l’autore, con quest’opera il regista intendeva offrire “una visione del mondo precisa: quella dell’infanzia oltraggiata che, di fronte alla solitudine e alla sofferenza, prima si ribella, nella straordinaria scena della battaglia dei cuscini, per poi sforzarsi di ricavare un posto al sole, quando i ragazzini si impossessano del collegio e mettono alla berlina i carcerieri”. Anche in questo caso si può intravedere una rifrazione delle vicende personali dell’autore relativamente al suo lavoro di insegnante di scuola media: a un certo punto lo scrittore racconta della sua esperienza di insegnamento in una nuova scuola, nella quale non si è trovato bene: “La ferrea disciplina e il clima di quella scuola mi terrorizzavano”. Forse si tratta di un istituto epigono di quello in cui si svolge la vicenda raccontata da Vigo, fra grotteschi, crudeli e ambigui istitutori e uno, invece, dalle qualità umane, Huguet, che viene prontamente allontanato. Quattro studenti, puniti con lo “zero in condotta”, capeggeranno una rivolta durante la festa della scuola, issando sul tetto della scuola una bandiera con un teschio (al posto della bandiera francese) trasformandosi così quasi in pirati durante un’incursione. Pirati che però assomigliano di più all’immagine ‘romantica’ e immaginaria (poco corrispondente alla realtà) che abbiamo di essi: liberi e anarchici guerrieri che lottano contro tutte le ingiustizie. Oltre alla denuncia sociale, nel film è molto presente anche una dimensione magica, onirica e poetica: un aspetto che – rileva Cocco – non è stato colto dai contemporanei ma è stato riscoperto nel dopoguerra e, successivamente, soprattutto grazie ai teorici e ai registi della Nouvelle Vague (basti pensare solo ai Quattrocento colpi – 1959 – di François Truffaut, che deve non poco al cinema di Vigo). I ragazzi si ribellano all’autorità gretta e meschina di un’istituzione rigida e antiquata che però – come possiamo evincere dalle notazioni dello scrittore – sembra sopravvivere ancora adesso nelle plaghe delle varie riforme della scuola.
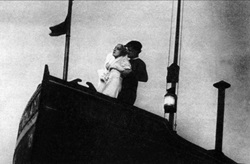 Infine, l’ultimo capitolo è dedicato al film più celebre di Vigo, realizzato nell’anno stesso della sua morte, avvenuta a soli 29 anni per tubercolosi. Si sta parlando di L’Atalante (1934), di cui alcune sequenze sono note al pubblico italiano come sigla di Fuori orario, con lo sfondo sonoro di Because the night di Patty Smith. È una storia d’amore che si srotola lungo i fiumi francesi, fino alla Senna e a Parigi, a bordo dell’“Atalante”, un barcone fluviale. La giovane Juliette (Dita Parlo), sposatasi con Jean (Jean Dasté, che già aveva interpretato l’istitutore Huguet, benvoluto dai ragazzi, in Zéro de conduite), comandante della barca, intraprende con lui, con il marinaio Père Jules (Jean Simon) e il mozzo di bordo (Louis Lèfebvre), un viaggio fino a Parigi. Qui la ragazza, attratta dalla città e dalle sue vetrine scintillanti, si perderà, facendo ingelosire il marito Jean, per poi fare ritorno sull’“Atalante”. Anche nel capitolo dedicato a L’Atalante, lo scrittore inserisce delle notazioni personali che, come già osservato, si rifrangono nella storia raccontata nonché nella vita personale di Vigo: “Mi capitava di pensare a me, a quello che stavo vivendo in quel frangente, a Costanza e ai miei figli: novant’anni prima Jean Vigo aveva messo in scena le stesse cose che stavo vivendo, il raffreddamento del rapporto di coppia, i primi malumori, il distacco progressivo che mi stava allontanando dalla mia compagna”. D’altra parte, come negli altri capitoli, incontriamo anche notizie sulla realizzazione del film, dall’analisi dei vari rimaneggiamenti cui è stato sottoposto senza il beneplacito di Vigo fino alle notizie che riguardano la sfera personale del regista, sull’aggravamento della sua malattia causato dalle riprese effettuate in inverno nell’umidità dei canali parigini.
Infine, l’ultimo capitolo è dedicato al film più celebre di Vigo, realizzato nell’anno stesso della sua morte, avvenuta a soli 29 anni per tubercolosi. Si sta parlando di L’Atalante (1934), di cui alcune sequenze sono note al pubblico italiano come sigla di Fuori orario, con lo sfondo sonoro di Because the night di Patty Smith. È una storia d’amore che si srotola lungo i fiumi francesi, fino alla Senna e a Parigi, a bordo dell’“Atalante”, un barcone fluviale. La giovane Juliette (Dita Parlo), sposatasi con Jean (Jean Dasté, che già aveva interpretato l’istitutore Huguet, benvoluto dai ragazzi, in Zéro de conduite), comandante della barca, intraprende con lui, con il marinaio Père Jules (Jean Simon) e il mozzo di bordo (Louis Lèfebvre), un viaggio fino a Parigi. Qui la ragazza, attratta dalla città e dalle sue vetrine scintillanti, si perderà, facendo ingelosire il marito Jean, per poi fare ritorno sull’“Atalante”. Anche nel capitolo dedicato a L’Atalante, lo scrittore inserisce delle notazioni personali che, come già osservato, si rifrangono nella storia raccontata nonché nella vita personale di Vigo: “Mi capitava di pensare a me, a quello che stavo vivendo in quel frangente, a Costanza e ai miei figli: novant’anni prima Jean Vigo aveva messo in scena le stesse cose che stavo vivendo, il raffreddamento del rapporto di coppia, i primi malumori, il distacco progressivo che mi stava allontanando dalla mia compagna”. D’altra parte, come negli altri capitoli, incontriamo anche notizie sulla realizzazione del film, dall’analisi dei vari rimaneggiamenti cui è stato sottoposto senza il beneplacito di Vigo fino alle notizie che riguardano la sfera personale del regista, sull’aggravamento della sua malattia causato dalle riprese effettuate in inverno nell’umidità dei canali parigini.
Perciò, ricollegandoci a quanto detto all’inizio, sarebbe riduttivo considerare Una grazia sconosciuta una semplice biografia di Jean Vigo o uno studio sulla sua opera cinematografica. È una narrazione polimorfa, che mette in gioco il regista francese e i suoi film in una dimensione più ampia, in cui si intensificano le rifrazioni fra la sua epoca e quella di oggi, fra la sua vita e quella dell’autore. Per chi già conosce il regista francese e, a maggior ragione, per chi non lo conosce, sarà un percorso, intriso di una sinuosa e avvolgente scrittura, capace di creare una magica e poetica dimensione, un immaginario ‘altro’ rispetto a tutta la banalità che ci circonda.



