di Sandro Moiso
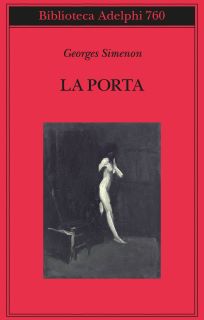 Georges Simenon, La porta, Edizioni Adelphi, Milano 2024, pp. 142, 18 euro
Georges Simenon, La porta, Edizioni Adelphi, Milano 2024, pp. 142, 18 euro
« Ti amo, Nelly! ».
« Anch’io, Bernard… ».
Lo ripetevano più spesso che in passato, come se cercassero così di far sprigionare una scintilla.
A volte gli pareva che ci fossero riusciti, che lui, all’improvviso, fosse guarito, che la vita sarebbe ripresa come un tempo. (Georges Simenon, La porta)
Il romanzo di Georges Simenon appena pubblicato da Adelphi e apparso per la prima volta in Francia nel 1962, può essere considerato come una delle storie più disgraziate scritte da un autore che dello scontento, dell’insoddisfazione esistenziale e della delusione aveva fatto il suo vero e proprio marchio di fabbrica.
Nella storia amara e desolata del quarantaduenne Bernard Foy e della moglie Nelly tutti questi elementi si intrecciano all’interno di una vita miserabile, ben lontana da quegli ambienti borghesi e altolocati cui altri romanzi dello stesso autore hanno abituato i lettori. Un ambiente piccolo borghese, una storia tra un grande invalido di guerra e la giovane moglie che, pur provenendo da una famiglia sottoproletaria e infame, è riuscita a trovare un posto di lavoro sicuro presso una ditta parigina di passamanerie.
« Quando saremo ricchi… ».
Per loro, come in genere per la gente di condizione modesta, la parola « ricco » non aveva lo stesso senso che ha nel dizionario. Voleva dire quando gli sarebbero rimasti un po’ di soldi dopo aver pagato l’affitto, il cibo, l’abbigliamento indispensabile, la bolletta del gas e della corrente elettrica.
« Quando saremo ricchi… »1.
Una vicenda che si articola intorno al vecchio cuore di Parigi, una place des Vosges che giorno dopo giorno sembra confermare la ripetitività dei gesti, delle esistenze e dei destini di chi la abitava ancora agli inizi degli anni Sessanta. Perché è in quel periodo che si colloca la vicenda di due anime disperate che del fantasma dell’amore hanno fatto una sorta di feticcio cui aggrapparsi nel tentativo di sopravvivere ai ricordi, alle disgrazie, alle ossessioni.
Sono queste ultime, rinchiuse nella testa di Bernard e con le quali il protagonista instaura un dialogo continuo e martellante, che passa dal monologo interiore ostinato e disordinato al dialogo, altrettanto disordinato e incoerente negli obiettivi, con la moglie. Discorsi e ossessioni che hanno un solo filo conduttore: la gelosia.
Una gelosia morbosa, fintamente superata ma che ad ogni nuova riflessione o scambio di impressioni e informazioni con la moglie non fa altro che riacutizzarsi. In una spirale che solo le ultime pagine del romanzo interromperanno. Una gelosia, però, che affonda le sue radici più nelle disgrazie dovute alla guerra e alle loro conseguenze, ancor più che in una cultura patriarcale e possessiva.
Perché La porta è la storia di un uomo privo delle mani, sostituite da uncini meccanici dopo che le prime erano state amputate dall’esplosione di una mina durante il secondo conflitto mondiale, più vecchio di quattro anni di una donna ancora avvenente, giovanile e sensuale. Ed è anche la storia di una donna giovane che, nonostante la grave menomazione del marito, ha deciso di restargli accanto. Fingendo nei fatti una normalità e una soddisfazione impossibili.
Ma in sé racchiude pure la storia dei mutilati di guerra e del lavoro, due temi mai così presenti come in questo caso nell’opera dello scrittore belga, che fa da sfondo all’infelicità della coppia, costituendone il vero e amarissimo background sociale. Una storia in cui, da un lato, Bernard confessa:
«Volevo solo spiegarti qualcosa che cerco di spiegare a me stesso… Ci penso spesso… ».
« Alla tua gelosia? ».
« A te… A me… Ti amo e sono geloso… Non interrompermi… Quello che dico è la verità e non è bella come vorrei… Anche se non ti amassi, ma tu fossi mia moglie, sarei geloso e soffrirei… Lo capisci questo? ».
« Forse. Hai sofferto molto con me? ».
« Di tanto in tanto… Come viene, poi passa, e allora sono perfettamente felice… Vorrei dire follemente felice, perché ci sono giorni, quando ti vedo scendere dall’autobus, in cui mi metterei a urlare di gioia… Fin da quando avevo quattordici anni sognavo il matrimonio, una donna tutta mia, un piccolo mondo di cui sarei stato… ».
Esitò.
«Vedi che non è bello!… Un mondo di cui sarei stato il centro, di cui sarei stato il padrone… Non tanto per comandare… Per sentirmi il più forte… Pensavo a una donna che avrebbe avuto bisogno di me, che non avrebbe avuto nient’altro al mondo, che avrei dovuto proteggere e rendere felice…»2.
In una delle più drammatiche e sintetiche riflessioni sul tema della gelosia maschile uscite dalla penna di uno scrittore e delle false premesse che l’accompagnano. Mentre dall’altro il tema della colpa e della menomazione fisica aggravano ancora di più lo stato di depressione e di morbosa gelosia in cui l’uomo si dibatte, senza alcuna speranza di poterne uscire.
Preferiva che lei non si prendesse un amante, ma solo degli uomini il più possibile anonimi, e non le avrebbe lasciato vedere che soffriva. Non era meglio che esser morto, o averla persa del tutto?
Era lui, non lei, che era stato reclutato ed era saltato su una mina giocando a fare il boy-scout nella neve. Era lui che aveva ricevuto una medaglia, quando neppure sapeva che cosa fosse successo di preciso. Non c’era alcuna ragione perché lei ne patisse le conseguenze!
Per la verità, tutte queste cose non gliele aveva mai dette. Come adesso, erano pensieri che gli venivano a certe ore, in certi giorni, e che lui si affrettava ad allontanare.
Sempre a quell’epoca, gli era capitato di chiedersi se lei avesse aspettato il suo consenso per andare con dei soldati americani, o con chiunque altro3.
In realtà, la gelosia è scatenata non dalla presenza di altri uomini o dai soldati americani ai tempi della liberazione di Parigi, ma dal giovane inquilino del primo piano dello stabile in cui abita la coppia. Anche lui invalido, condannato ad una vita su una sedia a rotelle. Con cui Nelly si rapporta per alcune incombenze e necessità quotidiane dello stesso.
Una storia interna ad un inferno che si finge normale e dove è la guerra ad aver lasciato la strascico più profondo.
Gli arrivavano a cadenza regolare i giornali pubblicati dalle associazioni di mutilati e invalidi di guerra, e lui si limitava perlopiù a dare un’occhiata alla pagina in cui si parlava di pensioni. Gli era capitato tuttavia di leggere anche alcuni articoli e gliene tornò alla memoria uno che sul momento non lo aveva particolarmente colpito. Vi era citato il caso di amputati che, dopo aver coraggiosamente sopportato la loro condizione per molto tempo, intorno ai quarantacinque,
cinquant’anni, cadevano in depressione.
Era strano. Quando, ancora giovani e pieni di vita, la loro invalidità avrebbe dovuto farli soffrire di più, la sopportavano invece quasi con allegria. Poi, con l’età, sembravano rendersi conto di quello che avevano perduto, ce l’avevano col mondo e se la prendevano con chi gli stava vicino.
Alcuni arrivavano a suicidarsi, quasi sempre suicidi minuziosamente preparati da lunga data, come se quel gesto fosse lo sbocco inevitabile di una lunga incubazione.
Di recente, nel quartiere di Batignolles, un reduce, ferito gravemente alla testa, aveva ucciso con una fucilata il vicino che si ostinava a tenere la radio accesa a tutto volume4.
Sono passati vent’anni da quando il protagonista ha perso le mani, troppi per continuare a fingere di essere felici.



