di Franco Pezzini
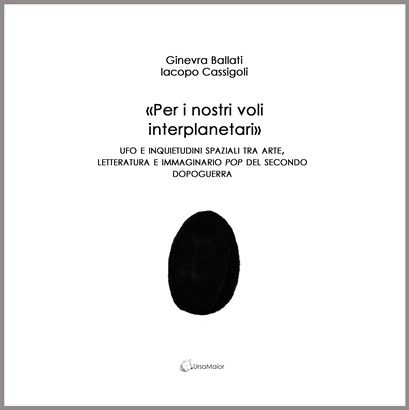 È appena uscito il volume di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli, Per i nostri voli interplanetari. Disastri atomici, UFO e inquietudini spaziali tra arte, letteratura del secondo Dopoguerra e immaginario pop, pp. 160, volume con immagini a colori, € 20,81, UrsaMaior, Pistoia 2024. Quella che segue è la mia introduzione. F.P.
È appena uscito il volume di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli, Per i nostri voli interplanetari. Disastri atomici, UFO e inquietudini spaziali tra arte, letteratura del secondo Dopoguerra e immaginario pop, pp. 160, volume con immagini a colori, € 20,81, UrsaMaior, Pistoia 2024. Quella che segue è la mia introduzione. F.P.
1958: in una fase di continui richiami all’energia atomica come rischio e insieme potenzialità esce il film Frankenstein 1970 di Howard W. Koch – una pellicola di fantascienza orrifica certamente minore ma di notevole interesse simbolico. Il barone Victor von Frankenstein sta continuando la sua attività di scienziato dopo le traumatiche vicissitudini patite sotto il nazismo, quando era stato torturato e sfigurato per il suo rifiuto di collaborare. La guerra è finita da anni, e ora per motivi economici il barone permette a una troupe televisiva di girare un horror sulla sua storia familiare (i grandi costruttori di mostri del passato) nel proprio castello in Germania.
Il fatto è che anche lui, come gli antenati, vagheggia di portare in vita una creatura. Per questo si è procurato un reattore atomico, ma per i corpi deve ricorrere ai soliti vecchi sistemi: e avvia dunque la disinvolta mattanza della squadra televisiva. Ovviamente la creatura si rivolterà contro il barone, ed entrambi periranno per un incidente al reattore. Scese le radiazioni a livelli di sicurezza, emergerà infine che sotto le bende il mostro ha lo stesso viso del barone, e avrebbe dovuto perpetuare l’esistenza dell’ultimo epigono della stirpe Frankenstein.
Come detto, a parte l’indubbio divertimento, la pellicola è interessante a livello di simboli e implicazioni. Anzitutto il barone è interpretato da Boris Karloff, il più leggendario interprete della creatura (anzi, del Mostro, come si usa dire nel cinema americano) in film consegnati all’immaginario planetario dalla stagione d’oro Universal, attraverso la produzione geniale e poetica postespressionista degli anni Trenta e quella più popolare e folle dei Quaranta: l’agnizione finale che il volto sia quello di Karloff non costituisce dunque solo un Amarcord, ma una sorta di garbata rivendicazione entro una storia che parla (non casualmente) di riprese video e di troupe. Il mostro della Universal è quello del baraccone delle meraviglie, il gangster dell’anima latore delle ambiguità del Vecchio Mondo, l’impressionante e fiabesca anomalia in un onirico e freudiano bianco e nero che minaccia la società – in particolare qualche giovane coppia pegno del futuro – e dovrà scomparire in un incidente clamoroso. Dal fondo ora di un film indipendente come Frankenstein 1970, Karloff ammicca a quei fasti passati ormai acquisiti da un fandom ultrapopolare e giovanissimo da drive-in, che trova il suo santo protettore nell’incredibile Forrest James Ackerman e ha appena visto inanellarsi surreali naïveté come I Was a Teenage Werewolf di Gene Fowler Jr. e I Was a Teenage Frankenstein di Herbert L. Strock, entrambi 1957 (a fronte dei quali il film con Karloff presenta ovviamente un’altra dignità).
Il fatto è che negli Stati Uniti degli anni Cinquanta, sull’onda della Guerra fredda, i vecchi mostri del gotico sono stati archiviati per lasciar spazio ai raggelanti alieni del Pianeta Rosso (comunista), a qualche mostruosità avventurosa da fronteggiare con la scienza invece che con l’occulto (il birichino sciupafemmine uomo pesce della Laguna Nera, 1954-56, alcuni gotici “riconvertiti”) e a un linguaggio di tipo fantascientifico.
Ma sta succedendo dell’altro: l’Inghilterra si sta riprendendo il gotico con le mitologiche riscritture Hammer delle saghe di Frankenstein (1957) e Dracula (1958), con Peter Cushing e Christopher Lee, per la regia di Terence Fisher e la sceneggiatura di Jimmy Sangster – e con loro cambia tutto. Il mostro diventa una figura impastata delle ambiguità sociali di tutto un mondo circostante (nella saga di Frankenstein il vero mostro è il barone, che però spicca da titano sull’odiosa società intorno); e se c’è un eroe non è più il giovanotto facciafresca di un’America che ostenta ottimismo, ma un uomo maturo e segnato dalla vita, affidabilmente british anche quando porta il cognome olandese Van Helsing. Il lavoro della Hammer, col miracolo di una piccola casa di produzione che subentra al colosso Universal nel dettare gli incubi a tutto il pianeta, avrà un peso non relativizzabile nell’immaginario – con curiosi cortocircuiti tra manti neri vampireschi e minigonne della Swinging London – e contribuirà all’innesco dello stesso revival magico dei Settanta. Inizia così una nuova stagione del gotico su schermo (ora in costume ottocentesco e a colori, sangue compreso) e Frankenstein 1970 con le sue radiazioni atomiche è il canto del cigno della vecchia.
Mary Shelley aveva probabilmente immaginato il materiale tecnico necessario allo studente (giovanissimo e borghese, non barone) Victor Frankenstein come un paio di borse di attrezzature galvaniche, che il giovanotto si porterà a zonzo per l’Europa assieme ai pezzi anatomici; ma già le prime liberissime trasposizioni teatrali avevano piazzato sulla scena istallazioni ingombranti come negli opifici della rivoluzione industriale. La stessa autrice, nell’edizione definitiva 1831, mostrerà di recepire questi spunti. Che, trasposizione dopo trasposizione, con attrezzature sempre più incontrollabilmente steampunk, alla fine si arrivi all’energia atomica non è dunque strano.
Del resto, radiazioni atomiche recheranno conseguenze impreviste anche nei laboratori del film giapponese Furankenshutain tai Baragon, letteralmente “Frankenstein contro il Baragon”, in Italia Frankenstein alla conquista della Terra) di Ishirō Honda, 1965. Lì il superuomo da guerra progettato da scienziati tedeschi nel secondo conflitto, e a distanza di anni realizzato dai giapponesi, diventa il mostro di Frankenstein e ingigantisce accidentalmente per effetto delle radiazioni: finirà utilizzato per fronteggiare l’ennesimo collega di Godzilla, il kaijū (cioè “mostro radioattivo”) Baragon emerso da un tempio maledetto a minacciare il Sol Levante… In un paese che cerca di metabolizzare il trauma di Hiroshima e Nagasaki, c’è qualcosa di un po’ disturbante che il feticcio pop sia il caposaldo di un’intera stirpe di mostri che flirta con l’atomica.
Siamo ormai approdati all’immaginario su Godzilla (o più filologicamente Gojira), e all’ultima parte dell’originalissimo lavoro di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli che a partire dalle provocazioni sullo spazio tra Movimento Spazialista e Movimento Nucleare, trasmissioni nell’etere e dischi volanti, arte interplanetaria e radiazioni cosmiche, minacce atomiche e Eaismo, infinitamente piccolo dell’atomo e infinitamente grande degli spazi, porta su e giù – come è prezioso fare – tra cultura “alta” e “bassa”, arte e fantascienza, cronaca e affabulazione – una serie di parole d’ordine, e finisce con l’implicare una lunghissima storia immaginale. Una storia collettiva, ma in fondo anche personale di quanti, come il sottoscritto, siano figli del boom economico e in quell’orizzonte hanno visto svilupparsi una serie di miti d’epoca qui ben evocati.
La televisione richiamata in Frankenstein 1970 è quella del resto tanto importante per la nostra generazione: e lo spoglio del materiale del Radiocorriere TV (oggi meritevolmente riproposto online) mi permette di collocare al 1972 nell’ambito della serie Realtà e fantasia la programmazione alla TV del ragazzi del film giapponese Atragon del già citato Ishirō Honda, 1963, che avrebbe molto colpito la mia immaginazione. Atragon – probabilmente da “drago atomico”, il tipo di sottomarino in questione – mostrava l’epico scontro tra l’incredibile sottomarino Gotengo in grado di muoversi anche nella terra o nell’aria, e sottratto a fine guerra dall’irriducibile capitano Hachiro Jinguji (Jun Tazaki) per riscattare l’onore del Giappone, e il redivivo impero di Mu, attualmente sommerso, che ça va sans dire mira a conquistare il mondo. Di qui la concitata tagline giapponese “Il temuto regno sottomarino sfida la superficie! La risposta d’emergenza della corazzata atomica multiuso!”, nell’ambito di una storia godibilissima dove non manca il solito kaijū, in questo caso il serpentiforme Manda, dio e custode di Mu (in seguito integrato nella saga di Godzilla). A commentare il film al passaggio in Rai erano stati il geofisico Antonio Rapolla dell’Università di Napoli, il direttore generale della Tecnomare Giuseppe Muscarella e il titano dell’orizzonte che questo libro andrà a scandagliare, il giornalista esperto di misteri e mondi perduti Peter Kolosimo.
Ma quella storia di energia atomica volta a scopi difensivi contro un nemico di tutti i popoli della terra emersa – i Mu di un’imperatrice cattivissima – presentava anche un altro abbinamento significativo di quella temperie culturale: quello tra un futuro estremamente avanzato e tempi passati non solo recenti (gli echi del secondo conflitto mondiale) ma anche molto remoti. Ecco così Kolosimo che parla dei continenti scomparsi Atlantide, Mu e Lemuria in libri che più generazioni divoreranno e portatori eventuali di tecnologie avanzatissime (anche Atlantide, il continente perduto di George Pal, 1961, metteva in scena sommergibili e un’arma dalla distruttività similnucleare); ecco i dischi volanti della clipeologia, il sottosettore dell’ufologia attento ai presunti contatti con oggetti volanti nel passato, tanto florida a Torino negli anni Sessanta (quando nel 1964 vi viene fondata la rivista «Clypeus»); ecco un’archeologia che flirta con lo spiritismo (a suon di rivelazioni di spiriti egizi o etruschi). Però i rivoli sono tanti: pensiamo a un libro come Il mattino dei maghi di Louis Pauwels e Jacques Bergier, 1960, in Italia 1963, con le sue riflessioni sulle tecnologie perdute, o al lavoro sul linguaggio fantastico del gruppo torinese Surfanta nato nel 1964. E attraverso una serie di maree culturali nella risacca della Guerra fredda, la voglia di mistero si declina in forme ora parascientifiche (archeologia misteriosa, ufologia, parapsicologia…), ora occultistiche (sotto il velo della cultura ufficiale nei lunari anni Sessanta – a usare l’aggettivo di un bel saggio di Fabio Camilletti –, ma pronte a eruttare fuori col grande revival magico dei Settanta). Un’ondata di pubblicazioni emerge negli Stati Uniti, in Francia, in Italia, e sui rotocalchi spuntano come funghi lisergici articoli su questi temi…
La televisione – oggetto-simbolo del viaggio nell’etere – registra le aperture d’epoca, la nuova frontiera e le sue varie declinazioni, sia per adulti (si pensi a Sapere, ricchissimo programma di divulgazione scientifica varato da Giovan Battista Zorzoli, e trasmesso 1967-1976, che non disdegna i risvolti pop), sia per ragazzi (per esempio Spazio – Il settimanale dei più giovani, a cura di Mario Maffucci – dove già il titolo suona indicativo).
Ed è in fondo la televisione, con buona pace dei cospirazionisti, a renderci partecipi di un evento epocale come lo sbarco sulla luna. Preceduto da fiumi di dirette alle quali assistevo (non a quella a notte fonda dell’allunaggio, domenica 20 luglio 1969, ma ricordo l’indomani mattina l’acquisto del giornale con i titoloni alla piccola edicola di quartiere), renderà lo spazio qualcosa di più concreto per gli spettatori. E stabilirà una sorta di paradigma del modo di interrogarsi dell’uomo dell’età atomica: come lo sintetizza la rivista «Epoca», varando nel 1972 la storica serie di inserti Gli uomini del mistero (primo numero su Nostradamus), “Perché nell’era spaziale rinasce l’interesse per maghi, veggenti e alchimisti?”. È l’avvio del grande revival magico, più o meno coevo allo sbarco sulla luna ma anche al Sessantotto e alla rivoluzione sessuale.
E intanto, tra manifesti, esperimenti, suggestioni l’arte – nelle sue varie declinazioni – è attenta a cogliere le energie d’epoca: Buzzati, Fellini, Giorgio Monicelli fondatore di «Urania», Calvino, David Bowie, Flaiano, Zanzotto, e tanti altri (fino idealmente ai Wu Ming di Ufo 78, 2022), contribuiscono con il loro lavoro a un immaginario che media tra il panico legato al rischio d’un cataclisma atomico e l’ottimismo sotteso a un’epoca ancora in grado di coniugare al tempo futuro. Fin nell’uso innovativo di termini come spazio o nucleare.
Poi certo, come mostrano Ballati e Cassigoli, una serie di suggestioni era assai precedente, fin dall’origine della Guerra fredda: il Movimento Spazialista era nato nel 1946 attorno alla personalità di Lucio Fontana, il primo manifesto in italiano era stato redatto nel 1947, nel 1948 è seguito il secondo, nel 1950 il terzo, e nel 1952 il Manifesto del Movimento spaziale per la televisione. A collocare queste intuizioni all’inizio della confusa e diramatissima storia fin qui abbozzata, che con i conflitti culturali della Guerra fredda ha molto a che vedere e condurrà a strascichi imprevisti: come quando nel 1977, sull’onda del fortunato filone anticristico del primo The Omen dell’anno prima, esce Holocaust 2000 di Alberto De Martino – che associa all’Anticristo nientemeno che la costruzione di una fatale e gigantesca centrale termonucleare.
Si riserva dunque agli autori la libertà (rigorosa) di articolare il discorso con l’originalissimo taglio che da Fontana traghetta a Godzilla. E intanto ci lasciamo portare dall’affascinante esperienza di un viaggio che per molti di noi recupera almeno scampoli di un passato amato e remoto.
Torino, maggio 2024



