di Luca Baiada
Diego Crivellari, Francesco Jori, Giacomo Matteotti, figlio del Polesine. Un grande italiano del Novecento, prefazione di Francesco Verducci, postfazione di Marco Almagisti, Apogeo Editore, Adria 2023, pp. 202, euro 18.
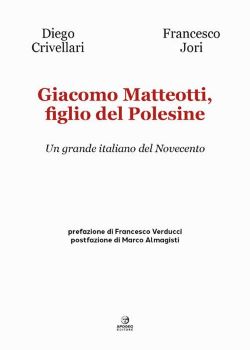 Attenzione precisa alla collocazione di Giacomo Matteotti nel tempo e nello spazio, convinzione e pluralità di registri: storico, culturale, economico e politico. Si sente – è una consapevolezza collaudata[1] – la conoscenza del territorio:
Attenzione precisa alla collocazione di Giacomo Matteotti nel tempo e nello spazio, convinzione e pluralità di registri: storico, culturale, economico e politico. Si sente – è una consapevolezza collaudata[1] – la conoscenza del territorio:
La campagna polesana offre ancora oggi al viaggiatore, al visitatore occasionale, al turista colto, curioso o meno distratto un’esperienza che, per certi versi, può perfino sembrare fuori dallo spazio e dal tempo ordinari, l’ambiente di un nord padano nella sua essenza eppure meno frenetico e battuto, l’assaggio di un territorio lento che, pensato e costruito e rammendato sulla base di successive opere di modernizzazione (le bonifiche, l’agricoltura, le infrastrutture) e di una lotta plurisecolare tra l’uomo e le acque, è forse riuscito a sfuggire, almeno in parte, agli effetti della modernizzazione più selvaggia.
Anche qui nel periodo postunitario economia e tecnologia fanno aumentare le sperequazioni sociali:
Elemento caratteristico della dura vita nelle campagne del Basso Polesine era ancora il diritto di vagantivo, che consentiva soprattutto ai più poveri di muoversi liberamente tra valli e paludi per praticare la pesca, la caccia, la raccolta di canne palustri. Le opere di bonifica contribuiscono a distruggere il vagantivo e a proletaritarizzare le masse contadine.
Ma il Polesine offre una novità: diventa un’enclave rossa nel Veneto, una terra di ibridazione, una Romagna di là dal Po dove ci si ribella:
Questo stesso territorio monotono e pianeggiante, apparentemente immutabile nel suo microcosmo politico e sociale, sarà entro pochi anni epicentro della prima grande ribellione contadina della storia italiana: «La boje!». Le plebi contadine che, per secoli, erano state ai margini della grande storia, irrompono sulla scena e preannunciano l’inizio, tra proteste, violenze e contraddizioni, di una nuova fase. […] Il movimento è spontaneo, i capi sono improvvisati, la parola d’ordine dell’esasperazione e della lotta è «la boje», cioè la «pentola bolle e di colpo va di sopra».
I limiti del tentativo ci sono e li noterà Piero Gobetti tracciando la storia di Matteotti prima di cadere come lui: «Una provincia tormentata con un’economia complessa ed incerta, terra storica di esperimenti di sovversivismo, spesso più servile che violento, sono toni sufficienti per determinare l’opera di un uomo»[2]. Eppure il seme è gettato: si è provato, si può.
Il conflitto sociale, insieme alla liberazione nazionale e alla riscossa politica, si ritroverà nella Resistenza:
Rappresenterà un ulteriore momento di riscatto, risveglio e partecipazione popolare, un fenomeno per certi versi sorprendente, perché sviluppato non tra le montagne, ma in un territorio pianeggiante, privo di ombra, in cui – se si escludono i campi di mais – non esistono luoghi in cui ripararsi, un territorio piatto che non si presterebbe tecnicamente alla tattica della guerriglia e che invece conosce la lotta partigiana, conosce i rastrellamenti, le torture, le stragi (come quella di Villamarzana del 15 ottobre 1944, la più grave, compiuta dai repubblichini), una lotta essenzialmente contadina che si rivolge […] contro i fascisti prima ancora che contro i tedeschi invasori e, per molti versi, assume la connotazione di una resa dei conti e di una guerra di classe.
Ancora prima dell’unità d’Italia, con caratteristiche diverse, queste terre covano contatti, progetti, scatti d’orgoglio. Proprio a Fratta Polesine, luogo di nascita di Matteotti, dove un tempo Lucrezia Gonzaga e intellettuali di vaglia si raccolsero in accademia, si tessono cospirazioni della Carboneria che non sfuggono all’occhio di Vienna e che portano i patrioti allo Spielberg. Se ne trarrà insegnamento: il fratello di Giacomo, Matteo Matteotti, studierà i carbonari.
Naturalmente la storia non può fermarsi ai progetti di un gruppo. La condizione dei lavoratori permette alla nobiltà, quando non è solo crapulona, l’opportunità di ozii culturali; però:
La maggior parte della popolazione abita nei tipici e poverissimi casoni, con tetto in paglia, pareti in vimini intrecciati, intonacati con terra argillosa a volte mescolata con sterco bovino, sostenuti da quattro pali agli angoli; all’interno una sola camera, dove gli uomini convivono con gli animali.
Bene, comunque, che si ricordi l’importanza del sapere per il socialista polesano. Il suo impegno in Parlamento e negli enti locali per le scuole, le biblioteche e le iniziative di formazione è forte e personale. Se mi fosse concesso un viaggio nel tempo per incontrare Matteotti, non sceglierei una seduta parlamentare ma la gita a Ferrara in cui fece la guida turistica per i lavoratori, si irritò perché erano pochi e poi capì: «Indolenza, ignoranza; delle quali in fondo la classe lavoratrice non ha colpa, perché da troppi secoli straniata a ogni cultura e ad ogni spettacolo di bellezza»[3]. Confondersi coi braccianti e seguirlo, passo passo.
Nell’attenzione alla cultura c’è una convinzione che Giacomo Matteotti, figlio del Polesine riconduce alle sue posizioni al congresso dei comuni socialisti, a Milano, nell’ottobre del 1919, quando disse di volere un insegnamento «libero, poetico, astratto» e aggiunse:
Vogliamo noi veramente che la scuola sia una preparazione per l’officina, pel lavoro? No, assolutamente; la scuola deve essere qualche cosa per cui, almeno per quattro o cinque anni, la gente del popolo non pensi alla preparazione del lavoro manuale, impari qualche cosa che sia fuori del lavoro immediato, impari anche delle astrazioni. Non dobbiamo essere di quelli che vogliono la preparazione del ragazzo all’abilità.
Cultura e lotta dei lavoratori uniscono la storia locale e quella italiana a un uomo che prima è tappa di un antico cammino, poi diventa mito fondativo:
Matteotti, nome in grado di suscitare accenti quasi religiosi, come ammantata di religiosità e di riferimenti nemmeno troppo velati al cristianesimo primitivo era stata la predicazione socialista nelle campagne padane tra i due secoli. Perfino negli anni più bui della dittatura, nella lunga traversata del deserto, il ricordo di Matteotti sarà all’origine di una ripresa attiva della coscienza antifascista, sarà memoria viva, non meramente sentimentale, radicata nella cultura popolare.
Le difficoltà delle terre basse, i controversi sviluppi, con caratteristiche particolari rispetto al Nord-Est, la collocazione geografica che favorisce i collegamenti e la disponibilità di mano d’opera sono elementi che si ripresentano. Non a caso proprio nel Polesine viene aperto un importante snodo logistico. Arriva Amazon:
Il lavoro sembra essere il filo rosso che lega il Polesine delle prime grandi lotte politiche e sociali e il Polesine di Matteotti al Polesine di oggi. L’approdo della potentissima multinazionale americana fondata da Jeff Bezos in una realtà in cui, negli anni Ottanta del XIX Secolo, si sviluppò la prima vasta ribellione contadina del nostro paese […] appare in ogni caso come un passaggio dal sapore altamente simbolico.
Di un Matteotti c’è bisogno ma un Matteotti non lo abbiamo; perciò questa osservazione degli autori va presa come un buon proposito:
Se […] è veramente possibile cercare di individuare, all’interno di una densa parabola storica, un punto di sintesi capace di collegare la vicenda dei braccianti polesani di Otto e Novecento ai nuovi, anonimi, precari operatori della logistica, questo può senz’altro coincidere con l’esperienza straordinaria – esemplare, interrotta, incompiuta – rappresentata da Giacomo Matteotti.
Fitto di dati, nomi e collegamenti – lo sconcertante Nicola Bombacci, prima rivoluzionario, poi fucilato a Dongo coi peggiori fascisti, Umberto Merlin del Partito popolare e molti altri – il volume ricostruisce l’affermazione di Matteotti in una terra che ama e in cui si muove bene grazie alla parola convincente e alla conoscenza di persone e problemi. La riprova dell’efficacia di quell’impegno sarà la determinazione con cui il fascismo si accanirà su un corpo sociale che ha i piedi nel torpore dei canali e la testa nella modernità della sindacalizzazione e della solidarietà di classe strutturata:
Lo squadrismo, nel terribile 1921, si abbatterà sul Polesine, smantellando con minacce e violenze sistematiche le leghe, le amministrazioni locali, i circoli, le tipografie, distruggendo le tracce di una presenza socialista che era stata pazientemente disseminata e organizzata nell’arco di una trentina d’anni, e su cui piomba ora la ferocia di una vera e propria guerra civile, […] una guerra civile a senso unico, una reazione agraria che troverà il movimento proletario scioccato, traumatizzato, largamente impreparato di fronte alla determinazione, all’efferatezza, ma anche alla «tecnica» di una violenza pianificata.
Il socialista non si scoraggia e porta la battaglia sino in Parlamento. Il suo stile è schietto, distante dal chiasso dell’arruffapopoli e dagli schematismi del quadro di partito:
Pareva incarnare una figura diversa di militante politico, perfino inedita, anche se riferita all’immagine del rappresentante socialista più tradizionale nelle istituzioni; nessuno sfoggio di oratoria preziosa, nessun artefatto intellettualismo, nessuna concessione alla demagogia o, per rimanere più vicini all’attualità, al populismo.
Non c’è da stupirsi, allora, che Matteotti si sia battuto contro qualsiasi compromesso col fascismo e abbia difeso tutti gli spazi di manovra concessi dalla società liberale, anche se quella società aveva col fascismo legami colpevoli e vistosi; quegli spazi legali, quegli istituti, quelle parole d’ordine borghesi, anche se erano espressione di un’egemonia di classe contigua a quella del nascente regime, andavano protetti: «Egli comincia a utilizzare il termine “dittatura” senza incertezze, perché gli è chiaro che l’avvitamento della crisi sta conducendo verso la liquidazione degli istituti liberali».
Uno studio così attento si fa perdonare anche i malintesi sull’età repubblicana, nel capitolo L’eredità di Giacomo Matteotti:
A frenare l’evoluzione del paese ha concorso in misura analoga un handicap di natura politica che rappresenta l’esatta antitesi dello stile e delle battaglie di Matteotti: la mancata evoluzione verso un moderno schema occidentale basato sulla competizione-alternanza tra un blocco riformista e uno moderato. […] Tangentopoli non è stata la causa del crollo del sistema, ma solo l’elemento della spinta finale, per giunta senza l’auspicato rinnovamento: la cosiddetta seconda Repubblica si è impaludata in una sfibrante transizione perenne che ha prodotto una sostanziale paralisi. […] Tra le conseguenze più pesanti, la profonda e radicale sfiducia dell’opinione pubblica, che si è tradotta e continua a tradursi in un allarmante astensionismo elettorale e nella compulsiva ricerca di un decisore credibile cui affidare le sorti del paese: compito in cui sono via via falliti i Berlusconi, i Prodi, i Bossi, i Renzi, ma anche tecnici di vaglia da Monti a Draghi, e che ora è stato raccolto da Meloni, peraltro senza che intorno si modifichi il clima di rissa continua.
Non ci siamo. L’alternanza fra due blocchi politici non era nelle ambizioni di Matteotti e dei socialisti, e se c’è una cosa da invidiare a quei tempi duri è che in politica non si contava solo fino a due. Il rilievo sul ruolo di Tangentopoli è giusto, ma altro che paralisi: da allora, e sono passati trent’anni, economia, politica e diritto corrono energici verso la più spietata ingiustizia sociale. Apatia e confusione, con l’astensionismo alle elezioni, sono cose connesse alla gagliarda lotta di classe del padronato e alla debolezza di quella dei lavoratori, non alla mancanza di uno schema occidentale. La ricerca di un decisore si chiama voglia di padrone, e il volume fa bene a denunciarla; i personaggi elencati, però, hanno ben poco in comune e due di loro, Monti e Draghi, sono stati imposti un po’ dagli effetti della condotta di chi li precedeva, un po’ da manovre dell’imprenditoria e del palazzo.
I cenni di attualizzazione lasciati a chi legge sono porte aperte – è il titolo del romanzo di Leonardo Sciascia – che siamo liberi di attraversare a nostro rischio. È una di queste il collegamento fra i due mesi di incertezza sulla sorte del socialista, con le congetture (anche sull’occultamento del corpo in un lago), e un periodo simile nel caso Moro. È un’altra porta il «mondo di mezzo», cioè la presenza di un ambiente criminale al servizio della politica e dell’affarismo, capace di tessere col potere legami fatti di connivenza e ricatto servizievole. Vengono in mente cose sempre più gravi, di tempi in tempi, come i contatti tra Francis Turatello e Craxi, poi il mafioso assunto a casa di Berlusconi, e ancora le frequentazioni altolocate dei personaggi intramontabili della malavita romana, in un sottobosco di affarismo e illegalità che non fa differenze tra uno schieramento politico e un altro, né tra Guerra fredda, berlusconismo e modello successivo.
In questo il delitto Matteotti, col coinvolgimento di sicari per mestiere, di intellettuali prostituiti, di politicanti e del capo del fascismo è un esempio di delitto del potere in cui convergono ruoli muscolari e torsioni linguistiche. Alcune forze trasmettono dall’alto verso il basso l’opzione della riduzione al silenzio, altre porgono dal basso all’alto l’esecuzione dello spargimento di sangue. In certi delitti successivi, anche molto diversi, si ritrovano le stesse caratteristiche di ubbidienza in cui un ordine preciso di vertice non c’è o non è verificabile: da alcuni fatti di mafia all’omicidio di Mino Pecorelli al caso Mauro De Mauro. Il rapporto fra il potere e i suoi bravi corre sul filo di cenni, perché appunto quello è il linguaggio del potere. È di segno opposto la lingua della giustizia, e per questo Giacomo Matteotti, figlio del Polesine riconosce nella Costituzione e nel suo nitore espressivo un paradigma indispensabile, lo stesso che Matteotti frequentava.
Si può intuire, allora, perché Sciascia ambienti il suo romanzo nel 1937 e lo pubblichi nel 1987. Gli «anni di fango» hanno qualcosa in comune con gli «anni del consenso»: nell’imminenza del crollo del blocco socialista, in quell’età di ricatti democristiani e craxiani, con un’opposizione inadeguata, si sviluppò qualcosa – un consenso al fango, si direbbe – che preparò il berlusconismo attraverso la scossa della stagione delle stragi. Parola e silenzio, chiasso e segreti favorirono l’arretramento del lavoro e l’attacco alla giustizia travestito da garantismo, da legalitarismo, da modernizzazione delle leggi.
Già, proprio il diritto; una cosa che vive di parole. Una cosa che con la parola pulita fiorisce, e in quella lurida imputridisce.
Quale rapporto […] esiste tra l’uomo politico e lo specialista del diritto? In linea generale possiamo affermare che è difficile comprendere l’itinerario intellettuale e politico di Matteotti, senza ritornare alla sua passione per il diritto. […] Questa passione non è venuta meno neppure negli anni più travagliati dell’impegno politico e parlamentare, contribuendo a fare del socialista polesano un tipo particolare di dirigente, di organizzatore, di rappresentante delle istituzioni, in cui alla veemenza delle posizioni, al febbrile attivismo, al coraggio personale si univano, nelle occasioni giuste, il rigore dell’uomo di scienza, lo sguardo oggettivo del tecnico, il piglio dell’esperto, l’approccio di chi padroneggia una materia cruciale e ne è ben consapevole.
Il tema coinvolge il nesso tra riformismo e rivoluzione, la questione del gradualismo e quella della lotta di classe. Gli autori, citando Carlo Carini e Paolo Passaniti[4], ribadiscono i punti di contatto di Matteotti con Antonio Labriola e Gaetano Salvemini e osservano:
[Matteotti], peraltro pagando con la vita, sarebbe stato il solo – o quasi – a intuire che la difesa del Parlamento come «organo depositario della sovranità nazionale e centro esclusivo di produzione democratica del diritto» non era una battaglia politica contingente, bensì una trincea decisiva per tutto il movimento operaio e per la libertà in Italia. La radice di questa consapevolezza, che lo porterà a sfidare il fascismo al potere e a percepirne la carica totalitaria, è da ricercarsi, molto probabilmente, proprio nella sua formazione giuridica e nella peculiare sensibilità sviluppata all’interno di questo percorso giovanile.
Se ci facciamo carico di questo, attrezziamoci per strade difficili. Il diritto è diventato o il pastone in cui beccano gli animali da cortile del palazzo, oppure il quadrato da cui chi vuole cambiamenti si tiene alla larga, temendo che sia ormai una gabbia irrimediabilmente cervellotica e chiusa.
Eppure, se Matteotti denuncia in modo inoppugnabile le mascalzonate del governo Mussolini, anche con il libro che pubblica nel 1924, Un anno di dominazione fascista, è perché frequenta il diritto con uno stile pratico, intriso di economia, contabilità e conoscenza della burocrazia. Gli autori afferrano una parte importante – che però non è affatto la sola – di quel volume battagliero:
Matteotti contesta che il governo abbia davvero migliorato la situazione economica: se aumentano i profitti, infatti, diminuiscono i salari, si aggrava il debito pubblico, cresce la disoccupazione e peggiora nel complesso la condizione dei lavoratori (un’ondata di licenziamenti colpisce in particolare i lavoratori delle ferrovie). L’interventismo economico dell’esecutivo smentisce le promesse liberiste del suo programma, avviando una stagione all’insegna di sussidi e favori nei confronti della grande industria e di quelli che oggi chiameremmo «poteri forti».
Sul punto è citata l’economista Clara Mattei[5], a proposito della «convergenza tra la politica economica inaugurata dal governo fascista, in cui si incrociano austerità, autoritarismo e tecnocrazia, e le idee degli economisti liberali».
Viene il sospetto – il libro si affaccia sulla questione senza percorrerla – che in fondo proprio l’originalità della posizione di Matteotti abbia segnato non solo la sua fine, che ha per colpevoli i massimi livelli del fascismo, ma anche la fase successiva.
Il sospetto, insomma, è che l’eliminazione di Matteotti, negli angoli della coscienza borghese, sia stata presa, oltre che da alcuni come un sollievo, da altri come un lutto, sì, ma chiarificatore, e che anche per questo il regime si sia ricompattato. Intransigente senza retorica, colto e vicino al popolo, avverso al correntismo ma attento a ogni novità, poliglotta europeo radicato in una terra afflitta dall’analfabetismo, Matteotti aveva ben poco del politico tradizionale e molto di nuovo da insegnare. La sua lezione ancora adesso ha pochi discepoli.
 Ma adesso sbrighiamoci. Abbiamo un appuntamento con una guida turistica d’eccezione, a Ferrara. Altrimenti scriverà: «Perché tanti assenti? Non per il tempo ch’era buono; non per la spesa, che in Ferrara si ridusse a lire dieci per persona (quanti se ne consumano nelle bettole?)»[6]. E lungo la strada godiamoci la campagna: nutriva di grazia il divisionista Gaetano Previati, che Matteotti commemorò alla Camera chiamandolo «meraviglioso pittore delle immagini, delle luci e dei colori»[7]. Forza, in cammino. Stavolta andiamo numerosi.
Ma adesso sbrighiamoci. Abbiamo un appuntamento con una guida turistica d’eccezione, a Ferrara. Altrimenti scriverà: «Perché tanti assenti? Non per il tempo ch’era buono; non per la spesa, che in Ferrara si ridusse a lire dieci per persona (quanti se ne consumano nelle bettole?)»[6]. E lungo la strada godiamoci la campagna: nutriva di grazia il divisionista Gaetano Previati, che Matteotti commemorò alla Camera chiamandolo «meraviglioso pittore delle immagini, delle luci e dei colori»[7]. Forza, in cammino. Stavolta andiamo numerosi.
[1] Diego Crivellari è autore anche di Scrittori e mito nel delta del Po. Un dizionario letterario e sentimentale, Apogeo Editore, Adria 2019.
[2] Piero Gobetti, Matteotti, Piero Gobetti Editore, Torino 1924, p. 11.
[3] Giacomo Matteotti, Sulla scuola, a cura di Stefano Caretti, Nistri-Lischi, Pisa 1990, p. 162.
[4] Carlo Carini, Giacomo Matteotti. Idee giuridiche e azione politica, Olschki, Firenze 1984. Paolo Passaniti, Giacomo Matteotti e la recidiva. Una nuova idea di giustizia criminale, Franco Angeli, Milano 2022.
[5] Clara Mattei, Operazione austerità. Come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo, Einaudi, Torino 2022.
[6] Matteotti, Sulla scuola, cit., p. 162.
[7] Ivi, p. 145.



