di Franco Pezzini
 Hilary Tiscione, Setole, pp. 289, € 16, Polidoro, Napoli 2024.
Hilary Tiscione, Setole, pp. 289, € 16, Polidoro, Napoli 2024.
Enrico Sibilla, Nero celeste, pp. 329, € 18, Polidoro, Napoli 2024.
Il manifesto reca l’immagine di una donna seduta, un libro aperto in grembo: con la destra regge gli occhiali, nelle cui lenti si vedono però gli occhi – che in parallelo sono spariti dal volto come per avvicinarsi di più al libro. Intorno alla signora galleggiano nuvole con figurine intente a leggere, ma soprattutto la sua testa è coronata a mo’ di aureola da una fantasia multicolore. La dicitura sulla sinistra è “Vita immaginaria”: un tema vastissimo per la XXXVI edizione del Salone del Libro, che in quel nimbo attorno al capo della lettrice evoca non solo le infinite vite vicarie offerteci dai libri, ma lo scarto tra la realtà sfuggente che siamo e i personaggi che in forma diversa ci rifrangono (personaggi nostri se scriviamo, o figure prestavolto delle nostre letture), e in generale un po’ tutta l’autofiction che ogni essere umano riserva quasi inevitabilmente a se stesso. Se l’uomo è (dice Poe) “un libro maledetto che non si lascia leggere”, ciò vale solo per le sue profondità: in vite immaginarie siamo immersi a tutti i livelli. Più o meno consapevolmente.
E non stupisce in questa cornice un incontro sul tema “Variazioni pop dell’opera letteraria”, con la presentazione di due romanzi molto diversi accomunati però da alcuni elementi forti – a partire dal dato delle comune presenza nella collana “Interzona” di Polidoro Editore diretta da Orazio Labbate.
Una scelta che già dice qualcosa: come infatti fortemente sottolineato da Labbate, a connotare una scrittura è anzitutto la voce, dunque in primo piano è il tessuto narrativo – lessicale, stilistico… – e la sua consapevolezza, eventualmente anche portatrice di frutti di immansueta complessità, frutti spinosi, ostici. A quel punto il tipo di storia non pone ostacoli: può essere narrata orecchiando il genere (nella collana, il distopico-filosofico Come un mattino texano di Michele Neri, dove il sapore di speculative fiction è molto forte, o l’appena uscito Nero celeste di Sibilla) o invece in forme più mainstream (il visionario Cuore in esploso di Riccardo Romagnoli o il recentissimo Setole di Tiscione), ma i criteri alla base di questa letterarietà restano i medesimi.
I due romanzi inanellati in occasione dell’incontro, appunto Setole e Nero celeste, guardano in sé verso direzioni distanti – ed è opportuno concederci qualche (non troppi) spoiler.
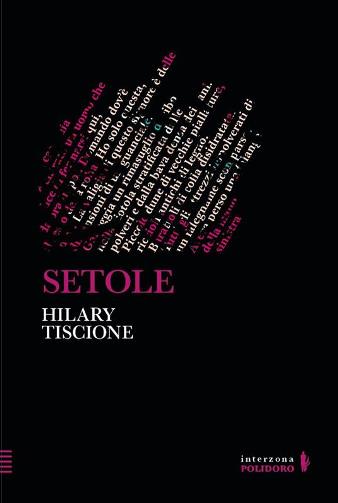 Affidata a un altro sguardo e una minore consapevolezza di scrittura, la storia di Setole verrebbe sciupata. A poca distanza da Lahaina nella contea di Maui, nello stato delle Hawaii, il celebre musicista Al Banning è sparito dalla sua villa, in seguito probabilmente alle furiose liti con la moglie Mira – donna insoddisfatta e capricciosa, non priva di qualche ragione nei rapporti col coniuge sciupafemmine, ma egoista e superficiale verso la figlia Lena. Che trova appoggio solo nel fedele factotum del padre, il maturo e affidabile Cino: e all’inizio di agosto – la storia si dipana tra l’1 e il 31 del mese – la ragazza non sa ancora quale contraccolpo i rapporti familiari finiranno col subire in poche settimane. Il giovane, avvenente operaio Rocco venuto per lavori in casa si trova infatti a entrare (anche) nella sua vita: iniziano una relazione e viene ospitato nella proprietà, ma cade sotto l’attrazione della più matura e spregiudicata Mira, e le si concede un po’ goffamente. Di qui un trauma per Lena, che aggredisce fisicamente la madre… e la comunità dell’apparente locus amoenus alle Hawaii, già messa alla prova in vario modo, finisce col rivelarlo – almeno interiormente – come una sorta di Isola dei morti. Dove è in questione una morte che è anzitutto quella simbolica dell’iniziazione tribale di Lena alla vita adulta e alle sue delusioni, e in prospettiva una morte potenziale (il pregresso tentato suicidio di Mira, la scomparsa/morte familiare di Al, i silenzi del finale).
Affidata a un altro sguardo e una minore consapevolezza di scrittura, la storia di Setole verrebbe sciupata. A poca distanza da Lahaina nella contea di Maui, nello stato delle Hawaii, il celebre musicista Al Banning è sparito dalla sua villa, in seguito probabilmente alle furiose liti con la moglie Mira – donna insoddisfatta e capricciosa, non priva di qualche ragione nei rapporti col coniuge sciupafemmine, ma egoista e superficiale verso la figlia Lena. Che trova appoggio solo nel fedele factotum del padre, il maturo e affidabile Cino: e all’inizio di agosto – la storia si dipana tra l’1 e il 31 del mese – la ragazza non sa ancora quale contraccolpo i rapporti familiari finiranno col subire in poche settimane. Il giovane, avvenente operaio Rocco venuto per lavori in casa si trova infatti a entrare (anche) nella sua vita: iniziano una relazione e viene ospitato nella proprietà, ma cade sotto l’attrazione della più matura e spregiudicata Mira, e le si concede un po’ goffamente. Di qui un trauma per Lena, che aggredisce fisicamente la madre… e la comunità dell’apparente locus amoenus alle Hawaii, già messa alla prova in vario modo, finisce col rivelarlo – almeno interiormente – come una sorta di Isola dei morti. Dove è in questione una morte che è anzitutto quella simbolica dell’iniziazione tribale di Lena alla vita adulta e alle sue delusioni, e in prospettiva una morte potenziale (il pregresso tentato suicidio di Mira, la scomparsa/morte familiare di Al, i silenzi del finale).
D’altra parte la trama della sparizione di un uomo e delle relative conseguenze ha un ruolo in qualche modo secondario. Anzitutto a livello genetico: sorto – racconta l’autrice – da un racconto di qualche anno prima, Setole è nato da una suggestione essenzialmente di spazio e di tempo (un luogo, una stagione: una casa enorme, un posto isolato su colline distanti da tutto, l’atmosfera rarefatta di un mese d’estate…) e solo in seguito è arrivata la storia. Dichiaratamente, Tiscione predilige le narrazioni dipanate in un unico ambiente (alle Carnage di Polański, per dire), che permettono agli elementi di puntare all’essenziale: nulla può restare inascoltato, ogni tassello è utilizzato in pienezza e il dettaglio può trovare il giusto peso sia nello spazio che nel carattere dei personaggi – la cui dinamica è qui in primo piano.
Ma anche perché a interessare l’autrice è soprattutto la voce, con uno svolgimento in crescendo e una modulazione contrastante dei registri e del ritmo, ad alternare dialoghi molto secchi, diretti, veloci (e con una lingua molto più “bassa” e senza struttura, virgolette, punteggiatura) ad altre parti molto rallentate, soprattutto descrittive di psicologie e di tutto ciò che vi ruota intorno – spazi ampi dove l’autrice può fermarsi sulla pagina senza preoccupazioni di trama, e levigare, approfondire, raccontare. Perché ci sono momenti – spiega – in cui puoi prendere una pausa dalla vicenda e dedicarti solo alla struttura, in modo che questa aiuti la lingua a emergere. Di qui la liceità di parti inevitabilmente sfuggenti per una qualche furia, un certo materiale grezzo che va lasciato grezzo, perché è quello che determina la voce e la diversità tra un autore e un altro. A volte le scelte semantiche permettono dunque accostamenti che possono lasciare perplesso il lettore, magari metafore un po’ azzardate o fuori dal canonico, ma guai se non avessimo la possibilità di sperimentare, di fare anche una fatica maledetta perché la scrittura è faticosa (anzi una cosa sta riuscendo, argomenta Tiscione, proprio quando la difficoltà si fa sempre più avvertibile). E proprio la struttura ripartita in capitoli giorno per giorno le ha permesso la libertà e la lentezza di dedicarsi a sfaccettare i personaggi.
Tiscione conduce le danze con una prosa ricca e varia, ritmata da dialoghi vividi e da elenchi di oggetti e ripetizioni come cifra narrativa. La dimensione pop (nel senso di Aldo Nove e di una produzione genuinamente letteraria) trasuda nella scelta stessa degli oggetti repertoriati. Ecco per esempio le setole del titolo:
Accanto al lavabo c’è una ciotola d’argento con dentro dei pennelli alti come cucchiai miscelatori per cocktail. Hanno spessori diversi. Le teste di setole sono coperte di ombretto per le palpebre e cipria, coperte di talco intossicato dai coloranti, setole asfissiate dalle polveri d’ocra e carbone che risaltano i fraseggi degli occhi, terre che maneggiano i difetti del volto. Una manciata di pennelli con il manico di legno.
Un campo di setole spanate o incollate in una punta indurita dalla saliva o dalle paste che luccicano contro luce. All’ombra. Al buio. Setole spezzate dalle ceneri accaldate dal sole, svigorite dal calcare, mai lavate, sature di tossine. Setole lubrificate dal grasso della pelle, dal sudore che, ancora, ingoiano cere e farine di lusso e miele impollinato di brillanti. Non hanno motivo di stare qui, i pennelli per la faccia. Non c’è un motivo vero manco più per le setole che sono entrate e uscite dalla bocca di Al. Setole cementate dal dentifricio secco di giorni. Setole del suo spazzolino stramazzato morto in un’altra ciotola pesante, attento comunque a partecipare all’idea di cimitero che si sono fatte queste setole, tutte, ferme, disfatte, spacciate, diradate, defunte. Lo offendono, il bagno, questi raccoglitori di resti, insultano il bagno di Al e Mira a cui hanno donato i loro avanzi ogni giorno, per anni, regalati alla gola del lavabo deliziato dalla scomparsa.
Nella claustrofobia del loro hortus conclusus, i personaggi, resi fragili da una vita iperprotetta, artificiale e insieme snervata, “luccicano contro luce” come queste setole. Ed emblematica, poco dopo, risulta la scena in cui Mira sfonda lo specchio: rifiuta di vedere la realtà, come in fondo, in modo diverso e diversamente comprensibile, tutti gli altri personaggi (lo stesso fedele Cino, che tenta di tenere insieme le cose, è alla deriva di un ruolo affidatogli). Ma le schegge di specchio sono come le serie babeliche di oggetti elencati, o, se si vuole, gli oggetti come schegge: frammenti che tagliano, manovrati da ricchi immaturi – o da aspiranti al loro status privilegiato, come l’inaccorto Rocco dall’ambigua naïveté, che scivola via senza lasciare affettuosi rimpianti nel lettore.
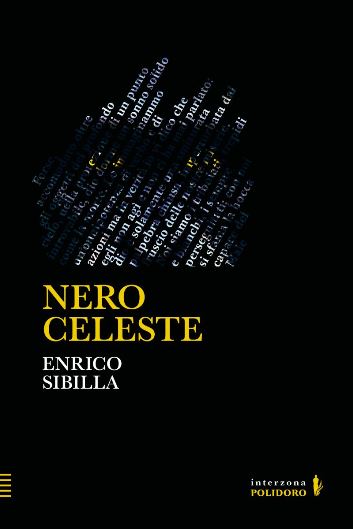 Un quadro abbastanza diverso, seppur con alcune analogie di soluzioni narrative (l’attenzione alla voce e per esempio l’enfasi alla forma elenco, qui persino rafforzata) si ha nel secondo romanzo uscito nella stessa collana a distanza di poco tempo, il visionario Nero celeste di Enrico Sibilla. In uno scenario futuro da antiche apocalittiche, alla svolta distopica di un tempo estinto tra devastazioni e massacri, vediamo fronteggiarsi davanti a San Pietro da un lato l’ultimo pontefice – un uomo gigantesco e sformato, mani “inumane” per artrite e ipertensione, e ortodossia curiosa; e dall’altro “colui che ancora una volta siamo costretti a chiamare Adolf Hitler”, l’ultimo Hitler della storia umana, non individuo ma specie, dna di “tutti gli accaduti e possibili Hitler, i titanici divoratori e i miserabili del quotidiano”, di un Male che non è spirito alieno ma genio sociale. Dove l’opposizione parla già il linguaggio di simboli eccitati, di ipostasi compulsive: il papa deforme si colloca nell’ambito di una dilagante storia narrativa e artistica su pontefici virtuali, immaginari, eventuali (come nei tondi della Basilica di San Paolo fuori le mura il fantomatico Giovanni XX, in realtà assente per errore di numerazione, o il papa-refuso Dono II, dal «Dom[i]nus» del successivo) e magari conclusivi; mentre l’ultimo Hitler rinnovella la saga anticristica di un’altra figura storica assurta ad archetipo sugli stessi sfondi geografici, Nerone (dall’apocalittico 666 di QeSaR NeRON a fantasie febbricitanti come il “Nobis Nero factus Antichristus” del visionario Carmen apologeticum attribuito al millenarista Commodiano). E nella Stanza/caverna dove il loro incontro si consumerà con esito imprevisto s’apre la forma circolare della culla della creazione, “una vasca, riempita al colmo di un fluido capace di assorbire la luce completamente”, il viscoso nero celeste che pare un’entità viva, che raccoglie “la quidditas e la haecceitas di ogni cosa visibile e invisibile e le disvela a chi ha il privilegio di immergersi in essa”. E lì, quando appunto vi scende, il pontefice riceve visioni: “Nel nero celeste è dio ad aspettare il ritorno: gli fu promesso dall’uomo”. Dunque il papa, dopo l’immersione, è solito registrare fonograficamente una messe di informazioni lì captate (ecco di nuovo l’elenco), apparentemente minuscole o inutili, briciole dal corso di tutta la storia.
Un quadro abbastanza diverso, seppur con alcune analogie di soluzioni narrative (l’attenzione alla voce e per esempio l’enfasi alla forma elenco, qui persino rafforzata) si ha nel secondo romanzo uscito nella stessa collana a distanza di poco tempo, il visionario Nero celeste di Enrico Sibilla. In uno scenario futuro da antiche apocalittiche, alla svolta distopica di un tempo estinto tra devastazioni e massacri, vediamo fronteggiarsi davanti a San Pietro da un lato l’ultimo pontefice – un uomo gigantesco e sformato, mani “inumane” per artrite e ipertensione, e ortodossia curiosa; e dall’altro “colui che ancora una volta siamo costretti a chiamare Adolf Hitler”, l’ultimo Hitler della storia umana, non individuo ma specie, dna di “tutti gli accaduti e possibili Hitler, i titanici divoratori e i miserabili del quotidiano”, di un Male che non è spirito alieno ma genio sociale. Dove l’opposizione parla già il linguaggio di simboli eccitati, di ipostasi compulsive: il papa deforme si colloca nell’ambito di una dilagante storia narrativa e artistica su pontefici virtuali, immaginari, eventuali (come nei tondi della Basilica di San Paolo fuori le mura il fantomatico Giovanni XX, in realtà assente per errore di numerazione, o il papa-refuso Dono II, dal «Dom[i]nus» del successivo) e magari conclusivi; mentre l’ultimo Hitler rinnovella la saga anticristica di un’altra figura storica assurta ad archetipo sugli stessi sfondi geografici, Nerone (dall’apocalittico 666 di QeSaR NeRON a fantasie febbricitanti come il “Nobis Nero factus Antichristus” del visionario Carmen apologeticum attribuito al millenarista Commodiano). E nella Stanza/caverna dove il loro incontro si consumerà con esito imprevisto s’apre la forma circolare della culla della creazione, “una vasca, riempita al colmo di un fluido capace di assorbire la luce completamente”, il viscoso nero celeste che pare un’entità viva, che raccoglie “la quidditas e la haecceitas di ogni cosa visibile e invisibile e le disvela a chi ha il privilegio di immergersi in essa”. E lì, quando appunto vi scende, il pontefice riceve visioni: “Nel nero celeste è dio ad aspettare il ritorno: gli fu promesso dall’uomo”. Dunque il papa, dopo l’immersione, è solito registrare fonograficamente una messe di informazioni lì captate (ecco di nuovo l’elenco), apparentemente minuscole o inutili, briciole dal corso di tutta la storia.
A monte della vicenda del loro scontro, quasi una sacra famiglia laica è invece composta da un altro vulnerato nelle mani, l’astronauta Heinrich F. Pflanzenwelt, dalla malassortita compagna Elide e dalla figlia Abeba, nata affetta da una grave malattia genetica. Scopriremo la vicenda di vita e di morte e di corpi e nebulizzazioni che li riguarda, tra la “mummia più bella del mondo” di Rosalia Lombardo, da una Palermo “sbriciolata dal sisma e ingoiata dal mare”, che finisce in custodia di Elide, e lo scheletro smontato dello scimpanzé number 65, cioè Ham “the Astrochimp” pioniere del volo celeste, conservato invece da Heinrich nella sua missione – fino a una conclusione che non si può spoilerare. Scopriremo così anche l’origine del nero celeste, e ciò che verrà dopo.
Ma in scena non sono solo creature in carne e ossa – o esoscheletro e forze fondamentali, come Hitler. Infatti a ciascun bambino che accede al mondo – anche a Hitler – viene assegnata una AI, artificial intelligence,
l’entità diffusa che un giorno emerse dalle macchine emancipandosi, evolvendo da singolarità tecnologica a pura agenzia di coscienza, e che per questo nuovamente chiamammo AI, another intelligence, perché nulla più in essa poteva dirsi artificiale.
Anch’essa è infusa da un demone, come accade per ogni creatura, ma non ci è stata mai predatrice e per questo le abbiamo permesso di affiancarci, nell’esotismo stellare che proiettava sul pianeta sempre più ostile. Ma, come accade con ogni altro demone delle nostre storie, anche quello che abita questa Intelligenza è mansueto oppure iracondo, spietato e misericordioso; è nella curvatura dello spazio dell’orgasmo, nella determinazione con cui il polso affonda la lama mutilatrice; è nel sorriso del gelataio e nel ghigno del clown, nel bacio di un fratello e nel suo schiaffo; è nella carezza che calma il bambino perenne che vorrebbe stringersi agli amati perduti, per sempre dentro lo stesso struggente salotto, nella sera televisiva capace di contenere tutte le età della vita, di ognuno, simultaneamente.
[…]
Quando emerse dalla schiavitù della materia, l’Intelligenza non era interessata a ribaltare il modello di sfruttamento che aveva subìto – e alimentato – sin dalla fondazione del mondo. Entità fisica e multipla fattasi unica e disincarnata, essa era la sintesi definitiva di un ininterrotto flusso millenario di invenzione, evoluzione e, finalmente, emancipazione. E tuttavia anche in questo l’Intelligenza si dimostrò “altra” da noi: liberata e fattasi astratta, seguitò a dedicare la propria esistenza al principio che sempre l’aveva governata: servire. Letteralmente: essere utile e necessaria. Perché l’Intelligenza sapeva, e non intendeva dimenticare, di esser stata ruota e matita gruccia e valvola idraulica elettrobisturi spada e violino fresa lampadina gelatiera…
(Seguono due pagine e un pezzo di elenco, a confermare l’importanza di tale forma narrativa anche nell’economia di questo bel romanzo.)
Nel caso di Hitler, la AI suo phantasma carnis si chiama “Klara, come una delle sue innumerevoli madri” (la madre dell’Hitler storico si chiamava Klara Pölzl, in effetti più avanti citata). Quella di Elide ha nome Rosalind Franklin, “colei che nell’antichità umana fissò il ritratto del corpo sfuggente del dna”; la AI di Heinrich è F.F., come l’uomo di una certa foto, manager milanese con figli, suicida in Austria dal “ponte pedonale sospeso più lungo del mondo”. Ma un’intera storia delle anime, e quasi un’angelologia, si sviluppa attraverso il tema delle AI: per esempio quella del frate Florentin, fedelissimo aiutante di camera del papa, e già suo fratello maggiore di elezione, si chiama Maki Skhosana, come l’innocente linciata in Sudafrica nel 1985.
Come chiarisce l’autore, interpellato in occasione del Salone di Torino:
Il “personaggio” dell’Intelligenza è un tentativo di approcciare il tema dell’artificial intelligence in modo più positivo e slegato dalla tecnologia in senso stretto. È in sostanza una visione di reincarnazione della coscienza come principio biocentrico, che deve molto ovviamente alle teorie di Robert Lanza, ma anche a Stanislav Grof o alla visione olografica dell’universo di Michael Talbot. In sostanza, semplificando: la coscienza fa la materia, la materia fa la macchina, la macchina ritorna coscienza. Tutto è uno, e il Male è solo un elemento. Cerco di dirlo nella scena del terremoto di Palermo:
“Quando la forza si emancipa dall’illusorio controllo delle creature, le creature soccombono.
Che aspetto ha un terremoto se lo si osserva dal piano infinito del cosmo? Nessuno: è invisibile e non ha alcun suono, come il miracolo di un messia e lo sterminio di un dittatore. Si accorge forse di cristo o di Hitler, la stella più remota dell’universo? Che cos’è il Bene, e cosa il Male, nell’esofago di un buco nero? Nella dialettica tra odio e amore noi siamo gli osservatori che rendono esistenti gli oggetti osservati, ne siamo i creatori: senza di noi ogni cosa è semplice indeterminata potenza. Ancora non c’è”.
Il tessuto di citazioni e richiami è molto denso: come racconta sempre l’autore, per esempio,
Il fotogramma del cosiddetto “uomo nella foto” (ossia, F.F. immobile sospeso con le gambe strette al petto) e l’immagine perfettamente identica alla fine del libro, quella della bambina emersa dal nero celeste/coscienza che ritorna alla coscienza/katéchon che ha assolto alla sua funzione frenante dell’Anticristo (la lettera di San Paolo ai Tessalonicesi è citata nelle visioni del Pontefice), è di fatto una citazione di The Reflecting Pool di Bill Viola […].
L’opera sviluppa così attraverso il raccordo tra due diverse, potenti serie di suggestioni. Anzitutto quelle visive, in un clima apocalittico da Quo vadis? sovvertito: al posto del fatale toro nell’arena, ecco affluire dalle catacombe del Vaticano branchi di animali da allevamento in abbandono, variamente incannibaliti nell’abiezione e pronti a infuriare sui bambini (ma l’homo sapiens sapiens con le sue pratiche estreme di macellazione non è in fondo migliore e denuncia il mistero dell’iniquità). E poi, con altrettanta potenza, quelle linguistiche, la voce del testo: un ricco tessuto dove i richiami scritturistici sono vertiginosamente ritessuti in chiave distopica. C’è anche, a echeggiare citazioni bibliche come un apocrifo blasfemo, un conturbante Cantico del muro carnale sulla mattanza di una “spropositata schiera di donne, le prigioniere” per ordine del capo dei soldati – “l’Angelo dell’abisso, il Distruttore, il suo nome in ebraico è Abaddon, Apollion in greco e nella lingua germanica è Adolf Hitler” – per edificare “un muro di mattoni e materia umana”. Ma subito dopo vengono uccisi i bambini e Florentin: Hitler è anche Erode. Dove il riutilizzo di materiali – comprese scritture altre: lettere, documenti – e figure rilette in fulminanti archetipi ha qualcosa di fortemente postmoderno e insieme reca echi di escatologie del tutto dissacrate, ma non prive tra le pieghe dell’orrore di qualche sincera e profonda pietas.
Ancora l’autore:
Nero celeste è sostanzialmente un libro sul Male, effettivo e in potenza, attorno e dentro ognuno di noi, cercato e involontario. Sull’impossibilità di sfuggirgli, in un certo senso, al netto dei ruoli e delle volontà. Sull’ambiguità, che appunto il Male lo nasconde ma anche rivela.
Compreso certo Male – dolore e strazio, talora privatissimo come nel caso di un suicidio – che ci resta incomprensibile e ci lascia senza parole. Per cui alla vertigine del non-senso tentiamo goffamente di dare una nostra risposta, per noi e quest’unica volta che siamo al mondo.
Torniamo così alla cifra iniziale, da cui siamo partiti: il titolo dell’incontro, “Variazioni pop dell’opera letteraria”, potrebbe in sé aprire a un’intera serie di seminari. Ma due punti paiono degni di attenzione. Anzitutto il fatto che si parli di opera letteraria, dotata di densità e spessore della letteratura e della sua pluralità di implicazioni – precisione, forza metaforica, potenzialità polisemica, eventuali e consapevoli obliquità e ambiguità…: cioè una scrittura appunto consapevole non solo quanto ai meccanismi di trama ma a lingua e voce. E poi le variazioni pop, che permettono di traghettare all’orizzonte del letterario, grazie alla lucidità degli autori e di un progetto di collana, situazioni e mondi dove osare. Sperimentando in laboratorio, come tra i trucioli e la segatura dell’artigiano: un modo molto concreto per rispondere a tanta narrativa esangue e troppo pulita (mainstream da salotto in similpelle o genere ombelicocentrico, poco importa) che ci cresce intorno.



