di Franco Pezzini
 Elia Faso, La vivisezione. Responsabilità e scrittura in Luca Rastello, pp. 238, € 22, Mimesis, Milano-Udine 2024.
Elia Faso, La vivisezione. Responsabilità e scrittura in Luca Rastello, pp. 238, € 22, Mimesis, Milano-Udine 2024.
- Voci e pronomi tra La guerra in casa e Piove all’insù
Secondo me è così che bisogna lavorare: mettere sotto il proprio fuoco ogni pratica, ogni retorica, ogni identità […]. Se l’intellettuale oggi ha un ruolo è ancora e sempre quello del vivisettore. Non bisogna enunciare valori, costruire speranza, ma smontare le retoriche, far fuori le immagini e le pratiche rassicuranti e concilianti […] come narratore il mio compito è soltanto (altrimenti sarebbe delirio di onnipotenza) vivisezionare le retoriche dominanti, che paralizzano l’agire democratico. Chi di mestiere fa il parolaio ha il compito di usare le parole come arieti contro le rappresentazioni rassicuranti. [L. Rastello, Piccola apologia della vivisezione. Intellettuali e potere, intervista a cura di E. Donaggio e D. Steila, in “alfabeta2”, 27 novembre 2011]
Concludo con una supplica: se mai accadesse di mettermi addosso la definizione di “Scrittore” e di darmi all’enunciazione di nobili valori, tiratemi i pomodori. [L. Rastello, Dell’orazione civile. Ovvero: che cosa possa fare uno scrittore per la democrazia, in A. Pascale, L. Rastello, Democrazia: cosa può fare uno scrittore?, Codice, Torino 2011]
 A distanza di quasi dieci anni dalla morte, e nonostante le speranze degli offesi dal romanzo I Buoni su una sordina alla sua produzione, Luca Rastello (1961-2015) conosce oggi sempre nuovi lettori. Ciò anche grazie a uscite di scritti incompiuti (Dopodomani non ci sarà. Sull’esperienza delle cose ultime, introd. di Monica Bardi, Chiarelettere, 2018) e alla riproposta di materiali della sua vita di giornalista (Uno sguardo tagliente. Articoli e Reportage 1986-2015, a cura di Giorgio Morbello, Chiarelettere 2021). C’è poi un interessante documentario di G.P. Amandola, M. Carnemolla, S. Gianandrea, F. Modica, Un passo più in là. Un viaggio con Luca Rastello, Rai Teche e Centro di Produzione Rai di Torino, 2017, con alcuni materiali video aggiuntivi su focus particolari; c’è una sezione monografica “Luca Rastello, scrittore” a cura di Andrea Brondino, Luca Chiurchiù e Lorenzo Marchese nel volume 20 (2021) della rivista “Contemporanea”. Non si contano poi gli interventi, le giornate di studio, le serie di incontri a tema su un panorama di lavoro eccezionale interrotto da una morte troppo precoce ma già tale da fornire una ricchissima messe di chiavi e provocazioni: tanto più che, di fronte a una prosa tanto densa, l’esigenza non è solo di leggere ma di rileggere, per cogliere dimensioni, strati, implicazioni alle quali una prima lettura non può rendere giustizia. Non si contano neppure i giochini di appropriazione surrettizia, depotenziata, della figura di Rastello: fin da qualche intervento un po’ naïf la sera della commemorazione nel luglio 2015, gli spasmodici tentativi di metterlo in qualche scatola (certi “Io e lui” autocelebrativi, per affettare un “Io lo conoscevo bene” magari a colpi di lettere private), di lottizzarlo – si parli di intellettuali modaioli o madamine/madamini in cerca di visibilità – magari cercando strategie di autenticazione un po’ oblique, di ridurlo ridicolmente a due dimensioni di comodo, sono tutti conati tra il losco e il kitsch destinati a scontrarsi con un profilo reale, incomprimibile, spesso ispido, la cui irresolubile complessità è documentata dai suoi testi, e forse particolarmente dai romanzi. Ora esce per Mimesis questo bellissimo saggio sulla sua scrittura letteraria a firma di un giovane studioso di valore, Elia Faso: un testo la cui importanza merita un’attenzione puntuale.
A distanza di quasi dieci anni dalla morte, e nonostante le speranze degli offesi dal romanzo I Buoni su una sordina alla sua produzione, Luca Rastello (1961-2015) conosce oggi sempre nuovi lettori. Ciò anche grazie a uscite di scritti incompiuti (Dopodomani non ci sarà. Sull’esperienza delle cose ultime, introd. di Monica Bardi, Chiarelettere, 2018) e alla riproposta di materiali della sua vita di giornalista (Uno sguardo tagliente. Articoli e Reportage 1986-2015, a cura di Giorgio Morbello, Chiarelettere 2021). C’è poi un interessante documentario di G.P. Amandola, M. Carnemolla, S. Gianandrea, F. Modica, Un passo più in là. Un viaggio con Luca Rastello, Rai Teche e Centro di Produzione Rai di Torino, 2017, con alcuni materiali video aggiuntivi su focus particolari; c’è una sezione monografica “Luca Rastello, scrittore” a cura di Andrea Brondino, Luca Chiurchiù e Lorenzo Marchese nel volume 20 (2021) della rivista “Contemporanea”. Non si contano poi gli interventi, le giornate di studio, le serie di incontri a tema su un panorama di lavoro eccezionale interrotto da una morte troppo precoce ma già tale da fornire una ricchissima messe di chiavi e provocazioni: tanto più che, di fronte a una prosa tanto densa, l’esigenza non è solo di leggere ma di rileggere, per cogliere dimensioni, strati, implicazioni alle quali una prima lettura non può rendere giustizia. Non si contano neppure i giochini di appropriazione surrettizia, depotenziata, della figura di Rastello: fin da qualche intervento un po’ naïf la sera della commemorazione nel luglio 2015, gli spasmodici tentativi di metterlo in qualche scatola (certi “Io e lui” autocelebrativi, per affettare un “Io lo conoscevo bene” magari a colpi di lettere private), di lottizzarlo – si parli di intellettuali modaioli o madamine/madamini in cerca di visibilità – magari cercando strategie di autenticazione un po’ oblique, di ridurlo ridicolmente a due dimensioni di comodo, sono tutti conati tra il losco e il kitsch destinati a scontrarsi con un profilo reale, incomprimibile, spesso ispido, la cui irresolubile complessità è documentata dai suoi testi, e forse particolarmente dai romanzi. Ora esce per Mimesis questo bellissimo saggio sulla sua scrittura letteraria a firma di un giovane studioso di valore, Elia Faso: un testo la cui importanza merita un’attenzione puntuale.
Certo, Rastello non è stato solo un romanziere, e probabilmente la sua opera letteraria va integrata con il ricorso ad altre chiavi: ma partire da lì pare fondamentale. Come scrive Faso,
In diverse occasioni di autocommento, Rastello mostra di credere che la scrittura letteraria non sia né una pura reinvenzione né una copia della realtà, ma una sua interpretazione complessa non meno valida di quelle prodotte dalle scienze umane e naturali. La letteratura, come tutte le forme di discorso, partecipa infatti alla “costruzione sociale della realtà”; “costruzione”, però, non implica relativismo, come in certa “smagata temperie postmoderna” per cui non ci sarebbe differenza fra i vari tipi di discorso. Al contrario, l’“opera di precisione” della scrittura può opporsi alle ideologie che rendono “accettabile l’inaccettabile”, con “una enorme mole di forzato lavoro mentale finalizzato a produrre il desiderio di vivere entro il meccanismo dominante”.
Vari critici hanno affrontato con vari tagli, e maggiore o minore profondità la produzione di Rastello (prendendo anche qualche brutto granchio, come chi attribuisce tout court all’autore opinioni e comportamenti del protagonista di Piove all’insù o ravvisa parentele letterarie del tutto infondate, per esempio con quel Tondelli alla cui opera Rastello rivolge motivate critiche, stroncando decisamente i “tondellismi”). Ma il lavoro che occorreva, e con cui tutti gli studi futuri dovranno fare i conti – per completezza, equilibrio, intelligenza, profondità, saggezza di toni – è questo che si presenta. Non si limita a contestualizzare l’opera di Rastello all’interno di filoni critici più ampi, repertoriandone le voci con sapienza, ma lavora – come faceva lo stesso soggetto dello studio – direttamente sulle parole. Ricchissimo il lavoro di vivisezione condotto da Faso sul linguaggio di Rastello, ricchissima l’analisi delle posture interiori dietro ciascuna scelta espressiva.
Accogliamo anche la provocazione dell’autore a criticarlo: non perché si sia autoincoronato “Scrittore” e si sia dato all’enunciazione di nobili valori, cosa che non ha mai fatto; ma perché il rigore stilistico, che gli ha permesso di produrre opere così riuscite come La guerra in casa e Piove all’insù, è sfociato nei Buoni in una postura enfatica e irrigidita, perdendo in complessità romanzesca quel che ha guadagnato nella spietata lucidità della critica.
E ben vengano le critiche equilibrate, costruttive di chi cerca di capire, dopo gli attacchi scomposti o sciacalleschi e i tentativi di “ammorbidimento” di quanto invece scritto con preziosa, “spietata lucidità” dall’autore. Il lavoro di Faso – che diventa un’ottima occasione anche per riprendere in mano questi libri importanti – è articolato in quattro ampi capitoli, più Introduzione e Conclusioni.
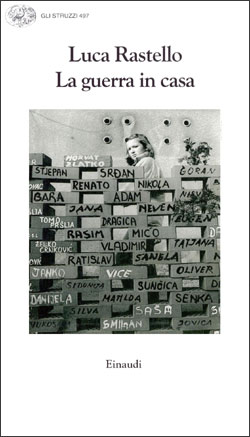 Il primo capitolo, “La guerra in casa: testimonianza individuale e storia collettiva”, affronta anzitutto il quadro generale che conduce il narratore a interessarsi della ex-Jugoslavia e all’azione solidale per i profughi della Bosnia come sfondo del suo singolarissimo testo (appunto) La guerra in casa, edito da Einaudi – non senza dibattito interno, pare – nel 1998. Sorto
Il primo capitolo, “La guerra in casa: testimonianza individuale e storia collettiva”, affronta anzitutto il quadro generale che conduce il narratore a interessarsi della ex-Jugoslavia e all’azione solidale per i profughi della Bosnia come sfondo del suo singolarissimo testo (appunto) La guerra in casa, edito da Einaudi – non senza dibattito interno, pare – nel 1998. Sorto
(d)alla continua autoanalisi (etico-politica, più che psicologico-sentimentale) necessaria a non cadere nelle trappole dell’’ambiguità degli aiuti umanitari’, dal confronto con le storie di chi scappa e di chi rimane nelle nuove repubbliche balcaniche, dall’inchiesta sul campo e dalla raccolta di informazioni,
il testo resta comunque un’opera radicalmente diversa dai
tanti reportage bellici che negli anni Novanta hanno goduto di un’ampia diffusione su tutti i media, dai giornali alla televisione, contribuendo più o meno volontariamente a una spettacolarizzazione del dolore delle vittime della prima guerra del Golfo e delle guerre jugoslave, spesso appiattita sul sentimentalismo ad effetto, nociva all’analisi storica e all’azione politica che avrebbero dovuto ostacolare con più efficacia quei conflitti.
L’angoscia di Susan Sontag per l’indicibilità dell’esperienza a Sarajevo “motiva precise scelte stilistiche e strutturali” e la scelta stessa di abbinare singole storie in soggettiva e scenari geostorici contestualizzanti in un’opera etichettata come non-fiction: ma
Se di non-fiction di deve parlare, […] sarà meglio farlo seguendo un’utile indicazione di Donnarumma [cfr. R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, il Mulino, 2014], quella di usare questa categoria solo “se ci rivela che ogni discorso sulla realtà è consapevole della propria natura artificiale senza per questo essere ridotto a finzione”.
Il tutto, affidando alla scrittura quell’“ossimorica ‘corruzione salutare’” che a suon di fallimenti permette di perdere un’innocenza originaria – e quindi “un poco dell’atteggiamento didattico e coloniale che caratterizza tanta parte di quel continente sfuggente e ambiguo che si agita e si impegna sotto le bandiere della pace”. Dove fondamentale è la categoria del fallimento, chiave in realtà ricorrente in tutta la produzione di Rastello, tra “buone intenzioni” più o meno catafratte di valori ideologici e responsabilità “sottratte a un simile trattamento mitografico”:
L’azione umanitaria acquista, credo, tanto più valore quanto più si sgancia dall’ideologia umanitaria, da quell’immaginario nutrito di carità e supplenza che non riconosce la dignità e la responsabilità delle vittime,
sfuggendo cioè a un paradigma vittimario progressista e deresponsabilizzante, a smarcare le vittime dallo “dello stato di minorità di un’identità cristallizzata”. Emblematica la figura del cecchino, il “mostro”, che Rastello ha avuto modo di incrociare in un paio di occasioni, sbattendo nel fatto che
la cosiddetta “identità etnica”, tanto essenzializzata e irrigidita dalla propaganda nazionalista e da molti commentatori del conflitto, non è dunque una questione di ontologia, ma di attribuzione. Tale attribuzione è effettuale: sei di una certa etnia perché te lo impongono gli altri, siano essi “della tua parte” o “dell’altra”, e dopo che te l’hanno imposto puoi venire assassinato per questo.
[…]
La soggettività di Darko [l’ex-cecchino] e degli altri personaggi della Guerra in casa (autore compreso) subisce una degradazione, che viene combattuta sia con il riconoscimento delle condizioni storiche che opprimono gli individui, sia con la decostruzione dei discorsi disumanizzanti e desoggettivanti che li circondano.
(Semplice nota in margine su ciò che l’autore sapeva invece trattenere nella scrittura: come raccontato poi agli amici, quando ha modo di esplorare la tana del cecchino di Turbe, non solo trova
(s)ulla parete […] tracciato a vernice spray nera un enorme disegno raffigurante un guerriero cetnico: la bustina sui capelli lunghi e folti, la gran barba selvaggia, il rosario al collo e due grandi coltelli alle mani. Era così che Boško [come i bosniaci chiamavano il cecchino] amava raffigurarsi, dunque. Per terra c’erano bottiglie vuote e una quantità incredibile di riviste pornografiche,
ma anche qualcos’altro omesso da Rastello per pudore, per non farlo liquidare come mezzuccio narrativo laddove la realtà stessa può suonare naïf, cioè una copia di Guerra e pace sul letto di Boško.)
E per lasciare spazio alla soggettività degli interlocutori, l’autore si serve di varie strategie, in particolare alcune di rarefazione della soggettività autoriale. Laddove in molta parte “della cosiddetta non-fiction degli ultimi anni l’‘esibizionismo ricattatorio’ degli autori è usato come un ‘dispositivo di intimazione di realtà’, Rastello cerca continuamente di sottrarre l’esposizione di sé alla narrazione”, si fa mero ascoltatore o osservatore o informatore impersonale: “La narrazione delle esperienze di Rastello è piuttosto una cornice per il racconto delle storie altrui”. Nella scelta stessa dei pronomi, con “una configurazione particolare della dialettica io/tu e io/tu/noi” e spesso rovesciando il suo io “nel tu dell’allocuzione del personaggio che gli sta raccontando la propria storia”. Una scelta sviluppata in due direzioni:
da una parte il discorso del tu, del personaggio, è riferito in un lungo discorso diretto – a volte occupa la maggior parte di un capitolo – o in un discorso indiretto riconoscibile come discorso riportato; dall’altra l’io sceglie fra i tanti racconti possibili quali entrano nel suo libro e quali no, e inserendoli in una cornice composita li fa interagire fra loro.
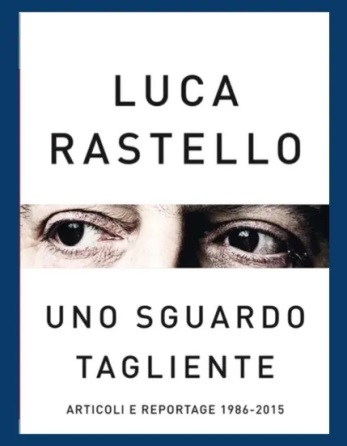 Dove il passaggio cruciale è che “l’autorità dell’io non sta tanto nella sua esperienza vissuta, quanto nella rielaborazione formale di storie che rimangono di altri”, con rispetto della soggettività degli individui incontrati, incompresi finché ridotti a oggetti del discorso, “con le consuete implicazioni tipologiche – il cecchino, il profugo, il volontario, ecc.”.
Dove il passaggio cruciale è che “l’autorità dell’io non sta tanto nella sua esperienza vissuta, quanto nella rielaborazione formale di storie che rimangono di altri”, con rispetto della soggettività degli individui incontrati, incompresi finché ridotti a oggetti del discorso, “con le consuete implicazioni tipologiche – il cecchino, il profugo, il volontario, ecc.”.
Altra tecnica di decentramento dell’io è quella che potrebbe chiamarsi “estroflessione enunciativa: nei discorsi del testo l’io dell’autore viene tendenzialmente reso con un tu, nel tentativo di non rinchiudersi nella sua soggettività e di osservarsi dall’esterno”. Un modo per reagire a quell’egocentrismo narcisistico che rende poco sensibili nei confronti dell’altro (una visione del citato documentario Rai Un passo più in là. Un viaggio con Luca Rastello permette di cogliere nei discorsi di taluni testimoni un ricorso all’io sgomitante assai meno trattenuto). Ma queste sono solo alcune delle strategie narrative sull’uso dei pronomi portate avanti da Rastello e incalzate da Faso per “attraversare le nebbie discorsive in cui tutti si trovano immersi”:
I blocchi fra “l’umanitarismo buono” e “l’indifferenza cattiva” non esistono in natura, ma si formano nell’irrigidimento delle posizioni; irrigidimento a cui i membri del Comitato possono involontariamente contribuire tanto quanto gli esterni.
Timori, questi sull’irrigidimento delle posizioni argomentative, che richiamano le letture di Furio Jesi sulla differenza tra mito genuino – “inteso come eterno presente disponibile a tutti e non come passato rievocato a fini di legittimazione del presente” (Rastello, Il mito, per decostruire, in G. Fofi, a cura di, Il racconto onesto. 60 scrittori, 60 risposte, Contrasto, 2015) – e mito appunto tecnicizzato: “il mito tecnicizzato serve le retoriche del potere, il mito genuino è un efficace strumento critico, invece, per decostruirle” (ibidem). Tecnicizzato è per esempio il mito brandito da governanti e intellettuali serbi – dall’accademia ai romanzieri – con uno sciovinismo basato proprio sulla mitologia vittimaria, cancellando o manipolando disinvoltamente centinaia di anni di storia. Ma la manipolazione del mito tecnicizzato accomuna in realtà figure come il serbo Milošević, il croato Tudjman con le sue rievocazioni degli ustascia e lo stesso presidente bosniaco Izetbegović che nel contesto dell’assedio di Sarajevo avvia la radicalizzazione islamica di una classe dirigente fino a quel punto laica.
D’altra parte
Rastello indaga i legami (ingarbugliati ma non inestricabili) fra la forma economica e la forma ideologica del vivere sociale, senza trascurare nessuna delle due cadendo in un materialismo gretto da una parte o in uno spiritualismo valoriale dall’altra.
Tanto più che gli slogan politici martellati finiscono con l’infettare le stesse dimensioni private e persino persone dalle esperienze culturali diverse, come i caschi blu di Srebrenica che ripetono ritornelli serbi.
Non si può rispondere alle mitologie belliche e nazionaliste con altre mitologie che, nonostante le buone intenzioni, presuppongono lo stato di minorità delle persone a cui si riferiscono. Altrimenti si arriva allo stesso risultato: instaurare un rapporto di potere e privare di agency le vittime.
Ed emblematica è la situazione del profugo bosniaco Izmet, schiacciato dalla mitologia che un ambiente torinese “solidale” gli cuce addosso, disapprovandolo per la sua inerzia e reificandolo nella figura del profugo fannullone. Il suo lungo racconto permetterà di capire molte cose, e Izmet diverrà – come già voleva – testimone di accusa al Tribunale internazionale sui crimini di guerra: senza vittimismi da stereotipo, e mirando invece a ristabilire una giustizia collettiva.
Un punto collegato – proprio attraverso la puntuale narrazione di Izmet – è il nesso tra memoria, precisione e storia: “come resistere ai rischi della mitologizzazione dell’esperienza vissuta e della sostituzione dell’analisi con ‘il racconto individuale e l’opinione personale’”? Un punto su cui oggi ferve tutto un dibattito, solo però agli albori all’epoca dell’uscita del libro. Scettico persino sull’uso metaforico del concetto di memoria collettiva, e memore di alcune fondamentali affermazioni di Primo Levi, Rastello si esprimerà così ne Il presente come storia (Edizioni dell’Asino, 2015):
come ha scritto recentemente Daniele Giglioli nella sua Critica della vittima, la memoria istituisce con il passato un rapporto proprietario. La memoria si appropria del passato. Non è mai neutra; è sempre la mia memoria, la nostra memoria, la memoria delle vittime, la memoria di qualcuno nel cui nome si parla. E serve per lo più a legittimare l’azione nel presente di qualcuno che diventa portavoce, detentore, mediatore dei possessori di memoria. Osservazioni banali, se non fosse per questo culto di massa che ci ha accecati. Tutti i nazionalismi sterminatori dell’ultimo secolo hanno avuto la memoria come propria bandiera […].La memoria è preziosissima, fondamentale, a condizione che sia sussunta nella fatica della storia, la fatica cioè di mettere molte interpretazioni, molte “memorie”, su un tavolo […] e di negoziare tra interpretazioni diverse, accettando anche di arrivare a un accordo artificiale, perché l’obiettivo, per certi versi impossibile, è di capire il passato. Il culto feticistico della memoria rivela i suoi piedi di argilla non appena se ne rovesci l’assunto di base. Non è vero che il passato si ripete se non lo si ricorda. È vero purtroppo che il passato si ripete se non lo si capisce.
Rileggere simili riflessioni nell’odierno contesto in cui la critica a Israele su Gaza vede contrapporre come automatismo falsante un certo passato di sterminio aiuta a sottolineare quanto le pagine di Rastello ci siano ancora essenziali.
Per certo, si tratta di capire il senso di La guerra in casa: come chiariva l’autore,
Questo è un libro di storie, non di storia. Queste pagine non intendono dare un’interpretazione complessiva della guerra jugoslava, anche se non sfuggono all’ambizione di fornire qualche alimento al lavoro di ricostruzione degli eventi che hanno insanguinato l’altra sponda dell’Adriatico fra il 1990 e il 1995, allineando dati e testimonianze anche su alcuni aspetti oscuri di quella tragedia.
Ma, puntualizza Faso, l’impersonalità del discorso scientifico negli “scenari” (le ricostruzioni storiche)
non significa apoliticità: al contrario, se l’“ideologia umanitaria” ha posto le sue fondamenta sulla morale individuale che può diventare una marxiana “falsa coscienza” (GiC, p. 91), la storiografia mostra la sua vocazione politica; non nel senso di “faziosità” a cui spesso la si riduce, ma nella caratteristica della distanza indicata, fra gli altri, prima da Weber e poi da Wieviorka.
[…]
Distanza, dignità, responsabilità […] sono i campi semantici che cercano di resistere alla falsa immediatezza, per usare una locuzione cara ad Adorno. Sono concetti che si contrappongono alle retoriche delle mitologie tecnicizzate e che puntano sulla precisione, parola chiave per Rastello.
Con il valore del documento ad allontanare la pretesa di un accesso immediato alla realtà, forma di impegno anche etico e limite alla soggettività: “nella precisione che lo costituisce si richiede alla memoria di superare il suo rapporto proprietario con il passato e di confrontarsi con la complessa molteplicità della realtà”. D’altra parte i documenti non sono neutri, e come ricorda lo stesso Rastello in merito alle cartine in calce al volume, “Niente è più fuorviante […] che assegnare alle cartine geografiche – soprattutto a quelle indicanti una composizione etnica – un attributo di oggettività”: e merita andare al volume per i chiarimenti “delle falsificazioni e delle semplificazioni che hanno portato agli accordi di Dayton”. Quanto agli almeno novemila morti di Srebrenica, il
discrimine principale non sta nei militari serbi comandati da Mladić o nel numero di persone uccise, ma nei buoni: la retorica dell’inevitabilità della strage è stata funzionale a rimuovere la sua evitabilità da parte delle “truppe di pace” e di buona parte del “mondo civile” che osservava immobile; mentre si impediva l’uso della forza a chi tentava di difendersi si è trasformata la violenza storica e politica in un altro dei tanti tristi apologhi della metafisica del male.
Dove il “mondo civile” è chiamato pienamente in correo.
L’ultimo snodo, sintetizza Faso, è un “Uscire da sé senza cadere dentro gli altri”: allo “sguardo che non guarda” – la spettacolarizzazione che non fa capire – Rastello oppone procedimenti (nel senso già chiarito) di “corruzione dello sguardo”. La scrittura che considera anche il fallimento nell’afferrare la realtà mostra un’importante funzione esplorativa negli sforzi “di uscire da sé senza instaurare un diritto proprietario sugli altri”:
L’indagine sulla realtà resiste al soggetto a causa della sua oscurità ma, proprio nella sua ambiguità, permette ancora qualche “via di fuga”, come dirà il narratore del libro successivo Piove all’insù: via di fuga per l’io/tu dell’autore/personaggio, per il tu della figlia [ancora piccola, che vede giocare e un giorno dovrà affrontare la “concretissima colpa di vivere qui”], per il tu del lettore.
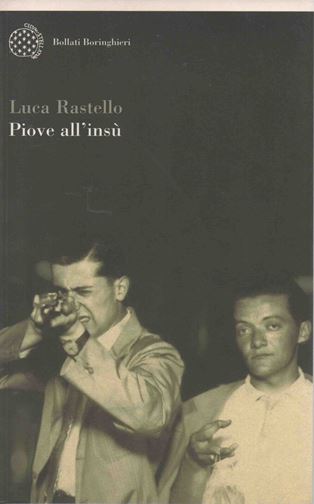 E il secondo capitolo riguarda proprio “Piove all’insù: perché il possibile non diventi necessario”. Stavolta un romanzo vero e proprio, che segue nel 2006, dunque a distanza di ben otto anni da La guerra in casa. Conclusa, almeno nelle linee di fondo, l’attività sulla Bosnia (i profughi accolti in Piemonte attraverso la rete organizzata con l’apporto importante dell’autore – e anche in casa sua nel Canavese – in parte resteranno in Italia), Rastello lavora a varie riviste, affronta la morte dei due genitori e si ammala a sua volta di tumore. La diagnosi è terribile. Il libro esce dopo che ha subito un intervento chirurgicamente estremo e quando sta affrontando pesanti terapie: un passaggio che apre una quantità di domande.
E il secondo capitolo riguarda proprio “Piove all’insù: perché il possibile non diventi necessario”. Stavolta un romanzo vero e proprio, che segue nel 2006, dunque a distanza di ben otto anni da La guerra in casa. Conclusa, almeno nelle linee di fondo, l’attività sulla Bosnia (i profughi accolti in Piemonte attraverso la rete organizzata con l’apporto importante dell’autore – e anche in casa sua nel Canavese – in parte resteranno in Italia), Rastello lavora a varie riviste, affronta la morte dei due genitori e si ammala a sua volta di tumore. La diagnosi è terribile. Il libro esce dopo che ha subito un intervento chirurgicamente estremo e quando sta affrontando pesanti terapie: un passaggio che apre una quantità di domande.
È possibile che una primissima provocazione – almeno in nuce – per il libro venga da un progetto proposto parecchi anni prima da Antonietta Bruzzone Chiama (già insegnante di matematica di Rastello al liceo, e interlocutrice di Sergio Solmi) appunto a un gruppo di ex-allievi: una sorta di inchiesta sugli anni Settanta al D’Azeglio, per cui Rastello giovanissimo intervisterà vecchi compagni di scuola con un casereccio registratore a cassette. Nel dopo-Bosnia, formandosi alla scrittura giornalistica, eccolo dunque riprendere in forma molto più ambiziosa l’idea del ripescaggio di testimoni di un’epoca per costruire una storia che in realtà va ben oltre, e che si compenetra con l’idea di un’inchiesta sul golpe Borghese, ma senza banalità consolatorie o complottismi da feuilleton. A dare una spinta ulteriore è la riflessione sul lavoro a fronte del licenziamento della moglie, una sorta di perdita di identità sociale che interpellava sugli sviluppi di una vita collettiva in cui accettiamo cose per cui un tempo ci saremmo ribellati: e, in dialogo con lei (un tu, di nuovo), il “come siamo diventati così?” finisce col ricondurlo – tra continuità e discontinuità col presente – alle vicende degli anni Settanta. Riduttivo però esaurire in quella rammemorazione (come spesso avvenuto in sede critica) il senso del libro: come scrive Faso,
Se la si considera dal solo punto di vista quantitativo, la rappresentazione delle vicende del protagonista sembra trovare un suo nucleo nel Settantasette, attorno a cui gravita l’intreccio con una cronologia non lineare che coinvolge gli anni precedenti e successivi; ma, prendendo in considerazione altri fattori, proporrò un’interpretazione diversa della struttura narrativa del romanzo e del ruolo del suo protagonista: è vero che la traiettoria del racconto orbita intorno agli anni Settanta, ma compie un giro più largo che, fra gli altri effetti, ha quello di rovesciare l’importanza della soggettività insieme ingombrante e debole del protagonista per lasciare le decisive scene finali alle scelte del padre, fino a quel momento rimasto dietro le quinte.
[…]
sarà meglio considerarlo un romanzo senza ulteriori attributi, se all’abusato termine “romanzo” si restituisce uno dei suoi sensi più proficui, quello di arte che tenta di raffigurare “la totalità estensiva della vita”, di tecnica linguistica e narrativa che grazie alla mimesis permette agli esseri umani di prendere “coscienza di sé in quanto esseri particolari, gettati nel tempo, collocati in un mondo e posti in mezzo agli altri”.
Un chiarimento già sufficiente a dare il senso della ricchezza e dell’equilibrio con cui l’autore di questo saggio avvicina l’opera di Rastello.
E tutto si sviluppa proprio a partire dal tu della compagna licenziata (e che resterà anonima), a cui il narratore scrive delle email, riflettendo, ricordando e confessandole anche che da ragazzi – per far colpo su di lei – le avesse spacciato per proprie le parole di un “Urania”. Dopo vari tentativi, riuscirà infine a identificarlo nell’onirico e psichedelico Opzioni, di Robert Sheckley (“Urania” 689, 1976 – uscito non a caso subito prima del Settantasette).
Torniamo però a sottolinearlo, anche se dovrebbe essere ovvio: a parlare è un narrante-protagonista, Pietro Miasco, la cui vita ha singoli punti di comunanza con l’autore ma un tale numero di altri divergenti da non potervisi assolutamente identificare – ciò che vale anche per una serie di giudizi sulla realtà, le sue posizioni non sono quelle di Rastello. Una figura peraltro, quella di Miasco, che per lo scrittore rappresenta in qualche modo una vecchia conoscenza. Nei numeri di prova di una rivista fondata da Rastello con un gruppo di amici negli anni Ottanta, L’Opera al Rosso (più precisamente nel n. 1, Città), figura tra gli altri un suo racconto Storia sdrucciolevole, che inizia: “Il mio nome è, per il momento, Pietro Piasco. Non sono del tutto la persona che scrive, credo”. Il passaggio da Piasco, toponimo piemontesissimo, a Miasco, sembra insomma non aver comportato alterazioni a questo denunciato sfalsamento di identità tra autore e narrante, a dispetto di quanto ravvisato da qualche critico:
Rastello preferisce invece inserire il suo narratore-protagonista in un gioco di soggettivazione e desoggettivazione tipicamente letterario. […]
Se nella Guerra in casa per poter al tempo stesso estroflettere l’io e rispettare lo statuto di storia vera del testo Rastello aveva costruito un particolare dispositivo enunciativo che permetteva l’alternanza io/tu, in Piove all’insù organizza invece dei dispositivi narrativi. L’“esasperata enfasi sull’Io, luogo delle finzioni riparatrici e protettive” vissuta dal protagonista adolescente trova un efficace contrappeso nella soggettività del narratore, portatrice di un’istanza di verità “eccentrica, centrifuga, proiettata verso il fuori; estrema dunque, alla lettera, per diritto e per definizione”.
Al di là dell’enfasi critica diffusa sull’eccellente ricostruzione storica e su valutazioni un po’ emotive come di romanzo “avvincente”, Faso punta più acutamente a un’interpretazione strutturale del testo: non tanto in chiave di essenza unitaria – come, esemplifica, potrebbero essere “il Settantasette, il Padre, la Soluzione del ‘rebus’ finale” –, ma di ipotesi strutturali sui rapporti fra i diversi livelli del romanzo. Discute dunque il tema della velocità (in realtà l’accelerazione narrativa, sottolinea, è in dialettica con un rallentamento riflessivo) attraverso forme come l’enumerazione caotica a rappresentazione della molteplicità dispersiva del reale, il raffreddamento e insieme le scintille prodotte dall’estrazione dei ricordi, una certa mimesi del parlato, la stessa diversa ampiezza delle email costitutive del testo, con aforismi che frenano più che rallentare. Rifacendosi agli studi di Francesca Gatta, ascrive il testo alla tendenza alla saggificazione della scrittura narrativa recente e vi riconosce innesti linguistici anomali, articolazioni in ampie lasse per modalità di monologo, ma rimarca l’originalità e le differenze strutturali da altri casi nella narrativa recente, il rapporto in Piove all’insù tra dispositivo saggistico e dispositivo narrativo.
E soprattutto identifica una macrostruttura del testo con “sfasatura temporale fra capitoli e le inserzioni delle trame di quattro romanzi di fantascienza usciti nella collana Urania fra il 1976 e il 1978” (per la precisione: K. Trout cioè P.J. Farmer, Venere sulla conchiglia, Mondadori, 1976; J. Fast, La pietra sincronica, Mondadori, 1978; R. Sheckley, Il matrimonio alchimistico di Alistair Crompton, Mondadori, 1978; e il citato Opzioni, 1976): una rappresentazione “che ne rilevi l’andamento insieme spiraliforme e lineare” con circolarità temporale e narrativa “dal 1958 (inizio del coinvolgimento del padre del protagonista nelle trame eversive) al 2002-2003 (vigilia della morte di Agnelli)”. E le quattro trame degli “Urania” contribuiscono a rafforzare l’idea di un tempo caotico tra epos e romanzo (impossibile qui dar conto in dettaglio delle ricche argomentazioni di Faso), con tanto di ironici interventi di “istanze metanarrative […], come il ‘Comitato per la Salvaguardia dell’integrità del Racconto’ (PaI, p. 169), che tentano goffamente di trattenere la coesione testuale”. Ma le folli trame degli “Urania” finiscono col trovare nessi con le vicende del protagonista, a partire da un romance che a un certo punto si frammenta irreversibilmente. La tentata incarnazione dell’Uomo Nuovo liberato nella sessualità e nella politica conduce però al fallimento delle sue intenzioni rivoluzionarie, schiacciato com’è sulla molteplicità dispersiva del movimento del Settantasette: e di nuovo ecco le opposizioni de La guerra in casa, astrazioni desideranti contro precisione, intenzioni contro responsabilità, in riferimento “non solo a categorie morali, ma anche a scelte linguistiche e storico-politiche”. Ma la volontà di “non prendere il potere” si rovescia “nel rifiuto dell’assunzione di qualsiasi responsabilità, nel qualunquismo dell’‘età di Tersite’ (PaI, p. 165)”:
Vuoi liberarti del tuo male? Liberati del tuo destino. Torna indietro, cambia il corso della natura, ringiovanisci, non invecchiare. Tersite che suggerisce l’impossibile ai prìncipi achei. Ulisse, eroe di un’epoca seria, lo espelle dal mondo degli uomini, lo bastona e lo caccia per qualcosa che dopo quella mattina a Torino sarebbe diventata invece la regola del mondo nuovo: ringiovanisci, non invecchiare, non morire, non diventare.
Una postura interiore che finisce con il rivelarsi congrua alla stessa struttura narrativa a spirale, che “collega in un comune fallimento vita pubblica e privata”. Il fatto è che “(c)ome nell’Ultracapitalismo apocalittico degli Urania, il potere politico-economico ha saputo assorbire le buone intenzioni del Settantasette e le ha paradossalmente realizzate”. Ma il tu relativo alla compagna e il lui sul padre (“il senso di responsabilità con cui […] ha affrontato la propria morte […] permetterà al figlio di scoprirne la passata assunzione di responsabilità etico-politica”) tornano infine a toccare la spirale dell’io, a permettergli di superare il narcisismo sterile, a uscire dall’egocentrismo verso un nuovo futuro. Dove, superando la lettura riduttiva del “documento”, il testo rivela la sua forza nella
particolare configurazione della forma romanzo; grazie ad essa egli riesce a praticare una vivisezione di quelle narrazioni dominanti che tanto infastidiscono Fofi perché usate dalla “parte ‘emersa’ della generazione” che “ha continuato a farsi bella e a occupare il presente”.
Faso affronta infine acutamente il motivo della Torino magica come affrontato da Rastello, sul filo della lettura fondamentale di Praga magica di Angelo Maria Ripellino (Einaudi, 1973), per un accumulo di motivi che nulla concedono all’esoterismo facile, smarcandosi solo dal richiamo ripelliniano al Kitsch in nome di una precisione decostruttiva.
Al termine della disamina del romanzo, è possibile smantellare l’abbaglio critico su un finale che non concluderebbe: l’indovinello con cui si chiude il romanzo (la simbolica dell’alchimia, il discorso su eros e femminilità) in giustapposizione all’allarmante trionfo di Agnelli morente è in realtà illuminante. Di contro al nuovo mondo di lugubre trionfo del denaro sulla politica, l’unione serena del protagonista con la compagna sarà elemento di resistenza.
- Continua



