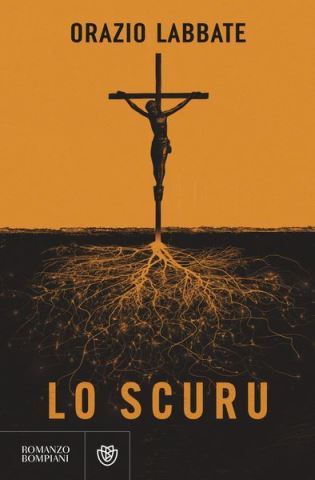di Franco Pezzini
Orazio Labbate, Lo Scuru, pp. 144, € 16, Bompiani, Milano 2024.
1970 (o giù di lì). Mio padre, dipendente Fiat a Torino, è stato trasferito per un lavoro alla Grandi Motori a Trieste: trattandosi di un soggiorno di anni, porta tutta la famiglia e prende in affitto dalla famiglia di un collega una casetta a due piani su Scala Santa, una delle vie scoscese che si inerpicano sulla collina dal popolarissimo e periferico (almeno allora) quartiere Roiano. La casetta è arredata secondo un gusto che oggi potremmo definire un po’ rétro, compresi una tappezzeria vinaccia nel salotto, una pittoresca cucina e un gigantesco quadro – quasi un’inquadratura all’americana, ma per il resto grandezza naturale – della Madonna sovrastante il letto dei miei. Quadro oggetto della vicenda che segue.
L’episodio che narro si svolge un tardo pomeriggio d’inverno, a tramonto consumato: con vari amici coetanei – neanche dieci anni a testa – saliamo al piano superiore per recuperare un paio di forbici (arrotondate) dalla nostra camera da letto, comunicante con quella dei miei. In stile piccoli esploratori nel buio, non accendiamo la luce, brandendo invece una piccola pila elettrica.
Recuperiamo le forbici, il temerario che regge la pila la punta distrattamente attraverso la porta aperta della stanza dei miei, illumina l’enorme quadro sul loro letto. Sappiamo che scherzi combini una luce su un quadro… Al grido “La Madonna si muove!”, presi dal panico, ci tuffiamo giù dalle scale e raggiungiamo le luci tranquillizzanti del piano di sotto e le madri in attesa. Ultima della fila, mia sorella – al tempo piccola – che non ha capito niente e trotterella giù dai gradini.
L’episodio è oggi incomprensibile a buona parte dei bambini, ma il panico descritto, e omogeneamente diffuso nella nostra piccola squadra, la dice lunga su un linguaggio d’epoca, che ci faceva considerare neppure troppo implausibile un simile evento. Al tempo, storie di apparizioni mariane più o meno impressionanti (quadri che piangono o – peggio – sanguinano, immagini che si staccano da dipinti per interagire con gli umani, eccetera) facevano ancora parte di un linguaggio devoto diffuso. Fortunatamente, nella fede della mia famiglia – o tra gli stessi preti incontrati via via – quell’arsenale miracolistico faceva parte di curiosità tramandate più per spiegare soggetti d’affreschi o fenomeni sociodevozionali che per punti saldi d’un credere: il Vaticano II stava venendo metabolizzato, e la fede medievaleggiante dei prodigi e della paura si ritraeva. Ma nello stanzone d’ingresso della casa di campagna dove andavamo d’estate ci sarebbe stato per anni – e lo ricordo con vaga inquietudine – un vecchio quadro molto scuro riproducente non so quale effigie della Madonna che colpita da sassi avrebbe sanguinato, e storie di rapporti agitati tra il sacro e le immagini sono del resto documentate un po’ su tutto il territorio nazionale.
L’idea che entità luminose – uso volutamente una formulazione generica – scelgano di comunicare con fragili esseri umani e tanto più con impressionabili bambini attraverso simili epifanie da cardiopalmo mi è sempre risultata difficile da comprendere: io ne avrei tratto più panico che confidenza spirituale. Vero che i testimoni – veri o presunti, non ci interessa – di simili eventi non ne risulterebbero in genere scioccati, ma almeno nelle Scritture l’apparizione mette subito le mani avanti: “non aver paura”, “non abbiate timore” sono le formule ricorrenti, perché è chiaro che paura e timore sono i nostri atteggiamenti più immediati di fronte a tali epifanie che lacerano il velo del naturale.
D’altronde la devozione popolare, allargando indebitamente e in modo talora molto losco il fronte del miracoloso, è ricorsa assai spesso a un immaginario che con le Scritture c’entra ben poco. Il teatro di mirabilia allestito una ventina d’anni fa da Carlo Dogheria nel volume Santi e vampiri. Le avventure del cadavere (Stampa alternativa, 2006), mostrando i percorsi di due assai diversi tipi di corpi, ricorda come un certo tipo di linguaggio devoto parli assai più di convinzioni arcaiche, di paure e archetipi primordiali e senz’altro pagani, che non del credo delle grandi religioni odierne. Tra i miracoli degli Acta sanctorum, di sconcertante varietà, si ravvisano manifestazioni talora incongrue o addirittura frivole o ingiuste – al punto che solo le pirotecnie interpretative di agiografi compiacenti riescono a conciliarle (in termini anche parecchio laschi) con lo spirito evangelico.
E un elemento risulta determinante: il ruolo di un supporto materiale vicario al corpo, di un’icona – dipinto, statua… – che catalizza l’inquietudine. Da bambino non potevo sapere che quell’effetto viene definito Perturbante: quando si muove qualcosa che per definizione non dovrebbe muoversi, quando interagisce con noi qualcosa che non dovrebbe farlo (pensiamo anche solo agli occhi di certi quadri, capaci di inseguirti in giro per la stanza). Ma è qualcosa che colpiva già gli antichi: non si contano le storie – e anzi i rituali teurgici – sull’animazione di statue. Come bambino dalla ricca fantasia, bastavano alcune immagini a colpirmi, tanto più se collocate in spazi dove dovevo passare da solo, o persino in certi libri – dove sapevo che voltando le pagine avrei incontrato a un certo punto una figura disturbante. E tante storie di miracoli non le avrei conosciute, se girando per la Torino barocca con mia madre e mia nonna non avessi ricevuto spiegazioni sul senso di una certa figura, sull’immagine in cera di un certo santo coricato, su certi soggetti di tele negli altari minori: tranquillissime, ma tali da attecchire come a una miccia del materiale esplosivo della mia fantasia.
Un simile carnevale di paure sovrannaturalistiche “pie”, “devote”, può accedere oggi a un linguaggio narrativo codificato, quello del folk horror – o piuttosto, considerando la scena italica, dell’orrore popolare, come riflettono Fabio Camilletti e Fabrizio Foni in una coppia di belle raccolte edite da Odoya (Almanacco dell’orrore popolare. Folk horror e immaginario italiano, 2021 e Almanacco dell’Italia occulta. Orrore popolare e inquietudini metropolitane, 2022); e rientra nell’orizzonte ormai riconosciuto di un gotico mediterraneo e peculiarmente nostrano (cfr. Italian Gothic. An Edinburgh Companion, a cura di Marco Malvestio e Stefano Serafini, Edinburgh University Press, 2023). Ma da un lato presuppone, per essere compreso davvero, una intensa appartenenza – culturale o psicologica – o almeno una vivida impressione recata da un orizzonte di convinzioni e di linguaggio, con adesione a un sistema immaginale diffuso. Ben difficilmente un gruppo di bambini di oggi può vivere un evento come quello descritto supra, legato alla cultura cattolicissima di un passato italiano.
Mentre avrebbe potuto capirlo, con lo stacco critico di un diverso referente culturale ma insieme con l’impressione di un’esperienza fortissima, un viaggiatore eccellente come Horace Walpole, che proprio quel tipo di suggestioni devote stranianti, oniriche, grottesche, traghetterà nel suo Castello d’Otranto. Giocando sulle situazioni incontrate in gioventù durante il Grand Tour in Italia, Walpole avrà la genialità di sviluppare questo immaginario in chiave narrativa, a colpi di incubi e miracoli. Eppure, persino nel grembo del genere gotico da lui avviato, pochi sapranno coglierne l’esplosivo specifico, il teatro emotivo e iconico, e gli stessi epigoni anglosassoni ne recupereranno solo modiche suggestioni, in genere tramite altri filtri (l’Irlanda cattolica a monte della santabarbara di res sacrae del Dracula, alcuni elementi sincretizzati nelle culture creole o latinoamericane, il Camera con vista folkloristico-streghesco stile Aradia).
E, molto tempo dopo, sta qui – più che nel set trinacrio in sé – una delle spiazzanti novità del gotico siciliano di Orazio Labbate: capace di riprendere in nero miracolismi e devozioni, icone e rituali idealmente sulla scia di Walpole. Immagini conturbanti come quelle del Signore dei Puci e della Madonna dell’Alemanna, riti di liberazione esorcistica che non liberano affatto, castelli e chiese e un intero abitato dalle presenze convulse e disturbanti: processioni da incubo, incendi finali dal sapor di crollo…
Di più: in Labbate troviamo il ricorso ad altri due elementi-chiave della novità walpoliana, cioè l’uso del grottesco – figure ossesse e burattinesche, sghembe derive, un teatro di eccessi che alla poesia alterna il sogghigno – e il contrappunto a un mondo anglosassone qui non inglese, ma americano. D’altra parte, vedendo citare (giustamente), tra le fonti ideali di Labbate, oltre a Bufalino, Consolo e D’Arrigo, anche Faulkner e McCarthy, sembra senz’altro il caso di ascrivere all’elenco il landlord di Strawberry Hill.
Di più: il Walpole tanto colpito da linguaggio e febbri immaginali del barocco “papista” – estremo e paradossale per un viaggiatore giunto da un’esperienza culturale diversa come quella britannica – vede eruttare le sue fantasie da un bacino onirico, un sogno o piuttosto (confesserà) un incubo occorsogli: quel set non è dunque colto puramente al filtro di un linguaggio da folklorista, filologo o protosemiologo, ma ruminato nel segno del notturno e dell’inconscio. Un linguaggio degli abissi, interiori come inferi, che può ben riconoscersi – a leggere Labbate – come peculiare linguaggio dello Scuru, come linguaggio scuru: un linguaggio aspro, febbricitante e immansueto, voce della perturbazione e del notturno, voce delle crisi di mondi diversi. E che paradossalmente ci accoglie in questo nostro faticoso oggi, prestandoci toni per parlarne e forse placarci:
La notte mi parla con la lingua dei fantasmi e mi dice che sarò perdonato. […] Vienimi a prendere Scuru. Proprio tu, Scuru. Salvami. Ti imploro. Prenditi la mia luce e spegnimi. Taglia la glossa e dalla a qualcheduno perché io possa spirare subito.
Di qui idealmente promanano le riflessioni articolate da Labbate nel suo saggio L’orrore letterario (Italo Svevo, 2022) che de Lo Scuru diventa l’esito inevitabile a raccolta di tutta una letteratura.
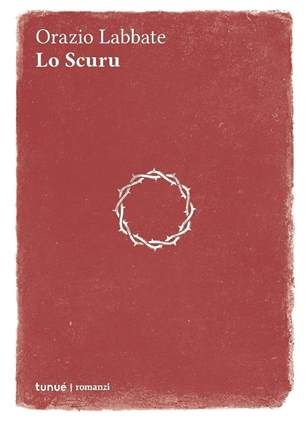 La riproposta in libreria de Lo Scuru, uscito inizialmente per Tunué, 2014 – dunque dieci anni fa – e riedito ora da Bompiani in attesa di un videogioco ispirato (entro l’anno) e della trasposizione cinematografica attualmente in lavorazione (2024 o 2025), sembra una buona occasione per riflettere sul rapporto con le fonti prime di un genere che Labbate non si limita a riprendere con passione, ma reinventa originalmente sulla base di un personale sentire. E proprio l’edizione Bompiani in uscita accompagna al testo del romanzo un vero e proprio manifesto, Genesi del Gotico siciliano di Orazio Labbate.
La riproposta in libreria de Lo Scuru, uscito inizialmente per Tunué, 2014 – dunque dieci anni fa – e riedito ora da Bompiani in attesa di un videogioco ispirato (entro l’anno) e della trasposizione cinematografica attualmente in lavorazione (2024 o 2025), sembra una buona occasione per riflettere sul rapporto con le fonti prime di un genere che Labbate non si limita a riprendere con passione, ma reinventa originalmente sulla base di un personale sentire. E proprio l’edizione Bompiani in uscita accompagna al testo del romanzo un vero e proprio manifesto, Genesi del Gotico siciliano di Orazio Labbate.
Che è anzitutto un bellissimo e intenso racconto autobiografico, a partire dai venti chilometri di deserto della strada provinciale tra Butera e Gela. Un deserto “sconfinato, eppure conchiuso nei pochi chilometri, su tutti i lati, in cui la desolazione domina lo sguardo”; un deserto malinconico e crudele, privo d’illuminazione notturna, ma insieme pronto a liberare energie in chi lo traversi non accidentalmente. Di qui la volontà dell’autore diciottenne di far sua quell’esperienza di iniziazione all’estremo vivendo la strada frammento dopo frammento: “Sentivo […] di dare un nome definitivo alla tenebra, non poteva considerarsi mero buio, emanava, complice il deserto, un’orribile filosofia esistenziale, emanava un’identità” diversa dalle entità cristianeggiate – ma memori di un retroterra antichissimo, pagano – dei riti comunitari di Butera.
Brandendo come ideali testi sacri le sue letture del tempo (McCarthy e Faulkner, Kafka, Bufalino e Consolo, D’Arrigo, Cioran: “Queste opere tentavano di suggerire un nome al buio della Sp8, mi aiutavano a definire l’astrattezza emotiva e teologica del territorio attorno e dentro di me”) Labbate riflette sul tipo di lingua necessaria a narrare quel tipo di esperienza. Che come nel gotico americano vede sostanziarsi
prospettive simboliche, culturali, visionarie, locative, in comune. A partire dall’attenzione nei confronti di una religione cattolica quale centro fanaticamente nevralgico della fede, dall’onnipresenza di ambientazioni desolate (nella cristica e avventurosa dimensione del deserto, come in quella di una più tangibile trascuratezza cittadina di contorno). Senza tralasciare la focale questione dell’invocazione delle divinità cattoliche, da parte dei più dubbiosi e controversi filosofi del posto, non per acquietarle bensì per scatenarvisi contro. Causa del dolore, della solitudine, della pazzia di tutta la popolazione.
Una religione in nero dove sedimenta il Perturbante da cui siamo partiti, certo da un altro luogo e un altro tempo, e che conduce a esiti simbolicamente anche molto distanti. Ma che in fondo richiama ancora una volta al lascito impressionante di devozioni & inquietudine importato in letteratura per la prima volta da Walpole.
Il tutto in una lingua congrua, un siciliano inconciliante, scheggiato e gutturale privo di ironia da commedia all’italiana o concessioni folkloriche. E la notte di Natale del 2010 (ricordiamo che il vecchio gotico era nato con Walpole la vigilia di Natale), nel buio della strada, l’autore vive un’agnizione che costituirà lo sbocco della sua narrativa, proclamando “al vento freddo del deserto, con sicurezza, certo del battesimo soprannaturale, come quando si dice a sé stessi una cosa giusta senza alcuna prova: ‘Questo è lo Scuru’”. Che acquista una sorta di dignità teologica e insieme finisce col richiamare vagamente le entità fronteggiate nel Salmo 91 (91), versetti 5-6: “Tu non temerai gli spaventi della notte, / né la freccia che vola di giorno, / né la peste che vaga nelle tenebre, / né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno” – a loro volta in origine, probabilmente, non concetti astratti ma figure demoniache.
Di qui, a reinventare il gotico americano in chiave nuova, nasce il gotico siciliano di Labbate, con la sua simbologia, l’iconografia, l’“immaginario cattolico quasi draculesco”, paganeggiante e connotato da una sorta di minacciosa retroflessione simbolica: e un viaggio del 2023 negli Stati Uniti lungo la storica Route 66 porrà una sorta di suggello immaginale a quell’esperienza pregressa.
Si è accennato al linguaggio scuru, qualcosa che in Labbate erutta in voce e lingua narrativa propria (il visionario, puntuto, apocrifo italo-buterese della sua saga) declinando il referente americano – ma, vorrei dire, la stessa remota eredità gotica settecentesca – in forma postmoderna. Dove il senso di un gioco di specchi – oscuri, ci ricorderebbe Le Fanu – finisce con il dire qualcosa sulla voce e le potenzialità del gotico in quanto tale: che non si consuma nell’horror, neppure trattenendo di tale termine (latino, prima che inglese) la nuda accezione di brivido e compulsione. Il gotico è il linguaggio del nostro specchio umbratile e di identità irriconosciute, del labirinto di un passato che ci portiamo dentro a sperderci (castello interiore, camera da letto infestata e relativi sipari). Un linguaggio che provoca la nostra fantasia fin dalle paure d’infanzia – se vogliamo, dal “La Madonna si muove!” del cardiopalmo bambino nutrito di racconti devoti maldigeriti, ma senz’altro da prima – e fino a nostalgie e malinconie, al non detto e non dicibile del trovarci invecchiati, che visita le insonnie e innerva le tentazioni. Proprio come ne Lo Scuro le confidenze in articulo mortis di Razziddu Buscemi accanto al corpo della donna amata, sul precipizio di una vita, e il riagganciare la sua esperienza di bimbo e la svolta di formazione, e tutte le dualità e contraddizioni conseguenti.
Persino provocatorio – serendipity, serendipity… – è che il Theodore del Castello d’Otranto appartenga alla stirpe siciliana dei signori di Falconara: la sua avventura di formazione (nel buio come tutte le iniziazioni) comporta il recupero di quel lignaggio. Ma anche Razziddu consuma la propria formazione al castello di Falconara, suggestivamente vicino a Butera. Mi conferma Labbate di non aver assolutamente pensato di stabilire un nesso, semplicemente il castello di Falconara sorge nell’area della sua storia. Tout se tient, come nel caso di Walpole che scopre a posteriori che un castello a Otranto esistesse davvero.
Poi, vero che Razziddu in punto di morte commenta: “Rosa non mi ha dato figli. Però li ho sognati. Li abbiamo sognati”, e invece nel seguito Suttaterra un suo figlio lo troviamo, il protagonista Giuseppe. Ennesimo paradosso che conduce al mondo dei sogni e dei morti: e insieme alla letteratura, ai figli letterari, a un teatro in costume come quello del Castello per celebrare pantomime interiori – in particolare quelle dei piani bassi di noi.
E poi (vorrei dire soprattutto) c’è appunto la lingua, magmatica e ipnotica, congrua alle catabasi e alle agnizioni, alle emersioni dal buio e alle iniziazioni infere. Del resto, come spiegava Labbate in un incontro a Torino, la Sicilia delle sue storie e della sua lingua è ancora quella nera dei culti inferi grecosiculi e del ratto di Kore, di gorgoniche entità pagane e di misteri di discesa nell’abisso. Le processioni sono quelle che ricorda lui, anche se – forse per scelta di qualche parroco prudente – l’antica statua del Signore dei Puci dei riti della Passione è stata ormai sostituita da una meno impressionante. Ma il fiato che esala come vapori allucinatori dall’ipotetica fenditura sotto il tripode della Sibilla pitonica è quello antico.
E antichi sono gli echi di questa storia al buio. Come in quella sorta di disperato rito di passaggio in cui Razziddu tenta il suicidio – quello rituale-iniziatico, di corda – e viene salvato dalla propria Arianna in un labirinto scuru anzitutto interiore, come il dedalo tenebroso di Manfred sottostante il castello. E poi ecco una schiera di doppi, figure grottesche o deformate nei fondamentali connotati umani e sociali (il mago, il prete, lo zio piromane, il pazzo Pidocchiuso che balla dietro la macchina delle pompe funebri come nell’inversione mortifera della danza di Davide avanti all’Arca); una Madre Terribile – per Razziddu, la nonna, il cui funerale si svela momento d’agnizione – e un padre dalla sorte inconosciuta come accaduto ai legittimi eredi dell’Otranto walpoliana; una Kore deliziosa dal ruolo salvifico, che gli permette di varcare l’oceano – che, com’è noto, permette lo sbarco alla terra dei morti – dopo un viaggio assai più lungo di quello toccato al genitore.
Leggere Lo Scuru alla luce del manifesto ora premessovi – e che pure sintetizza racconti offerti dall’autore in varie occasioni – è sicuramente illuminante: e l’intera saga di Butera vi trova un’esegesi fondamentale. Se d’altra parte può essere difficile prefigurarsi a quali sviluppi ulteriori condurrà la machina immaginale avviata da Labbate, resta fin d’ora il dato oggettivo di uno sviluppo nuovo, che porta il gotico salutarmente lontano da cortiletti fandom e loro beghe di pollaio per pretendergli pubblicamente una dignità meritata e opportuna.