di Franco Pezzini
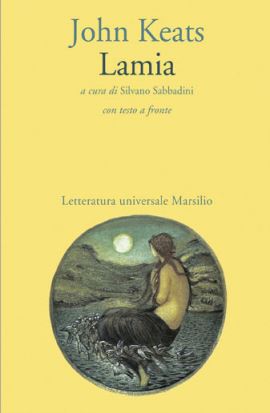 (qui e qui le puntate precedenti)
(qui e qui le puntate precedenti)
Donne-serpente sull’orlo di una crisi di nervi
Mostro-femmina e cacciatore, in particolare, saranno interessati dalle originali soluzioni del poemetto narrativo Lamia di John Keats, scritto nel 1819 e pubblicato nel luglio del ’20, pochi mesi prima della morte del poeta: un’opera di febbrile potenza onirica che sappiamo debitrice di attente letture del dizionario di Lemprière e soprattutto – attesta Keats – del testo a lui caro di Burton. In quest’opera circonfusa di malinconia romantica, l’innominata lamia/strega diviene, semplicemente, Lamia, peraltro molto diversa dall’originale orchessa greca; e “Menippo Licio”, cioè di Licia (almeno in Filostrato), appare presente come Licio di Corinto. Se la complessità dei problemi dell’opera e la sua altissima dignità letteraria non permettono in questa sede che cenni fuggevoli, già un riassunto offre indicazioni interessanti per lo sviluppo che andiamo delineando. La vicenda inizia dunque con l’arrivo a Creta del dio Hermes, bramoso di sedurre una bellissima ninfa locale già desiderata invano da torme di spasimanti semidivini, e che egli stesso non riesce a rintracciare: trova invece un serpente, che lamenta la propria condizione con parole inattese quanto struggenti.
«Potrò mai destarmi da questa tomba coperta di fiori,
muovermi in un morbido corpo adatto alla vita,
all’amore, al piacere, alla calda lotta di cuori
e di bocche! Infelice son io!».
La minuziosa descrizione del serpente rappresenta in qualche modo l’esito estremo del lungo processo di concretizzazione della seduttrice, da demone/spettro a melusina/strega a rettile vero e proprio (per quanto, vedremo, inabitato da un’entità pneumatica); ma insieme ne delinea l’estremo limite di ambiguità ontologica e caratteriale, al di là d’ogni tipizzazione da dizionario mitologico. Di un’ambiguità ontologica, anzitutto, che la qualifica compiutamente per mostro, entità mutante equivoca e sfuggente: se la creatura anguiforme è affamata d’amore e dotata di voce dolcissima, bocca e (plausibilmente) occhi di donna, arriverà addirittura a confidare precedenti esistenze in forma umana.
«Sono già stata donna, e per una volta ancora
vorrei la bella forma femminile d’allora.
Amo un giovane di Corinto – ah, che dolcezza!
Concedimi forma di donna [Give me my woman’s form], la bellezza,
e poi lasciami lì dove lui si trova […]»
Si tratta di versi, nota Silvano Sabbadini,
molto interessanti sia perché suggeriscono una durata temporale di Lamia precedente e, come vedremo, posteriore alla sua storia con Licio, sia perché mettono in crisi la lettura di Lamia semplicemente come serpe mascherata.
“Se Keats potesse avere la certezza di Burton che lei è soltanto un serpente che ha assunto forma di donna, ci basterebbe trapassare con lo sguardo illusioni e finzioni come fenomeni che non fanno altro che nascondere una bruttezza primaria. Ma dal momento che l’esistenza di Lamia come donna precede la sua esistenza come serpe, siamo costretti a chiederci se, dopotutto, lei non è proprio quella forma di bellezza che sembra essere. E tuttavia, poiché dice soltanto d’essere stata donna “once” e non originariamente, la possibilità d’una esistenza precedente come serpe dietro alla sua prima incarnazione umana non è mai del tutto esclusa” [T. Rajan, Dark Interpreter: The Discourse of Romanticism, Ithaca 1980, cit. da Sabbadini].
Sul filo dei versi che più avanti evocheranno le esperienze da lei vissute in spirito “quando, imprigionata dentro il serpente, / ogni cosa desiderava, ricca o sorprendente” si può supporre di ravvisarvi un’entità disincarnata, condannata a risiedere in un corpo di rettile ma periodicamente in grado – per concessione divina, e non per propria forza – di sostituirlo con uno femminile; al punto che forse il nome Lamia, par suggerire il testo, connota la sola identità di donna (semplice pseudonimo, magari già usato in precedenza, o “vero” nome dello spirito?), e non anche la preesistente vita animale. Comunque la creatura conclude con Hermes un accordo giurato, aiutandolo a vincere il sortilegio d’invisibilità della ninfa e ottenendo in cambio la propria – my, dice Lamia – “forma di donna” (intende semplicemente la stessa forma che aveva assunto in passato, o intrinsecamente la sua?): e dopo una drammatica metamorfosi che ne distrugge la bellezza di rettile, la vediamo riapparire col fascinoso sembiante umano nei dintorni di Corinto. Ma, si è detto, ci troviamo anche agli estremi limiti dell’ambiguità caratteriale: e non a caso la critica appare radicalmente divisa tra quanti enfatizzano l’immagine della cruel lady – come Lamia verrà definita nell’ambito della schermaglia per sedurre Licio – e altri che ne sottolineano la sostanziale innocenza (si vedano le diverse interpretazioni di Bate – “innocentista” – e di Evert e Stillinger – “colpevolisti” – citate da Silvano Sabbadini, Introduzione, cit.). Keats presenta la sua eroina come “vergine, con labbra pure, ma nelle cose d’amore / sapiente”, ciò che ben evoca il gioco sottile tra innocenza e disinvoltura che sostanzia la seduzione al di là d’ogni facile stereotipo sulla vamp; e comunque, lungo il filo di tutto il poemetto, non offre certezze sugli esiti ultimi dell’eros di Lamia, eventualmente vampirici o divoranti. Eppure il sentimento trascinante per quel Licio incontrato in spirito, durante le peregrinazioni eteriche dell’avatar-serpente, non permette di assimilare Lamia alla meretrice nera delle antiche favole – e anzi pare difficile che la donna umiliata della Parte II del poemetto, ormai succube dell’amante, intenda davvero mangiarselo. Certo Keats attinge alla mitologia delle lamie divoratrici e la presuppone, ma per poi contrapporre provocatoriamente alla cruel lady della fase seduttoria il maschio “perverso” (perverse) che prova “un piacere voluttuoso al dolore di lei” e impone il matrimonio quale equivoca celebrazione del trofeo erotico. La stessa divisione in dittico dell’opera sembra sottolineare tale dialettica e ribaltamento tra i conduttori del gioco, nel segno di un’innocenza o almeno simpatia e spezzata sofferenza del mostro-femmina, e della sua sottomissione al compiacimento del maschio. Anche se, in realtà, la questione resta aperta: e non potrebbe neppure escludersi l’ipotesi d’un teatro delle crudeltà (come poi certi sviluppi gotici, Carmilla in particolare) nel quale la soavità dolente dell’innamoratissima Lamia si concilî con la prospettiva alimentare ai danni dell’amante, per soccombere in ultimo al fanatismo altrettanto vampirico del vecchio Apollonio. Qualunque interpretazione si scelga, la leggiadria maltrattata della Lamia di Keats finisce con l’enfatizzare per contrasto la brutalità del “cacciante”/cacciatore, molto diverso dal santo filostrateo.
La storia in effetti prosegue con l’avvicinamento del giovane sulla strada fuori città, la sua calcolata seduzione e il ritorno notturno in Corinto: ed è allora che la coppia incrocia un uomo con “barba grigia, ricciuta, occhi pungenti, / il cranio calvo, liscio, passi lenti, / una tunica da filosofo”, da cui Licio non vuol farsi riconoscere e che ispira a Lamia un tremito inquieto.
«Dimmi», disse lui [=Licio], «amore, perché miseramente
tremi, e la tua tenera palma s’imperla di rugiada?»
«Sono stanca», disse la bella Lamia, «e poi quello
chi è, dimmi, quel vecchio?
Nella mente non trovo le sue fattezze.
Oh, Licio, perché ti nascondi al suo mobile sguardo?»
E lui: «È il saggio Apollonio,
la mia guida fidata, un maestro di riguardo,
ma che stanotte a quello spettro rassomiglia
della follia che ai miei dolci sogni s’appiglia».
Certo Lamia finge di abitare a Corinto, e l’affermazione di non ritrovare “Nella mente […] le […] fattezze” di Apollonio può semplicemente significare che non l’ha mai visto; ma un senso ulteriore potrebbe ravvisarsi nell’impenetrabilità della sfera del filosofo alle visioni astrali della seduttrice-serpente, e in ultima analisi a un orizzonte mentale antitetico e irriducibile. Una presenza, comunque, o meglio uno sguardo al quale Lamia trasale (un’angoscia autoconservativa, se non di premonizione) e Licio prova imbarazzo nella nudità delle proprie emozioni e fantasie: ciò che può riecheggiare in nero una diversissima pagina su donne e serpenti, il nascondersi a Dio di Adamo ed Eva consci d’essere nudi (Gn 3,8). Ma a differenza del Dio del Genesi, Apollonio risulta qui il padre (di elezione) equivoco, e ci si può domandare se Keats non avvertisse il paradosso d’una lettera corinzia sull’amore tanto amaramente antitetica a quella paolina del celeberrimo inno di 1 Cor 13, 1-13 – a maggior ragione in un contesto tanto fitto di richiami alla visione, magari negata o confusa quasi in a glass darkly (traduceva re Giacomo e avrebbe ripreso Le Fanu nel titolo della sua raccolta ultima, appunto In a Glass Darkly: nella moderna tradizione interconfessionale in lingua corrente, LDC/ABU 1985, il richiamo è reso: “Ora la nostra visione è confusa, come in un antico specchio”, 1 Cor 13, 12).
In ogni caso il “mobile sguardo” di Apollonio sviluppa un motivo già filostrateo con forza particolare: e sarà l’occhio e lo sguardo, prima ancora della parola che lo suggellerà, il vero motore dell’esorcismo. Al drammatico epilogo conduce in realtà lo stesso Licio, non soddisfatto dell’estasi appartata nel palazzo incantato di Lamia, e voglioso d’imporre lo spettacolo della propria fortuna agli occhi dei conoscenti: e dopo una vana resistenza, la bella amante è piegata alle nozze. Il pericoloso momento di passaggio esistenziale che nelle versioni di Filostrato e Burton appariva desiderato e anzi accelerato della protovampira, ansiosa di porre il sigillo sulla vittima per meglio divorarla, in Keats diviene un evento che Lamia non riesce a evitare: l’occasione minacciosa d’un confronto col mondo esterno che può porre in crisi – e lo farà – lo spazio chiuso dell’incanto, il suo carattere di fragile assoluto. Lamia strappa all’amante solo la promessa di non invitare Apollonio, di tenerla nascosta da lui (“from him keep me hid”), e invano Licio cerca di capirne il motivo; quando però allo sfarzo incantato del palazzo affluiranno a frotte gli invitati, anche il filosofo indesiderato farà la sua comparsa.
Entravano in fretta, stupiti, curiosi, attenti,
tutti tranne uno,
che guardandosi attorno con occhio severo
procedeva a passi lenti, placido e austero.
Era Apollonio: a volte tra sé e sé ridacchiava,
come se qualche problema intricato
che aveva sfidato il suo pensiero paziente
cominciasse ora a sciogliersi, rendendosi patente.
Sì, era proprio come aveva pensato.
Il “problema intricato” (knotty problem) richiama naturalmente la “forma gordiana” (gordian shape) con la quale il serpente innamorato si presentava a Hermes all’inizio del poemetto: un rimando al nodo del re Gordio e alla figura di Alessandro Magno “che, non diversamente da Apollonio, sta a indicare la forza violenta della semplificazione razionalistica contro la ricchezza e la indistinzione del mondo preanalitico” (Silvano Sabbadini). E torna l’occhio, severo ma capace di brillare di compiacimento al risolversi del “problema”, alla conferma del quadro ipotizzato alla luce della fredda ragione – certo sulla natura dello spettacolo nel palazzo e soprattutto di Lamia.
Apollonio affetta di scusarsi con il discepolo per l’autoinvito e Licio incassa spiazzato, ha inizio la festa sontuosa: ma – Keats ci avverte – la ghirlanda adatta ad Apollonio sarebbe piuttosto di gramigna e cardo, considerando come gli incanti dileguino “al semplice tocco della fredda filosofia”, capace di dissacrare i misteri della natura e della fantasia. Dove il richiamo alle armi impoetiche della misurazione, “riga e squadra”, evoca un paradosso che forse l’autore non avrebbe sospettato: mentre cioè l’antico esoterista Apollonio assurge in Lamia a campione di razionalità fanatica, proprio gli strumenti qui emblematici d’un approccio di concretezza al mondo, quelli geometrici e di misura, finiranno in seguito col suggerire all’immaginario del grande pubblico (tramite la volgarizzazione di romanzi e pellicole popolari) un sapore di esoterismo mistico-irrazionalistico dalle radici comunque presettecentesche – si pensi al compasso dell’Anziano di giorni raffigurato da Blake e a tutta un’iconografia massonica e rosicruciana. E proprio guardando a tale spazio simbolico, esteso lungo un vasto arco di esperienze culturali (spesso in opposizione reciproca, come nelle diverse posizioni delle logge massoniche, regolari o di frangia, verso l’occultismo), matureranno varie figure di epigoni di Apollonio, medici psichici come il dottor Taverner o John Silence, pronti a cacciare le nuove lamie con strumenti più magici che razionali.
Il poemetto precipita ormai verso la drammatica conclusione: e ancora una volta è lo sventato Licio a innescare la crisi, quando con un’occhiata al momento del brindisi implora “uno sguardo dal viso rugoso / del suo vecchio maestro”.
Il filosofo calvo, con occhi di doglio
Fissava la bellezza inquieta della sposa,
e senza un batter di ciglia, senza un movimento,
ne intimidiva le belle forme turbandone il dolce orgoglio.
Sembra ora difficile dire chi, tra Lamia e Apollonio, assomigli più a un serpente, in una riproposizione emblematica dell’opposizione tra diversi vampirismi e mostruosità – anzi accentuati nella gelosia del vecchio maschio verso la rapitrice (giovane e donna) dell’allievo. Licio si accorge dello smarrimento di Lamia, la sente gelida, chiede invano se conosca “quell’uomo”, la vede annichilire – e con lei la festa, e persino il mirto emblema dell’amore. Davanti alla compagna ormai priva di coscienza e come inaridita, Licio urla ad Apollonio di chiudere “quegli occhi incantatori”, minacciandolo col castigo della cecità dagli dei:
«[…] per la loro potenza a lungo offesa,
per la tua logica empia e altezzosa,
per le tue magie illecite, le tue bugie lusinghiere.
Guardate, Corinzi, questo fattucchiere dalla barba grigia,
Vedete come, possedute, le sue palpebre senza ciglia
si distendono attorno ai suoi occhi diabolici! guardate!
La mia dolce sposa avvizzisce sotto la loro potenza».
«Pazzo!» disse il sofista, a voce bassa, rauco nello sdegno.
Gli risponde con un gemito di morte, Licio,
mentre colpito al cuore e perduto
cade supino accanto allo spettro dolorante.
«Pazzo! Pazzo!», ripeté il vecchio cavilloso,
ma lo sguardo restava implacabile, cocciuto.
«Da ogni male della vita t’ho sino a oggi preservato,
e dovrei vederti preda d’un serpente? »
Esalò Lamia l’alito della morte.
L’occhio del sofista come una lancia acuta
La trafisse, affilato, crudele, pungente.
Lei, per quanto la debole mano un intento
Potesse accennare, gli fece cenno di tacere;
inutilmente, che lui la guardava fisso,
la fissava continuamente. – No!
«Un serpente!» ripeté, e la parola non era finita
che con un grido orrendo Lamia era svanita.
E a Licio stroncato dal dolore sarà infine sudario il manto nuziale. La scena, di straordinaria potenza drammatica, incalza con paradossi furiosi: il fanatico razionalista Apollonio si trasmuta, nelle accuse sconvolte di Licio, in uno stregone (si potrebbe persino pensare, in via virtuale, che Keats giochi a costruire così l’icona dell’Apollonio mago); il giovane “salvato” muore proprio a causa del salvataggio; l’immagine classica della teratomachia, con la lancia di san Giorgio che trafigge il drago-serpente, si ripropone in esplicita, paradossale metafora tra l’occhio del vecchio e una creatura probabilmente innocua. Certo la rivelazione che Lamia sia solo un serpente appare banalizzante, cioè non coglie né lo specifico d’una situazione originaria, né la dinamica del rapporto tra Lamia-donna e il suo uomo; ma insieme è derealizzante, cioè nega Lamia nella sua individualità (legata al nome proprio usato da Keats e da Licio) per rigettarla alla deriva d’un generico nome di specie, in un sostanziale ed effettivo annichilimento. La parola, peraltro, fa collassare nel drammatico esito un esorcismo anzitutto visivo: e ritroveremo quell’occhio implacabilmente indagatore (anche se raramente in forme tanto estreme) tra i successori di Apollonio, tesi a smascherare e fare autopsia dei mostri via via incontrati. La costellazione ottica del mito gorgonico si ripropone così quale sguardo entro lo specchio oscuro delle proprie categorie asfittiche, che vanifica pericoli e ricchezze dell’incontro fascinatorio in una visione brutale e parziale – come quella che appiattisce il mistero dell’amante incantata a mero nome zoologico di specie, e disattiva l’oggettivo rischio (ma anche le possibilità e la bellezza) del rapporto tra Licio e Lamia nel segno dell’aridità esistenziale e ideologica. Ed è proprio l’intervento brutale di Apollonio a strappare al lettore la possibilità di sapere se Lamia sia davvero pericolosa, ma anche – in radice – a rendere impossibile uno sviluppo del rapporto tra i protagonisti, in senso distruttivo o invece vitale.
Non è del resto un caso che il contrapporsi tra “immaginazione” e “realtà” – o, in termini moderni, tra istanze dell’individuo e società – intessuto nel testo keatsiano abbia spesso conosciuto letture critiche fuorvianti:
schiacciare il poemetto Lamia sul personaggio Lamia, e identificare l’illusione di Licio con quella di Keats, costruendole come illusioni soggettive di contro a un reale “pubblico” e oggettivo, non farebbe che raddoppiare l’errore di Apollonio nel corso del poemetto stesso, ossia schiacciare Lamia su una qualsiasi lamia, e cioè non rendersi conto che anche un’illusione privata è sempre e comunque prodotta da e all’interno di una realtà sociale, e deve quindi essere letta all’interno di un sistema a forze concentriche e non opposte. La spiegazione del poemetto non potrà allora consistere nel riproporre le sue antitesi, come troppo spesso è avvenuto nella sua ricezione critica, semplicemente schierandosi per una di esse, per la poesia o l’immaginazione contro la realtà, o, al contrario, riducendolo a una «denuncia pessimista dei pericoli del sogno, dei sovrainvestimenti nell’illusorio, e della impossibilità di una fuga dalle realtà della condizione umana», ma nel cercare di capire il meccanismo che le ha costituite in una opposizione che entrambe le tiene: Hermes, Licio, Apollonio, e, paradossalmente, Lamia stessa, non rappresentano scelte e posizioni alternative, ma un unico meccanismo sociale astrattivo che, progressivamente realizzandosi, nel doppio senso di un processo verso la realtà ma anche verso la sua feticizzazione, trasformano una potenzialità mitica e innominabile in una singolarità povera ed empiricamente tangibile con il nome comune di “serpente”, seguendo quella stessa logica che ha trasformato ogni Valore in “borsa valori”: che la massima comprensibilità e circolarità del nome, “comune” appunto, coincida con la sparizione delle soggettività individuali messe in campo, la dice lunga sui processi di maturazione e di educazione alla realtà evocati da tanta critica apologetica del “reale”.
[Silvano Sabbadini, Introduzione, cit. Per la citazione riportata («denuncia pessimista dei pericoli del sogno […]»), cfr. J. Stillinger, The Hoodwinking of Madeline and Other Essays on Keats’s Poems, Urbana 1971.]
In effetti la corrispondenza di Keats nel periodo di composizione dell’opera testimonia un’acuta attenzione al tema della trasformazione dell’arte in produzione artistica, e alla connessa dinamica tra scrittore e mercato – in relazione a una più ampia riflessione sull’autonomia dell’arte nel mondo uscito dalla rivoluzione industriale.
Dietro la superficiale affermazione che i grandi romance keatsiani del 1819 mettano in scena l’opposizione tra illusione e realtà, sta di fatto l’illusione critica, ben più inconsapevole delle “illusioni” keatsiane, che l’equazione tutta storica e borghese tra letteratura e falsità come regno del soggettivo-illusorio, contrapposte a una realtà-fattualità come mondo dell’oggettività, sia un dato naturale, un principio, appunto, di realtà cui sarebbe maturo sacrificare ogni principio del piacere. Ma in Keats, molto più problematico dei suoi critici, la trasformazione borghese dell’immaginazione in fantastico, del creativo in fittizio, è problema politico per eccellenza, in quanto metafora della trasformazione di tutti i rapporti umani in rapporti mercantili.
[Silvano Sabbadini, Introduzione, cit.]
E proprio la logica commerciale dell’economia dei desideri – i reciproci favori di Hermes e Lamia, i “desideri triangolari” di Hermes per la ninfa (bramata da Satiri e Tritoni) e di Licio per Lamia (da ostentare come trofeo) – conduce allo svuotamento finale. Dall’iniziale, insoddisfatta indifferenziazione di serpente/donna, la Mutante diviene donna concreta, poi oggetto feticistico e quindi (violentata dalla banalizzazione astrattiva di Apollonio) nudo nome comune, “serpente”, senza che la progressiva definizione comporti arricchimenti nel segno della fecondità esistenziale o della comprensione della realtà – e al contrario, il culmine della sequenza vede Lamia svanire, letteralmente cancellata.
Una volta trasformato in oggetto, feticizzato e usato come mezzo di scambio, ogni personaggio, secondo una necessità narrativa fortissima, passa questa maledizione astrattiva a un altro, secondo una socializzazione che non fa nessuna differenza tra dei, ninfe, umani e filosofi, sino alla massima astrazione finale, quella di Apollonio, che per riavere Licio lo riduce a una spoglia nel medesimo istante in cui trasforma Lamia e Lamia a “una lamia”, e cioè poemetto e personaggio a un semplice inganno semantico.
[Silvano Sabbadini, Introduzione, cit.]
Come nel mondo economico il richiamo alla concretezza trascina (al tempo di Keats o a maggior ragione oggi) alle astrazioni del denaro e della finanza, così la mozione al buon senso e alla realtà concreta segna la banalizzazione e anzi il dileguamento delle diverse soggettività nella deriva astratta di generici nomi e categorie. La Corinto della concretezza, gli abitanti e lo stesso Apollonio si svelano del resto fin dall’inizio almeno altrettanto onirici e persino più spettrali della Mutante e del palazzo incantato, in una prefigurazione di rara lucidità della nostra civiltà di fantasmi finanziari ed ectoplasmi mediatici. Il gioco di sentimenti e sogni inscenato in Lamia appare in sostanza un encausto amaro sullo spazio concesso all’immaginario all’interno delle società industriali: dove la crisi delle illusioni (con la paradossale, ironica scelta del genere romance, tipicamente associato al mondo dell’immaginario, per sceneggiare la crisi del medesimo) non conduce alla “realtà”, al trionfo dell’umano sul sogno, ma a una sconfitta generale e a un panorama di vuoti e nude spoglie. “Lamia, insomma, è il sogno erotico di una città commerciale; non la sua antitesi, ma piuttosto il suo compimento” (ivi): dove il poeta svela non solo i procedimenti di costruzione dell’oggetto erotico/estetico, ma il fatto che tale modalità sia la medesima che per qualunque altra merce, “cosicché il fantastico non s’opporrà più al mercato, ma ne diverrà uno dei prodotti principali” (ivi). Ciò che pare almeno interessante per la comprensione di molte contrapposizioni e teratomachie celebrate sul palcoscenico dell’immaginario contemporaneo.
La bella seduttrice, dunque, svanisce – e dal testo di Keats non è chiaro se possa sopravvivere in qualche altra forma, pneumatica o animale. Difficilmente col suo nome proprio, in apparenza legato all’aspetto umano e con esso imploso: eppure nell’eco di tale notissimo precedente letterario e insieme dello stereotipo velenoso e rapace della donna-serpente, le lamie torneranno con frequenza nell’arte (si pensi ai vittoriani come John William Waterhouse, col suo Lamia del 1905) e nella letteratura fantastica per serrati confronti coi cacciatori, spesso (non sempre) maschi. Se in effetti nel febbricitante romanzo di Bram Stoker The Lair of the White Worm, 1911, la fatale Lady Arabella March si trasmuta in una creatura anguiforme imparentata ai draghi, la rilettura del personaggio nel film omonimo di Ken Russell, 1988, la apparenterà proprio alle lamie con venature vampiriche: interpretata da Amanda Donohoe, asservita a un grande serpente-idolo e talora adorna di attributi ermafroditi come l’arcaica orchessa greca, verrà addirittura incantata con una musica orientale per serpenti, prima dello scontro presso la tana, della grande esplosione mutuata dal romanzo e del beffardo finale aperto. Dove il collegamento – più tenue in Stoker, marcato in Russell – tra le due triadi san Giorgio/drago/principessa e Apollonio/Lamia/discepolo, vede la distruzione del “verme” non più col classico fuoco purificatore, ma con il moderno esplosivo – capace di dissolvere poco meno d’uno scongiuro. Per altri avatar della seduttrice anguiforme, si rammenti The End of the Story, 1930, di Clark Ashton Smith, il grande autodidatta epigono di tutta una dinastia di visionari attivi in California (fu discepolo di George Sterling, oggi meno noto ma al tempo figura centrale di una vivace Boemia letteraria californiana, come questi lo era stato di Ambrose Bierce) che seppe giocare una raffinata sensibilità simbolista nei fasti della letteratura popolare e fu uno dei cosiddetti tre moschettieri della leggendaria rivista “Weird Tales”: certo memore dell’esorcismo della Clarimonde di Gautier (sulla quale torneremo), il racconto vede la bella lamia Nicea fuggire innanzi all’aspersorio del priore Hilaire, ma illesa e pronta a riaccogliere l’amante-vittima Christophe (“Essa è antica come il paganesimo e già i greci la conoscevano; fu esorcizzata da Apollonio di Tyana e se tu potessi vederla come realmente è, vedresti, al posto del suo magnifico corpo, le spire di un immondo e mostruoso rettile”, avverte invano il priore). Libere eco della seduttrice riemergeranno in The Stress of her Regard, di Tim Powers, 1989, che inscena suggestivamente gli incontri di Byron, Shelley e Keats con la belle dame sans merci, pericolosa musa dei poeti; mentre in Circus of the Damned di Laurell K. Hamilton, 1995, a confrontarsi con l’ambigua donna-serpente Melanie è un epigono femmina di Apollonio, cioè l’ammazzavampiri Anita Blake nel corso di un complicato conflitto tra leader non-morti. Laddove poi The Journal of Professor Abraham Van Helsing di Allen Conrad Kupfer, 2004, giunge a identificare nell’inquietante Malia/Lamia l’antica seduttrice mesopotamica Lilith o Lilitu che, inviata dai Turchi, avrebbe infettato Dracula, siamo ormai arrivati al cuore simbolico della moderna caccia al mostro.
(3-continua)



