di Paolo Lago
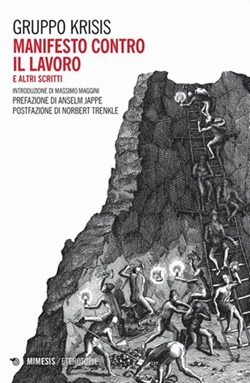 Gruppo Krisis, Manifesto contro il lavoro e altri scritti, introduzione di M. Maggini, prefazione di A. Jappe, postfazione di N. Trenkle, Mimesis, Milano-Udine, 2023, pp. 164, euro 16,00.
Gruppo Krisis, Manifesto contro il lavoro e altri scritti, introduzione di M. Maggini, prefazione di A. Jappe, postfazione di N. Trenkle, Mimesis, Milano-Udine, 2023, pp. 164, euro 16,00.
È sicuramente un’esperienza interessante rileggere oggi il Manifesto contro il lavoro (Manifest gegen die Arbeit) del Gruppo Krisis, uscito in Germania nel 1999 e tradotto per la prima volta in italiano nel 2003 per DeriveApprodi1. Come ci informa Massimo Maggini nell’introduzione di questa nuova edizione uscita per i tipi di Mimesis, il Manifest ebbe in Germania altre tre edizioni, la seconda già nel settembre del 1999, la terza nell’ottobre del 2004 e la quarta ed ultima nel 2019. Le teorie esposte nel Manifest appartengono alla corrente di pensiero chiamata Wertkritik, cioè “Critica del Valore”, secondo la quale la crisi che sta investendo il sistema del capitale è irreversibile ed è determinata proprio dalla crisi del lavoro, provocata a sua volta dalle varie ‘evoluzioni’ che esso stesso ha subito nel tentativo di aumentare e rendere migliori le sue applicazioni tecnico-scientifiche. Ciliegina sulla torta è stata la “rivoluzione micro-elettronica”, che ha espulso e reso inutili enorme masse di forza lavoro umana, ormai improduttive dal punto di vista della valorizzazione capitalistica. Naturalmente, come ricorda anche l’autore dell’introduzione, il lavoro che attaccano gli studiosi della “Critica del Valore” non è tanto l’operare umano in sé quanto invece quello che Marx definisce “lavoro astratto”, non finalizzato al benessere degli individui ma all’aumento del profitto e all’accumulazione monetaria in vista di nuovi investimenti.
Gli autori del Manifesto sono tre fra gli studiosi di spicco del Gruppo Krisis: Robert Kurz, Norbert Trenkle e Ernst Lohoff. La presente edizione2 ripropone, insieme al Manifesto, dei saggi significativi di questi studiosi (ai quali si aggiunge un saggio di Anselm Jappe) già presenti nella traduzione italiana del 2003. In più, adesso possiamo leggere un nuovo testo di Norbert Trenkle, Il manifesto contro il lavoro vent’anni dopo che fungeva da postfazione alla quarta edizione tedesca, un’intervista a Robert Kurz in occasione dell’uscita del suo importante saggio Libro nero del capitalismo, un altro scritto di Norbert Trenkle dal titolo Rottura qualitativa. Sull’attualità della critica del lavoro, uscito nel 2022, e, infine, Il duplice Marx di Robert Kurz, uscito in occasione dei centocinquanta anni dall’apparizione del Manifesto del Partito Comunista. Come possiamo vedere, l’attuale edizione è corredata di numerosi altri testi che integrano e chiosano in modo sicuramente interessante le teorie espresse nel Manifesto. Ma che senso ha rileggere oggi il Manifesto contro il lavoro? E, soprattutto – possiamo chiederci – è sempre attuale? La risposta è sì, senza dubbio, nonostante gli anni siano passati e la situazione sia nettamente cambiata rispetto al 1999. Una rilettura del Manifesto, oggi, va indubbiamente caricata di senso nuovo perché le pagine degli studiosi del Gruppo Krisis hanno ancora tanto da dire e possono diventare delle fondamentali chiavi di lettura per comprendere la contemporaneità.
A mio avviso, tra gli snodi fondamentali della società odierna di cui la stesura del 1999 non ha potuto tenere conto, rientrano la sempre più pervasiva digitalizzazione di massa, la diffusione dell’intelligenza artificiale e gli inediti risvolti sociali e lavorativi, con l’affermazione del cosiddetto smart working, che sono emersi dal truce periodo dell’emergenza Covid. Nel primo capitolo del Manifesto, intitolato Il dominio del lavoro morto, il Gruppo Krisis scrive che “proprio nel momento della sua morte, il lavoro getta la maschera e si rivela come una potenza totalitaria, che non tollera nessun altro dio al di fuori di sé. Il lavoro determina il modo di pensare e di agire fin nelle minime pieghe della vita quotidiana e nei più intimi recessi della psiche”. Ebbene, queste osservazioni sono più che mai attuali anche alla luce della contemporaneità più stringente. Più che mai, oggi, con l’affermazione dell’intelligenza artificiale, dei sistemi di controllo digitali e dello smart working, il lavoro è diventato una “potenza totalitaria che non tollera nessun altro dio all’infuori di sé”. Infatti, come nota Gioacchino Toni nel suo saggio Pratiche e immaginari di sorveglianza digitale, a partire dal 2011 si inizia a parlare di “Industria 4.0”, espressione probabilmente introdotta dall’azienda tedesca Bosch, che indica una nuova, iperconnessa, modalità organizzativa della produzione. Come scrive lo studioso, “dalla fusione tra il mondo reale / fisico degli impianti e quello virtuale / digitale dell’informazione scaturisce un sistema misto cyber-fisico finalizzato, ad esempio, a ridurre gli sprechi, a raccogliere informazioni dal processo lavorativo rielaborandole in tempo reale, anticipare errori e malfunzionamenti attraverso la virtualizzazione dell’azienda, sfruttare al massimo la creatività del lavoratore e incorporare le richieste del cliente nel corso del processo produttivo”3. Nelle “smartificazioni” che avvolgono la società contemporanea (e che nel 1999 sarebbero sembrate frutto di una fantascienza distopica), il lavoro emerge veramente come un idolo totalitario e assoluto, in quanto la diffusione della digitalizzazione è spesso finalizzata al miglioramento della produttività capitalistica e al controllo coercitivo dei lavoratori.
Con lo smart working, questa “potenza totalitaria” penetra persino nella sfera domestica e privata degli individui, in quella “sfera astrattamente privata”, come leggiamo nel Manifesto. Quella “sfera separata dalla vita”, quella cioè dedicata al lavoro, dove, secondo il Gruppo Krisis, “il tempo cessa di essere vissuto”, con i processi di digitalizzazione si unisce e si ibrida con i momenti e gli spazi che dovrebbero essere dedicati, invece, alla “cura di sé” in senso foucaultiano, ad un arricchimento interiore. Non esiste più una “sfera astrattamente pubblica”, dedicata al lavoro, e una “sfera astrattamente privata”, dedicata al “tempo libero” (altra faccia del dominio del lavoro): esse finiscono per ibridarsi in un nuovo, teratologico spazio-tempo. L’individuo dell’epoca del Covid, costretto a stare chiuso in casa e a consumare il suo divertimento sulle piattaforme digitali mangiando cibi più o meno esotici consegnati da rider sottopagati, e lavorando in un altro angolo del soggiorno al suo PC, non appare più “scisso” come scrive il Manifesto. È invece un essere ibrido, meccanizzato, totalmente alienato, un ‘mostro’ che non si era mai incontrato prima d’ora nella storia sociale. D’altra parte, in un altro punto, sembra che il Manifesto preconizzi l’arrivo dell’intelligenza artificiale come uno strumento liberatorio dal giogo del lavoro: “Perché passare tante ore, giorno dopo giorno, nei capannoni delle fabbriche e negli uffici, se robot di ogni tipo possono risparmiarci la maggior parte di queste attività? Perché far sudare centinaia di corpi umani, se bastano alcune trebbiatrici? Perché sprecare energie in compiti di routine che un computer può tranquillamente eseguire?”. Potrebbe apparire una visione sostanzialmente ingenua, del tipo “affidiamo a robot e ‘androidi’ i lavori più pesanti, come nei film Metropolis e Blade Runner”; eppure, come scrive Anselm Jappe nella Prefazione, “la prospettiva del Manifesto in generale non è di certo quella di aspettare un paradiso tecnologico dove le macchine lavorano al nostro posto e noi umani ci possiamo limitare a guardarle”.
Risulta assai interessante e denso di echi negli anni più recenti anche il capitolo 9, intitolato La sanguinosa storia dell’affermazione del lavoro, in cui leggiamo che “non furono i pacifici mercanti sulle antiche vie del commercio i precursori della moderna borghesia, che in fin dei conti fu l’erede dell’assolutismo. Furono piuttosto i «condottieri» dei soldati di ventura agli inizi dell’era moderna, i direttori delle case di lavoro, gli esattori, i sorveglianti di schiavi e altri tagliagole a costituire un fertile terreno sociale per l’«imprenditoria» moderna”. Le guerre di oggi che rimbalzano pervasivamente sui media come tragici sfondi della nostra quotidianità, come ferite lancinanti e presenti, sono quelle portate avanti dal capitale e dalla società del lavoro e, al posto dei condottieri di soldati di ventura e di sovrani sanguinari, ci sono truci fantocci della società capitalistica come i vari Biden, Zelensky, Putin e Netanyahu. E, per fare ancora un riferimento all’emergenza Covid del 2020, mentre innumerevoli lavoratori erano costretti a stare chiusi in casa e a lavorare tramite lo smart working, altrettanti erano invece costretti a andare a lavorare in fabbrica rischiando la vita, mentre i rider erano mandati a solcare le strade deserte per portare le vivande a domicilio come i corrieri della serie tv sudcoreana Black Knight, costretti a muoversi in un ambiente distopico devastato e inquinato per non far rallentare la produzione. Come ha notato Sandro Moiso in un articolo scritto ‘a caldo’ in quel periodo, “le aree industriali d’Italia si stanno trasformando in autentici lager che, esattamente come quelli a cielo aperto in Palestina, non hanno nulla da invidiare o da rimproverare a quelli nazisti”4. Il lavoro continua la sua “sanguinosa affermazione” anche nell’epoca dell’Industria 4.0.
Un altro capitolo del Manifesto che possiede una tragica risonanza contemporanea, soprattutto in Italia, è anche quello intitolato Il lavoro è dominio patriarcale. È infatti la società del lavoro a creare e ad accentuare la sfera separata dal lavoro stesso, quella intima e famigliare, alla cui custodia è assegnata la donna: “Non a caso, l’immagine della donna come essere naturale e istintivo, irrazionale ed emotivo è diventata un pregiudizio universale insieme a quello del maschio lavoratore e creatore di cultura, razionale e padrone di sé”. Soprattutto in Italia perché, recentemente, troppo spesso si sono verificati femminicidi, figli di una cultura patriarcale difficilmente sradicabile, una cultura che si perde nei meandri più oscuri della mentalità maschile e maschilista del “Belpaese”. L’Italia appare un paese fondamentalmente patriarcale, in cui non si risparmiano neppure episodi di razzismo. Altro che “primato civile degli italiani” rispetto all’obbligo di lavorare, come scrive Jappe facendo riferimento ad un’immagine macchiettistica del napoletano o al ladro de I soliti ignoti (immagini stereotipate magari filtrate da uno sguardo prettamente tedesco). In Italia, come negli anni Novanta c’era soltanto la scelta fra D’Alema e Berlusconi (come leggiamo nel Manifesto, perché la democrazia impone scelte non libere ma solo “fra la peste e il colera”), adesso c’è soltanto la scelta fra Schlein e Meloni e la maggioranza degli italiani sembra propendere per la seconda e per i suoi accoliti.
Infine, un altro aspetto interessante messo in rilievo dal testo del Gruppo Krisis, pure se fugacemente, riguarda l’educazione e la scuola, ormai totalmente asservite, anche più che nel 1999 e nel 2003, alla società del lavoro e del capitale. La sfera educativa che riguarda il rapporto con bambini e adolescenti viene introiettata nelle dinamiche aziendali più becere e ciniche, a cominciare dalla cosiddetta alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), introdotta in Italia dalla riforma Moratti nel 2003. Non è un caso che tutti i recenti governi (Renzi, Draghi ecc. ecc.) abbiano incentivato le scuole tecniche e promosso percorsi di avviamento al mondo del lavoro. Sulla stessa linea – inutile dirlo – si sta muovendo il governo Meloni. Nelle linee guida di questi governi in fatto di educazione si leggono frasi e parole agghiaccianti come “lavoratori qualificati”, “capitale umano”, “crescita economica” mentre schiere di consulenti digitali del Miur invitavano a “stalkerare gli studenti” che erano restii a seguire la famigerata didattica a distanza durante l’emergenza Covid. Il Manifesto, rifiutando la sfera alienata ed alienante del valore capitalistico, persegue quindi rapporti più autentici fra gli esseri umani, sia in fatto di educazione che di interazione sociale, ponendosi abbastanza vicino, in questo, a certe istanze portate avanti dai situazionisti (pensiamo all’Avviso agli studenti di Raoul Vaneigem). Come scrive Norbert Trenkle in Rottura qualitativa, “vogliamo riappropriarci del tempo di vita e delle risorse che il capitale ci sottrae in modo permanente e che trasforma in mezzi di distruzione del mondo. Solo così potremo riuscire ad aprire gli spazi per un modo di produzione e di vita che si basi sull’attività libera e autodeterminata, sulla cooperazione e sulla solidarietà”. Probabilmente, una pecca che possiamo imputare al nostro testo è quella di non chiarire fino in fondo come si delineerà questa “vita che si basi sull’attività libera e autodeterminata” ma le basi critiche restano in ogni caso solide e interessanti.
E comunque, anche da questo necessariamente rapido excursus possiamo comprendere che rileggere oggi il Manifesto contro il lavoro può offrirci – come già notato – tante chiavi di lettura per capire più a fondo la contemporaneità, per creare inediti ed inaspettati cortocircuiti. Ecco che allora il testo del Gruppo Krisis si può trasformare in una sorprendente “cassetta degli attrezzi” per muoverci criticamente nel nostro tempo. Da quel 1999, lembo estremo d’un altro millennio, grazie alla sua capacità già allora di guardare lontano, il Manifesto oggi ha ancora molto da dire.
Cfr. Gruppo Krisis, Manifesto contro il lavoro, trad. it. di S. Cerea, DeriveApprodi, Roma, 2003. ↩
Con le traduzioni dal tedesco di G. Rossi, S. Cerea, A. Jappe e M. Maggini. ↩
G. Toni, Pratiche e immaginari di sorveglianza digitale, Il Galeone, Roma, 2022, p. 137. ↩
S. Moiso, Le città verranno distrutte all’alba, in L’epidemia delle emergenze. Contagio, immaginario, conflitto, a cura di J. Orlando e S. Moiso, Il Galeone, Roma, 2020, p. 40. ↩



