di Paolo Lago
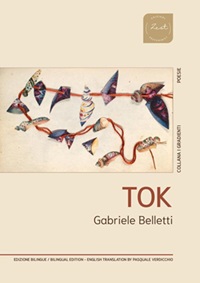 Gabriele Belletti, Tok, Zest Edizioni sostenibili, 2023, pp. 159, euro 14,00.
Gabriele Belletti, Tok, Zest Edizioni sostenibili, 2023, pp. 159, euro 14,00.
Il poemetto Tok di Gabriele Belletti (che si presenta, grazie alla traduzione inglese di Pasquale Verdicchio, in una versione bilingue) è il primo volume che esce per “Zest edizioni sostenibili”, un marchio guidato da Antonia Santopietro la quale da diversi anni porta avanti, col sito “Zest Letteratura sostenibile”, da lei curato, un progetto di studio e di analisi delle tematiche ambientali ed ecologiche applicate alla letteratura. Tok è infatti un’opera in cui tali tematiche rivestono un’importanza fondamentale, fin dal titolo. Come leggiamo in una nota dell’autore, la parola “tok”, per i Kaluli, indigeni della Papua Nuova Guinea, significa “sentiero”, “accesso” fino ad assumere il senso più esteso di “mappa”. Un sentiero che può rappresentare una via di salvezza per la società contemporanea, rappresa nelle dinamiche di una quotidianità basata su ripetitivi rituali imposti dal capitale e in cui gli individui trascorrono la propria esistenza in “altissimi palazzi” non conoscendo nulla della dimensione del “fuori”. Una società in cui “le proiezioni delle cose / sono diventate le cose” e in cui “si vive / di pulsanti / e contatori”. Dentro “l’appartamento parco” è rinchiuso anche il bambino che “non sa ancora” che in una dimensione lontana “già lo attende / una foresta”. Il poemetto racconta infatti il viaggio di uscita di un bambino dalla “Città-mondo”, un ambiente fatto di cemento, verso l’universo della foresta, in cui la natura pare magicamente essere sopravvissuta agli scempi della società capitalistica che, come un abulico zombie, non fa altro che devastare qualsiasi elemento naturale – alberi, piante, prati e animali – che ostacola la sua meccanica e cinica crescita.
I primi momenti del poemetto mettono in scena un universo fatto di palazzoni, cemento, apparenze, un vero e proprio “carcere della terrestrità” – per utilizzare il titolo di una bella raccolta di poesie di Francesca Fiorentin del 2021, alcune delle quali rappresentano questo stesso mondo alienato1 – dal quale si deve ‘evadere’ per ritrovare finalmente la dimensione del “fuori”. Non è un caso che Gabriele Belletti scelga un bambino come alfiere di questa possibile liberazione: chi, infatti, meglio di lui, può muovere verso una nuova e libera rinascita? D’altra parte, si può ricordare anche come la figura del bambino rappresenti, in diversa narrativa ecodistopica italiana contemporanea, l’incarnazione di una possibilità di salvezza e rinascita. Si può pensare, allora, a Bambini bonsai (2010) di Paolo Zanotti, in cui in una Genova del futuro, connotata dal cambiamento climatico e da una cementificazione senza precedenti, sono proprio i bambini, nel momento in cui gli adulti si rinchiudono in casa impauriti dalla “stagione delle piogge”, ad uscire per esplorare il mondo cercando una via di fuga dalla devastazione. Ricordiamo anche Anna (2015) di Niccolò Ammaniti, in cui a muovere verso il “fuori”, sfidando le distruzioni provocate da un’epidemia che uccide solo gli adulti, sono Anna e il suo fratellino Astor o il più recente racconto dal titolo La fiaba di Miriam, inserito nella raccolta Quando qui sarà tornato il mare (2020) del collettivo Moira Dal Sito, in cui la piccola Miriam riesce ad incontrare un lembo di territorio sopravvissuto a un disastro ambientale ed esistenziale.
Anche in Tok è presente una diffusa deriva esistenziale e la figura del bambino può quindi incarnare un frammento di resistenza che potrebbe estendersi ed allargarsi. Non per la sua ‘innocenza’ – credo – ma, anzi, per la sua maggiore consapevolezza e sensibilità. Donna Haraway, nel saggio Chtulucene. Sopravvivere su un mondo infetto, affida proprio a una generazione di “bambine del Compost”, le “Camille”, la possibilità di una rinascita anche esistenziale e culturale. Secondo la studiosa, è necessario generare continue connessioni e “parentele” per poter continuare a sopravvivere su un pianeta infestato dalla spinta distruttiva del “Capitalocene”2. Anche nella raccolta di Belletti è possibile incontrare un’aspirazione a una nuova “interconnessione” tra esseri viventi. Come scrive Pasquale Verdicchio nell’introduzione (un’altra introduzione al testo è firmata da Serenella Iovino), “Tok suggerisce che la guarigione può dipendere dalla ricerca o dall’elaborazione di un «linguaggio» comune, un percorso comune che poggia sulla conoscenza dell’interconnessione di tutti gli esseri, il riconoscimento di ciò che Thich Nhat Hanh ha chiamato «interbeing» («inter-essere»)”. Il bambino inizia quindi la sua erranza verso il “verde partigiano”, verso la possibilità di una “rivoluzione”, per poter raggiungere una nuova forma di connessione con gli altri esseri viventi, animali e vegetali. Raggiunge il bosco e “un maestoso vegetale / in mezzo al bosco / è il punto cardinale. / La sua chioma è madre / di un’ombra espansa / – una timida corona. Un’isola piena / di aria antica”. Il grande albero è significativamente definito “isola piena di aria antica” come se si trattasse, proprio come un’isola, di uno spazio nettamente separato da tutto ciò che lo circonda. In esso c’è un’“aria antica”, un’atmosfera che rimanda ad un mondo precedente alle devastazioni contemporanee. Dall’albero si leva il canto di un uccello e, sembra, proprio grazie ad esso si crea una nuova interconnessione fra le creature (“Trasporta una canzone / – fa quello che si deve – unisce le creature / le fa ascoltare insieme”): alberi grandi come isole, sulla cui canopia si poteva incontrare un affascinante mondo sconosciuto, ce li aveva raccontati anche Richard Powers nel suo romanzo Il sussurro del mondo (The Overstory, 2019). Alberi che erano capaci di entrare in connessione fra di loro e parlarsi, in una eterna e continua lotta di resistenza. Da una parte c’è la spazialità della foresta, fatta di alberi in connessione e sinergia fra di loro, dall’altra, invece, lo spazio cementificato della città, in cui si elevano i palazzi che rappresentano il trionfo dell’individualità e dell’individualismo, ‘carceri’ nelle quali si trascorre la vita in preda alla solitudine e all’alienazione.
Il viaggio del bambino è scandito da un incedere ritmico e sonoro che Belletti rende con sicura maestria ricalcando la sintassi lenta e spezzata tipica delle canzoni popolari: “Il ritmo è già nel cuore / – distillato – / pulsa e ripete / il suo semplice dettato. – Torna al luogo / dove il colore è colore / dove il pavimento è prato”. Le pause, le anafore, lo stile cantilenante conferiscono al testo un andamento da racconto popolare che ci può far venire in mente i versi di Peter Handke dal titolo Elogio dell’infanzia (connotati dall’intercalare “quando il bambino era bambino”) che Wim Wenders ha inserito nel suo film Il cielo sopra Berlino (Der Himmel über Berlin, 1987). Il movimento di erranza del bambino protagonista di Tok si srotola in un universo devastato, in cui la distopia sembra appartenere già al presente: “Fuori / il bambino sùbito si perde / – tra scheletri di paesaggi scomparsi, / mutili fossili / di fuggiti passi. / Vaga / tra cumuli di polveri / di scordate epoche”. Al pari dei “bambini bonsai” di Zanotti, di Anna di Ammaniti, del ragazzino che insieme al padre percorre le strade post-apocalittiche degli Stati Uniti in La strada (The Road, 2006) di Cormac McCarthy, si trova inserito in un universo di devastazione. Lo scenario eco-distopico e post-apocalittico descritto da Belletti è però già qui, è la nostra contemporaneità devastata dal tecnocapitalismo avanzato. Forse non ce ne siamo nemmeno accorti, ma la distopia la stiamo già vivendo. La dimensione post-apocalittica che avvolge il poemetto è stata rilevata anche da Serenella Iovino nella sua introduzione: la studiosa scrive infatti che “un diluvio c’è già stato. Un diluvio di cemento e dimenticanza, di lontananza e solitudine” forse riferendosi al “diluvio” (cioè, fuor di metafora, una pandemia globale) che ha devastato la società del futuro raccontata da Margaret Atwood in L’anno del diluvio (The Year of the Flood, 2009). Gli spazi verdi ormai ricoperti di cemento, dove si vive lontani e in solitudine, è già una dimensione post-apocalittica che tutti abbiamo sotto gli occhi nella nostra contemporaneità.
Nella seconda parte della raccolta, intitolata Cantica dei cerchi, sono gli stessi alberi a prendere la parola. Uno di essi dice che “dell’antico prato / avevano fatto un parcheggio. / Mi avevano graziato / per essere albero / prediletto / di un poeta morto ammazzato”. Insieme ad altri alberi superstiti – afferma – “scambiavamo / il nostro ricordo paesaggio / rinnegavamo i fabbricati che con desideri altissimi / imprigionavano / tutti”. Chissà se in quel “poeta morto ammazzato” vi è un riferimento all’assassinio di Pasolini; certo è che la chiusa del poemetto, come vedremo, è affidata a dei versi in friulano del poeta, scrittore e regista ucciso all’Idroscalo di Ostia nel 1975. E poi quando l’autore descrive il prato trasformato in parcheggio ci viene in mente quello che Pasolini scrive ne Il pianto della scavatrice (Le ceneri di Gramsci, 1957): “[…] Piange ciò che ha / fine e ricomincia. Ciò che era / area erbosa, aperto spiazzo, e si fa / cortile, bianco come cera, / chiuso in un decoro ch’è rancore”3. D’altra parte, l’andamento sintattico della versificazione, in cui alcune volte risuona un rintocco grazie alla presenza della rima, può ricordare, per certi aspetti, lo stile pasoliniano presente nelle Ceneri (si legga, ad esempio, da Tok: “Lontano, si elevava / la Città-Mondo / e il deserto / si faceva / latifondo”). Quell’apocalisse descritta da Belletti pare essere cominciata, almeno in Italia, già negli anni Cinquanta, quando si distruggevano prati e boschi per erigere palazzi di cemento tutti uguali, allineati come impietriti zombie silenziosi. Il bosco nel quale si perde il sentiero percorso si contrappone, come già notato, alla cieca edilizia avanzante creatrice di quella “Città-Mondo” che è “sbiadita prigione”. L’incedere del bambino è accompagnato dall’accendersi di tante lucciole (della cui “scomparsa”, metaforicamente, aveva scritto sempre Pasolini) che si muovono incessantemente – quasi come in un film di Miyazaki – foriere di una nuova incantata e magica dimensione. Una dimensione che appartiene fortemente alla terra – come suggeriscono, a guisa di suggello, due versi di Pasolini in friulano appartenenti a La meglio gioventù (1954) che, come già notato, chiudono il poemetto – e che sta a noi riuscire a riscoprire. Contro future e peggiori distopie e apocalissi, contro lo zombie dominio capitalista che sta distruggendo il mondo e la natura.
Cfr. F. Fiorentin, Carcere della terrestrità, Macabor, Francavilla Marittima, 2021. ↩
Cfr. D. Haraway, Chtulucene. Sopravvivere su un mondo infetto, trad. it. di C. Durastanti e C. Ciccioni, nero, Roma, 2020, pp. 143 e seguenti. ↩
P.P. Pasolini, Tutte le poesie, vol. 1, a cura di W. Siti, Mondadori, Milano, 2003, p. 848. ↩



