di Gioacchino Toni
 Storicamente gli studi sull’universo audiovisivo si sono concentrati soprattutto sull’ambito visivo trascurando il sonoro e, in particolare, la voce. Due recenti volumi, di altrettante studiose, hanno affrontato meticolosamente, da diverse angolature e focalizzazioni, la questione della voce: Alma Mileto, La voce del reale. Il rapporto voce-immagine nel cinema documentario (Meltemi, 2023) e Annalisa Pellino, La voce in transizione. Cinema, arte contemporanea e cultura fonovisuale (Mimesis 2023).
Storicamente gli studi sull’universo audiovisivo si sono concentrati soprattutto sull’ambito visivo trascurando il sonoro e, in particolare, la voce. Due recenti volumi, di altrettante studiose, hanno affrontato meticolosamente, da diverse angolature e focalizzazioni, la questione della voce: Alma Mileto, La voce del reale. Il rapporto voce-immagine nel cinema documentario (Meltemi, 2023) e Annalisa Pellino, La voce in transizione. Cinema, arte contemporanea e cultura fonovisuale (Mimesis 2023).
La complessità del rapporto tra voce e immagine nella storia del cinema documentario viene indagata in profondità dal corposo volume La voce del reale di Alma Mileto. Ad essere passate in rassegna dalla studiosa sono le modalità con cui è stata utilizzata la voce nelle opere a carattere documentario a partire dall’avvento del parlato fino ai giorni nostri; dall’uso della voce fuoricampo nelle modalità didascaliche dei reportage e delle opere naturalistiche, alle retoriche dei cinegiornali di regime, fino alle sperimentazioni più liriche o dialogiche.
Mileto opera una decostruzione dell’idea tradizionale di voce documentaria convinta che l’elemento vocale applicato al cosiddetto “cinema del reale” «costituisca uno dei terreni di maggior sperimentazione del complesso rapporto tra piano dell’immagine e piano del linguaggio», come hanno dimostrato, tra gli altri, Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, Jean Rouch, Agnès Varda, Aleksandr Nikolaevič Sokurov, Werner Herzog, Pier Paolo Pasolini, Cecilia Mangini e Vittorio De Seta.
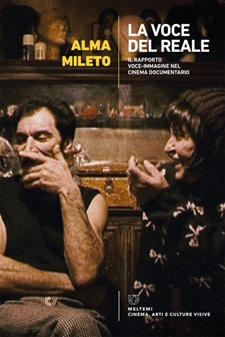 Focalizzandosi soprattutto sul documentario italiano, il volume di Mileto, prima di affrontare le produzioni del nuovo millennio di autori come Pietro Marcello, Alina Marazzi, Michelangelo Frammartino, Alessandro Comodin, Agostino Ferrente e Stefano Savona, ricostruisce le tappe principali della produzione documentaristica nazionale a partire dall’immediato secondo dopoguerra, quando a incentivare la produzione documentaria concorse la cosiddetta “Formula 10” che destinava una percentuale degli incassi ai filmati di dieci minuti, quanti consentiti da una singola bobina di pellicola, proiettati prima del film in sala. Una produzione che formalmente non riuscì a distinguersi granché dai cinegiornali di regime del periodo precedente: la voice over manteneva infatti l’aura di potere propria dei filmati di propaganda soffermandosi sugli aspetti più superficiali delle rappresentazioni.
Focalizzandosi soprattutto sul documentario italiano, il volume di Mileto, prima di affrontare le produzioni del nuovo millennio di autori come Pietro Marcello, Alina Marazzi, Michelangelo Frammartino, Alessandro Comodin, Agostino Ferrente e Stefano Savona, ricostruisce le tappe principali della produzione documentaristica nazionale a partire dall’immediato secondo dopoguerra, quando a incentivare la produzione documentaria concorse la cosiddetta “Formula 10” che destinava una percentuale degli incassi ai filmati di dieci minuti, quanti consentiti da una singola bobina di pellicola, proiettati prima del film in sala. Una produzione che formalmente non riuscì a distinguersi granché dai cinegiornali di regime del periodo precedente: la voice over manteneva infatti l’aura di potere propria dei filmati di propaganda soffermandosi sugli aspetti più superficiali delle rappresentazioni.
A cavallo tra la fine degli anni Trenta e l’inizio del decennio successivo sarebbero arrivate le prime sperimentazioni di un uso della voce più emotivo, funzionante come “sovrastruttura fittizia” rispetto al materiale originario, grazie soprattutto ai celebri documentari d’arte di Luciano Emmer.
Poi fu la volta del suono in presa diretta sperimentato sul finire degli anni Quaranta da Michelangelo Antonioni, successivamente sviluppato nella seconda metà del decennio successivo da Vittorio De Seta nel suo intento di togliere significato semantico alle voci e ai suoni d’ambiente registrati autonomamente rispetto alle immagini.
Sulle orme degli studi di Ernesto De Martino si è poi sviluppato un filone di documentari etnografici che annovera tra le sue opere più significative Stendalì (1960) di Cecilia Mangini e Lino Del Fra, in cui i due esplorano «la forma musicale del canto funebre nei paesi salentini di lingua grica» affidando a Pier Paolo Pasolini la stesura di un testo di commento in forma di poema dal tono epico-mitologico declamato fuori campo dall’attrice Lilla Brignone. Si tratta di una modalità ripresa da Gianfranco Mingozzi in La taranta (1962), con commento di Salvatore Quasimodo e, ancora, nel successivo Li mali mestieri (1963), ricorrendo al poeta Ignazio Buttitta.
Circa l’uso della voce nell’universo audiovisivo un ruolo di primo piano spetta a Pier Paolo Pasolini tanto a livello teorico che di sperimentazione pratica.
Se l’esperienza poetica con il dialetto friulano aveva significato per il Pasolini-scrittore un regresso alla condizione materica della parola, la stessa nostalgia di una maggiore carnalità del linguaggio (più vicino alla sua manifestazione empirica che alla sua dimensione semantica) è alla base di quello che il regista definisce un “cinema di poesia”. Il cinema, fatto con i pezzi del mondo reale e fondato sulla pura mimesis praxeos (imitazione dell’azione) aristotelica, rappresenterebbe cioè la fase massima di “regresso lungo i gradi dell’essere” capace di affondare nella dimensione prelogica (usando un termine vygotskijano) o sensuosa (usando un termine ejzenštejniano) del pensiero. Se il cinema riproduce la realtà e quest’ultima è ciò che viene prima del linguaggio, la lingua del cinema rappresenta il primo momento scritto della realtà.
Come il discorso orale si muove su un terreno meno strutturato di quello della lingua scritta, altrettanto la realtà «deve condizionare la forma cinematografica a muoversi in una direzione più vicina all’oralità che alla scrittura, capace di “verbalizzare” il “non verbale” del mondo rievocandolo nella sua fisicità».
È dunque nella poesia che Pasolini individua la forma verbale che si colloca tra la forma orale e quella scritta del linguaggio. La forma poetica, pur nel suo distacco da una realtà che si limita ad evocare, «produce, nel suo “ineliminabile contrasto tra senso e suono”, valore fonico e valore semantico della parola, una totale liberazione dalla convenzione linguistica e dunque, paradossalmente, una rinnovata forma di azione – a sé stante, costruita su canoni strutturali evidenti, eppure in grado di riattivare una dinamica dei sentimenti che riesce a corrispondere a quella della vita reale che racconta».
Alla luce presenza fisica della voce, legata al suo statuto anche pre-verbale, Mileto elabora il concetto di oromedialità, a partire dal quale indaga «le due opposte tendenze che attraversano la “voce del reale” nel nostro presente: da una parte, essa appare compromessa con il ricco impasto mediale delle narrazioni in cui è coinvolta; dall’altra, sembra sempre più recuperare un carattere di “carnalità” nella sua esposizione orale, svelando l’instabilità emotiva e/o materiale della sua performance».
 A partire da quel territorio di confine incerto tra cinema e arte contemporanea, si muove invece Annalisa Pellino con il suo La voce in transizione che si propone come studio sul cinema in quanto medium fonovisuale e sulla voce come strumento carnale, pensando «l’evento filmico e il cinema come una mise-en-scène di corpi, concentrandosi sulla voce come estensione del corpo e corpo che risuona, non mero medium invisibile della parola». La voce viene dunque considerata «nella sua materialità, come coscienza incarnata o pensiero incorporato» al fine di «proporre una ricomposizione, un riequilibrio tra l’ambito del semantico e quello del vocalico, restituendo alla parola la sua musicalità e riconoscendo alla voce il suo valore euristico».
A partire da quel territorio di confine incerto tra cinema e arte contemporanea, si muove invece Annalisa Pellino con il suo La voce in transizione che si propone come studio sul cinema in quanto medium fonovisuale e sulla voce come strumento carnale, pensando «l’evento filmico e il cinema come una mise-en-scène di corpi, concentrandosi sulla voce come estensione del corpo e corpo che risuona, non mero medium invisibile della parola». La voce viene dunque considerata «nella sua materialità, come coscienza incarnata o pensiero incorporato» al fine di «proporre una ricomposizione, un riequilibrio tra l’ambito del semantico e quello del vocalico, restituendo alla parola la sua musicalità e riconoscendo alla voce il suo valore euristico».
La voce viene indagata come oggetto tecno-culturale e istanza performativa, gesto estetico e politico al centro dei processi di soggettivazione e di (dis)identificazione che hanno luogo sullo schermo o a partire da esso. Dopo essersi soffermata sull’intrinseca materialità della voce al cinema, materialità che riguarda tanto il corpo quanto le sue protesi, i dispositivi e gli ambienti mediali, la studiosa individua spazi e momenti in cui con maggiore evidenza si manifestano gli spostamenti della phoné dentro e fuori dal testo e dal dispositivo filmico, esplorando poi gli usi estetici e politici della voce nelle pratiche artistiche basate sull’immagine in movimento.
Ampliando il discorso dalla voce al sonoro, restando agli studi recenti, in alternativa all’approccio oculocentrico con cui le teorie filmiche hanno storicamente indagato il cinema, Antonio Iannotta, Il cinema audiotattile. Suono e immagine nell’esperienza filmica (Mimesis, 2017) [su Carmilla], pensando alla percezione come ad un’esperienza sinestetica, propone una riflessione sul cinema come esperienza audiotattile indagando la reciproca relazione tra sonoro e visivo nell’esperienza cinematografica.



