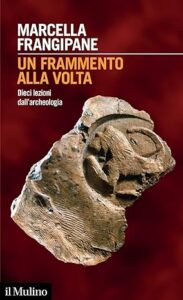Marcella Frangipane è professoressa ordinaria di Preistoria e Protostoria e ha insegnato fino al 2018 all’Università di Roma La Sapienza. Autrice di più di 180 pubblicazioni, ha condotto ricerche sul campo in Italia, Messico, Egitto e Turchia. Dal 1990 è divenuta la direttrice del Progetto di scavi e ricerche ad Arslantepe, Malatya (Turchia), che ha condotto fino al 2019, contribuendo attivamente all’iscrizione del sito nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO (2021).
Lo scavo di Arslantepe è stato il progetto della sua vita ed è divenuto il cuore e la principale fonte di ispirazione della sua attività di ricerca, incentrata su temi come la nascita della disuguaglianza, l’origine della centralizzazione economica, dello Stato e della burocrazia, l’urbanizzazione e le politiche economiche delle prime elites di governo nel Vicino Oriente, con particolare riferimento all’Anatolia e alla Mesopotamia.
Nel 2023 è uscito, per le edizioni Il Mulino, “Un frammento alla volta. Dieci lezioni dall’archeologia”, un saggio divulgativo che affronta i temi principali delle sue ricerche.
L’intervista è avvenuta in una tarda mattinata di luglio del 2023, all’ombra immobile di un albero.
Per oltre trent’anni sei stata la direttrice della missione archeologica ad Arslantepe, un importante sito protostorico in Anatolia dove scavi dal 1976. Lo scrittore ed entomologo Frederik SjÖberg ha osservato (L’arte di collezionare mosche, Iperborea 2015) come spesso i naturalisti, gli entomologi, passino anni o l’intera esistenza su un’isola. Quei confini ristretti sono il limite che definisce la loro attività, il loro studio: non un ostacolo ma il perimetro entro il quale approfondire gli argomenti che interessano. Un limite che libera. Arslantepe è la tua isola?
Sicuramente sì. Devo premettere che prima di Arslantepe ho lavorato altrove. Quando ho cominciato la mia carriera, dopo la laurea, ho avuto una borsa di studio dell’Università La Sapienza con la quale il mio professore mi mandò in Messico perché voleva avviare a Roma un nuovo corso sulla Mesoamerica. Là ho trascorso 3 anni molto formativi perché sono venuta a contatto diretto con la New Archaeology americana, ovvero con quegli archeologi che stavano riscoprendo l’idea dell’archeologia come antropologia, come studio profondo dei meccanismi antropologici nella vita delle comunità antiche. Per me è stata una bellissima esperienza; poi non ci sono stati finanziamenti e la cosa non è andata avanti, sono tornata e da allora ho iniziato a lavorare a Arslantepe. Ho lavorato anche nel Basso Egitto, però Arslantepe è diventato in effetti la mia isola, il luogo dove ho potuto sviscerare nel profondo tanti elementi che erano emersi anche nelle precedenti esperienze: per esempio la nascita delle società gerarchiche e di certi meccanismi economici. Arslantepe è un tell, ovvero una collina artificiale costituita dal sovrapporsi di decine e decine di insediamenti per millenni, racchiude la storia lunghissima di quel sito e di quella regione ma anche riflette quella delle regioni intorno. Le sue relazioni con le altre popolazioni, che sono variate nel tempo (nella fase più antica erano più dirette verso la Mesopotamia, poi verso l’Anatolia centrale, poi verso quella orientale), la sua posizione di confine culturale e geografico e la lunghezza dell’abitare sempre nello stesso posto ricostruendo i villaggi e le case, hanno permesso di studiare non solo la sua storia particolare e la storia riflessa delle altre comunità ma anche l’evoluzione, lo sviluppo interno, i meccanismi con cui le società si modificano. Per questo sono convinta che la ricerca archeologica sia un mestiere che richiede tempi lunghi. In pochi anni scopri la presenza in uno strato di un dato momento storico, di un’altra fase nello strato successivo, ma non capisci i processi che hanno dato loro forma e ne hanno determinato i cambiamenti. Per capire quella che Fernand Braudel ha chiamato la “storia profonda”, cioè l’andare dentro alle cose, devi lavorarci molto tempo perché la ricostruzione è complessa e avviene un frammento alla volta. Partiamo da piccoli frammenti della vita materiale sopravvissuti al passare del tempo e per ricomporli in un quadro storico generale ci vuole moltissimo tempo. Così, come l’entomologo studia tutti gli insetti di un’isola e le loro interazioni, io credo che sia necessario per noi archeologi fare lo stesso. È proprio partendo da quel sito, Arslantepe, che ho potuto studiare approfonditamente per moltissimi anni, che ho poi avuto la possibilità di spaziare su tematiche vaste e su altre aree geografiche.
Com’è nato Un frammento alla volta? È una macro-sintesi che racconta l’origine di fenomeni fondanti della storia profonda dell’umanità: lo stato, i meccanismi di potere, la burocrazia, la famiglia, il vivere in comunità, le prime città, la specializzazione del lavoro… Hai sentito l’urgenza di raccontare fin dove può arrivare l’archeologia?
 Sì, esattamente. Non è un caso che questa esigenza l’abbia sentita e la senta tuttora, alla fine della mia carriera, dopo tanti anni di studio e di ricerca sul campo. È accumulando e costruendo conoscenza che ti si aprono domande e cerchi risposte su tanti quesiti fondamentali. Anche perché vedendo come viene trattata l’archeologia nei media, nei documentari – con questa idea della scoperta, del tesoro, della cosa sensazionale – ho pensato che bisognava assolutamente cercare di far capire a un pubblico il più vasto possibile, non solo di studiosi, che cosa fa davvero l’archeologia e quali sono le sue potenzialità come scienza globale, cioè che raccorda tante scienze diverse (credo che nessuna scienza sia così integralmente interdisciplinare); e poi, soprattutto, far capire che cosa può fare l’archeologia per la nostra vita presente. Per questo ho usato quelle tematiche attuali. Andare a cercare l’origine di molti fenomeni e meccanismi sociali ci permette di capire come si sono evoluti nel tempo e quindi, poi, di riflettere su di noi, su come siamo oggi e domandarci se c’è una possibilità di cambiare il corso della storia. In ogni campo le possibilità sono state varie, alcune sono state prevalenti e hanno vinto, però le strade che si aprivano erano anche altre. Riflettere su questi meccanismi significa capire se abbiamo qualche strada alternativa alla nostra vita oppure se siamo obbligati a seguire un percorso già segnato.
Sì, esattamente. Non è un caso che questa esigenza l’abbia sentita e la senta tuttora, alla fine della mia carriera, dopo tanti anni di studio e di ricerca sul campo. È accumulando e costruendo conoscenza che ti si aprono domande e cerchi risposte su tanti quesiti fondamentali. Anche perché vedendo come viene trattata l’archeologia nei media, nei documentari – con questa idea della scoperta, del tesoro, della cosa sensazionale – ho pensato che bisognava assolutamente cercare di far capire a un pubblico il più vasto possibile, non solo di studiosi, che cosa fa davvero l’archeologia e quali sono le sue potenzialità come scienza globale, cioè che raccorda tante scienze diverse (credo che nessuna scienza sia così integralmente interdisciplinare); e poi, soprattutto, far capire che cosa può fare l’archeologia per la nostra vita presente. Per questo ho usato quelle tematiche attuali. Andare a cercare l’origine di molti fenomeni e meccanismi sociali ci permette di capire come si sono evoluti nel tempo e quindi, poi, di riflettere su di noi, su come siamo oggi e domandarci se c’è una possibilità di cambiare il corso della storia. In ogni campo le possibilità sono state varie, alcune sono state prevalenti e hanno vinto, però le strade che si aprivano erano anche altre. Riflettere su questi meccanismi significa capire se abbiamo qualche strada alternativa alla nostra vita oppure se siamo obbligati a seguire un percorso già segnato.
Una delle domande che volevo porti – a questo punto la anticipo, anche se un po’ hai già risposto – era proprio in merito alle alternative. Soprattutto pensando alla questione della famiglia: nel libro ricostruisci l’origine della famiglia sulla base della forma e della suddivisione interna delle abitazioni e scrivi che nella struttura e relazioni di quelle prime famiglie si trovano il germe delle disuguaglianze sociali, dell’organizzazione gerarchica della società, del potere e dello stato. Studiando questi argomenti, hai mai avuto l’impressione che le cose sarebbero potute andare diversamente, che si sarebbe potuto imporre un altro tipo di famiglia e quindi di società?
È la domanda delle domande, era proprio questo il cuore della riflessione. Per questo ho mostrato nel libro diversi tipi di famiglie, nati in diverse società e ambienti naturali. L’interazione con l’ambiente naturale è importante; non è una questione di determinismo ambientale, che lì sei costretto a fare così e in quell’altro posto sei costretto ad essere in un altro modo. È l’interazione che le comunità umane stabiliscono con quell’ambiente a determinare il loro sviluppo, per questo ho confrontato il caso della Mesopotamia meridionale, dove sono nate gerarchie sociali ed economiche da famiglie già gerarchizzate, con altre aree geografiche. La Mesopotamia era un ambiente arido con problemi di controllo dell’acqua e di gestione dell’agricoltura, che però potenzialmente poteva diventare molto produttiva, e in quel contesto è sorta la necessità di strutturare la società in forma gerarchica perché c’era bisogno di un coordinamento. Tutto questo ha portato allo sviluppo di disuguaglianze non solo perché chi gestiva (per esempio la canalizzazione dell’acqua o lo scambio interno tra prodotti diversi) aveva dei privilegi che gli venivano assegnati dalla comunità stessa, ma perché gestendo certe produzioni finiva con l’appropriarsi di esse o di parte dei prodotti. All’inizio, probabilmente, si tratta di una disuguaglianza sociale, di prestigio: vengono assegnati dei ruoli da leader a quelli che nella scala gerarchica generata dai sistemi di discendenza sono considerati di status più elevato. Ma poi, a un certo punto, quel privilegio diventa altro. Scatta un meccanismo per cui queste persone approfittano del loro ruolo e invadono altri campi, soprattutto quello economico. E quando la disuguaglianza diventa economica è molto difficile tornare indietro. Però ci sono società in cui questo passaggio sarebbe potuto non avvenire. Per esempio, le società più antiche antiche (neolitiche) del nord del Mesopotamia erano tendenzialmente egualitarie, perché lì le caratteristiche del territorio con ampie distanze, montagne, pianure, diversi tipi di climi, ha fatto sì che queste comunità si organizzassero in attività di gruppo: non la singola famiglia che produce e consuma, diventando in alcuni casi privilegiata e capace di gestire il surplus, ossia la produzione in eccedenza, a proprio vantaggio, ma comunità che gestivano collettivamente la produzione e il consumo, con diversi gruppi che si specializzavano in una specifica attività, per esempio nella pastorizia, nella caccia, nell’agricoltura. Questi gruppi poi dovevano scambiarsi i prodotti e farlo in modo tendenzialmente egualitario. Uno può dire: ma come lo so? Lo so perché la ricerca archeologica ci permette di vedere nei resti dei villaggi i segni materiali delle diverse strutture organizzative; le case, per esempio: se sono tutte uguali, se ce ne sono di più grandi e importanti; gli oggetti contenuti nelle case. Le comunità del nord della Mesopotamia avrebbero forse potuto continuare su una strada di sostanziale uguaglianza, ma hanno avuto l’impatto delle comunità del sud che sono arrivate lì e hanno offerto ai capi-comunità un modello da emulare.
Che è sembrato più appetibile…
Sì, ed è cambiato tutto. Ma è sempre così? La domanda è: ogni volta che una società di eguali incontra una società di diseguali prevale sempre e necessariamente la disuguaglianza? A questo non so dare una risposta ma credo che dobbiamo porci il problema. È inevitabile andare sempre nella direzione della progressiva disuguaglianza economica? È chiaro che un coordinamento è necessario, e quindi avere dei capi; in una società complessa come la nostra sarebbe impensabile essere tutti uguali nel vero senso del termine. Il problema è quando la disuguaglianza economica diventa rilevante e determina i rapporti sociali e politici, diventando quindi potere sugli altri. Studiare l’origine di questo meccanismo può essere utile, certo non è detto che oggi sia ancora possibile fare marcia indietro.
Nel tuo libro mi ha stupita l’assenza di nomi di re, dinastie, battaglie, l’assenza di epigrafi. Quando si studiano storie del Vicino Oriente antico o dell’Egitto si legge una sequenza di dinasti e di invasioni: è la storia raccontata dai vincitori, dai detentori del potere. I resti materiali oggetto dell’archeologia sono fonti alternative di costruzione della storia e di storie: la “storia degli anonimi”, come la definiva l’archeologo Salvatore Puglisi. L’archeologia è un po’ in tensione tra queste due possibilità di storia, quella dei vincitori e quella di tutti. Però è anche vero che un reperto materiale che rimanda a un’individualità precisa per quanto anonima (l’impronta di un piede su un mattone, un errore di tornitura su un vaso, una sepoltura con caratteristiche anomale) è emotivamente toccante, anche per un archeologo esperto, perché ci vediamo una persona. Questo mi fa venire in mente una cosa che mi ha detto un’amica antropologa (Anna Delfina Arcostanzo), con la quale si parlava del fatto che le persone del passato, e le loro relazioni con le cose, per lo più “mancano”, ovvero se ne conservano pochissime tracce e resti; lei mi ha fatto notare che non solo mancano ma anche “ci mancano”, tanto che le andiamo a cercare, a diseppellire. Perché a molti di noi mancano così tanto tutti questi anonimi del passato?
Non a tutti mancano, dipende dal tipo di interesse e sensibilità. Credo che sia invece comprensibile che ci manchino, perché il passato è qualcosa che non passa, è qualcosa che resta. Resta una piccola cosa, resta quello che riusciamo a ricostruire, però in ogni caso si tratta di cose che ci segnano, che ne siamo consapevoli o no. Basta pensare alla storia delle famiglie: ti raccontano del tuo bisnonno, che non hai mai conosciuto, e quel racconto diventa parte di te, anche se non è la tua storia reale, non l’hai vissuta, però è la storia della tua famiglia e questo si riflette su di te. Così vale anche per le comunità. Andiamo a ritrovare, anche emotivamente, questa presenza e materialità della vita, soprattutto noi pre-protostorici che non abbiamo i testi scritti. I testi vanno sempre interpretati perché sono un punto di vista, mentre noi abbiamo a che fare con una realtà non mediata: frammentaria, poca, ma reale. Mi ricordo un episodio, di quando stavamo costruendo ad Arslantepe il magazzino per i materiali archeologici nella casa della missione. Avevamo steso i mattoni crudi ad asciugare e avevamo un cane che era un disastro, zampettava dappertutto lasciando le impronte sui mattoni, invano cercavamo di scacciarlo. Quell’anno stavamo scavando uno dei piccoli templi all’interno del palazzo del IV millennio e rimuovendo uno strato di mattoni crollati è venuto fuori un mattone con l’impronta di un cane. Per me è stata un’emozione fortissima perché ho visto la mia vita, con il cane che saltellava sui mattoni, e la loro, e ho pensato: chissà quanto l’hanno cacciato per non fargli rovinare i mattoni. Questi momenti ti avvicinano innegabilmente ai tuoi antenati. I passati sono passati fino a un certo punto.
Tornando al libro e all’idea di archeologia che permette di costruire storie alternative, una cosa che mi è piaciuta molto sono i paralleli tra le varie aree geografiche. L’archeologia può servire per destrutturare il modo lineare di raccontare la storia? Quella temporalità lineare – una civiltà dopo l’altra – che definisce la narrazione nelle discipline storico-artistiche.
Certamente, l’aspetto comparativo è fondamentale. Io sono partita da un’isola, che è stata Arslantepe, ma quando ti poni delle domande devi allargare lo sguardo e allora ti accorgi delle differenze con altre aree. Avendo lavorato in Egitto, conoscevo bene quella storia e comparandola con la Mesopotamia meridionale ho visto delle differenze fondamentali in quella che apparentemente è la stessa cosa: la nascita dello Stato, delle prime forme statali con potenti monarchi che controllano la società. Poi ho visto che la situazione in Anatolia occidentale è del tutto diversa, lì non ci sono mai state agli inizi forme statali mature; il primo stato in Anatolia è quello degli Ittiti, più tardo quindi, rispetto alle fasi formative dello Stato, e che comunque copia il modello dal mondo mesopotamico. Le differenze sono profonde e ti aiutano a capire che non c’è un’evoluzione unilineare, che le possibilità sono tante e diverse a seconda delle circostanze ambientali – dove ti trovi e quali sono le risorse che quell’ambiente ti offre – ma anche sociali. Da lì nascono storie diverse. Questa è una di quelle cose che ho molto assorbito nei miei anni messicani perché lì ho fatto un seminario con alcuni famosi studiosi, tra cui Kent V. Flannery, William T. Sanders, che avevano questa tendenza alla comparazione, molto più evidente rispetto ai colleghi europei. Di recente sono stata invitata a un workshop in Arizona sulle economie pre-moderne, dove sono state confrontate tutte le economie antiche: la Mesopotamia, gli Inca, gli Aztechi, l’Europa dell’età del Bronzo, Roma. Forse gli americani a volte esagerano, la comparazione deve essere cauta e rigorosa, ci devono essere gli stessi elementi per poterla instituire, però è utile: comprendi tante cose quando capisci che c’è, c’è stato, anche un altro modo per fare quella stessa cosa.
Nel libro riporti un aneddoto risalente a uno dei primi anni ad Arslantepe. Un giorno Salvatore Puglisi fece capire al fotografo dei reperti che doveva interrogarsi sull’oggetto prima di fotografarlo, perchè fotografarlo senza prima osservarlo e coglierne in qualche modo l’anima, equivaleva a creare un ibrido, un pesce fuor d’acqua. Un pesce lo si fotografa nell’acqua oppure cotto, in pentola – diceva Puglisi. Per un archeologo il pesce, il reperto, ha senso soltanto nel suo contesto, in relazione ad altri, al luogo, alle vite passate. “Iniziavamo a capire” – scrivi – “come guardare oltre l’oggetto, alla sua storia e alla sua vita, prima che il tempo lo trasformasse in una «rovina»”. Ti viene naturale, ormai, guardare oltre l’oggetto?
Direi di sì, mi viene naturale perché la prima cosa che mi domando, quando lavoro sul terreno e con i materiali, è con che cosa quel reperto stava. Cioè l’associazione, la relazione. Quell’oggetto di per sé non significa nulla, inizia a prendere significato quando lo contestualizzo, lo ricolloco nel suo ambiente. Che c’era vicino? Un focolare, un altro oggetto? Così capisci come funzionava e viveva. Anche il reperto in sé ti può dire delle cose; è il frutto di lavoro, di manipolazione, ti rivela come è arrivato a essere quello che è. Per esempio sulle ceramiche, sugli oggetti di pietra e di metallo facciamo analisi chimiche per vedere la composizione dei materiali per sapere da dove vengono, se da vicino o da lontano, quindi se il manufatto è frutto di commercio o è stato prodotto in loco. Oggi sulle ceramiche si fanno le analisi dei residui alimentari anche quando non si vedono, perché c’è sempre qualche molecola intrappolata nella terracotta; quindi preleviamo dei campioni, in accordo con il restauratore (per non togliere frammenti la cui assenza potrebbe impedire la ricomposizione del vaso), su cui fare analisi biochimiche. Così si può ricostruire se quel vaso ha contenuto latte o prodotti derivati del latte, cereali, carne. Quindi ci sono due piani: l’analisi dell’oggetto in sé che contiene la storia di chi l’ha fatto e la storia di chi l’ha usato, e l’analisi “oltre l’oggetto”. Anche l’oggetto singolo può rivelare tante cose. Però poi è importante vedere con cos’altro viveva.
Secondo te da quando esiste l’archeologia moderna è cambiato qualcosa nel nostro atteggiamento e nella nostra relazione con le cose? Sapere che esistono delle figure come gli archeologi ci influenza, ci fa cambiare qualcosa in quello che lasciamo, e quindi in quello che resta?
Credo che dovremmo esserne molto più influenzati. C’è una visione distorta dell’archeologia: si tende a vedere il tesoro, l’oggetto speciale, antichissimo e quindi di valore. Mentre dovremmo capire molto di più come gli oggetti parlano, a prescindere che siano di valore o meno, e come sono parte della nostra storia. Questo modo di guardare gli oggetti antichi ci aiuterebbe a vivere anche gli oggetti di oggi in un modo diverso. A conservare certe cose non perché preziose ma perché ci parlano del nonno, del padre, di quel momento particolare. Secondo me succede poco.
Prima, a un certo punto, hai definito l’archeologia una scienza. È davvero una scienza? Perché molti archeologi affermano con forza che lo è, come se così facendo la elevassero rispetto alle discipline umanistiche?
Per me l’archeologia è una scienza come l’antropologia, la letteratura. Le scienze umane sono scienze. Diverse da quelle naturali (le cosiddette ‘scienze dure’), con altre prospettive, metodologie, finalità. L’archeologia è una scienza anche per l’approccio interdisciplinare con scienziati, economisti, sociologi, storici ma principalmente perché ricostruisce scientificamente, rigorosamente, un mondo del passato. Ma c’è una cosa per cui l’archeologia non è ancora una scienza, secondo me. Riguarda il metodo. Purtroppo non c’è ancora un comportamento metodologico uniforme. È chiaro che ogni sito è diverso da un altro, ogni problematica è diversa, però ci sono delle regole di base, per esempio su come si scava, che non possono non essere seguite. Questo ancora non accade in archeologia, e questo non la rende una scienza. Scienza significa che quando parli con un altro collega devi poterti fidare dell’informazione che ti dà, e fidarsi significa sapere come ha ottenuto i suoi dati. Mentre noi spesso non lo sappiamo. È un gravissimo handicap.
Secondo te quale ne è la ragione?
Un po’ deriva dalla storia della disciplina, che è stata diversa a seconda del paese. Sono stata di recente in Germania e ho visto che i tedeschi scavano in un modo completamente diverso dal nostro. Un modo che io personalmente non approvo. Bisognerebbe confrontarsi ma nessuno ha il coraggio di farlo; il modo in cui si lavora diventa tradizione, abitudine radicata. C’è un mio ex allievo che da anni mi dice di scrivere un libro sul metodo e sulla documentazione di scavo. Non lo voglio fare non perché non penso sia importante ma perché temo le reazioni dei colleghi, che potrebbero essere negative. Perché se uno si sente dire, seppur implicitamente, “stai sbagliando tutto”, si irrigidisce. Lo temo e quindi non lo voglio fare esplicitamente, lo farò in un altro modo. Stiamo preparando i vari volumi della serie di Arslantepe, li stiamo pubblicando periodo per periodo, proprio per dare preminenza al contesto; le analisi in ogni volume saranno divise non per categorie di materiali, ma per periodi storici. Nel primo volume ci saranno la storia del sito, degli scavi archeologici, la sequenza cronologica e stratigrafica generale e, primo per ordine di importanza, la descrizione dettagliata della metodologia di scavo e di documentazione. Non la impongo a nessuno ma è la nostra. I colleghi, vedendo i risultati, potranno valutare se quella metodologia ha funzionato oppure no.
“Tutto il futuro esiste nel passato” è una frase di Truman Capote che riporti nel libro. Mi fa venire in mente altri riferimenti al passato, da Agamben che ha scritto che il vero spazio di accesso al presente è il passato, a Lalla Romano, che più volte è ritornata sul concetto del passato come spazio di libertà, anche da reinventare: riferendosi in particolare al suo spazio autobiografico, ha detto che il passato è l’unico campo realmente modificabile, l’unico spazio di manovra. In Ritorno a Ponte Stura (Einaudi, 2000) ha scritto: “Nelle origini c’è tutto quello che sarà. Non è determinismo, termine odioso, ma libertà. Parola sacra. // Memoria è libertà? Deve esserlo. La memoria è sacra, ma non è un carcere. // Amare la memoria è anche amare il futuro.”
Si torna all’idea del limite, perché il passato (proprio perché passato) è uno spazio limitato. Un limite che però serve: il perimetro entro il quale spaziare. La riscrittura del passato – proprio e di tutti, personale e collettivo – è anche un esercizio di libertà?
Assolutamente sì. Molto bella questa frase. Sapere come sono avvenute le cose, conoscere le origini, non è una prigione che ingabbia. Perché le cose, come dicevo prima, hanno avuto tante possibilità. Capire che c’erano alternative ti permette di legare in modo libero, aperto, questo passato con il presente. Di leggerlo in una chiave che è comprensione ma non è dogma. L’archeologia scompone la storia; ma quello scomporre è esattamente la storia. È appunto questo spazio di libertà. Destrutturare significa comprendere, continuare a crescere e a capire. L’idea del passato come una cosa scritta per sempre e definitiva è un’idea sbagliata. Ampliando il discorso, questo vale anche per l’idea della verità nella scienza. Durante la pandemia c’è stato un grande equivoco su questa questione: medici e scienziati davano ognuno la propria versione come verità e questo ha creato sfiducia nella gente che vedeva i contrasti tra un’opinione e l’altra senza comprendere che questo fa parte della scienza. Noi non abbiamo verità, ci avviciniamo continuamente a una qualche verità ma lo facciamo per passi ed errori, è il modo di procedere di tutta la scienza. Questo senso di libertà rispetto al passato, sapere che puoi vedere cose diverse da quelle viste finora; questo passato che si allarga, cresce, ti invade, è una visione che condivido.
Parliamo di archeologia al femminile. Nella tua carriera ti è capitato di incontrare ostacoli determinati dal fatto di essere donna?
Ostacoli, nel vero senso della parola, no. Anche perché non ho avuto figli, un fattore che purtroppo a volte condiziona le colleghe perché, per come è concepito nella società il ruolo della donna, il nostro mestiere che ci impone di passare diversi mesi fuori casa crea più difficoltà a chi ha una famiglia da gestire. In questo senso sono stata favorita. Diciamo però che ho dovuto “combattere” contro la mentalità dei colleghi maschi, che spesso faticano a vederti in una posizione di apice. Ostacoli non ne ho incontrati, ma modi di guardare paternalistici sì. Il paternalismo mi ha dato molto fastidio. Quel dire, parlando di te, “è molto brava, aiutiamola” e commenti simili che non si fanno con un maschio. Poi, certo, ho lavorato in un paese islamico, tendenzialmente maschilista, ma lì non ho avuto nessun problema. Si è creato un rapporto bellissimo con la comunità e con gli operai, mi hanno accettata sin da subito, anche perché anche chi mi aveva preceduto era stata una donna, molti stimata e amata (Alba Palmieri), quindi ho avuto la strada aperta. Dal momento in cui si sono fidati, sono diventata una persona, né donna né uomo: una persona. Mi invitavano alle cerimonie di circoncisione dove le donne non erano ammesse, io non andavo ma sentivo che mi percepivano come una persona indipendentemente dal sesso. È stato molto bello, però te lo devi conquistare.
Secondo te ci sono delle peculiarità di una archeologia al femminile?
Ci sono molte donne nell’archeologia, un po’ per un fatto pratico, perché è un mestiere che non porta soldi, è difficile, non fa facilmente far carriera, quindi gli uomini lo lasciano volentieri alle donne. Però è anche un mestiere che trovo molto adatto alle donne. L’attenzione verso le cose, verso la memoria, secondo me è una caratteristica più presente nelle donne. Quindi credo che siano due i fattori: quello pratico – il mestiere non è appetibile – e il fatto che le donne spesso riescono a fare bene questo lavoro perché hanno questo tipo di cura e di sensibilità.
Mi piace chiudere le interviste con una domanda che non c’entra niente, la prendo da un libro di Max Frisch, Diario di coscienza, dove ogni capitolo inizia con una sequenza di domande su vari temi della vita, dell’esistenza. Quella che ho scelto per te è questa: Chi avresti preferito non incontrare mai?
Non è una domanda facile. Forse qualche collega, di cui ovviamente non faccio il nome, per i danni fatti non a me in particolare ma ai giovani. Parlo di persone nell’ambito universitario, nell’accademia, che presentano questo mestiere, l’attività di ricerca, come una carriera da scalare e si pongono di fronte ai giovani come quelli che li possono aiutare, proteggere, raccomandare. Questo atteggiamento causa un danno enorme. Ho avuto degli studenti che sono purtroppo caduti in questa trappola, affidandosi a docenti che gli facevano balenare maggiori possibilità di successo. Io non l’ho mai fatto, perché non l’hanno fatto i miei maestri. Da Salvatore Puglisi, Alba Palmieri, Enrica Fiandra ho ricevuto l’insegnamento ad essere principalmente persone. Non ho fatto una carriera veloce, sono diventata professore ordinario molto tardi rispetto a tanti colleghi. Anche nei riconoscimenti. Qualche anno fa mi hanno associata all’Accademia Nazionale dei Lincei, dopo che la National Academy of Science americana mi aveva cooptato. I riconoscimenti mi sono venuti prima dall’estero e poi in Italia. Non ho mai sgomitato, non lo dico come piaggeria o forma di presunzione, però è vero. Non l’ho fatto perché l’ho imparato, anche dai miei genitori. Non solo è disonesto ma soprattutto, per me, non è importante. Quello che è importante è crescere, imparare, lavorare a qualcosa di realmente utile. È l’unico modo vero per lasciare un segno. E questo ho sempre cercato di insegnarlo agli studenti. Quelli che colgono questo spirito in modo positivo, in sintonia con questi obiettivi, mi hanno seguita, e non sono pochi. Con chi mi ha preceduto e con loro abbiamo formato una Scuola, che spero duri ancora a lungo. Qualcuno è stato invece attratto dalle allodole della carriera facile. I docenti di questi ragazzi sono coloro che avrei preferito non incontrare mai.